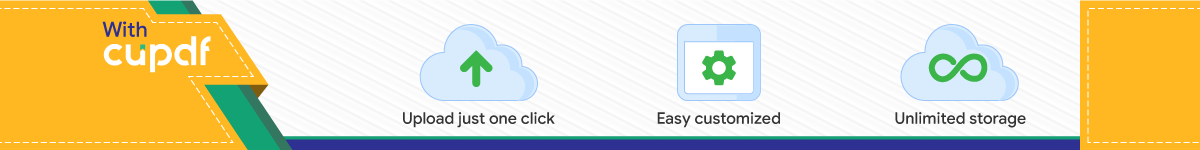

di MARCO DOTTI
●●●Ci sono luoghi che ci ostiniamo achiamare «casa», solo perché non sap-piamo trovare loro altro nome. Luoghidi una estraneità così inquietante dapoterla sopportare solo se continua-mente giocata tra le sponde dell’incu-bo e del desiderio. In uno di questi luo-ghi, tra desideri che avvicinano il tem-po e incubi che inesorabilmente lo al-lontanano, si fanno largo ricordi, mol-to simili a fantasmi, che quel tempo lo«bucano», trascinando tutto con sé.
Attorno a quel buco, si affacciano ifantasmi che per almeno tre generazio-ni attraversano la vita di una famigliaportoghese: un patriarca che ha fattofortuna, con la propria durezza e la fati-ca altrui, servi e domestiche, una tenu-ta di campagna, due fratelli di sangue,uno legittimo e uno no, che si conten-dono lo sguardo del padre, abusi e vio-lenze sui contadini, comunisti in rivol-ta e comunisti ricondotti a più miticonsigli, gente che non ricorda e genteche ricorda fin troppo e, da ultimo, unragazzino autistico che forse è il solo atrarre un senso dal disordine che domi-na le cose. Anche le loro vicende si ag-girano per la casa come fantasmi – oforse sono tutt’uno con essi – attratteda un centro scuro o meglio da qualco-sa che ha l’umore e l’odore della colpa,ma forse con la colpa non c’entra.
Il centro, la casa, disorienta più cheorientare: «Da dove mi arriverà l’im-pressione che alla casa, sebbene ugua-le, manchi quasi tutto? I vani sono glistessi con gli stessi mobili e gli stessiquadri, eppure non era così, non eraquesto, vecchie fotografie al posto dimia madre, di mio padre, delle dome-stiche in cucina e della tosse di miononno che comandava il mondo, nonla sua presenza, non gli ordini, la tosse,un fazzoletto gli usciva dalla tasca e glidisordinava i baffi». È la tosse – un pic-colo choc – a spezzare il ritmo e a inver-tire la linea degli eventi. Si apre cosìL’arcipelago dell’insonnia, pubblicatonel 2008 e ora tradotto da Vittoria Mar-tinetto per Feltrinelli, («I narratori»,pp. 284, € 18) del portoghese AntónioLobo Antunes, che sembra mettere afrutto le tante e spesso fuorvianti buo-ne intenzioni di cui è lastricato l’infer-no di ogni autore, ma in particolare diquesto autore, psichiatra in pensione,«primo paziente di me stesso» comeama scherzare, che in Italia si è fattoconoscere nel 1996, con la traduzionedi un libro edito diciassette anni pri-ma, In culo al mondo (Einaudi, 1996;ora passato al catalogo Feltrinelli).
La scrittura, osservava António Lo-bo Antunes, è «capacità di incorporarela violenza nella tenerezza». Una voltatanto L’arcipelago dell’insonnia non èun libro che smentisce le facili profe-zie di un autore in vena di confessioninon richieste, rivelandosi, al contrario,proprio un romanzo di grande tenerez-za e di grandi violenze. Non sono peròle violenze coloniali e postcolonialiche hanno segnato altri suoi romanzi,dal citato In culo al mondo fino agli ul-timi, non ancora tradotti, Comissãodas Lágrimas, del 2011, o A criar Não ÉMeia Noite Quem Quer del 2012.
Come sempre accade nell’opera del-lo scrittore portoghese, è la dimensio-ne della memoria e la sua dissemina-zione afasica a costituire l’asse portan-te. La scrittura trasferisce atti e incon-tri del passato in un presente che defi-niamo tale solo se ne percepiamo la
sfasatura con un altrove temporaleche nel romanzo è però sovvertito. Nesia prova la scelta, continuamente con-traddetta, dei tempi verbali e dalla pre-senza della casa nel romanzo (e nei ro-manzi: c’è sempre una casa, infatti, neisuoi libri), una casa che «va in rovina»e a poco a poco diventa lo spazio tangi-bile di una simultaneità che la scrittu-ra asseconda e ricalca, nel farsi e disfar-si dei suo processi mnestici. È proprioquesto tentativo di riflettere sui proces-si di memoria – senza mai riuscire a ac-cordarsi in pieno – a rendere talvoltadisarmante il patchwork di António Lo-bo Antunes. Su questo disarmo, d’al-tronde, l’autore gioca d’anticipo e gio-ca pesante e in prima persona.
L’elemento vissuto è importante,non solo per un autobiografismo più omeno di facciata, ma proprio perchégli consente di calarsi interamente in
questo processo mnestico. Un procedi-mento complesso, saturo di rimandiinterni (pochi quelli esterni, perlopiùimpliciti, come quello che dà il titolo al-l’Arcipelago dell’insonnia, che riman-da al poeta Blaise Cendrars), passibiledi apparire ostico o difficile a quel letto-re che non accettasse di calarvisi in pie-no.
Il 25 ottobre del 2012, concludendola sua collaborazione col settimanaleVisão, sul quale teneva una rubrica fis-sa, Lobo Antunes annunciò di conside-rare conclusa la propria opera. «Hoscritto ciò che volevo scrivere, ora toc-ca al lettore». Salvo qualche post-scrip-tum, sempre possibile di questi tempi,il lavoro era da considerarsi terminato:basta interviste, basta apparizioni tele-visive, basta romanzi. Un sano silen-zio, insomma. Non prima, però, diaver regolato qualche conto con chi di-
chiara di non capirlo. Ciò che non capi-scono, osserva l’autore, non è questo oquel romanzo, ma «la complessità del-la vita, e questo non è un mio proble-ma. John von Neumann, padre della te-oria dei giochi, lo spiegò chiaramente,distinguendo tra variabili vive (che l’in-dividuo tiene in debito conto, nel-l’eventuale calcolo di una strategia) evariabili morte (di cui l’individuo nonsi serve mai).
Le variabili morte sono quasi inutili.È sufficiente prestare orecchio attivo al-le cose e a noi per comprendere. La pa-ura di sapere ci terrorizza. L’idea diprendere coscienza ci fa venire la pelled’oca. Rifiutiamo l’idea di vivere den-tro di noi. Leggere storie rende menoviolenta la parte di infanzia che è innoi. Ma questo non serve a niente. Ser-ve solo a tranquillizzarci, a allontanar-ci da ciò che ci inquieta e ci spaventa.
Io non mi sono messo a scrivere perportare la tranquillità a qualcuno. Nonvedo alcun interesse a divertire o a agi-tare nell’aria animali di pelouche. Hoscritto libri per adulti che tengono gliocchi aperti».
Tenere gli occhi aperti o, meglio,sbarrati è una caratteristica delle figu-re che popolano l’universo romanze-sco di Lobo Antunes. Troppa luciditàconduce al delirio, come nell’insonniaprolungata. Ma troppa lucidità appros-sima anche a quel «negativo» che, altri-menti, ci scapperebbe di mano pertroppo delirio o troppa ragione. Quelnegativo che è da sempre al centro del-la sua riflessione e ha trovato nella «ca-sa» e nella sua decadenza una immagi-ne efficace e un espace fictionnel dovelo scrittore può giocare e giocarsi tuttele proprie figure, con tutte le ambiva-lenze messe da loro e con loro in movi-mento. Ecco, allora, che proprio neimomenti di massima tensione, che so-
no momenti di lucidità e al tempo stes-so sono delirio, queste figure hanno ac-cesso a qualcosa che somiglia a un sen-timento o a una nostalgia.
Accade anche nell’Arcipelago dell’in-sonnia – libro tra i più «intimisti» del-l’autore, in cui personaggi sono intera-mente calati in se stessi e nella storiache attraversa questo sé – quando trauna morte certa e una promessa di ma-trimonio, davanti agli occhi aperti dellettore si presente improvvisamentequesta sequenza: «non sei cambiata,non sono cambiato e da adulto arrivoin paese noncurante delle imposte, mipresento ai tuoi genitori e ci sposiamo,c’è spazio per tutte le tue cose qui, perle bambole e per il carillon con la ma-novella che va girata con cautela per-ché a dar troppa corda smette di fun-zionare, non appena si sente uno scat-to bisogna fermarsi e dopo basta ascol-tare, prima veloce e poi sempre più len-to, interrompendosi a metà del ritor-nello e noi una malinconia tranquilla,ho sempre immaginato che si morissein questo modo, un suono flebile chesi prolunga per qualche secondo pri-ma di cessare e cessare significa losguardo altrove dato che quello che ri-mane non sono occhi che si spengonochiedendo».
VIOLENZA E TENEREZZAIN LOBO ANTUNES
BORTOLOTTO • TERNI • SPELLMAN • BRITTEN • RHYS• MOEHRINGER • IRVING • DUKAJ • DEHNEL • POESIAACUSTICA • CARMI/NERI • MOSTRE:BEMBOAPADOVA
ROMANZO TRA I PIÙ «INTIMISTI» DELL’AUTOREPORTOGHESE, «L’ARCIPELAGO DELL’INSONNIA»PRESENTA PERSONAGGI CALATI IN SE STESSI,NEGLI INTERNI DI UNA CASA ASSAI DISORIENTANTE

(2) ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
Un dioramadi idiosincrasiee intuizioni
di MARCELLO LORRAI
●●●Rievocando nel suo TheAutobiography of LeRoi Jones/Amiri Barakale sue esperienze universitarie, l’autore delPopolo del blues introduce, con untrasparente camuffamento delle iniziali delnome, che da A.B. slittano a C.D., un suocompagno alla Howard, anche luiafroamericano, «forse il mio amico piùstretto in quel campus». Siamo nel cuoredegli anni cinquanta e, in un’epoca in cuila «nigger music» non è ancora ammessaalla Howard, LeRoi Jones e C.D. sono tra ipochi studenti a approfittare delle lezioninon ufficiali sulla musica neroamericanaimpartite in un dormitorio da SterlingBrown, figlio di un ex schiavo, poeta,straordinario studioso della cultura neradel Sud degli Stati Uniti. Per LeRoi Jones sitratta dell’insegnamento più alto ricevutoalla Howard: ne ricava che la musica è arteoltre che divertimento, e che il popolo neroha una storia. Nel decennio successivoLeRoi Jones e A. B. Spellman, diventatientrambi intellettuali e poeti, pubblicanotre libri cruciali sulla musica
afroamericana: nel ’63 esce, di Jones, BluesPeople, poi nel ’68 Black Music; in mezzo,nel ’66, Spellman pubblica Four Lives inthe Bebop Business, più tardi ripropostocome Four Jazz Lives, e ora finalmentetradotto in italiano Quattro vite jazz,minimum fax, pp. 272 € 16). Se BluesPeople è la prima grande lettura del jazz in
chiave storico-sociologica, se è unospartiacque, perché afferma che il jazz vainterpretato alla luce dell’esperienzaafroamericana, che il motore dellosviluppo del jazz va ricercato nella vicendaafroamericana, e che i protagonisti decisividi questo sviluppo sono, non casualmente,in modo quasi esclusivo dei neri, FourLives dal canto suo richiama l’attenzionesu quattro musicisti afroamericani: ungrande misconosciuto, il pianista HerbieNichols; un fuoriclasse proveniente daljazz moderno ma arrivato a convergerecon le istanze musicali e la sensibilitàpolitica dell’avanguardia, il sassofonistaJackie McLean; e i due musicisti chedell’avanguardia Spellman considera gliesponenti fondamentali assieme aColtrane, e cioè il pianista Cecil Taylor e ilsassofonista Ornette Coleman. All’epocanon c’era l’odierna vastità di letteraturajazzistica in materia di biografie eautobiografie (che anche adesso del resto èmolto carente sulle figure meno comodedell’attualità jazzistica): dare estesamentevoce, facendole assumere la «massacritica» di un libro, a quattroanticonformisti era dunque decisamenteirrituale. Ma il valore di Four Lives è lungidall’essere solo storico. Prendiamo Taylor,la prima, e la più corposa, delle quattro«vite». Lungo un sessantennio di carrieraTaylor, che ha oggi ottantaquattro anni, èstato aristocraticamente avaro di interviste,e non ha mai prodotto un’autobiografia, equindi Four Lives rimane un riferimentoindispensabile per le informazioni e lamole di sue affermazioni che contiene. Mac’è molto di più. In un momento in cuiTaylor è tutt’altro che una figuraconsacrata, e le sue occasione di suonare
di PIERO GELLI
●●●Uno degli aspetti più inquietanti dellinguaggio, anche colloquiale e fatico, nonsolo letterario critico, è quello di celare unsignificato diverso, ambiguo dietro un’ap-parenza comunicativa, un sorriso che co-pra una smorfia, un grazie che suoni un in-sulto. Se è vero, come afferma Lévi-Strauss, che la musica, proprio perché lin-guaggio senza parole, è un meta-linguag-gio ideale per carpire o adattare ogni possi-bile diversità di significazione, quest’ulti-ma raccolta di Mario Bortolotto, Fogli mul-ticolori (Adelphi «Saggi. Nuova serie», pp.377, € 30,00), così aperta alle occasioni ecosì chiusa in realtà dentro le sue note at-trazioni e allergie, rivela qualcosa di più allettore fedele del musicologo più colto esornione che abbia oggi l’italia, un abboz-zo di teoria della musica se si vuole, che inrealtà non lo è, perché diventa subito unacritica del costume musicale, incastonatoquasi al centro della silloge e differenziatoda un titolo in corsivo: De Musica. Ci dicemolto, questo aperçu subito richiuso, sul-le idiosincrasie lontane del critico intornoa classificazioni facili di generi oggi nonpiù accettabili se non per comodità o su-perficialità di catalogazione. Tornerò suquesto brano insinuativo, in chiusura, an-che perchè si accenna al «concetto» di di-vertimento e di noia, così dirimente nel-l’estetica-etica bortolottiana, e vi si trovaquell’idea di cultura che il suffisso abusa-tissimo di meta- oggi sembra incarnare,per quanto il critico lo carichi di ironia:l’età delle certezze è lontana, come quelladei verdetti definitivi; e da questo tutto
sommato eravamo partiti.Converrà, prima di troppo divagare, sof-
fermarsi a esaminare i contenuti, per lomeno alcuni, di quest’ultima raccolta, chesi apparenta all’altra più sostanziosa appar-sa qualche anno fa, Corrispondenze (anco-ra Adelphi, 2010), dopo una serie di saggimirabili più «compatti» che affrontavanoora un tema, come quello del teatro lirico(Consacrazione della casa, Adelphi 1982),ora un periodo, come la Francia tardo-otto-centesca (Dopo la Battaglia, Adelphi,1992) o la Russia da Glinka a Skrjabin (Estdell’Oriente, Adelphi, 1999), ora un autorecome Wagner (Wagner l’oscuro, Adelphi,2003) oppure come Richard Strauss (La ser-pe in seno, Adelphi, 2007); temi e autori tut-ti questi prediletti dal nostro critico e offer-ti a una lettura tra le più affascinanti e ar-due, dove alla sapienza specifica si accom-pagna sempre una conoscenza letteraria eculturale vastissima, talvolta proposta an-che in formula di sprezzante snobismo: co-me qui, quando invece di citare il Libro del-l’ inquietudine e l’amato Pessoa, parla di di-sassosego e del linceo Lisboeta (pag. 140).
Non a caso, questa scelta di articoli o sag-gi di varia lunghezza si apre e si chiude suautori di musica contemporanea: con unomaggio e un ricordo dell’amico scompar-so, il compositore Goffredo Petrassi, cuinel 1964 era stato dedicato un approfondi-to saggio apparso ne «I Quaderni della Ras-segna Musicale (pp. 11-79)», quasi a colma-re un’assenza assai lunga, essendo il mae-stro morto novantanovenne, nel 2003, marifiutando di poi l’ingrata fatica, per «l’ine-sorabile diversità» e soffermandosi signifi-cativamente sui bellisssimi Estri per 15 ese-
cutori, quasi coetanei a quella monografia(del 1967 e non 1987 con evidente erroredi stampa); e si chiude, questa raccolta,con la descrizione dell’impervia esecuzio-ne del quartetto Arditti dell’Helicopter-Quartet di Kerlheinz Stockhausen. A quel-lo Stockhausen, ricordo, cui Bortolotto ave-va dedicato molte pagine nel suo libro piùsperimentale e avanguardistico, Fase secon-da, studio rischioso di una musica «fatta aperfetta dissimiglianza di Dio» come recital’esergo; uscito nel 1969 da Einaudi, a ri-sguardi bianchi, poi riproposto nel 2008,da Adelphi, come historicum exemplum, asignificare che quell’epoca-meteora dellaneue Musik, 1946-’64 oltre Webern, era de-finitivamente tramontata. Chissà se Borto-lotto ancor oggi pensa che Stockhausen,con Kafka, ciò che toccava si sfasciava?Quasi poi passando se non la palla la sug-gestione all’amico editore Calasso (cfr. K.,Adelphi, 2002). Su Kakfa comunque nonha dubbi, se oggi ribadisce che due sono iboemi grandi del passato, il suddettto scrit-tore e Mahler, con buona pace di Janácek,cui l’aggettivo grande non si addice nono-stante le accorate difese di Milan Kundera.E l’opinione, decisa, apparteneva già, conpiù ricche modulazioni, al volume del1982 La consacrazione della casa, nel capi-tolo «Janácek come cattivo lettore»: di Do-stoevskij, per l’appunto, e del suo Da unacasa di morti.
Si è già detto che sono articoli scritti perun quotidiano, e così recita il risvolto, dovealtro non si specifica accomunando nellosprezzo filologico editore e autore (ma il ti-tolo elegantemente indirizza a Il foglio), an-che se in questo caso lo sprezzo è giustifica-to, perché nessuno di questi quaranta «ri-tratti» più uno, il citato De Musica, ha nien-te dell’occasionalità recensoria o celebrati-va, poiché tutti si costruiscono intorno aun’intuizione di così penetrante perspi-cacia e fulminante, che non si recuperamai nella critica musicale, neppure nel-l’idolatrato Fedele D’amico, bensì incampo letterario: ha infatti la stessa im-pronta e acutezza che si ritrova in Gior-gio Manganelli, del resto amatissimo:quella capacità di sintetizzare in po-che frasi, talvolta perfino nel titolo, ta-laltra in un semplice aggettivo sor-prendentemente desueto o trasgressi-vo, un’interpretazione che coglie inmodo direi definitorio l’essenzia-lità vitale poetica di quel musi-cista e di quell’opera. E sa-ranno le pagine su Debus-sy e sul suo pianismo, lon-tane certamente da quellemallarmeiane di Jankélévi-tch, perchè per Bortolotto «iltempo debussiniano» è un tempo «profa-no dove muore la slavata traccia dell’esi-
stenza»; e le penetranti osservazioni sul Pel-léas et Mélisande, che lo studioso curiosa-mente concordando col Leibowitz defini-sce come il no man’s Land dell’opera liri-ca. E ancora quelle seducenti su Ravel, sucui ritorna più volte, sul bambino dei sorti-legi e la sua geniale inattualità, dove, però,i sortilegi siano pensati «in funzione ancil-lare, rispetto al suo lirismo beffato e inestir-pabile». O il davvero incantevole capitolo«Francis à jamais», l’adorato Poulenc e lasua «derisoria capacità di tessere trame me-lodiche sempre rinnovate e il gusto di co-struire musiche profane come nate in unbordello di lusso e quelle sacre in un esclu-sivo atelier di moda». Ed è facile immagina-re quanto il raffronto diverta l’estro dissa-cratorio del nostro critico.
In realtà, Fogli multicolori ripropone undiorama bortolottiano che il suo lettore disempre conosce bene, a parte qualche no-vità come il capitolo dottissimo dedicato al-l’americano, da noi quasi sconosciuto,Charles Ives; sono gli autori che lo studio-so ama da sempre o che da sempre detestasopratutto perchè l’annoiano, come la piùparte del Rossini serio proposto dal ROF(Rossini Opera festival), o l’inerzia dram-maturgica di Haendel (in questo d’accor-do con Stravinskij), o «l’eterno piagnisteo»di Luigi Dallapiccola, di cui poche cose loconvincono. In ogni caso, in ogni «foglio»,del musicista preso in esame per rapide as-sociazioni, per insoliti illuminanti accosta-menti, anche letterari, per bizzarre maacutissime interferenze, Bortolotto riescesempre a rilevare quell’aspetto da altri ne-gletto, quella caratteristica insolita che nerinnova radicalmente la conoscenza, lacomprensione. Ci sono, inoltre, articolipiù elaborati e importanti, quelli per esem-pio dedicati al bisbetico grande Schönberg, dove, tra l’altro, quasi venendo die-tro a un suggerimento arbasiniano, si af-fronta il frammento-torso Moses undAron, oppure rivolti, sia pure per accenni,al vivace dialettico rapporto con Adorno,rispettato anche quando sbaglia, forse perun’indubbia affinità di fine alterigia. Ci so-no infine, per concludere e riallacciarmi aquel che dicevo all’inizio, due capitoli su-blimi per «ideologia», termine che Borto-lotto aborre e che qui significa soltanto li-bertà di giudizio, di gusto da ogni impe-denza classificatoria, classicistica o simi-lia, e sono, per esempio, «Limiti e silen-
zio», il «De Musica» già citato,oppure «Sitlnuovo vienne-
se». Insomma Bortolot-to, tra connessionimetalinguistiche ometamusicali, inclina-
zioni camp appena oc-culte e noie bisbetiche, an-
cora una volta ci diverte e affascina.
di P. GE.
●●●Leggo di seguito a Bortolotto, il nuovolibro di Paolo Terni, La melodia nascosta(Bompiani, pp. 264, € 12,00), in parteinedito, in parte recupero di «frammenti»già usciti, negli anni, da Sellerio: peresempio qui la prima sezione, Il temporubato. Bortolotto e Terni, nella loroantropologica distanza, convergono in dueaspetti: un’incombente passione per lamusica accolta senza barriere di generi, euno sguardo sornione di convolutoarbasiniano dandismo. Per il resto nonpotrebbero essere più diversi: chiuso l’uno eriservato nel suo universo musicologico, dadove emergono di tanto in tanto accenni distoria personale e perfide osservazioniextramoenia; aperto l’altro a un dilagatoautobiografismo, dove la musica è angelotutelare e viatico esistenziale. Terni hapercorso le stesse vie, frequentato forse glistessi caffè di Kavafis, di Forster, diLawrence Durrel, anche se il suo Quartettodi Alessandria, altrettanto folclorico emorbido, ha origini più domestiche,essendo, tra l’altro, nipote di quella FaustaCialente che se fosse nata in Francia ora i
suoi romanzi sarebbero tutti in commercionelle varie edizioni-poche, mentre in Italiagiacciono dimenticati nelle bilioteche,nonostante tentativi, anche miei, direcuperarli (Ballata Levantina, Cortile aCleopatra). Della zia ha, direi, la grazia e lafluidità narrativa, non la capacità inventiva.La sua narratività ha itinerari accidentati,quasi casuali, come definirei questiframmenti di autobiografia per musica, perriprendere un sostantivo etichettatoall’inizio: frammenti perché hanno untempo disordinato, come lo è quello dellamemoria; per musica e non musicale,perché i ricordi si collegano, si accendono,come le madeleines proustiane, a episodi dicui la musica è l’interprete orfica. Può esserel’acquisto di un disco, un ascolto carpito percaso dietro una porta, un’esecuzione magarianche primitiva ma che rivela un autore,che diventerà un amour fou, come Mahler,o Haendel, o Stravinskij. In realtà è pieno difolli amori questo libro, direi tutti i suoi libri,perché la passione è infrenabile, ha pulsioniadolescenziali, e si esalta passando daCouperin a Cage, da Rossini a Bartók; anchese saggiamente Terni della musica hasaputo ricavare una ragione di vita anchepratica, un uso polimorfo, come divulgatoreelegantissimo, insegnante, immagino,incantevole, e infine consulentedrammaturgico, capace di farla ascoltare, lasua musica, in contesti allotri, in insoliti,inusitati accostamenti; insomma, comeafferma l’autore, «una sorta dispettacolarizzazione dell’ascolto». Comespettacolare è il contesto, l’ambiente, da cuiprendono avvìo queste nugae così folgorantie insieme così investite di perspicaci rilievicritici, di felici intuizioni sulla musica e suimusicisti: quell’Alesssandria coloniale da cuiTerni pare non potere, non volere dipartirsi,luogo al contempo mitico ed edenico, comel’Atene dei fratelli De Chirico, ma piùcialtrona e fantasmagorica, immedicatotormento di un’epoca, doppiamenteperenta, da Faruk prima e dai ricordi che lasospendono, come vecchie foto cheingialliscono.
BORTOLOTTOSi apre col ricordo di Petrassi,
amico di una vita; chiudeStockhausen, «amore» giovanile.E poi Debussy, Ravel, Poulenc...
PAOLO TERNI
«Autobiografia»per musica:da Coupina Bartók, comeun ‘Quartettod’Alessandria’
BIOGRAFIE «QUATTRO VITE JAZZ» DI A.B. SPELLMAN
Cecil Taylor e Herbie Nichols,Ornette Coleman e Jackie McLean,le star dell’improvvisazione
«FOGLI MULTICOLORI»: UNA RACCOLTA DI ARTICOLI E SAGGI MUSICALI DA ADELPHI

(3)ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
La condizione umanasu spartito inglese
sono rarissime, Spellman, affrontando dipetto il problema delle condizioni di lavoronei club, dà la parola a Buell Neidlinger, alungo bassista di Taylor: «Tu saresti maipiombato su Stravinsky, mentrecomponeva, per dirgli: ’Basta, Igor! È ora divendere un po’ di drink!’? Perché non èmolto diverso. Non si può dire a Cecil chedeve smettere di suonare». Neidlinger nontira in ballo Stravinsky solo per dire chebisogna avere rispetto per l’arte: vuoleanche dire che la statura di Taylor è intutto paragonabile a quella di Stravinsky, eSpellman è chiaramente d’accordo. Laparte relativa a Taylor mette i piedi nelpiatto: il pianista argomenta il concetto diuna «tecnica» afroamericana (su cuiperaltro è personalmente inattaccabile) –vedi Thelonious Monk – che va giudicataiuxta propria principia; rivendica ilprofondo rapporto della sua arte con latradizione nera. E musicisti che hannolavorato con lui, spinti da Taylor aimparare a orecchio, nel solco di NewOrleans, gli spunti compositivi,testimoniano del «metodo» nonoccidentale di Taylor nel comporre estrutturare la musica. Oggi Taylor non èpiù rifiutato come così spesso allora: ilconservatorismo jazzistico è disposto aconcedergli una patente di eccezionalità,modo comodo e perfido per relegarlonell’irrilevanza. Spellman ci dice inveceche la poetica e il metodo di Taylor sono laquintessenza dell’estetica afroamericana,del jazz. In un mondo del jazz dei giorninostri dove vale tutto e il contrario di tutto,questo non è un dibattito di ieri: ècompletamente una questione per l’oggi,che ci interpella su cosa è il jazz e su qualisono i criteri di valore con cui guardarlo.
USCITA LA PRIMA MONOGRAFIA ITALIANA DEL COMPOSITORE
di GUIDO BARBIERI
●●●L’oro e il piombo. Il british idyllche accarezza l’Inghilterra felix al tra-monto dell’epoca vittoriana e la nuvola-glia ferrosa che si addensa sui cieli diLondra negli anni della Grande Guerra.Il grande inganno perpetrato dalla paxbritannica di Edoardo VII (sinistramen-te soprannominato the peace maker) ela cruda realpolitik della Triplice Intesache fa sprofondare il Regno Unito nelprimo conflitto intra moenia dall’iniziodella sua apoteosi coloniale. È una na-zione che cammina pericolosamentesull’orlo di un abisso (pur senza abban-donarsi ai fasti viennesi della danza…)quella che accoglie, il 22 novembre1913, la nascita di Benjamin Britten,uno dei suoi figli non a caso più lacera-ti, dimidiati, contraddetti e contraddit-tori. Una fatherland crudele che tra-smette il proprio codice genetico allapiù mite e candida delle sue creature,obbligandola a ricapitolare nella suaontogenesi individuale la propria stori-ca, e non certo innocente, filogenesicollettiva.
È una suggestione originale e abba-gliante, una tra le molte che accendo-no uno studio decisamente atipico nelpaesaggio brullo della musicografia na-
zionale. Si tratta, anche se si stenta acrederlo, della prima monografia italia-na dedicata a Britten, vale a dire, népiù, né meno, il maggior compositoreinglese del Novecento. L’ha composta(scritta sarebbe riduttivo), in anni dipassione e di ricerca, Alessandro Mac-chia, uno dei musicologi italiani più ori-ginali e inventivi del tempo presente,già autore nel 2006 di uno studio senzaprecedenti (né conseguenti) sugli epice-di musicali del Novecento e non a casoestraneo all’universo chiuso della acca-demia universitaria (forse occorrereb-be chiedersi perché…). E c’è da temereche se non fosse stato per il primo seco-lo di vita compiuto proprio quest’annodal festeggiato, questo libro, BenjaminBritten (L’Epos, pp. 468 € 48, 30) sareb-be rimasto ancora per chissà quantotempo nel cassetto dei desideri.
Ciò che distingue questa monografiadalle altre che affollano, ad esempio, ilprezioso catalogo dell’editore palermi-tano sono innanzitutto il metodo d’in-dagine e la tecnica di esposizione. Mac-chia non si limita certo a intrecciare inastri paralleli della vita e delle opere,né a compilare un diligente schedarioanalitico dedicando il «giusto» spazio aogni singolo titolo . Il procedimento ar-gomentativo è basato, piuttosto, sulla
attrazione quasi spontanea che mate-riali spesso eterocliti, tratti dalla storiadelle letteratura, dalla storia economi-ca, dalla filosofia, dalla storia delle idee,generano tra loro. Un esempio rivelato-re è dato proprio dal capitolo introdutti-vo che si apre, per l’appunto, nel segnodell’oro e si chiude in quello del piom-bo. Per fotografare con precisione l’epo-ca ponte che va dalla traumatica scom-parsa della regina Vittoria (1901) alla di-scesa in guerra a fianco della Francia edella Russia, Macchia ricorre alla allego-ria rappresentata dal più amato sportnazionale inglese: il cricket.
«Nel Regno Unito – questo l’incipitsorprendente del libro – il ventennioche precorre la Grande Guerra è detto«The Golden Age of Cricket». Il candido(e per i continentali incomprensibile)sport britannico viene assunto come lametafora più limpida e trasparente del-le contraddizioni in cui si dibatte la bignation: da un lato la bellezza inconta-minata e innocente (parola chiave, co-me vedremo nel lessico britteniano)dei campi da gioco, il leggendario fairplay dei competitors preservati da ognivolgare contatto fisico, i tea break cheinterrompono gli smisurati inning sen-za tempo, dall’altro la natura spietata-mente classista della competizione, la
sua inevitabile identificazione con la fe-rocia delle conquiste coloniali, la falsi-tà, insomma, celata dietro l’idillio cam-pestre. E al di sopra di ogni contraddi-zione l’ideologia cara alle classi domi-nanti di ogni latitudine, che identificabrutalmente lo spirito sportivo con lospirito della guerra e che pretende diidentificare nell’apparato muscolaredel buon atleta la macchina bellica delbuon soldato.
È con questo mix esplosivo nella bi-saccia che l’esercito inglese entra inguerra. Una guerra alla quale molti in-tellettuali, scrittori, filosofi, musicistipagano il loro tributo: Butterworth, Kel-ly, Coles, Browne, Gurney, Farrar sonosolo alcuni dei nomi di compositori og-gi dimenticati che appaiono sulle lapi-di dei caduti della Big War. E secondoMacchia è proprio la reazione controla macelleria insensata della guerra agenerare nei compositori sopravvissutiai campi di battaglia, e nei loro «figli»nati nel nuovo secolo, non solo unamole impressionante di musica fune-bre e commemorativa, ma anche una
profonda, sofferta, attitudine antimilita-rista che non ha eguali in nessun’altranazione europea. Fu proprio uno deigrandi disillusi del secolo, Frank Brid-ge, del resto, a piantare il seme del paci-fismo nella mente del giovanissimoBenjamin, suo discepolo prediletto.Una disposizione d’animo, di pensieroe di carattere che avrebbe abitato persempre nei gesti pubblici e privati del-l’autore del War Requiem. Fino a diven-tare, ben oltre i suoi contenuti politiciimmediati, una forma costante di rea-zione contro le degenerazioni più spa-ventose che minano alla radice l’esi-stenza della human community: l’ag-gressione dell’uomo contro l’uomo, laviolazione dell’innocenza, la brutalitànei confronti degli indifesi: i bambini,le donne, i diseredati.
Il motivo dell’idillio perduto, della in-nocenza minacciata, il passaggio in-somma dall’età dell’oro a quella delpiombo, è senz’altro uno dei nervi sco-perti del pensiero di Britten. Colin Mat-thews ricorda di aver visto con i propriocchi la reazione del compositore difronte a un articolo in cui si sostenevache tutte le sue opere fossero attraver-sate dal tema della corruption of inno-cence: «Spazzatura, solo spazzatura»avrebbe urlato Britten facendo a pezziil giornale. Una reazione così violenta –commenta lo stesso Matthews – che fanascere un sospetto: e cioè che la paro-la innocenza avesse smosso qualche co-sa nel suo pensiero che possedesse perlui un valore forte, profondo, forse in-sondabile… Sarebbe insensato, ovvia-mente, leggere le opere drammatichedi Britten attraverso questa lente par-ziale e deformante. E bisogna resisterealla tentazione di farlo anche di frontealle numerose epifanie narrative chesembrano dare ragione ai sospetti diMatthews. Come interpretare, ad esem-pio, in The Rape of Lucretia, il sacrificioverso il quale cammina inesorabilmen-te l’innocente matrona romana violatae stuprata dal desiderio selvaggio diTarquinius? E quel verso, magnifico, diRonald Duncan cantato dal coro fem-minile: «Il tempo conduce gli uomini,ma cammina sui piedi stanchi delledonne»? Oppure la morte apparente-mente inspiegabile del piccolo Miles, ilprotagonista di The turn of the Screw,soggiogato dal potere maligno dei fan-tasmi? E l’altro verso chiave, «rubato» aYeats, che Britten fa intonare alla Istitu-trice e che sembra un «manifesto» sintroppo esplicito: «The ceremony of in-nocence is drawned»? O ancora i testipoetici di Wilfred Owen, poeta soldato,stroncato in battaglia a venticinque an-ni d’età, epitome della innocenza ol-traggiata, che costituiscono il troncopoetico del War Requiem?
A molte di queste domande lo studiodi Macchia fornisce una risposta com-plessa, acuta, mai prevedibile, mai paci-ficata. Il suo libro è sostanzialmente uninvito a cercare senza sosta le relazioniprofonde che intercorrono tra la cortec-cia esterna della scrittura musicale diBritten (analizzata con strumenti anali-tici affilatissimi) e il mallo, a volte duro,a volte tenero, che la noce racchiude.
E molto spesso l’operazione stratigra-fica, condotta con l’ausilio di una prosadi sontuosa precisione lessicale, rivelasorprese abbaglianti: si scopre ad esem-pio che la ratio di Lucretia non è costi-tuita dal tema della «innocenza reden-trice», bensì dal nodo etico che avvilup-pa la dimensione della libertà con quel-la della virtù e che sfocia nella sgomen-ta ammissione di un nichilismo privodi alcuna forma di redenzione. Oppureche il misterioso verso dell’istitutrice inGiro di vite prende luce soltanto se lo siconnette al dualismo ontologico di Yea-ts, che concepisce l’esistenza comeuna continua interazione, e negazione,tra gli opposti. E in cui la posta in gioconon è affatto, o non solo, la dimensio-ne dell’innocenza, bensì, tout court, ilpassaggio tormentato e doloroso dal-l’età infantile a quella adulta. Insommain queste pagine rivelatrici l’oro dell’in-telligenza critica trionfa a ogni riga sulpiombo fuso delle apparenze e dei luo-ghi comuni.
BRITTENGERENZA
In copertina di «Alias-D»:Luís Noronha Da Costa,«Sem título», 1972;in piccolo, lo scrittoreAntonio Lobo Antunes
A cent’annidalla nascitadi Benjamin Britten,Alessandro Macchiainvita a cercarele relazioni profondefra la cortecciadella scritturamusicalee i suoi contenutimeno scontati
Benjamin Britten (a sinistra)con Peter Pears, compagnodi vita e partner musicale.Nella pagina a fianco,Arman, «Cello», 1990, collez.Agrati; sotto: Cecil Taylorcon Hans Bennink,Hilversum, 1967
Il manifestodirettore responsabile:Norma Rangeri
redazione:via A. Bargoni, 800153 - RomaInfo:tel. 06687195490668719545email:[email protected]:http://www.ilmanifesto.it
impaginazione:il manifestoricerca iconografica:il manifesto
concessionaria di pubblicitá:Poster Pubblicità s.r.l.sede legale:via A. Bargoni, 8tel. 0668896911fax 0658179764e-mail:[email protected] Milanoviale Gran Sasso 220131 Milanotel. 02 4953339.2.3.4fax 02 49533395tariffe in euro delleinserzioni pubblicitarie:Pagina30.450,00 (320 x 455)Mezza pagina16.800,00 (319 x 198)Colonna11.085,00 (104 x 452)Piede di pagina7.058,00 (320 x 85)Quadrotto2.578,00 (104 x 85)posizioni speciali:Finestra prima pagina4.100,00 (65 x 88)IV copertina46.437,00 (320 x 455)
stampa:LITOSUD Srlvia Carlo Pesenti 130,RomaLITOSUD Srlvia Aldo Moro 4 20060Pessano con Bornago (Mi)
diffusione e contabilità,rivendite e abbonamenti:REDS Rete Europeadistribuzione e servizi:viale BastioniMichelangelo 5/a00192 Romatel. 0639745482Fax. 0639762130
Nella ontogenesiprivata di Brittenla storica, e di certonon innocente,filogenesidi una nazione

(4) ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
di MASSIMO RAFFAELI
●●●Fra i troppi libri pubblicati in Italia,quelli sul cibo e sul calcio si segnalano peruna loro fastidiosa ridondanza. Dunque fadue volte eccezione, a firma di John Irving,Pane e football Due nazioni, due passioni(Slow Food Editore, pp. 222, € 14,50) che conl’aria di trattare solamente di cibo e di calcioscrive tanto la sua autobiografia sentimentalequanto un vero e proprio trattatello diantropologia. Poco meno che sessantenne,da trentacinque anni in Italia, già redattoredi «Slow Food» e collaboratore di importantitestate (fra cui The Guardian), Irving è unnome ben noto ai lettori del manifestoavendo redatto, nella pagina sportiva, unarubrica dal titolo decisamente anfibologico,Slow Foot, a quattro mani con GiovanniRuffa, dedicatario del volume stesso.Ambientati a Bra (la tana elettiva il cui nomerinvia alla costellazione di Giovanni Arpino eVelso Mucci, al gioco del pallone elastico,all’hockey e ai più vetusti fuoriclasse dellaenologia), quei dialoghi contaminavano leOperette morali con Le interviste impossibili(dove il pretesto era lo sport, il calciospecialmente) ma intanto ribaltavano il
cliché che continua a opporre l’italianoall’inglese: John è in effetti un passionale, si èlaureato su Paolo Volponi e tifadisperatamente per la Juventus; Giovanniviceversa è l’uomo dell’ironia sottile, hainteressi prevalentemente storico-politici e ilsuo tifo, sia pure dai dubbi trascorsi, èconsacrato al Torino. In Pane e football ècome se Irving avesse introiettato lo sguardodel suo interlocutore e l’avesse proiettatonello spazio e nel tempo. Cibo e calcio, certo,ma anche «qui» e «altrove» o «prima» e«dopo», vale a dire l’Inghilterradell’infanzia-adolescenza e l’Italia dellagiovinezza come poi della maturità. Quasifossero i tempi di una partita di calcio o diun incontro a tavola, il testo si divide
esattamente in due. Baricentro della primaparte è la cittadina dove Irving è nato neipieni anni cinquanta, Carlisle, nella Cumbria,il Nord Ovest britannico che congiunge, daest a ovest, Glasgow e Newcastle. Qui,componendo le tessere di un romanzo diformazione, Irving colloca alcune figure escene iniziatiche, a partire da suo padreGeorge. Si immagini allora unpiccolo-borghese, la sua vicendaquarantennale di contabile, la casetta nellaprima cintura suburbana, sua moglie e i suoitre figli, si immagini un uomo laconico eprobo che abbia comunque alle spallecinque anni di guerra mondiale nell’esercitodi Sua Maestà avendo toccato ogni spondadel Mediterraneo (Italia compresa), si
Disfatta sentimentaledi una donna in cercadi protezione maschiledi SILVIA ALBERTAZZI
●●●Primo romanzo di Jean Rhys,scrittrice dominicana nota soprattut-to per Il grande mare dei Sargassi, ilprequel di Jane Eyre, Jean Rhys, Quar-tetto (Adelphi, traduzione di FrancaCavagnoli, pp. 172, €16, 00) vennepubblicato dalla autrice nel 1966,quando era in una età ormai avanza-ta, e divenne subito un testo chiavetanto per gli studi di genere quantoper quelli postcoloniali. Difficile tro-vare premonizioni del tardo capola-voro in questa opera giovanile, che ri-chiama piuttosto il modernismo tut-to al femminile di Katherine Man-sfield – soprattutto le deprimenti at-mosfere e le sventurate protagonistedi certi racconti dell’autrice neoze-landese ambientati nelle capitali eu-ropee. Del resto, Quartetto, prima diuna serie di narrazioni al cui centrostanno figure femminili alla deriva,concepite dalla Rhys nel decenniotra la fine degli anni venti e il 1939,ha finora incuriosito critici e lettorisoprattutto per gli scabrosi elementiautobiografici che ne costituisconola trama: vi si raccontano, infatti, gliavvenimenti di un anno piuttosto tur-bolento per la scrittrice, quel 1923 incui, rimasta sola e senza mezzi di so-stentamento a Parigi dopo l’arrestodel marito, Jean Lenglet, accettandol’ospitalità dello scrittore Ford Ma-dox Ford e della di lui compagna, lapittrice australiana Stella Bowen, sitrovò invischiata in un ambiguo mé-nage à trois, destinato a divenire unvero e proprio «quartetto» erotico,dopo la scarcerazione di Lenglet.Non è certo un caso che la storia diquesto quadrilatero amoroso sia sta-ta narrata, con diversi accenti, da tut-ti e quattro i protagonisti: eppure,mentre le opere autobiografiche diBowen e Lenglet sono pressoché di-menticate e il resoconto di Ford,When the Wicked Man, è relegato trai lavori minori dell’autore inglese,Quartetto, che è stato anche portatosullo schermo da James Ivory nel1981, resiste sugli scaffali delle libre-rie in Inghilterra e continua a esseretradotto all’estero.
Molto più degli elementi biograficipruriginosi presenti nella vicenda, eal di là del parallelo con la storia im-maginata in precedenza da Ford inquello che è ritenuto uno dei maggio-
ri romanzi del Novecento, Il buon sol-dato (confronto più volte propostoper dimostrare come lo scrittore siaarrivato a far combaciare vita e arte,sperimentando nella realtà situazio-ni che aveva già immaginato nellafinzione) quel che attrae nel primoromanzo di Jean Rhys è l’amara rap-presentazione della disfatta senti-mentale e umana subìta da una don-na passiva, in balìa della sorte e allaperpetua ricerca di protezione ma-schile. Melodia volta a svelare il gio-co delle apparenze su cui si fonda lavita sociale, il Quartetto di Rhys enfa-tizza il fatto che ogni posizione reale
nasconde un atteggiamento fittizio,ogni individuo si cela dietro una ma-schera. Così Marya Zelli, la protagoni-sta femminile, e Lois Heidler (l’alterego narrativo di Stella Bowen), puressendo entrambe soggette al dispo-tismo di Heidler (il Ford del roman-zo) reagiscono alla propria condizio-ne subordinata calandosi in ruoli af-fatto diversi. Se Marya gioca alla«bambina sperduta» – priva di indi-pendenza economica, sola, bisogno-sa di protezione – Lois si fa dapprima«padrona» fredda e autoritaria, salvopoi svelarsi complice del maschio do-minatore nel tranello ordito per in-trappolare la giovane preda. E tutta-via, entrambe le donne appaiono,pur se in maniera differente, vittimedella tirannia maschile, impegnate adilaniarsi in un jeu de massacre, pri-gioniere incapaci di unirsi nella lottacontro il comune carceriere.
Non a caso, il primo titolo sceltonel 1928 e poi respinto dalla autrice,era Posizioni: il racconto è condottoper larga parte come una partita ascacchi tra un Gran Maestro (Heidler/Ford) e una principiante maldestra(Marya). Grande attenzione è dedica-ta, di conseguenza, ai movimenti deipersonaggi, al continuo avanzarsi eritrarsi della coppia Heidler, alle mos-se goffe di Marya, al ritmo inquietan-te di una esistenza che pare la resanarrativa di un finale di partita in cuire e regina neri si trovano in posizio-ne vantaggiosa. E se negli stessi annie negli stessi luoghi, per gli espatriatisenza fede di Hemingway il codice dicomportamento onorevole era circo-scritto dalle ferree leggi della tauro-machia, tra gli esuli sradicati di Rhysil mantenimento dell’onore può limi-tarsi all’ottemperanza rigorosa dellemosse concesse al giocatore sullascacchiera.
Si tratta, dunque, di saper calcola-re le posizioni degli avversari, piutto-sto che di analizzarne le motivazioni.A Marya, che ora agisce di istinto,ora si perde in sterili riflessioni, la-mentando una vita deprimente e di-sperata, si oppone il cinico realismodi Heidler, «impenetrabile e vigile co-me un giocatore di scacchi che ha ap-pena fatto una buona mossa»; al sofi-sticato intrigo delle posizioni prefis-sate sulla scacchiera, l’assoluta muta-
bilità della vie de bohème. Dallo scon-tro di queste realtà antitetiche nonpuò che emergere l’impossibilità, daparte della più sprovveduta, Marya,di comprendere le regole del giocoche tutti sembrano conoscere e cheanche Stephen, suo marito, una vol-ta uscito dal carcere, capisce perfetta-mente, pur non accettandole.
È interessante notare come, impo-nendo il titolo Quartetto a partire dal-l’edizione americana del 1929, Rhysconferisca dignità pari a quella deglialtri tre protagonisti alla evanescentefigura di Stephen, che appare com-piutamente in scena solo verso laconclusione del romanzo e finisceper reagire con la fuga alla desolazio-ne in cui si trova coinvolto. Sottoline-ando in questo modo la responsabili-tà di tutti e quattro i personaggi nellavicenda, la loro partecipazione in ve-ste di comprimari alla tessitura dellatrama, la scrittrice evita l’omologazio-ne del suo romanzo con l’ennesimavariazione sul tema banale del trian-golo erotico.
La scelta del termine «quartetto» ri-manda anche volutamente al mon-do musicale, a suggerire che la narra-zione si costruisce come una partitu-ra eseguita da quattro diversi stru-menti, non sempre in armonia, anzi,spesso dissonanti: per Marya, Lois è«uno strumento concepito, forgiatoe affilato per un unico scopo» e Heid-ler, «lo stesso accordo ma suonato inchiave più bassa». A sua volta, Mar-ya, che sembra non avere coscienzadella propria individualità, si lascia«suonare» dagli uomini che la circon-dano, cercando la propria identità inun rapporto di soggezione all’univer-so maschile. Dominata da un orroreesistenziale con il quale è impossibi-le scendere a patti – «Con la fame, ilfreddo o la solitudine potevi ragiona-re, ma con quella paura no» – Maryasperimenta una discesa assurda ver-so la perdita dell’Io e la progressivadisintegrazione della sua personalitàgià frammentata. Per lei la vita è unsogno spezzato e illogico: una visio-ne riflessa in uno specchio rotto, in-completa e frantumata. Una visioneche Rhys rende soprattutto attraver-so un attento uso delle parole, soppe-sate a una a una in vista di un effettototale, volto non tanto alla progres-sione e alla soluzione dell’intreccio(di per sé alquanto esiguo), quanto al-l’accumulo di risposte emotive – deipersonaggi (soprattutto della prota-gonista), dell’autrice (celata dietrouna narrazione falsamente onni-sciente) e di chi, leggendo, si trova asprofondare in un mondo in cui l’in-dividuo sembra aver perso – o nonaver mai posseduto – la capacità dicontrollare il proprio destino. Operaaperta, ma aperta sul nulla; narrazio-ne di fronte alla quale è impossibilefarsi complici sia dell’autore sia dellaprotagonista, Quartetto ci conducelungo una china dolorosamente pre-vedibile fin dalla prima pagina, de-nunciando l’assurda tragicità dell’esi-stenza umana in un universo vuoto,sconvolto e lacerato. Franca Cava-gnoli riesce mirabilmente a tradurrequesto linguaggio in cui ogni parolaè calibrata come un passo nella disce-sa della protagonista verso l’abisso o,se si preferisce, come una nota nellacupa musica suonata dal quartetto, eci consegna intatta la prima di quellestorie senza gloria, oltre la morale co-mune, che imposero Jean Rhys all’at-tenzione del pubblico modernista, edalla cui lettura non si può che usci-re lacerati e sconfitti.
JOHN IRVING CIBO E CALCIO
Dalla Cumbriaa Torino (Juve),la mia vitain due tempi
L’infanzia a Carlisle, con i sabaticonsacrati al dio football, quindi lo sbarcoin Italia nel ’77... Questa autobiografia«a tavola» è anche un match antropologico
Jean Rhys, dal sito web Modernista; sotto, Pietro AnastasiRHYS
Scritto da Jean Rhystra fine anni ventie anni quaranta,«Quartetto»ricostruiscela fin tropposcabrosa biografiadell’autrice
L’ESORDIO DELLA SCRITTRICE DOMINICANA PUBBLICATO NEL ’66

(5)ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
MOEHRINGER
La crisi dalla partedi un rapinatore
di TOMMASO PINCIO
●●●Che la critica statunitense ab-bia letto l’ultimo libro di J. R. Moe-hringer scegliendo quale stella pola-re il tracollo finanziario del 2008 èpiù che ragionevole. Argomento diPieno giorno (Piemme, trad. Giovan-ni Zucca, pp. 469, € 19,50) è infatti lavita di Willie Sutton, nemico di un si-stema da sempre inviso a una discre-ta fetta della nazione. La sua aura daeroe popolare ci viene sbandieratasin dalle primissime pagine, con pa-role che definire benevole è un eufe-mismo: «Più romantico di Bonnie eClyde, Sutton vedeva le rapine inbanca come una vera arte e ci si dedi-
cava con uno zelo e una concentra-zione degni di un artista... Era un cre-ativo, un innovatore, e aveva dimo-strato di avere, come i più grandi arti-sti, un tenace istinto di sopravviven-za... Era come Henry Ford reinterpre-tato da John Dillinger, con tratti diHoudini, Picasso e Rasputin».
Lo stesso Moehringer ha inoltrepiù volte dichiarato che a ispirarlofurono proprio i rovinosi eventi del2008. A suo dire, all’epoca carezzavaun progetto di tutt’altro genere: de-dicarsi alla vita di un allenatore di fo-otball (dunque ancora uno sportivo,dopo la fortunata esperienza comeghostwriter di Agassi). Il terremotofinanziario gli ricordò però quanto
odiasse i banchieri, per lui «architet-ti dell’apocalisse». Giunse alla con-clusione che calarsi nei panni di unrapinatore di banche sarebbe statoil modo più salutare di elaborare lasua rabbia per l’ennesima e non ac-cidentale depressione economica.La scelta cadde appunto su WillieSutton, più confidenzialmente chia-mato Willie l’attore per la sua pro-pensione a travestirsi prima di ese-guire una rapina.
In decenni di «onorata» carriera,mise assieme una discreta fortunasenza sparare un colpo. Che nessu-no si fosse mai «fatto male» costitui-va un motivo di vanto per Sutton,ma non risponde del tutto al vero.Nel 1952 un ragazzo ventiquattrennecon l’hobby dell’investigazione lo ri-conobbe in metropolitana, lo seguì econtribuì alla sua cattura. Poco tem-po dopo fu ucciso. A sparare, sem-bra, fu la mafia, ma su Sutton pesatuttavia il sospetto di aver sollecitatol’esecuzione. Nelle tante e patrie gale-re che l’ospitarono, tra cui la famige-rata Sing Sing, trascorse all’incircametà della vita. Evase tre volte e trevolte fu ripreso. Sarebbe dovuto re-stare dentro sino alla fine dei suoigiorni, ma nel 1969 la Corte Supremane decise la scarcerazione per motividi salute. Sutton era messo parec-chio male a quel punto. Ormai quasisettantenne si ritrovava con un enfi-sema e le arterie delle gambe da ope-rare. Sopravvisse un altro decennio,nel corso del quale, fra le altre cose,prestò il volto per la campagna pub-blicitaria di una carta di credito e fe-ce da consulente per alcune banche,alle quali spiegò anche come proteg-gersi da gente come lui.
Fu anche letterato, a suo modo. Ilungi soggiorni carcerari gli consenti-rono di leggere molto e bene. Dante,Shakespeare, Tennyson e persinoFreud. Scrisse anche, e pubblicò duelibri. Il primo risale agli anni 50 e èun memoir in forma di intervista ilcui titolo suona più o meno così: Io,Willie Sutton. La vicenda personaledel più scaltro fra i rapinatori di ban-che moderni, nel racconto fatto aQuentin Reynolds. Il secondo lo scris-se invece di suo pugno in vecchiaia,giovandosi in parte dell’aiuto di unghostwriter (dettaglio che Moehrin-ger deve aver certamente soppesa-to). In questo caso il titolo, Where themoney was, è ancor più significativo.Proviene infatti dalla leggendaria ri-sposta data a un giornalista che glichiese per quale ragione rapinavabanche. Talmente leggendaria da di-ventare legge, perlomeno tra i medi-ci americani, che oggi chiamano «leg-ge di Sutton» il corretto procedimen-to da seguire in una diagnosi: in pri-mo luogo, prendere in considerazio-ne l’ovvio.
Ma come spesso capita con i miti,la risposta, oltre che ovvia, è apocri-fa. Fu lo stesso Sutton a negare diaverla mai data. Per giunta, a sentirlui, anche la domanda lo sarebbe.Non gli fu mai posta, rivela nell’auto-biografia. Concede però che, qualoraglielo avessero chiesto, avrebbe pro-babilmente risposto così, perché èquel che direbbe chiunque. La cosapiù ovvia.
Perché rapinavo banche? Perché èdove ci sono sono i soldi. O forse no.Sutton ci ripensa all’istante, per forni-re una ragione più sottile: «Perchémi piaceva. Amavo farlo. Nulla mi hamai fatto sentire più vivo dell’entrarein una banca per rapinarla. Mi piace-va a tal punto che in capo a una setti-
mana o due ero già lì che cercavo ilprossimo obiettivo. Il denaro rappre-sentava lo stuzzichino, nient’altro».Dobbiamo credergli? Secondo Moe-hringer, no.
Moehringer è un narratore e sa be-ne come tanto l’ovvio quanto il puropiacere siano motivazioni troppo de-boli per reggere un racconto. Fatal-mente, anche il suo Sutton nega diavere mai dato la risposta diventataleggenda, e lo nega proprio parlandocon un giornalista, un giovanottonon granché esperto, il quale, guar-da caso, ha il cattivo gusto di vestireabiti da banchiere. In alternativa alpuro gusto della rapina, il Sutton diMoehringer ci propone però una ra-gione più forte, quella del cuore. Èper via di un perduto amore di gio-ventù se il Sutton di Moehringer nonha fatto che rapinare banche; più pre-cisamente un amore contrastato dalfacoltoso padre di lei. Su un pianostrettamente narrativo, la motivazio-ne non fa una piega. Un poco sconta-ta forse, ma non ovvia. Resta però laverità storica e qui Moehringer siprende varie licenze, perché la ragaz-za in questione non sembra avere oc-cupato un posto tanto importantenel cuore del vero Sutton.
Pieno giorno è tuttavia un roman-zo, non una biografia. Non lo è perl’elusività del soggetto. Resosi contoche Sutton era un imbroglione, chesi travestiva non soltanto quando ra-pinava banche ma ogni qualvoltaparlasse di sé, dando versioni im-mancabilmente diverse e contraddit-torie, Moehringer ha preferito la stra-da del romanzo, seppure dalle carat-teristiche particolari. Perché se da unlato la vita di Sutton viene romanza-ta per dargli un senso, ovvero sfron-data delle versioni più o meno apo-crife affinché diventi storia, dall’altrola circostanza in cui il racconto si ma-nifesta è vera.
Sappiamo per certo che nel giornodella definitiva scarcerazione, avve-nuta alla vigilia di Natale del 1969,Sutton era atteso da una folla di gior-nalisti. Tutti volevano intervistarlo,ma soltanto uno poté. Il privilegiato(nel romanzo, il giovane imberbe ag-ghindato da banchiere) sequestròSutton per un giorno intero, portan-dolo a spasso per New York, per i luo-ghi del suo passato. Da questo amar-cord forzato scaturì un articolo «stra-namente superficiale, infarcito di er-rori o di menzogne, e carente di vererivelazioni», perlomeno stando al giu-dizio dato da Moehringer nella notaintroduttiva di Pieno giorno. Un giu-dizio non propriamente terzo, per-ché quel che davvero accade in quellontano Natale tra Sutton e il giornali-sta è di fatto la storia raccontata nelromanzo.
C’è poi un altro e più significativoelemento che mina l’imparzialità delgiudizio. Anche Moehringer si è tro-vato in una situazione analoga. An-che Moehringer ha avuto la possibili-tà di ascoltare le confessioni di uneroe popolare, il tennista Agassi. Di-versamente dal giovane giornalistadi Pieno giorno, ne ha però ricavatoun racconto straordinario. Si ha dun-que la sensazione che in questo suonuovo libro Moehringer voglia rac-contarci, seppure trasfigurati in uncontesto diverso, i retroscena del pre-cedente, la cornice in cui è natoOpen, quasi che il suo intento profon-do fosse dare visibilità a cosa signifi-ca fare lo scrittore fantasma, mo-strandoci che il senso di una vita nonemerge tanto dalle parole di chi l’havissuta, quanto da chi è capace diidentificarcisi al punto di ricavarneun racconto. Due libri complementa-ri dunque. Ma se in Open non c’erache la storia di Agassi, con il suo ba-gliore toccante, qui tutto appare unpoco sfumato, come rischiarato dauna luce incerta, simile a quella cheprecede l’alba e segue una notte chesi è trascorsa insonni, a ricordare. Eforse il modo più soddisfacente perleggere Pieno giorno è proprio quellodi pensare a Sutton non come a unleggendario rapinatore di banche(del quale non ci importa poi molto),ma semplicemente come al protago-nista di una storia in cerca d’ascolto.
immagini infine quest’uomo come esempiodi una vita ordinata, ripetitiva, sommamenteprevedibile: ebbene, costui è il medesimoindividuo che in ogni week end si trasformaper il figlio in una guida iniziatica e, anzi, inun maestro dagli estri imprevedibili. David èinsomma il Virgilio calcistico di John (ognivolta lo accompagna a piedi alla partita) eper entrambi il sabato è football e nient’altro,laddove non importa se la squadra di casa, ilCarlisle United F.C., flotti regolarmente tra laseconda e la quarta divisione comenemmeno importa se lo stadio sia losquallido impianto di Brunton Park, personella brughiera suburbana. L’essenziale è lapreparazione di quel piccolo evento, lecabale superstiziose e i domestici riti diavvicinamento, la traversata a piedi delquartiere, l’incontro con una umanità oggidefunta ma rimasta leggendaria nel ricordo.A parte, come fossero il preludio a unapartenza che sarà definitiva, alcune trasfertememorabili, ad esempio a Glasgow pervedere il Celtic di Jock Stein e dei «Leoni diLisbona» che trionfarono sulla Grande Inter,oppure a White Hart Lane, il campolondinese del Tottenham, o da ultimo nelpiccolo stadio della zona portuale di
Edimburgo (la città universitaria di Irving)per un Hibernian-Juve finito 2 a 4 condoppietta di José Altafini. Ma quel calcioessenziale, ancora primordiale, chiama lamemoria del cibo con la intermittenza di unamadeleine la quale evochi a piacere zuppe dilegumi, torte di risulta, pie di ogni tipo,arrosti e sformati: ma solo per chi ha valicatola linea d’ombra c’è tutta la birra di cuiCarlisle fu peraltro capitale produttiva,chiusa in un reticolo di mescite e pub chel’autore censisce con lo scrupolo di unostorico della cultura materiale rendendoomaggio agli scrittori e ai cineasti che, fra glianni cinquanta e settanta, sepperoraccontare l’Inghilterra proletaria e socialista,da John Osborne al grande Alan Sillitoe e aun allora giovanissimo Ken Loach. A dispettodi ogni stereotipo, la Torino del ’77 cuiapproda Irving, plumbea e segnata dallaguerra civile, sembra per certi versi unaprosecuzione della Cumbria nativa, in unclima di tenebra che egli avrebbe prestoritrovato nel libro più intenso, e più bello, diCarlo Fruttero e Franco Lucentini, A chepunto è la notte, che di quella Torino è infattilo specchio ustorio. Qui, se non può piùgodere di un Virgilio paterno, si imbatte nelle
presenze non meno soccorrevoli di vecchipensionati, di meridionali disoccupati e distudenti fuoricorso: «Arrivai a Torino sottol’abbagliante sole di luglio ma avvertivofortemente l’atmosfera cupa e minacciosa.(…) Dipendeva dai soldi. Quandomancavano ci si arrangiava. Ricordo unweek end in cui, per mancanza di fondi, coni miei coinquilini nel nostro squallidoappartamento di corso Sebastopoli,sopravvivemmo mangiando solo riso e lardo.(…) Nei primi anni torinesi vissi sempre neipressi del vecchio Stadio Comunale, semprenel raggio di 500 metri. Tre case diverse inun processo di avvicinamento a quello che,per me, era un vero e proprio santuario».Quello del vecchio Comunale, nel quartieredi Santa Rita, rappresenta il baricentroantipode e complementare al vetustoBrunton Park di Carlisle. Anche in questocaso, è il punto di partenza di una dupliceesplorazione perché, da un lato, lì gioca laJuventus (una squadra pensata di termini diAufsuedung, «meridionalizzazione», disseallora un teorico della Scuola di Francoforte,cioè la squadra di Gentile e Causio, diFurino, Cuccureddu e Anastasi) ma,dall’altro, vi si dirama una topografia di
«tampe» e di «piole» nonché di trattorie doveè possibile appurare le inaudite risorse diuna cucina volta a volta diversa per quantesono le regioni italiane. Ovvio che, a Torino,Irving nei suoi peripli urbani fra calcio, ciboe vino finisca con l’imbattersi nelle opere diMario Soldati e Gianni Brera, cui dedicaalcune tra le pagine più nette di Pane efootball, un libro, e qui sia detto soltanto perinciso, scritto con un ritmo, una felicitàinventiva e una vivacità linguistica chedovrebbe imbarazzare più d’uno fra i nostrinativi. Quanto a Brera, viene riprodotto ilsuo menù per il pranzo di Natale 1945, unmenù postbellico e insomma riparatorio,autografato come Mansarde des Frères Bréra,Rue Catalani 43 - Milan: «Antipasto misto;ravioli asciutti e in brodo; bollito di manzomisto; arrosto di vitello; arrosto di pollo;dolci ‘misticamente assortiti’; frutta secca efresca; caffè-caffè. Contorni: insalatina,finocchi e carote al burro. Vini: Chianti;Brachetto 1938; Oltrepò; Cognac. Sigarette:Nazionali e estere». Chi abbia avuto laventura di sedere a tavola con John Irving sache non ce la farebbe mai, però immaginache quella è una piccola, laica, versione delparadiso anche per lui.
TRA FINZIONE E REALTÀ, L’ULTIMA PROVA DEL GHOSTWRITER DI AGASSI
Fu l’odio per i banchieri,«architetti dell’apocalisse»,a ispirare l’identificazionedi J. R. Moehringer con il celebreWillie Sutton, una sorta di eroepopolare che usava mascherarsiprima di assaltare una banca
Una foto di Ray K. Metzkerda «City Stills», Prestel, 1999

(6) ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
di VALENTINA PARISI
●●●Sullo sfondo della casualità imper-scrutabile che governa spesso le scelteeditoriali risulta tanto più significativa lalinearità con cui Voland ha fatto seguire– nella genealogia degli scrittori polacchiospitati dalla collana «slava» Sirin – il no-me di Jacek Dukaj a quello assai più no-to di Stanislaw Lem, di cui aveva pubbli-cato nel 2010 le recensioni di libri inesi-stenti raccolte in Vuoto assoluto. Malgra-do le incomprensibili proteste dissemi-nate qua e là sulla stampa polacca neiconfronti di chi aveva definito lo scritto-re nato a Tarnow nel 1974 l’erede dell’au-tore di Solaris (quasi che un simile giudi-zio potesse suonare come una diminui-tio), è impossibile non intravvedere tra idue consonanze che vanno ben al di là
del comune ricorso al genere della scien-ce fiction. Per esempio, l’idea paradossa-le che la crescente entropia testuale ge-nerata dall’odierna società dei mediapossa essere contrastata innescandouna proliferazione abnorme di metanar-razioni apocrife che, esibendo spudora-tamente la loro inverosimiglianza, fini-scano per contaminare e attaccare dal-l’interno ogni enunciato investito di unostatus veritativo.
Per entrambi gli scrittori, la virtualitàdei mondi prefigurati dall’evoluzionetecnologica si riflette infatti nella non ob-bligatorietà delle narrazioni che li offro-no alla nostra immaginazione. Anzi: difronte al diluvio universale dell’informa-zione, dove «il bello viene stritolato dalbello e il vero annientato dal vero», me-glio sarebbe tacere – sosteneva Lem nel-
la raccolta di apocrifi Grandezza immagi-naria, definendo il silenzio come «salvifi-ca arca dell’alleanza tra lettore e scritto-re» e divertendosi a presentare le sue pre-fazioni a volumi inesistenti come «an-nuncio di quei peccati da cui sono riusci-to ad astenermi».
Anche Dukaj sembra consapevole chenell’entropia non esiste bellezza e che,come diceva Lem, «la voce di un milionedi Shakespeare crea lo stesso frastuonodi un branco di bisonti mugghianti nellasteppa, lo stesso frastuono delle ondedel mare». Nel contempo, rispetto al suoillustre predecessore, Dukaj appare an-cora più risoluto nell’esporre quella spe-cifica narrazione realistica costituita dalfeticcio dell’identità nazionale polaccaall’azione erosiva di parabole fantascien-tifiche o ucroniche, ossia fondate su svol-gimenti alternativi degli eventi storici.Cosa resti di un simile simulacro dopogli interventi demistificanti di Dukajemerge con brutale chiarezza dalla lettu-ra parallela degli unici due suoi libri fino-ra apparsi in italiano, l’opera prima Gliimperi tremano (proposta l’anno scorsoda Transeuropa) e il recente La cattedra-le, trittico di racconti tradotto per Vo-land da Marco Valenti e Justyna Kulik ecurato da Giuseppe Dierna (pp. 198, eu-ro 14). Un confronto, questo, che mettein luce le molte ossessioni coltivate dalloscrittore polacco, prima tra tutte la ten-denza a investire immancabilmente ilsuo protagonista di una missione di diffi-cile realizzazione che lo porterà poco a
poco alla rovina. Ne è un esempio ciòche fa succedere a Ian Smith, il reporterdi guerra statunitense chiamato in Gliimperi tremano a documentare visiva-mente per il pubblico occidentale le di-scutibili gesta di Xavras Wyzryn, spietatoguerrigliero a capo dell’esercito di libera-zione polacco, che alla fine del Ventesi-mo secolo lotta ancora contro l’ArmataRossa per assicurare al proprio paesel’indipendenza. Nella prospettiva disto-pica di Dukaj l’Unione Sovietica non hamai cessato di esistere, e nella Zona diGuerra Europea, dalla Valacchia alla Bes-sarabia, dai Carpazi fino a Mosca, scheg-ge impazzite di resistenza armata si af-frontano sotto gli occhi più o meno atto-niti della comunità internazionale, inuna logica convulsa e sanguinaria che ri-corda da vicino quella dei videogiochi.Ma l’elemento di maggior interesse inGli imperi tremano non è tanto questoscenario ucronico o i fantasiosi neologi-smi di cui è disseminato il testo, quantola volontà quasi diabolica di Dukaj di ro-vesciare quelli che lui stesso chiama «icomplessi nazionali polacchi», conse-gnando la realizzazione del riscatto terri-toriale non a compassati patrioti timora-ti di Dio, bensì a un inglourious bastardcome Xavras Wyzryn, cinico terroristache non esiterà a sganciare una testatanucleare su Mosca pur di costringere ilmondo a parlare di sé.
Se la Polonia non si fosse liberata delgiogo zarista grazie alla Rivoluzione d’Ot-tobre ora sarebbe né più né meno nellaposizione della Cecenia – questa è la con-clusione di Dukaj, abilissimo nel confu-tare la logica dell’eterno martiriologiopolacco, mostrando una nazione assaipiù incline a seguire Wyzryn sul piano in-clinato delle sue azioni di guerriglia chenon il mite appello ai valori democraticidel presidente in esilio Kochanowski.Inutile dire che anche Smith finirà persubire il fascino mediatico di «Xavrasl’imprendibile», dopo aver tentato inutil-mente di convertirlo a quell’umanitari-smo che, a sua detta di quest’ ultimo,«solo i nipoti di militari sanguinari posso-no permettersi».
Un analogo naufragio esistenziale èquello che attende padre Lavone, il reli-gioso protagonista della Cattedrale, mis-sionario nel vero senso della parola, dac-ché la Chiesa gli ha affidato il compito direcarsi su un lontano planetoide per for-mulare la sua «perizia» sulle presuntequalità miracolose delle spoglie di Ismir,astronauta-martire sacrificatosi per sal-vare i suoi compagni da morte certa.Giunto sulla costellazione degli Ismirai-di da scettico burocrate della parola diDio, Lavone si trasformerà a poco a po-co in prigioniero malgré soi della Catte-drale, edificio enigmatico ispirato alla Sa-grada Familia di Gaudì (cui non a caso èdedicato il racconto) e destinato a ospita-re la tomba di Ismir. La vertigine esteticatrasmessa dalle sue forme apparente-mente sconnesse, eppure contrassegna-te da una superiore necessità, gli impedi-rà di lasciare il planetoide alla vigilia del-
l’imminente impatto con un altro corpoceleste, costringendolo nello stesso tem-po a confrontarsi, forse per la prima vol-ta in vita sua, con l’Assoluto. L’idea cheil cosmo sia lo sfondo ideale su cui pro-iettare le contraddizioni della Chiesa cat-tolica torna anche nel secondo fram-mento del trittico intitolato In partibusinfidelium, dove Dukaj immagina unconclave assai singolare, in cui i cardina-li riuniti a Roma per l’elezione papale so-no costretti a dialogare con i loro confra-telli provenienti da altri pianeti. Malgra-do nessuno tra gli esseri umani avessemai osato pensare che le religioni terre-stri potessero suscitare interesse in civil-tà più avanzate della loro, nel mondo fu-turibile immaginato dallo scrittore polac-co l’homo sapiens si è trasformato inuna sorta di minoranza etnica in seno al-la Chiesa, i cui fedeli sono ormai costitui-ti per il novantotto per cento da devotis-simi alieni.
Se Dukaj dà il meglio di sé quando ri-corre alla logica dello straniamento perdimostrare come come la ragione uma-na, eccessivamente legata alle coordina-te temporali, risulti sempre inadeguatarispetto all’inafferrabile evolversi deglieventi, meno riuscita appare l’operazio-ne inversa, là dove contamina con ele-menti di denuncia sociale le sue spiaz-zanti costruzioni astratte. È il caso del-l’ultimo racconto, La scuola, centratosulla vicenda alquanto scontata di Puno,figlio delle favelas sfuggito a una bandadi pedofili per poi finire negli Usa sotto-posto a crudeli esperimenti di mutazio-ne genetica che dovrebbero auspicabil-mente renderlo in grado di comunicaree interagire con gli abitanti di altri piane-ti. Anche qui Dukaj affida al suo eroe ilcompito paradossale di tradurre da unalingua sconosciuta – missione impossibi-le che aveva già condotto alla rovina il re-porter di Gli imperi cadono, incaricatodi trasporre nel linguaggio della televisio-ne le gesta ai suoi occhi incomprensibilidi Xavras. Una chimera, questa della tra-duzione da un sistema linguistico chenon si padroneggia, perfettamente in li-nea con la tendenza di Dukaj a immagi-nare narrazioni coerenti esclusivamenteall’interno delle proprie coordinate di ri-ferimento e non meno lontane le unedalle altre di pianeti appartenenti a ga-lassie diverse.
di V. P.
●●●Saturno (Chronos) non può che divorare i suoifigli – chiunque contemplando il dipinto «nero» di Go-ya al Prado non potrebbe che convenire sull’inevitabi-lità di un simile destino. Ma che a uno dei pargoli, mi-racolosamente scampato dalle fauci del genitore, siadato in sorte di scoprire in tarda età che l’insaziabilitàerotica del padre non era limitata a un pur consisten-te stuolo di cortigiane e servette, ma si ripercuotevaanche con insolita fedeltà su un rappresentante delsuo stesso sesso, questa è una chiosa che Jacek Deh-nel aggiunge a margine del mito antico nel suo note-vole Saturn (2011), ora edito da Salani con il titolo al-quanto piatto e impreciso di Il quadro nero (traduzio-ne di Raffaella Belletti, pp. 252,€ 14,90). Ispirandosi al-l’ipotesi avanzata di recente dallo storico dell’arteJuan José Junquera, secondo cui le celebri pinturas ne-gras che adornavano le pareti della Quinta del Sordonon sarebbero opera di Goya, bensì di suo figlio Ja-vier, lo scrittore nato a Danzica nel 1980 orchestrauna brillante rilettura in chiave queer della figura delpittore spagnolo che si lascia facilmente sintetizzaredalla epigrafe attribuita a un certo R. M.: «Dimmi chiha inventato il padre, e mostrami il ramo al quale èstato impiccato». Non sappiamo se davvero Goya ab-bia involontariamente «divorato» i suoi nove figli, im-pregnando la propria abitazione di cinabro e biancodi piombo e rendendola così particolarmente insalu-bre e inadatta alla crescita dei virgulti che pure egli ge-nerava con un certo entusiasmo. Ignoriamo egual-mente se l’intensità dei suoi appetiti vitali abbia mai
raggiunto i livelli pantagruelici attribuitigli dall’auto-re, che ne descrive così la giornata tipo: «...butteraigiù qualche altro ritratto, comprerai un pezzo di ter-ra, trangugerai un pranzo di quattro portate, abbatte-rai qualche pernice e una lepre, inciderai un Capric-cio molto raffinato, darai una botta a una cameriera esubito dopo alla bella mora della taverna che ha posa-to per te come santa vergine». Di certo Dehnel «vendi-ca» il povero Javier, unico sopravvissuto alla stragedel bianco di piombo, attribuendogli nientemenoche la paternità di quell’opera che Fred Licht ritenevafondamentale per la comprensione della condizioneumana moderna. Così facendo, vanifica il malevolointervento del figlio di Javier, Mariano, che aveva grat-tato via con l’unghia la firma del padre dalle pareti del-la Quinta del Sordo nell’intenzione di vendere l’interociclo spacciandolo per l’opera del ben più quotatononno. A completare il delizioso quadretto edipico incui Goya nipote defrauda Goya figlio dell’unico rag-giungimento in grado di riscattare una vita incolore, equest’ultimo a sua volta turlupina gli ignari turisti in-glesi, facendo passare per schizzi del geniale padre isuoi scarabocchi, interviene – autentico deus ex ma-china – l’erede del nobilotto amato di Francisco chemostra a Javier le lettere del padre. Superfluo aggiun-gere che sarà questa rivelazione a far assumere alla vi-sione di Saturno la sua definitiva consistenza. Se il tut-to non precipita nella soap opera, è merito della scrit-tura calibratissima di Dehnel, ironica e sensibile, ca-pace di evocare il mondo domestico della Spagna diinizio Ottocento con la stessa commozione riservatain Lala (Salani, 2009) alla Polonia novecentesca.
di MARCO PACIONI
●●●Il suono, il ritmo, la voce, il timbrosono elementi che da sempreconcorrono alla creazione e allafruizione della poesia. E tuttavia, quandoappare come testo sul foglio o sulloschermo, quando diventa oggetto dalquale deriviamo concetti, la poesiasembra perdere contatto con i suoicostituenti originari. Il saggio di BrunellaAntomarini La preistoria acustica dellapoesia Per uno studio antropologico delfenomeno poetico (Aragno, pp. 105, €10,00) si chiede se sia possibileriaccedere allo stato primordiale dellaparola poetica spogliando quest’ultimadi tutti i significati secondari di cui lacultura l’ha rivestita.
Per la studiosa è la scrittura l’ostacoloprincipale che sbarra la strada alladimensione acustica del fenomenopoetico. La scrittura sarebberesponsabile della trasformazione dellapoesia in fatto comunicativo, semantico,simbolico e statico. La poesia si sarebbemanifestata nella sua vera natura diritmo, canto, movimento in etàpreletteraria quando la memoria nonera affidata ancora alla trasmissionescritta e non c’era distanza tramemorizzazione dei versi e chi li
Aporie cattolicheproiettatesu sfondo cosmico
Il feticcio dell’identitànazionale polaccasottoposto all’azioneerosiva di parabolefantascientifiche,nel trittico di raccontidi Jacek Dukaj
Da «Solaris» di Andrej Tarkovskij,1972
ANTROPOLOGIA
Quando poesiaera soprattuttoritmo, cantoe movimento
DUKAJ
POLONIA
Jacek Dehnel,il Goya «nero»alla Quintadel Sordocome Saturnoin chiave queer
«LA CATTEDRALE» DELL’AUTORE POLACCO

(7)ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
di SILVANA TURZIO
●●●Due biografie su due figure femminilidella fotografia italiana offrono la possibilitàdi guardare alla seconda metà del Novecen-to alla luce dell’impegno incondizionato sianel campo del lavoro culturale che in quellocivile. Lisetta Carmi, classe 1924, genovese eGrazia Neri, classe 1935, milanese. Molto di-verse fisicamente, la prima minuta, ipercine-tica, dalle mani forti come quelle di un bo-scaiolo e la voce imperiosa; la seconda alta esottile, occhi orientali quando sorridono, in-quieti e vigilissimi quando si guardano intor-no, le due sono curiosamente simili nella vo-lontà ferrea e nell’intelligenza intuitiva dellesituazioni, nella passione che le anima e nel-la riflessione acuta che portano oggi sul lorolavoro e sulla loro vita. L’uscita quasi con-temporanea dei due libri induce a una rifles-sione sugli anni della grande trasformazioneculturale italiana che, tra altre cose, vedel’immagine fotografica occupare uno spaziosempre più importante nell’editoria periodi-ca, prima del declino dell’ultimo decennio.Due donne in un mondo di uomini che nonsi sono mai poste il problema di un’emargi-nazione di genere. Se c’è stata non l’hannonemmeno sentita tanto erano prese dal faree dall’esistenza.
Le cinque vite di Lisetta Carmi, l’autrice èGiovanna Calvenzi (Bruno Mondadori, pp.184, € 18,00), presenta sia testi autobiografi-ci che di amici; la biografia ripercorre le fasimolto nette che vedono Carmi pianista soli-sta di successo e poi fotografa, per passare at-traverso altre fasi prima di approdare allameditazione e alla pratica buddista. Ogni vol-ta chiude con fermezza una porta per aprir-ne un’altra e ciò con tutta la dedizione di cuiè capace. Inutile dire che i risultati sonosempre eccellenti. Del suo lavoro fotografi-co, pur essendo avvolto in un’aura quasimitica, si hanno purtroppo poche occasio-ni di esposizione. Eppure ogni sua immagi-ne tracima letteralmente dal grande fiumedella fotografia italiana per la capacità nar-rative, per la qualità formale, e soprattutto,per i temi affrontati in tempi precoci. Sipensi alle date: Il lavoro sul parto del 1965,I travestiti (1965-’72), e poi i servizi sul-l’America latina degli anni settanta, sul-l’Anagrafe di Genova, Acque di Sicilia del’77 che vince il premio mondiale del librodi Lipsia. Altri lavori interessanti come l’al-luvione di Firenze e la serie dei ritratti diEzra Pound del ’66 avrebbero meritato nel
libro più spazio e più illustrazioni.Celebre, ma non inferiore agli altri per
qualità, I travestiti, ahimè presente solo sulmercato della bibliofilia, è il risultato di unafrequentazione quasi quotidiana di un grup-po di travestiti genovesi: còlti nella loro inti-mità dallo sguardo dell’amica Lisetta, trasu-dano di sentimenti integri come bambini du-rante il gioco. Peccato che nella biografianon si riporti almeno una parte del testo in-troduttivo di Elvio Fachinelli, psichiatra e psi-coanalista (tra le altre attività, uno dei redat-tori e fondatori de L’erba voglio), che avevaanalizzato in modo lucido e non pregiudizia-le le fotografie di Carmi: a suo giudizio, ciòaveva permesso alle persone di rivelarequanto di più intimo lasciavano emergerenel travestimento, mettendo così in discus-sione la presa di posizione della psicoanalisiallora teoricamente avanzata, che vedeva so-lo la «mascherata». «L’argomento del libroha fatto sì che esso venisse rifiutato (alla let-tera) dalla grande maggioranza dei librai ita-liani. Noti progressisiti e anticonformistihanno espresso la loro “ripugnanza” di fron-te a tale “orrore”, altri si sono limitati a re-spingerlo ... due dei maggiori periodici italia-ni hanno rifiutato di occuparsene ... Le fotodi Lisetta testimoniano quante facce diverseabbia la femminilità proposta da questi uo-mini e quanto diversa possa essere la profon-dità del loro travestirsi. ... Si procede via viaattraverso la rappresentazione parodisticadella checca omosessuale all’incarnazionedi un modello culturale femminile ... la diffe-renza dalle donne non riguarda più l’aspettofisico o gli atteggiamenti quanto la convizio-ne stessa delle feminilità come valore ... ci so-no in questo libro sguardi , atteggiamenti,movenze, di profonda delicatezza e dolcez-za...». Un discorso coraggioso, quanto le foto-grafie, sia dal punto di vista civile che profes-sionale. Il libro I travestiti è straordinario.Qualcuno potrebbe pubblicarlo nuovamen-te? Sarebbe utile e necessario. Un altro lavo-ro fotografico importante della Carmi è la se-
rie dei ritratti di Ezra Pound ripreso sulla so-glia della sua casa in Liguria, già isolato nel si-lenzio e nell’ipocondria più solida. Carmi inpochi minuti gli gira intorno, si avvicina e siallontana come una mosca silenziosa e lo di-segna nella rete di rughe, solitario e muto, gliocchi profondissimi, già lontani. Tra i grandiritratti fotografici questi sono un’eccellenza.Brava Carmi. Un esempio di coraggio e di ca-pacità ritrattistiche fuori dal comune.
Grazia Neri ha conosciuto Lisetta Carmi.Ne ha valutato la qualità e la serietà, ma nonha distribuito il suo lavoro sui travestiti: eraimpubblicabile, scrive oggi nella sua biogra-fia La mia fotografia (Feltrinelli, pp. 468, €25,00). Una scelta difficile, improntata peròalla profonda conoscenza del mercato edito-riale italiano. Grazia Neri è anzitutto il nomedi un’agenzia fotografica tra le più importan-ti sul piano internazionale. Chiusa da pochianni, è stata il motore di un’esperienza stra-ordinaria, che la fondatrice ripercorre qui inmodo puntuale, con aneddoti e riflessioniacute, e i ricordi dei numerosi fotografi e per-sonaggi incontrati nel corso della lunghissi-ma carriera. L’agenzia Grazia Neri ha per pri-ma imposto il copyright, ha organizzato il la-voro nella sua sede milanese come avvenivanelle grandi sedi newyorchesi, è stata unesempio di effervescenza lavorativa per i gio-vani, soprattutto donne che oggi occupanoposti chiave nel sistema editoriale italiano:«alla fine degli anni Ottanta, era un satellitecon una popolazione eterogenea piacevol-mente eccentrica e straordinariamente pro-duttiva. Nel complesso assomigliava alla tito-lare», racconta Chiara Mariani entrata giova-nissima in agenzia e oggi photeditor. I foto-grafi italiani degli anni sessanta, scrive Gra-zia Neri, «erano deliziosi, impegnati politica-mente, colti e preparati ma del tutto digiunidelle regole del mercato». Così lei e la suaagenzia hanno procurato alla fotografia ita-liana, soprattutto quella indirizzata all’edito-ria, il rigore della professionalità e l’accessoal mercato internazionale. Non è stato poco.
Carmi la ritrattistae l’aura dei ’60-’70
ricordava per eseguirli e offrirliall’uditorio senz’altra mediazione.L’immediatezza acustica del fenomenopoetico però non scomparecompletamente nell’epoca dellascrittura, che anzi conserva la sonoritàdella poesia sulla pagina nellavisualizzazione dei versi e delle strofecome un «fossile» che può rivivere nelleperformance per poi però inabissarsinuovamente nella stratificazionesemantica, nella «foresta di simboli» enel circolo chiuso comunicativo deltesto scritto. Nella sua dimensioneacustica, affidata solo alla memoria dichi la pronuncia e accompagna con ilgesto e il movimento, la poesia vivrebbeessenzialmente soltanto nella dinamicadella sua esecuzione. Secondo lastudiosa, la scrittura, intervenendo sianell’invenzione che nella trasmissione
della poesia neutralizzerebbe propriotale sua natura dinamica.
Il rapporto tra oralità e scrittura è unavecchia questione su cui rimane moltoda dire (ma sulla quale vi è anche moltoda mettere a frutto rispetto a ciò che èstato detto) e che va oltre il fenomenopoetico, investendo più in generale tuttoil linguaggio. Il libro di Antomarini ètutto dalla parte dell’oralità e in tal sensosi ricollega a una tradizione molto foltadi filosofi, poeti e antropologi citati neltesto che vedono la scrittura come underivato che conserva, ma per ciò stessoimpedisce l’accesso alla vera naturadella poesia, del linguaggio, del pensieroe del modo autentico di abitare ilmondo. (La fine del saggio non a casoassume toni apocalittici quando parla di«tecnologia della scrittura» come«possibilità di vivere senza corpo, senza
la fatica fisica e i suoi ritmi, senza ilpatto che la poesia ha stretto con lacontingenza»).
Ma che forse le cose non stianosoltanto così e cioè che non siano tutte afavore dell’essenza acustica della poesia,lo mostra il secondo capitolo del libro.Qui si affronta la questione dellatraduzione e della traducibilità dellapoesia da una lingua all’altra. Passaggiopossibile, per Antomarini, perchétradurre, in conformità con la naturadinamica della poesia, è «il mododell’esecuzione; il modo di usare unalingua comunque sconosciuta». Ma seciò è vero, perché allora non considerarela traduzione e con essa il dinamismoche la caratterizza come elementiessenziali del linguaggio tout court chefanno da ponte non solo da lingua alingua, ma anche tra scrittura e oralità,gesto e immagine? Il linguaggio contienela lingua, ma non coincide con essa.Quello che secondo l’autrice eccede lalingua e di cui la poesia sisostanzierebbe esclusivamente e cioèl’acustico, il vocale e il ritmico, non sononecessariamente fuori dal linguaggio.Forse l’eccedenza è il linguaggio stessotra le lingue; è la mera potenzialità diparlare suscettibile di diventare linguediverse. Sulla scorta di ciò che
Antomarini sostiene sulla traduzione,forse si può dire che con la poesia noifacciamo esperienza del linguaggio in sestesso, pur se incarnato nel suono, nelritmo o nella scrittura di una linguaspecifica. E in ragione di ciò nonritorniamo né a una preistoria acustica,né a una post-storia scritta della parolapoetica, ma alla simultanea potenzialitàdel ritmo, del suono, della voce, delgesto, dell’immagine e della scritturanon ancora completamente ridotti a unafunzione specifica o a un modocomunicativo più che a un altro. Non diuna mitica età dell’oro prima dellascrittura dobbiamo riappropriarci perfare esperienza della poesia, ma dellasoglia di convergenza fra le varie formeespressive – soglia nella quale illinguaggio sempre si trova rendendopossibile la traduzione.
L’alluvione di Firenze, l’anagrafe di Genova,lo «scandaloso» libro sui travestiti... Invece«La mia fotografia» di Grazia Neri raccontal’agenzia che lanciò il fotogiornalismo italiano
UN PROFILO DI LISETTA CARMI, E POI L’AUTOBIOGRAFIA DI GRAZIA NERI
FOTOGRAFIA
Un saggio di Brunella Antomarini esaminala dimensione pre-letteraria (cioè primadella scrittura) del fenomeno poetico:quando viveva di oralità e performance Qui a fianco, Calliope, Musa della poesia epica,
copia romana del II sec., Roma, Palazzo Altemps;sopra, di Lisetta Carmi: Ezra Pound a Rapallo,1966, e uno dei ritratti de «I travestiti», 1972

(8) ALIAS DOMENICA5 MAGGIO 2013
di CLAUDIO GULLIPADOVA
●●●Finalmente una mostra intelligente,e di successo! e bisogna dirlo, una buonavolta, ripeterlo, spargere la voce, al vicinodi casa, nelle piazze, ai sindaci, nei cda del-le fondazioni: quando si fa ‘cultura alta’, ilpubblico risponde! (pubblico e elettorato,in fondo, non coincidono… ma, passatal’euforia, ci ricomponiamo). Tre sembra-no essere le mostre più visitate di questoinizio 2013: Tiziano alle Scuderie, Modi-gliani a Palazzo Reale e questa di PietroBembo, promossa dalla Cassa di Rispar-mio di Padova e Rovigo, allestita nel Palaz-zo del Monte di Pietà, a due passi dal Duo-mo di Padova (fino al 19 maggio, a cura diGuido Beltramini, Davide Gasparotto eAdolfo Tura, catalogo Marsilio, pp. 439).Dalla prima del podio, se entri con un’ideaanche vaga di chi è Tiziano, esci senza al-
cuna consapevolezza in più – e speriamoche la saga veneziana-quirinalesca, partitacon Antonello nel 2006, finisca davverocon questo settennato qui. Della mostramilanese daremo conto prossimamente;si merita comunque la nostra incondizio-nata preferenza questa rassegna su un let-terato centrale per capire sorti di libri equadri italiani di primo Cinquecento.
Pietro nasce a Venezia nel 1470 e crescein una casa patrizia, dove appeso alle pare-ti stava un dittico di Memling, venuto daWashington e squadernato in mostra ap-pena entri. La volontà di veder chiaro nel-le cose, respirabile nei dipinti fiamminghi,dovette forgiare, oltre che la mente di tantipittori del tempo, anche la sua. Da giova-ne si butta a emendare un codice di Teren-zio, insieme al Poliziano, con il quale a Ve-nezia confronta codici, poi va a Messinada Costantino Lascaris per imparare il gre-co. Migliori maestri, in filologia e linguagreca, era difficile trovare. Quando torna aVenezia, un incontro gli cambia la vita:con Aldo Manuzio, l’editore più all’avan-guardia che c’era in giro. I due allestisco-no una collana di ‘classici moderni tascabi-li’ e sanciscono che la letteratura italianava fatta partire tre secoli prima (con Dantee Petrarca). Quando si tratta di dare allestampe la prima edizione del libro che glidarà fama nazionale, Gli Asolani, natural-mente Bembo manda le bozze al torchiodi Manuzio (1505). Il modo di ragionare diamore di questi dialoghi corre in parallelo,dice la mostra, con i ritratti di Giorgione, eper chi ama la pittura la seconda sala è in-dubbiamente un giardino di delizie. I duedipinti di Giovanni Bellini recentemente ri-scoperti da Antonio Mazzotta (la Madon-na Dudley e il Ritratto di Giovanni dellaCasa, entrambi di collezione privata), fron-teggiano, a lasciarti sbalordire come sem-pre, tre pezzi giorgioneschi: il Doppio ri-tratto di Palazzo Venezia, il Ritratto di Bu-
dapest e un ultimo da San Francisco (solapresenza insensata: un Busto bronzeo pro-veniente dalla tomba di Petrarca a Arquà).La candida perfezione belliniana, di civiltàgeometrica esportabile in campagna, siscioglie nella doppia sensazione, di malin-conia e voglia di scherzare, di spleen vissu-to in arcadia, che ti trasmette il Giorgioneromano (1502), o l’ermetico snobismo delsuo uomo di Budapest (1503), o la rudetensione del lettore di aldine finito in EastCoast (1500). Tanto è concentrato il botta-e-risposta di questa seconda sala, che il re-sto della mostra è, emozionalmente, forza-ta decrescita.
Entri nella terza sala, trovi la ciocca di ca-pelli di Lucrezia Borgia (ritrovata fra le car-te di Bembo e poi inserita nella teca am-brosiana di Alfredo Ravasco, nel 1928), ca-pisci che il clima è cambiato: il Rinasci-mento è pur sempre quel pezzo di storiasu cui è agevole stendere una patina di de-
cadentismo. Sarebbe meglio non mischia-re mai fortuna critica e histoire événemen-tielle. Si procede lampeggiando sulla cultu-ra di corte: l’incontro con Ariosto a Ferra-ra, alcune apparizioni di Isabella d’Este,una parete di fondo su Urbino, dove ilBembo fu dal 1506 al 1512. La sala si costel-la di prime edizioni dell’Orlando Furioso,delle Rime bembesche, del Cortegiano diBaldassarre Castiglione. La varietà dei gu-sti pittorici di questi ambienti è tale che unPerugino assai leonardesco (la Maria Mad-dalena di Palazzo Pitti) può convivere sen-za scandalo con il dipingere a bolle di sapo-ne di Lorenzo Costa o le eroine melodram-matiche che sforna la pittura bolognesedel tempo. Si va verso un’uniformità, ma ilprocesso non va confuso con l’opera dinormalizzazione ordita a tavolino, nellaRoma medicea di Leone X. Quando Bem-bo accorre nella capitale (1513), una socie-tas di amanti delle antichità venne a crear-si, fra lui, l’autore e i due soggetti di un al-tro Doppio ritratto, quello Doria Pamphilj:parliamo di Raffaello, Andrea Navagero eAgostino Beazzano – e ricordiamo di aver-lo visto di recente, nella poco raccomanda-bile mostra sul tardo ‘divin pittore’ chiusaa gennaio al Louvre. Per questo circolo diveneti a Roma, Raffaello non poteva che ri-correre al suo bagaglio di pittura tonale,dove il verde del fondo accende il nero de-gli abiti, i chiari dei volti, gli svolazzi dellemaniche. Una penombra alla Sebastianodel Piombo, incontrato sui ponteggi di Vil-la Chigi, non ancora assuefatta al Miche-langelo della volta. Siamo al momento fon-dante della ‘maniera moderna’, dove Leo-nardo, Raffaello e Michelangelo assurgo-no, come le ‘tre corone’ letterarie (Dante,Petrarca e Boccaccio), a glorie nazionaliche codificano un linguaggio.
La partecipazione di Bembo al confezio-namento di un modus operandi nazionaleavviene con le Prose della volgar linguanel 1525. (E ricordiamolo sempre, non famai male: sono gli anni in cui il più grandeintellettuale del tempo, Niccolò Machiavel-li, da quegli stessi Medici che incensano ilBembo, viene torturato e lasciato marcirein esilio. Un altro che di Italia ragionavaspesso e volentieri). Che con l’umanesimosi potesse fare l’Italia era il sogno diun’epoca, e chissà quanta disillusione, an-che per Bembo, alla morte di Raffaello
(1520) e nei giorni del Sacco (1527)! lui tor-na a Padova già dal ’21, e si consola com-prando casa vicino agli Eremitani. Qui ‘gliozii delle lettere’ combaciano con una pra-tica collezionistica anch’essa altamente ci-ceroniana. E il riscatto emozionale dellamostra è questa sala dove gli Antinoo o iCaracalla guardano il San Sebastiano delMantegna, dove antichi e moderni non so-no contrapposti in querelle. Fuori dallacappellina della Ca’ d’oro, l’omone mante-gnesco perde il suo ruolo di feticcio; frapezzi di statuaria antica, ti illudi davverosia stato pensato per esser di marmo enon di carne. Il gusto di Bembo sembraaver seguito un filo tutto veneziano: Belli-ni da giovane, Giulio Campagnola e il suoclassicismo campestre da adulto, Tizianoquando i capelli si tingono di bianco. Se os-serviamo il suo volto nei primi ritratti certi– il dipintino di Cranach il Giovane, la me-daglia di Valerio Belli –, l’uomo-Bembo ciappare protervo, tenacemente ancorato aideali immutabili.
Tutto cambia, naturalmente, quando aritrarlo è Tiziano. Ora Bembo è diventatoporporato, siamo di nuovo a Roma, ma lacittà si è fatta grigia e bigotta, ai tempi diPaolo III Farnese. Quell’irraggiungibile pre-datore di psicologie che è il cadorino, nonpuò che ribadire, nella tela del ’39 venutada Washington, quanta intelligenza possacelarsi negli occhi di un potente, come ac-cade nel papa andreottiano di Capodimon-te o nel nipote con un’infanzia negata, Ra-nuccio Farnese – due dipinti portati alleScuderie. Il Bembo cardinale, passeggian-do per i corridoi vaticani o per una loggiadi Castel Sant’Angelo, dovette orecchiarequella crisi spirituale che tormentava unanuova generazione, che leggeva Juan deValdès o le Rime di Vittoria Colonna: quelmondo di immagini e suoni che fermentanel Giudizio sistino. Di Michelangelo, a co-spetto del Cristo portacroce di Sebastianodel Piombo (1535-40), è in mostra la cele-bre Crocifissione a carboncino del British(1540 circa); ma i nessi con il nostro lettera-to son già allentati. Lo vediamo per l’ulti-ma volta nel Busto funerario di Danese Cat-taneo, eseguito dopo la morte, che giungenel ’47. Questo marmo scolpito da unoscultore amico, estrapolato dal monumen-to nella Basilica del Santo, è incapsulato inuna sala poco coesa: era meglio non inqui-nare il discorso Jacopo Sansovino-Bartolo-meo Ammannati-Cattaneo – la linea più fi-lotoscana della scultura veneta – con la pre-senza di Giulio Clovio o dell’Idolino ritrova-to a Mantova, di cui Bembo scrive l’epigra-fe. Il Bembo di Cattaneo, dall’aldilà, ci ap-pare come un patriarca certo di aver fattoquello che c’era da fare, per sé e per gli al-tri: ai posteri seguire i suggerimenti.
di CL.GU.PADOVA
●●●E chi va a vedere Bembo, trovi anche iltempo di fare un salto a Palazzo Zabarella,dove è ospitata un’importante retrospettivasu Giuseppe De Nittis (1846-1884) – curata daEmanuela Angiuli e Fernando Mazzocca, ri-mane aperta fino al 26 maggio. Che il barletta-no di nascita diventi il più parigino dei pittoriitaliani dell’Ottocento è, senza troppi indugi,la tesi sventolata: a noi ora, di buon grado, ilcompito di verificare. Sole e strade iniziali sa-ranno pure meridionali, ma è vero che a DeNittis basta metter piede a Parigi, nel 1867,per trovare moglie e cambiare tavolozza, en-trambe scelte francofone. Il celebre Passaggiodegli Appennini, esposto alla Promotrice fio-rentina, entusiasma i macchiaioli – «il successo di questo quadro giunse al fanatismo»,scriverà retrospettivamente Adriano Cecioni – e il merito è tutto del grigio, del fango,della macchia gialla della diligenza che spezza un basso orizzonte luminescente, sottoun cielo che pare esalare pioggia e vertiginosa serenità.
I tappeti rossi arrivano presto anche nella ville lumière, dove fioccano le vendite allaMaison Goupil, la galleria di maggior fama del momento – per saperne di più andrebbevista la mostra a Rovigo. L’affinità elettiva non scatta con Degas («ha l’occhio osservato-re e la mano che risponde a metà») ma con Manet («dà l’impressione della delicatezza
del vero»), così scrive De Nittis nel ’74. Al cen-tro di questa amicizia non doveva essere ilgusto dello scandalo, ma un quotidiano rac-contare quel che si vedeva per strada, lasciar-si ispirare dalle gite in barca con le consorti odai volti sfuggenti di rispettabili e impercetti-bili signore vestite in nero. Una fedeltà al veroche gli invidiosi battezzarono come ripetizio-ne di una formula di successo; mentre il limi-te dell’artista ci pare più umano che pittorico.De Nittis è il tipico meridionale che, compiu-to lo sradicamento, si ferma il prima possibilee assorbe tutta la cultura del luogo in cui vuo-le piantare le tende. Uomo dunque verghia-no, che si lascia abbagliare dalla ricchezza me-tropolitana, come un galantuomo di provin-cia. Nulla di male in questo, sia chiaro; soprat-tutto perché, anche a poetica ferma, De Nittissforna capolavori su capolavori e in mostra losi vede bene. Ci viene in mente l’altro italiende Paris, Giovanni Boldini – e la mostra vistaa Ferrara, vedi «Alias-D» del 30 dicembre scor-so, è ora malamente segmentata a Firenze,tra Villa Bardini e Palazzo Pitti – lui sì che,istrione e viveur, interiorizza Parigi per poiestrarne una materia pittorica personale!
De Nittis invece non vuole stupirti, e la pen-nellata accarezza la realtà, come se volesseadescarla con modestia. Nei dipinti londinesi,città frequentata saltuariamente dal ’74, paredi sentire una partitura lievemente più ritmi-ca: in Trafalgar Square (1877) o fra gli operaiche guardano Westminister (1878), il lirismoscema. Ma è nei pastelli più domestici, quan-do l’ora è intima, che De Nittis dà il meglio disé. Sono le opere finali di un grande pittoredeceduto anzitempo: se ritratta è la moglie, onella familiare Colazione in giardino (del 1883e rimasto incompiuto), una bellezza particola-re sembra la si voglia riservare agli amati.
NEL PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ A PADOVA
PIETRO BEMBO ■ AL CROCEVIA DEL PRIMO CINQUECENTO
Sogno umanistatra le aldinee i maestri a olio
DE NITTIS ■ ALLO ZABARELLA
La fedeltà al verodi un meridionalesedotto da Parigi
La filologia e l’editoriaa Venezia con Manuzio,l’incontro con Ariostoa Ferrara, la Romadi Leone X, il collezionismociceroniano... Una rassegnadi libri e quadri da cuil’autore de «Gli Asolani»esce come intellettualee crocevia di un’epoca
Tiziano, «Ritratto di Pietro Bembo cardinale»,Washington, National Gallery of Art; in piccolo,Giuseppe De Nittis «La signora col cane (Il ritornodalle corse)», 1878, Trieste, Civico Museo Rivoltella
BEMBO