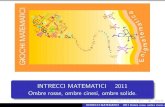v1 Intrecci Luce Arte
Transcript of v1 Intrecci Luce Arte

1© 2011 RCS Libri S.p.A./La Nuova Italia – A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza
unità 7 LafilosofianelMedioevo
Luce,claritas,filosofiaLa luce come
punto di incontro tra filosofia e arte
L’immagine del Medioevo legata allo stereotipo degli “evi bui” è un pregiudizio dovuto all’Illuminismo, come se l’oscurantismo, la superstizione, il fanatismo religioso, la violen-za, i pregiudizi e gli errori fossero un’esclusiva dell’età di mezzo. In realtà, il Medioevo, e in particolar modo il Basso Medioevo, è caratterizzato dalla rinascita del pensiero e delle arti europee. L’uomo dei secoli XIII-XIV raffigura se stesso, nella poesia e nella pittura, in ambienti inondati di luce.
La luminosità (claritas) è considerata una qualità fondamentale sia nel pensiero filo-sofico sia nelle manifestazioni artistiche. Il suo studio ci aiuta a comprendere meglio un aspetto significativo della mentalità dell’uomo medievale.
L’importanza della claritas
La luce è la caratteristica che una lunga tradizione di pensiero ha legato indissolubilmen-te a Dio. «Dio è claritas», è il «circonfuso di luce»: simili espressioni del linguaggio cristia-no trovano i loro antecedenti filosofici nel neoplatonismo dello Pseudo-Dionigi Areopagi-ta (V secolo) e, successivamente, vengono riprese da Giovanni Scoto Eriugena (IX secolo) e da Tommaso d’Aquino (1221-1274).
Il Dio cristiano è una fulgidissima luce; è il padre dei lumi e la fonte della bellezza. Le creature partecipano solo in modo molto limitato alla perfezione del creatore.
Esiste uno stretto legame tra luce e bellezza, intese come segni di Dio, metafore di verità e di elevazione. Il sentimento della bellezza percepibile dagli uomini nell’esperienza terre-na rinvia a una realtà metafisica. Il principio del bello è trascendente, ossia al di là delle singole armonie visibili.
Il bello raggiungibile attraverso l’esperienza terrena è il segno divino inscritto nelle creature. Le menti degli uomini corrono sempre il rischio di essere fuorviate dal buio del peccato, oscurate dagli errori e turbate dalle passioni del corpo. La luce e la bel-lezza possono costituire una via di salvezza.
Le opere d’arte del XIII e del XIV secolo aspirano ai modelli di perfezione e di bellezza teorizzati, ad esempio, da Tommaso d’Aquino, per il quale i tratti dell’arte che esprime il bello sono l’armonia, l’ordine e, appunto, la claritas (luce, luminosità).
1 La luce nella filosofiaAlcune
testimonianze filosofiche
Nella luce si cela una doppia presenza: sensibile e soprannaturale insieme. La contem-plazione della bellezza in terra non può essere un piacere fine a se stesso, ma deve essere funzionale alla contemplazione della fonte della vera luce-bellezza, ossia Dio.
Nell’Eruditio scolastica Ugo di San Vittore (1096-1141) scrive:
Che cosa c’è di più bello della luce che, pur non avendo colore in sé, tuttavia fa apparire i colori di tutte le cose illuminandole?
La luce fra filosofia e arte
i ntr ecc i

2© 2011 RCS Libri S.p.A./La Nuova Italia – A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza
unità 7 LafilosofianelMedioevo
La luce fra filosofia e arte intrecci
Per il vescovo francescano oxoniense Roberto Grossatesta (1175-1253) Dio è insieme fonte di luce, di bellezza e di essere:
“Se togli la luce tutte le cose rimangono sconosciute nelle tenebre, poiché non possono manifestare la loro bellezza”. La luce, la bellezza e l’ordine di ogni creatura visibile risale a Dio. La sua prima parola ha creato la natura della luce e ha disperso le tenebre e dissolto la tristezza e ha reso immediatamente ogni specie lieta e gioiosa (Commentario all’Hexaemeron).
La luce è considerata l’emanazione risplendente della grazia divina. Il fiat lux è l’atto crea-tivo stesso. Rappresenta la vittoria sulle tenebre e il nulla. Nel trattato De luce seu de inchoatione formarum (Sulla luce o sull’origine delle forme) Roberto Grossatesta si figura l’atto creativo come un punto luminoso che si espande istantaneamente (v. p. 520):
Non a causa di un’aggregazione di parti, ma grazie a un fulgore immediato e gioioso (propter laetum alacremque fulgorem).
Luce e bellezza si legano indissolubilmente, formando un connubio destinato a durare nel tempo, tanto che per Grossatesta
La luce è al massimo grado rivelativa della bellezza ed è essa stessa bellezza.
Il mistico francescano Bonaventura da Bagnoregio (1217-1274) elabora una vera e pro-pria metafisica della luce. Ad esempio, nel suo Commento alle Sentenze, si può leggere:
La luce è la natura comune che si ritrova in ogni corpo sia celeste che terrestre […]. La luce è la forma sostanziale dei corpi, che possiedono tanto più realmente e degnamente l’essere quanto più partecipano di essa (II,12,1 e II, 13,2).
Queste teorie filosofico-teologiche sono riferimenti (auctoritates) che hanno ispirato gli artisti dello stile gotico, fiorito in architettura e in pittura dalla metà del XII alla fine del XV seco-lo. La luce è considerata da molti storici dell’arte uno dei principi fondamentali del gotico.
2 La luce nelle arti. Dalla metafisica della luce all’estetica della luce
L’architettura religiosaLe cattedrali
e il loro ruolo sociale
L’unità della christianitas medievale trova il proprio culmine artistico nell’edificazione del-le grandi cattedrali (dal latino cathedra, trono del vescovo). Per i fedeli esse rappresentano bibbie di pietra; accedervi significa entrare in una dimensione allo stesso tempo religiosa ed educativa.
La chiesa medievale risulta contemporaneamente un’entità ideale e reale insieme. Anche se la chiesa si concretizza nell’edificio della cattedrale, come manifestazione visibile della fede, la vera Chiesa continua a risiedere nel cuore degli uomini. È la Chiesa dei cuori il fulcro unitario della cristianità, come la tradizione mistica non si è stancata di sottolineare.
Le immagini sacre
La rievocazione nelle menti dei fedeli di concetti sacri è ricondotta alla presenza delle immagini che, incise all’interno delle cattedrali sui capitelli delle colonne, scolpite nelle absidi, dipinte sulle tavole e sui crocifissi lignei, sono elementi figurali che stimolano la fan-tasia dei fedeli nell’immaginare gli altri mondi desiderati o temuti. Le varie figure finiscono con l’arricchire la mentalità collettiva della comunità cristiana uniformandone la fede. A partire dal secondo concilio di Nicea (787), la Chiesa aveva difeso il culto di tutte le imma-gini sacre contro il movimento iconoclasta (i distruttori di immagini) orientale, favorendo, quindi, un notevole sviluppo delle arti figurative.

3© 2011 RCS Libri S.p.A./La Nuova Italia – A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza
unità 7 LafilosofianelMedioevo
La luce fra filosofia e arte intrecci
Tutt’intorno nelle cattedrali si possono vedere le storie bibliche e le stazioni della via crucis della passione di Cristo. «La figurazione è un modo per addottrinare gli indotti. Anche per questi, dunque, è fatta l’arte: la stessa immagine che parla alla fantasia popolare par-la, con i suoi sensi allegorici, anche all’intelligenza dei dotti» (G.C. Argan). Alcuni versi del poeta François Villon (1431-1463 ca.), dedicati alla madre che prega in chiesa, rendo-no un’adeguata testimonianza di questo stato d’animo dei fedeli:
Sono povera e vecchia ignorante e analfabeta, alla mia parrocchia vedo dipinti il paradiso con le arpe, i liuti e l’inferno dove ardono i dannati: questo mi atterrisce, quello mi fa gioire.
Le cattedrali gotiche e la luce
Il linguaggio del gotico conquista progressivamente l’area europea. L’architettura go-tica erige una specie di ossatura in pietra in grado di sorreggere le innervature delle volte, che da parte loro permettono l’apertura di ampie vetrate, finestre e archi a sesto acuto. Le cattedrali hanno grandi superfici di vetro che, leggere e rilucenti, al-ludono alla dimensione celeste. I virtuosismi delle volte, i pinnacoli, le guglie, gli archi rampanti, liberando le pareti dalla loro funzione statica, indicano una spinta verso l’alto. Queste costruzioni generano una sensazione di profonda ammirazione nei fede-li e li richiamano al valore della trascendenza. Le chiese, inondate di luce attraverso le nuove vetrate, appaiono, agli occhi dei fedeli, visioni glorificanti il Signore. La luce diurna esterna filtra attraverso le immense vetrate istoriate e si trasforma.
I colori delle vetrate
I pittori e i costruttori di vetrate scelgono liberamente, cioè senza l’intento di imitare la natura, i colori e le forme per dar vita alle loro figure. Ori, azzurri smaltati, rossi accesi e verdi intensi esprimono l’idea del soprannaturale attraverso il loro splendore sma-
gliante. Entrare in una cattedrale significa acce-dere alla dimensione del sacro. Il portale è il limite tra il mondo consueto e un ambito che favorisce
Le vetrate della cattedrale di Saint-DenisL’arte gotica si diffonde tra il XII e il XV secolo. Si basa sullo slancio verticale degli edifici, su linee «percorse da un’audacia folle e inesausta», sull’arco a sesto acuto e su trafori, guglie, pinnacoli e vuoti, sulla tensione verso la luce: le finestre a vetri sono scritture divine che riversano nella chiesa la luce di Dio, il vero sole, illuminando il cuore dei fedeli. «Anche visti da lontano questi edifici miracolosi parevano proclamare la gloria del cielo» (E. Gombrich). Il gotico nasce in Francia – alcuni esempi sono l’abbazia di Saint-Denis, le cattedrali di Chartres, di Parigi e di Strasburgo – poi si diffonde con forme diverse nel resto dell’Europa. Le vetrate della cattedrale di Saint-Denis vengono commissionate dall’abate Suger e sono eseguite da maestranze di diversa provenienza. Egli fa incidere sul portale centrale della chiesa una frase ripresa da Giovanni Scoto Eriugena: «L’opera nobile risplende, ma l’opera che così risplende in modo nobile chiarifica le menti, affinché percorrendo attraverso le vere luci giungano alla vera luce, in cui Cristo apre la vera porta».

4© 2011 RCS Libri S.p.A./La Nuova Italia – A. La Vergata, F. Trabattoni, Filosofia, cultura, cittadinanza
unità 7 LafilosofianelMedioevo
La luce fra filosofia e arte intrecci
nel fedele l’elevazione verso Dio, perché lo avvia ai valori trascendenti attraverso le immagini e i segni inscritti all’interno. Si esce dal mondo modesto, disa-dorno e un po’ incolore del quotidiano e, la domeni-ca (nel giorno del Signore), si entra in una dimensio-ne risplendente di sfavillanti colori. I fedeli vivono, allo stesso tempo, una sensazione estetica e spiritua-le, che li spinge a riflettere sulla propria misera con-dizione e li invita a sperare in un riscatto futuro.
La pitturaGiotto: una
pittura nuova La fama di Giotto in breve tempo conquista l’Euro-
pa e per la prima volta il nome di un artista diventa così noto. Mentre il Medioevo per lo più ignora l’identità dei maestri delle sculture delle cattedrali di Chartres o di Strasburgo, relegandoli al rango di meri esecutori tecnici (la pittura e l’architettura era-no concepite come artes mechanicae), con Giotto si inaugura un nuovo capitolo nella storia dell’arte.
La poesiaL’illuminazione
come esperienza estetica
e salvifica
Nella Commedia di Dante Alighieri (1265-1321) il viaggio dal buio dell’inferno allo splen-dore assoluto del paradiso è un percorso di purificazione e un’ascesa verso l’illuminazione. Questa esperienza nei regni dell’oltretomba è una forma di itinerarium mentis in Deum (viaggio della mente verso Dio) sulla scia dei mistici: riscatta l’uomo facendolo elevare dal buio del peccato alla contemplazione dello splendore trinitario.
Nel Paradiso risultano chiarissime le tracce di una metafisica della luce, intesa alla maniera dei teologi. Il paradiso è presentato come il regno della luce per eccellenza; nel canto XXX è descritto lo splendore divino, il lumen della grazia. Siamo di fronte a una claritas trionfante.
O isplendor di Dio, per cu’io vidil’alto triunfo del regno verace,dammi virtù a dir com’io il vidi!lume è lassù, che visibile facelo Creatore a quella creaturache solo in lui vedere ha la sua pace; [...] Fassi di raggio tutta sua parvenzareflesso al sommo del mobile primo,che prende quindi vivere e potenza.
[Paradiso, canto XXX, vv. 97-108]
Giotto, La fedeGiotto (1267-1337) deve molto agli scultori delle grandi cattedrali nordiche. Ad esempio nella Fede (cappella degli Scrovegni a Padova, 1305 ca.) è facile verificare quanto riprenda dai maestri della scultura gotica. Attraverso abili giochi di luce (i chiaroscuri) e una riproposizione della scatola spaziale, questa pittura riesce a ingannare l’osservatore dando l’impressione di una scultura a tutto tondo. Si tratta della riscoperta della profondità in pittura, un concetto perduto da secoli. È l’inizio di una vera e propria rivoluzione.