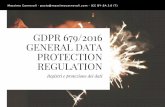UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ... statistiche e registri di imprese, popolazione...
Transcript of UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA’ DI ... statistiche e registri di imprese, popolazione...

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
TESI DI LAUREA
Il riutilizzo della Public Sector Information tra diritti di proprietà intellettuale e privacy dei cittadini.
Candidato: Ilaria Buri Relatori: Chiar.mo prof. M. Ricolfi Matricola 254144 Chiar.mo prof. U. Pagallo
Anno Accademico 2008/2009

Rivolgo un sincero ringraziamento al prof. Marco Ricolfi e al prof. Ugo Pagallo per aver accolto l’idea di questa esperienza di tesi, sostanziando il mio lavoro di preziosi suggerimenti e fiducia. Ringrazio inoltre il Centro Nexa per Internet e Società del Politecnico di Torino per i numerosi spunti e la lungimiranza delle sue iniziative. Infine, i miei genitori, per il paziente sostegno, e tutti gli amici, assieme al loro entusiasmo sorridente. Al caro ricordo di mio nonno.

They hang the man and flog the woman That steal the goose from off the common, But let the greater villain loose That steals the common from the goose. […] The Law locks up the man or woman Who steals the goose from off the common, And geese will still a common lack Till they go and steal it back.
Versi popolari inglesi, 1764 ca.

INDICE
Introduzione pag.
1. Dal diritto di accesso alle opportunità di riutilizzo dell’informazione pubblica pag. 1
1.1. Verso una cornice normativa europea
1.1.1. La Public Sector Information: nozione e potenzialità
1.1.2. I lineamenti essenziali della politica americana di disseminazione
dell’informazione pubblica
1.1.3. L’Unione Europea: dalle Linee Guida del 1989 al Libro Verde del 1998
1.1.4. La proposta di una direttiva (2002)
1.2. Basi giuridiche del diritto d’accesso all’informazione pubblica
1.2.1. L’accesso all’informazione detenuta dal settore pubblico: un diritto
fondamentale?
1.2.2. La legislazione europea sull’accesso: omogeneità e differenze
1.3. La direttiva 98/2003/CE sul riutilizzo dell’informazione pubblica
1.3.1. Oggetto e ambito di applicazione
1.3.2. La definizione di “settore pubblico” e le tipologie di informazione
governativa
1.3.3. Politiche tariffarie e rispettivo impatto economico
1.3.4. Gli istituti pro-concorrenziali nella disciplina del riutilizzo
2. I diritti di proprietà intellettuale sulla PSI e le licenze di utilizzo
2.1. I dati pubblici e la tutela del diritto d’autore
2.2. L’informazione governativa e la direttiva 96/9/CE: un diritto sui generis sulle
banche dati pubbliche?
2.3. Informazione pubblica e pubblico dominio
3. Le licenze Creative Commons: un modello applicabile all’informazione pubblica?
3.3.La diffusione dell’informazione pubblica sotto licenza Creative Commons:
inquadramento generale
3.4.La compatibilità delle licenze Creative Commons con la normativa sull’accesso
alla PSI

3.5.La compatibilità delle licenze Creative Commons con la normativa sul
riutilizzo della PSI
4. Riutilizzo della PSI e diritti fondamentali: riflessioni sul diritto alla privacy
4.3.Premessa
4.4.Le filosofie della privacy
4.5.Accesso documentale e tutela della privacy: la soluzione legislativa al
potenziale conflitto
4.6.Riutilizzo della Public Sector Information e la tutela della privacy
4.6.1. L’implementazione della direttiva 2003/98/CE e la tutela della privacy
4.6.2. Il riutilizzo della PSI e i principi generali del trattamento dei dati
personali
4.6.3. I limiti del riutilizzo: a tutela dei dati personali oggetto di riutilizzo
4.6.4. (Segue): a tutela della qualità dei dati nella regolazione della privacy
4.7.Registri pubblici e mercato dell’informazione: alcuni significativi casi di
riutilizzo commerciale di informazioni personali
4.7.1. L’utilizzazione per finalità commerciali e di marketing dei dati
personali contenuti nelle liste elettorali, negli atti anagrafici e negli atti
dello stato civile
4.7.2. I casi Kehoe (US) e Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA (UK)
4.7.3. (Segue): lo sfruttamento commerciale dei dati personali tra tutela della
privacy e sicurezza nazionale
Conclusioni ……………………………………………………………………………... pag. 81
Bibliografia ……………………………………………………………………………... pag. 86

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
1
INTRODUZIONE
Il settore pubblico appare come il maggiore singolo produttore e detentore di una
vasta mole di informazioni, suscettibile, nel suo complesso, di varie forme di
riutilizzo - anche in senso commerciale – e caratterizzata da elementi che ne
determinano la peculiarità rispetto all’informazione che trova origine in fonti di
diversa natura.
Nell’insieme della c.d. Public Sector Information (PSI), che può essere suddivisa
in molteplici categorie, certamente confluiscono, tra le altre voci, carte
geografiche ed immagini satellitari, dati meteorologici, legislazione e
giurisprudenza, statistiche e registri di imprese, popolazione e brevetti1. Tali
informazioni si collocano alla base di svariati prodotti e servizi offerti ogni giorno
ai cittadini europei, quali i sistemi di navigazione, le previsioni meteorologiche o i
servizi finanziari e assicurativi.
La centralità dell’informazione pubblica poggia non soltanto su elementi relativi
alle opportunità di attiva partecipazione della cittadinanza nelle dinamiche
politiche e sociali di un contesto autenticamente democratico, ma anche, ed in
maniera crescente, sul potenziale economico che essa rappresenta per l’attività
delle imprese.
Internet, infatti, ha radicalmente cambiato il modo in cui imprese e cittadini
possono accedere e riutilizzare l’informazione pubblica, consentendo di aggregare
contenuti provenienti da varie fonti e creando così valore aggiunto: è quanto
1 Rispetto alle frazioni di mercato corrispondenti a ciascuna categoria, si rimanda ai diagrammi di Pira International, Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Information – Final Report, European Commission, Directorate General for the Information Society, Brussels, 2000, p. 10, e a quelli dello studio Micus, che analizzano con particolare precisione la situazione delle imprese europee che si occupano dell’elaborazione delle tre tipologie di informazione più redditizia in termini di riutilizzo: quella geografica, quella meteorologica e infine quella di tipo legale-amministrativo. V. MICUS Management Consulting GmbH, Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information Sectors, 2009, p. 13 ss. Si rinvia altresì, per un’illustrazione sintetica della questione, alla brochure realizzata nel 2004 su iniziativa della Commissione Europea: v. European Commission, Directorate General for the Information Society, Exploiting the Potential of Europe’s Public SectormInformation, 2004, disponibile all’indirizzo web: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/brochure/psi_brochure_en.pdf.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
2
accade con le informazioni sul traffico in tempo reale, le previsioni
meteorologiche inviate direttamente sui telefoni cellulari e i servizi di rating. Si
tratta di prodotti e servizi basati interamente, o in parte, sull’informazione del
settore pubblico, che agiscono nella direzione di accrescere la competitività e di
creare nuovi posti di lavoro, sfide ineludibili, entrambe, affinché l’Unione europea
possa muoversi come attore di primo piano nell’ambito dell’attuale società
dell’informazione.
Il valore del mercato dell’informazione del settore pubblico nell’UE si aggira
attorno ai 27 miliardi di euro2, ossia quattro volte il mercato dei servizi di roaming
per la telefonia mobile, il che dimostra come i contenuti del settore pubblico
svolgano un ruolo trainante per l’economia nell’era digitale. Si tratta, in ogni caso,
di un segmento di mercato poco più che modesto se confrontato con il fatturato
medio annuale dell’industria dell’informazione statunitense, il cui riuso,
tradizionalmente, è incoraggiato da una politica che non contempla diritto
d’autore sull’informazione pubblica, si astiene dall’imporre restrizioni alle
modalità di riutilizzo, anche commerciale, dei dati pubblici e limita le tariffe
imposte a tali operazioni ai soli costi di riproduzione e diffusione.
Dopo quasi un quindicennio di dibattiti in sede comunitaria, inaugurati dalle Linee
Guida del 19893, è stata approvata, il 17 novembre 2003, la direttiva 2003/98/CE4,
che ambisce a tracciare una disciplina generale per il riutilizzo, “in condizioni
eque, adeguate e non discriminatorie”, dei documenti del settore pubblico, tenuto
conto delle profonde differenze che la Commissione ha riscontrato tra gli Stati
membri nella disciplina dello sfruttamento delle risorse informative. I quindici
articoli della direttiva fissano norme in materia di non discriminazione,
2 HELM (UK), ZENC (NL), Mepsir Study (Measuring European Public Sector Information Resources), Final Report of Study on Exploitation of Public Sector Information –benchmarking of EU framework conditions, 2006. Mantengono rilievo anche le risultanze dello studio PIRA, finanziato dalla Commissione Europea e pubblicato nell’ottobre del 2000, ha valutato il valore annuale della PSI europea in 68 miliardi di euro, pari a circa l’1% del prodotto interno lordo dell’Unione Europea, a fronte di un investimento statale di 9,5 miliardi di euro. 3 EUROPEAN COMMISSION, Guidelines for Improving the Synergy between the Public and private Sectors in Information Market, 1989. 4 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, G.U.U.E. L 345 del 31 dicembre 2003. Sul complesso percorso legislativo di cui è frutto la direttiva: v. JANSSEN K., DUMORTIER J., Towards a European Framework for the Re-Use of Public Sector Information: A Long and Winding Road, International Journal of Law & Information Technology, vol. 11, n. 2, 2003, p.184-201; PAS J., RECHTEN L., The commercialization of Government Information and the

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
3
tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti tecnici che
facilitano la ricerca e il riutilizzo dei documenti pubblici.
Accanto ad ostacoli di natura tecnica che - impedendo ai soggetti riutilizzatori di
verificare preliminarmente la consistenza della “materia prima” e di calibrare
investimenti e piani di sviluppo - risultano impeditivi del riuso, una delle questioni
giuridiche più complesse in materia è rappresentata, indubbiamente, dai diritti di
proprietà intellettuale in capo alle amministrazioni pubbliche sull’informazione da
essi prodotta.
Il testo della direttiva non affronta direttamente il tema del conflitto tra i diritti di
proprietà intellettuale sull’informazione di cui il settore pubblico è titolare e
l’impegno a consentire il riutilizzo della stessa: la direttiva, infatti, lascia
impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale esistenti in capo agli enti pubblici,
ma, allo stesso tempo, sollecita gli enti medesimi ad esercitare detti diritti in
maniera tale da favorire il riutilizzo.
Ciò ha richiamato, dunque, la necessità di una riflessione sul tema del diritto
d’autore sull’informazione pubblica, a partire dalle disposizioni della
Convenzione di Berna, e tenendo presenti le differenze di principio, sul punto, tra
la tradizione dell’Europa continentale, degli Stati Uniti e dei paesi c.d. di Crown
copyright. L’analisi del menzionato tema, assieme alla riflessione circa la
configurabilità o meno di un diritto sui generis sulle banche dati pubbliche, è stata
infine raccordata al dibattito, più generale, sui contorni dell’ambito di pubblico
dominio, ingiustamente erosi, secondo alcuni studiosi, dalle iniziative di
commercializzazione della PSI.
Di qui l’interesse e l’utilità di un confronto con le esperienze dei principali paesi
dell’UE sugli schemi adottati in seguito alla trasposizione della direttiva, con una
particolare attenzione alle opzioni risultanti dall’adozione di modelli informativi
più “aperti”, sulla base dei quali rifondare paradigmi alternativi di gestione dei
diritti esclusivi sulla PSI. Oggetto privilegiato d’indagine è, in particolare, lo
studio della compatibilità, e dunque della adattabilità, del modello di licenze
Creative Commons - affiancato all’analisi degli altri più diffusi sistemi a base
open-content, quali Click-Use, Creative Archive, AEShareNET e GNU - al regime
Proposal for a Directive (2002) 207 by the European Commission, Murdoch University Electronic Journal of Law, vol. 9, n. 4, 2002.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
4
d’accesso e di riutilizzo dell’informazione pubblica, attraverso un’analisi
comparata delle principali iniziative adottate, in questa direzione, in ambito non
soltanto europeo e, altresì, mediante un esperimento di ricerca focalizzato sullo
specifico contesto italiano.
Oltre alla questione dei diritti di proprietà intellettuale, altro tema giuridico di
primaria importanza in materia di riuso della PSI è rappresentato dalla necessità di
realizzare un contemperamento tra la legislazione sul riutilizzo, quale definita
dalla direttiva 2003/98/CE, e il complesso normativo attinente alla protezione dei
dati personali, che detta direttiva fa salva per intero. Lo studio della tutela della
privacy nel riutilizzo della PSI, che costituisce un ambito di relativa novità, si
muove dunque tra i pareri resi, sul punto, dall’autorità garante per la tutela dei dati
personali (e da omologhe autorità europee), l’esame delle disposizioni
fondamentali del Codice della privacy (d. lgs. 196/2003) e la valutazione
dell’applicabilità di strumenti giuridici, quali apposite licenze di riutilizzo, rispetto
agli obiettivi di tutela dei dati personali.
In conclusione, la finalità prima del presente lavoro è di tracciare un quadro
generale dell’attuale normativa europea in materia di riutilizzo della PSI, ponendo
in particolar modo sotto la lente d’ingrandimento, da un lato, la questione
dell’esistenza e della gestione dei diritti di proprietà intellettuale di cui sia titolare
il settore pubblico, e, dall’altro, il tema della tutela della privacy nell’ambito delle
iniziative di riutilizzo - commerciale o non commerciale – dell’informazione a ciò
resa disponibile.
L’indagine in oggetto si propone, altresì, di descrivere lo stato del riutilizzo
dell’informazione pubblica a seguito dell’implementazione della direttiva
2003/98/CE, richiamando progetti ed iniziative adottate nei principali Stati
membri al fine di chiarire le modalità del riuso e di favorire, allo stesso tempo,
trasparenza democratica e crescita economica.
Quanto alla selezione delle fonti, si è scelto di non limitarsi alla dottrina - peraltro
non ancora nutrita, data la novità dei temi in argomento – bensì di privilegiare
studi istituzionali e accademici, di ambito tanto europeo quanto extraeuropeo:
proprio l’insieme delle menzionate ricerche, infatti, ha rivestito un ruolo
fondamentale nello sforzo di disegnare l’attuale stato dell’arte e di evidenziare su
quali direttrici dovrebbe svilupparsi una politica sensibile alle esigenze di imprese

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
5
e di privati intenzionati ad attingere a quella che può, a buon diritto, essere
definita un’autentica “miniera “ informativa.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
6
Capitolo primo
Dal diritto di accesso alle opportunità di riutilizzo
dell’informazione pubblica
1.1. Verso una cornice normativa europea
1.1.1. La Public Sector Information: nozione e potenzialità
Nell’ambito dell’odierna società della conoscenza5 il bene “informazione” è
venuto da tempo a configurarsi come elemento chiave trainante e materia prima
preziosissima, in ragione soprattutto delle crescenti opportunità di raccolta,
conservazione, elaborazione e scambio rese possibili dallo sviluppo delle
Information and Communication Technologies.
In particolare, il settore pubblico appare come il maggiore singolo produttore e
detentore di una vasta mole di informazione, suscettibile, nel suo complesso, di
varie forme di riutilizzo, anche in senso commerciale, e caratterizzata da elementi
che ne determinano la peculiarità rispetto all’informazione che trova origine in
una fonte di diversa natura. La considerazione della affidabilità e completezza
dell’informazione pubblica, infatti, deriva in primis dall’essere collezionata con
metodo sistematico da un attore percepito come neutrale; inoltre, essa appare
adatta ad analisi sul lungo periodo, poiché raccolta in maniera continuativa
durante tempi di norma piuttosto prolungati.
5 L’aforisma baconiano “Sapere è potere” pare più che mai attuale, per quanto riferito prettamente al processo di disvelamento degli “ingranaggi” della natura e alla conquista tecnologica della stessa, v. F. BACON, Meditationes Sacrae. De haeresibus, 1597; sulla centralità dell’informazione nella società attuale, si rimanda altresì a W. MOCH, On the Centrality of Information Law: a rational discussion on information law and transparency, John Marshall Journal of Computer and Information Law , 1999, p. 1074 e P. BIRKINSHAW, The Importance of Information, in Freedom of Information. The law, the practice and the ideal, II edition, Buttherworths, London, 1996, pp. 14-18.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
7
L’insieme della c.d. Public Sector Information (PSI) può essere suddiviso in
diverse categorie: informazione legale, in cui confluiscono materiale legislativo e
giurisprudenziale; informazione sociale, avente ad oggetto analisi demografiche e
dei comportamenti di consumo, ma anche statistiche in materia sanitaria;
informazione politica, quali conferenze stampa degli organi di governo, proposte e
consultazioni pubbliche; informazione geografica, di taglio innanzitutto
cartografico e catastale; informazione meteorologica; informazione economica, ivi
inclusi i dati sulle imprese detenuto dalle Camere di commercio o altri registri
pubblici delle imprese; informazione di tipo turistico o in materia di marchi e
brevetti; informazione scientifica e culturale6.
Tale complesso di informazione, da un lato, riveste un’importanza pressoché
vitale in relazione all’attiva partecipazione della cittadinanza in un contesto
democratico, non potendosi scindere le opportunità di intervento nelle dinamiche
politiche, sociali ed economiche dalla possibilità concreta di accedere e di
elaborare la documentazione relativa ai citati processi.7
D’altra parte, la centralità dell’informazione pubblica poggia non soltanto su
considerazioni relative ad elementi coessenziali alla struttura democratica, ma
anche, e in maniera crescente, sul potenziale economico che essa rappresenta per
l’attività delle imprese.
6 Per un’idea della frazioni di mercato corrispondenti a ciascuna categoria, si rimanda ai diagrammi di Pira International, Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Information – Final Report, European Commission, Directorate General for the Information Society, Brussels, 2000, p. 10, e a quelli dello studio Micus, che analizzano con particolare precisione la situazione delle imprese europee che si occupano dell’elaborazione delle tre tipologie di informazione più redditizia in termini di riutilizzo: quella geografica, quella meteorologica e infine quella di tipo legale-amministrativo. V. MICUS Management Consulting GmbH, Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information Sectors, 2009, p. 13 ss. Si rinvia altresì, per un’illustrazione sintetica e schematica della questione, alla brochure realizzata nel 2004 su iniziativa della Commissione Europea: v. European Commission, Directorate General for the Information Society, Exploiting the Potential of Europe’s Public Sector Information, 2004, disponibile all’indirizzo web: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/brochure/psi_brochure_en.pdf. 7 Come osserva Yvo Volman, una PSI abbondante e agilmente accessibile facilita l’interazione della cittadinanza con le amministrazioni e incrementa la partecipazione della stessa nei processi democratici: se infatti è data al singolo l’opportunità di accedere ai siti degli enti pubblici per ottenere dettagliata informazione su ciò che è stato discusso e deliberato nell’ultima seduta di un determinato ente locale, questi potrà reagire in maniera pronta ed efficace. L’effettività dell’accesso all’informazione pubblica realizza, nel quotidiano del cittadino dotato di competenze informatiche anche minime, una molteplicità di benefici: dalla possibilità di evitare inutili code in attesa del documento errato a quella di aggirare gli ingorghi di traffico grazie ad una tempestiva informazione stradale. V. Y. VOLMAN, Expoitation of Public Sector Information in the Context of the eEurope Action Plan, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
8
La disponibilità di dati provenienti dal settore pubblico, infatti, può rivelarsi un
fattore-chiave oltre che nell’elaborazione di politiche di mercato o strategie
commerciali di successo8, anche nei procedimenti decisionali delle imprese stesse,
in particolare se operanti su scala transnazionale. Basti pensare al forte interesse
che una catena di supermercati può nutrire nei confronti dei profili tracciati da un
istituto pubblico di statistica in ordine ai comportamenti d’acquisto dei
consumatori, o alla necessità, per un impresa che intenda partecipare ad una gara
d’appalto all’estero, di un’informazione approfondita e affidabile circa le regole
procedurali e il contesto locale.
L’informazione del settore pubblico si caratterizza però, soprattutto, come materia
prima fondamentale per lo sviluppo di prodotti e servizi a valore aggiunto nel
contesto di un mercato attualmente in forte espansione: il mercato europeo
dell’informazione.
Lo studio PIRA9, finanziato dalla Commissione Europea e pubblicato nell’ottobre
del 2000, ha valutato il valore annuale della PSI europea in 68 miliardi di euro,
pari a circa l’1% del prodotto interno lordo dell’Unione Europea, a fronte di un
investimento statale di 9,5 miliardi di euro. Secondo lo studio MEPSIR10,
anch’esso svolto per iniziativa della Commissione durante la fase di
implementazione negli Stati membri della direttiva 98/2003/CE sul riuso
dell’informazione pubblica, il valore medio annuale del mercato
dell’informazione pubblica nell’Unione europea si aggirerebbe invece sui 27
miliardi di euro, ossia quattro volte il mercato dei servizi di roaming per la
telefonia mobile.
Si tratta in entrambi i casi di segmenti di rilievo dell’economia europea, il cui
valore, però, è poco più che modesto se confrontato con il fatturato medio annuale
dell’industria dell’informazione statunitense, pari a 750 miliardi di euro (9% del
PIL), con un investimento pubblico di 19 miliardi di euro.
Information in the Digital Age. Between Markets, Public Management and Citizens’ Rights, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2004, p. 94. 8 Ibidem. 9 Pira International, Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Information – Final Report, cit. 10 HELM (UK), ZENC (NL), Mepsir Study (Measuring European Public Sector Information Resources), Final Report of Study on Exploitation of Public Sector Information –benchmarking of EU framework conditions, 2006.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
9
La sproporzione tra i due mercati dell’informazione, a fronte di economie
pressoché equivalenti, sarebbe riconducibile ad una politica americana forte e
risalente in tema di libero accesso all’informazione federale, che non contempla
l’esistenza di copyright sulla stessa informazione pubblica e che non riconosce la
dicotomia, propria della sensibilità europea, tra diritto d’accesso, da un lato, e
disseminazione attiva e commercializzazione dall’altro.
1.1.2. I lineamenti essenziali della politica americana di disseminazione
dell’informazione pubblica
Il mercato americano dei prodotti e servizi di informazione si connota, sia a livello
pubblico sia a livello privato, per una ricchezza e vitalità che al momento non
conoscono pari in nessun altro paese e neppure, come detto, nell’Unione Europea
intesa nel suo complesso.
La politica statunitense in materia di accesso all’informazione federale, che si
realizza nell’assenza di copyright sulla stessa e nella tariffazione a costi marginali
e che, altresì, sfocia in opportunità di riutilizzo pressoché prive di limitazioni,
trova la sua configurazione attuale verso la metà degli anni novanta, quando
Internet, imponendosi come il principale strumento di accesso e di diffusione
dell’informazione, rovescia gli assetti tradizionali delle politiche di Public Sector
Information.
In linea con tale orientamento e a compimento della c.d. “Open Goverment
Initiative”, l’amministrazione Obama ha annunciato, ai primi di ottobre del 2009,
di voler procedere alla digitalizzazione e alla messa on-line del più importante
giornale ufficiale del governo federale degli Stati Uniti: il Federal Register. Una
svolta battezzata dalla Casa Bianca “Federal Register 2.0”, affidata al Government
Printing Office e alla National Archives and Records Administration e finalizzata,
nel suo complesso, ad utilizzare le potenzialità delle nuove tecnologie per rendere
più trasparente l’azione di governo11.
11 Il Federal Register (pubblicato dal marzo del 1936) contiene tutti gli atti amministrativi, le decisioni delle authorities federali e anche le proposte di riforma di leggi e regolamenti. Federal Register 2.0 ha già una finestra aperta, accessibile sul sito www.gpo.gov; l'ultima edizione degli aggiornamenti del Federal Register nel 2008 era arrivata a contenere 32.000 documenti, pari a 80.000 pagine: il formato digitale consentirà di compattarne il volume e al tempo stesso di creare degli strumenti di accesso selettivo e motori di ricerca per semplificare la raccolta delle

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
10
Oltre al citato obiettivo di ridurre il deficit democratico tra istituzioni e
cittadinanza, la finalità dell’approccio statunitense è, da un lato, quella di sottrarre
i privati ad un duplice pagamento dell’informazione in possesso del settore
pubblico - giacché la produzione della stessa è finanziata attraverso la
contribuzione fiscale - e, dall’altro, quella di incoraggiare in maniera decisa le
imprese alla creazione di prodotti e servizi a valore aggiunto, frutto della
rielaborazione e del repackaging di una risorsa informativa pubblica
autenticamente accessibile e disponibile.12
Non è un caso, infatti, che lo studio Micus13 del 2009, rilevi, in relazione al
riutilizzo dell’informazione meteorologica, che molte delle imprese europee del
settore ottengono detta informazione di base dalle agenzie statunitensi quali il
NCEP (National Centres for Environmental Prediction) o il NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration), poiché i dati da esse forniti sono
sensibilmente più economici -quando non addirittura gratuiti- e particolarmente
accurati anche rispetto all’area europea14.
notizie. Per maggiori informazioni sull’iniziativa, si rimanda a: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/White-House-Announces-Federal-Register-20-Transforming-the-Chronicle-of-the-Executive-Branch-for-the-21st-Century/. 12 Particolarmente incisiva, sul punto, la posizione di James LOVE, citato in: U.S. Congress, Senate, Committee on Rules and Administration, Public Access to Government Information in the 20th Century, 104th Cong., 2nd sess, 1996, pp. 78, 88; “Innovative and efficient private firms will find ways to sell information products in electronic formats, as they have for hundreds of years in paper formats. The freedom to publish Federal information will prevent abuses far more efficiently than a policy of denying public online access to Government databases. […] It is the freedom to publish which protects the information industry. If the Government publishes something, and the information company can’t compete with the Government, I don’t think I have any compassion for the private sector. If they can’t put the information in a more valuable and interesting way than the Government, it is not a problem. But believe me, they will. In fact, they will flourish even more.”; si veda, anche, H. CAWS-ELWITT, Copyright, Competition and Reselling of Government Information: Impact on Dissemination, Katharine Sharp Law Review, n. 7, 1998, pp. 1-10. 13 MICUS Management Consulting GmbH, Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information Sectors, 2009. 14 Ivi, p. 45-48; condizioni di licenza più favorevoli agli utenti e un tetto massimo tariffario corrispondente al costo marginale di riproduzione e trasmissione incoraggiano i providers di servizi meteo europei a procurarsi i dati dalle agenzie statunitensi anziché dai rispettivi enti meteorologici nazionali. Lo studio Micus cita l’esempio di un’impresa tedesca operante nel campo, che nel 2007 ha ottenuto il 99, 87% dei suoi 4.300 Gigabytes di informazione meteorologica dai servers dei servizi meteo americani. Nonostante la relativa prosperità del settore in Germania, con più di 25 imprese private che si occupano di fornire servizi meteo, la Deutscher Wetterdienst, agenzia meteorologica nazionale, è oggetto di forti critiche da parte degli operatori privati, che lamentano il rifiuto dell’ente statale a rendere disponibili determinate categorie di dati e importanti immagini radar, anche a fronte di pagamento.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
11
I fondamenti costituzionali e legali della politica statunitense di diffusione
dell’informazione federale possono essere rintracciati in quattro fondamentali atti:
il Primo Emendamento della Costituzione americana, il Freedom of Information
Act del 1966, il Copyright Act e infine il Paperwork Reduction Act, negli
emendamenti apportati nel 199515.
Il Primo Emendamento alla Costituzione16 costituisce l’inevitabile sfondo di ogni
dibattito che abbia ad oggetto la circolazione delle idee e delle informazioni;
sebbene tale norma non si occupi, nello specifico, di regolare la questione
dell’accesso all’informazione governativa, essa fissa saldamente il principio –
oggetto, nei secoli, di elaborate interpretazioni giurisprudenziali - per cui il
Congresso deve astenersi dal limitare la libertà di parola e di stampa. Lo sviluppo
di un principio costituzionale di accesso agli atti dell’esecutivo, sulla base del
Primo Emendamento, non ha avuto luogo soprattutto in ragione del fatto che i
contorni di una simile procedura sono definiti dal Freedom of Information Act
(FOIA); d’altra parte, poiché quest’ultimo non regola l’accesso agli atti giudiziari,
di norma viene richiamato sul punto il Primo Emendamento.17
Il Freedom of Information Act (FOIA)18, emanato nel 1966, consente ad ogni
singolo l’accesso totale o parziale ai documenti in possesso del governo federale.
Naturalmente, le agenzie governative possono avvalersi di una serie di eccezioni,
tese a difendere legittimi interessi pubblici o privati: si tratta delle nove eccezioni
elencate nel titolo 5, sezione 552, dello United States Code, tra le quali
In particolare, le imprese che operano il riutilizzo dei suddetti dati lamentano che tale situazione darà luogo a meccanismi di sostituzione sempre più massiccia dei dati: si avrà, ad esempio, la sostituzione di immagini tratte dai servizi satellitari europei (quali Meteosat o Meteop) con immagini provenienti da fonti statunitensi (ad es., satelliti NOAA) disponibili senza restrizioni. Secondo gli operatori privati, in conclusione, le citate politiche messe in atto dalla Deutscher Wetterdienst costituirebbero un innegabile freno allo sviluppo del mercato tedesco dei servizi meteo. 15 Cfr. R. GELLMAN, The Foundations of United States Government Information Policy, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 123-134. 16 Il Primo Emendamento alla Costituzione Americana, contenuto nel Bill of Rights, recita quanto segue: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”. 17 R. GELLMAN., Public Records -Access, Privacy and Public Policy, Government Information Quarterly, vol. 12(4) 1995, pp. 391-426. 18 Il “Freedom of Information Act” viene firmato il 6 settembre 1966 dal presidente Lyndon B. Johnson ed entra in vigore l’anno successivo; gli emendamenti più significativi sono stati apportati negli anni 1996, 2002 e 2007.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
12
innanzitutto figurano documenti rilevanti ai fini della sicurezza nazionale, segreti
in materia commerciale e dati personali.
Il FOIA rappresenta un punto fondamentale nell’elaborazione di una cultura di
accessibilità e trasparenza rispetto ai documenti governativi; è infatti comune
prassi della maggioranza delle agenzie federali procedere alla disseminazione
attiva e selettiva della documentazione in loro possesso, potendo ormai avvalersi
della Rete come del più efficace degli strumenti di diffusione dei dati pubblici.
Inoltre, se un tempo le agenzie potevano opporre un rifiuto pressoché arbitrario di
fronte ad una richiesta di accesso, dal 1966 la negazione dell’accesso può essere
appellata di fronte al vertice dell’agenzia e quindi presso le corti competenti.
La natura del FOIA è, dunque, quella di legge sull’accesso, almeno fino al 1996,
quando gli Electronic FOIA Amendments19 hanno imposto alle agenzie federali di
intensificare la disseminazione attiva delle informazioni (attraverso la
pubblicazione su carta, nastri magnetici, cd-rom e Internet) e di allestire apposite
reading rooms all’interno dei propri siti web, soprattutto rispetto ai documenti
l’accesso ai quali sia sollecitato da una molteplicità di cittadini.
Infine, fatta salva la possibilità della cessione delle informazioni a titolo gratuito,
il FOIA consente alle agenzie di rendere disponibili i documenti dietro
versamento di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di riproduzione e
diffusione, vietando dunque di ricorrere al prezzo di mercato per la
determinazione del prezzo delle informazioni cedute.20
Il terzo pilastro della politica americana di diffusione dell’informazione
governativa è rappresentato dal Copyright Act21 del 1976, che esclude dall’ambito
di protezione del copyright qualsiasi documento di origine federale e colloca detta
informazione nell’area del pubblico dominio, ponendosi pertanto in una relazione
19 United States House of Representatives Committee on Government Operations, (1996), Electronic Freedom of Information Amendments of 1996, H.R. Rep. No. 104-795. 20 In generale, per gli operatori dei mezzi di informazione e delle strutture educative, o per scopi scientifici senza fini commerciali, la tariffazione è limitata ai costi di riproduzione; per riutilizzo a fini commerciali la tariffazione è invece proporzionale ai costi di raccolta, riproduzione e revisione. Infine qualora il rilascio dei documenti sia di evidente interesse pubblico, la cessione può avvenire in assenza totale di costi applicati. V. QUINTON C. G., Access to European Public Sector Information: Reconciling the Access Needs of Administrative Transparency and the Information Market, Cardozo Electronic Law Bulletin, vol.3 (18)1997. 21 An Act for the general revision of the Copyright Law, title 17 of the United States Code, and for other purposes (Copyright law), Public Law nr. 94-553, 19 October 1976. Il Copyright Act del 1976 va ad emendare quello del 1909, modificando il titolo 17 dello United States Code e creando in esso le sezioni 101-810.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
13
di complementarietà rispetto al Primo Emendamento e al divieto, da esso
garantito, di interferenza governativa nella libera circolazione delle idee.
Al fine di illustrare efficacemente il potere di controllo e le limitazioni che
derivano dal riconoscimento di diritti di esclusiva sull’informazione governativa,
Gellman richiama un episodio avvenuto nel 1993 in Gran Bretagna, avente come
protagonista la Regina di Inghilterra. Il tradizionale discorso natalizio della
sovrana era stato registrato con anticipo dalla BBC, ma due giorni prima della
programmata trasmissione il quotidiano “The Sun” pubblicò il testo del discorso22.
I legali della regina dunque mossero azione legale contro il tabloid per violazione
del copyright: la controversia si sarebbe chiusa in tempi brevissimi con la
pubblicazione di una prima pagina di pubbliche scuse, il versamento di 200,000
sterline ad un’associazione di beneficenza, il pagamento delle spese legali della
regina e infine il ritiro degli accrediti della stampa rispetto ad alcuni eventi cui la
famiglia reale prense parte nel periodo seguente.
Osserva Gellman, riportando le reazioni della stampa americana23, che in una
situazione analoga il Presidente degli Stati Uniti non avrebbe potuto appellarsi alle
norme sul copyright per ottenere il risarcimento dei danni seguiti alla
pubblicazione non autorizzata di un discorso presidenziale fatto trapelare alla
stampa, essendo anch’egli vincolato alle previsioni del Primo Emendamento
relative alla libertà di stampa e di opinione. L’episodio mostrerebbe dunque
l’incidenza del copyright nel controllo del flusso di informazione ufficiale e nel
perseguimento di finalità sostanzialmente politiche, obiettivi entrambi soddisfatti
dal severo perseguimento delle condotte in violazione dei diritti di esclusiva.24
22 W.E. Schmidt, Queen Seeks Damages from Paper Over a Speech, New York Times, 3 February 1993; S.O’Shea, The Queen Accepts the Sun’s Pounds Sterling 200 000 Apology, Daily Mail, 16 February 1993; A. Hamilton, Editor Links BBC Worker to Leak of Royal Speech, The Times, 24 December 1992. 23 R. Perez-Pena, Chronicle, New York Times, 16 February 1993. 24 Scrive Gellman: “Another way to apply political criteria is through the selective use of remedies. Not all violations of a government copyright would necessarily be prosecuted. The government could choose to bring infringement actions only against those who hold different views. Consider copyright infringement brought by the Queen of England and discussed in the first paragraph of this article. Had the Queen's speech been reprinted by a newspaper viewed favorably by the Royal Family, the infringement action may not have been brought. Asking a government bureaucracy for a license to use copyrighted material could be as complex, time-consuming, and expensive as the bureaucracy the infringement action may not have been brought. … The process of licensing people to use copyrighted information offers additional methods of imposing controls on the use of the information.”, R. GELLMAN, Twin Evils: Government Copyright and Copyright-Like Controls over Government Information, Syracuse Law Review, (45)1995, pp. 999-1072.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
14
L’esplicita esclusione dalla protezione del copyright è in ogni caso limitata alla
documentazione federale, essendo per converso legittima la configurazione di
diritti di esclusiva sull’informazione dei singoli Stati.
La questione dell’eventuale contrasto tra le norme statali sull’accesso e le
disposizioni in materia di copyright si presenta come piuttosto complessa. La
significativa pronuncia di una corte d’appello federale25, risalente al 2001,
stabilisce che, sul punto, non sussiste alcun conflitto. Nello specifico, una contea
dello Stato di New York, nel quale vige un regime di libero accesso ai documenti
pubblici, aveva iniziato un’azione legale contro un’impresa di servizi di
informazione, contestando la violazione del copyright sulle proprie mappe
ufficiali in seguito alla ripubblicazione delle stesse senza autorizzazione. La corte
decise con sentenza che il copyright detenuto dalla contea conserva la sua validità
a dispetto delle norme statali sul libero accesso alle mappe: queste ultime, infatti,
non impediscono ad un’agenzia statale di porre delle limitazioni alla circolazione
di un documento sicuramente pubblico, ma comunque soggetto a copyright.
In secondo luogo va osservato come, in alcuni casi, le agenzie federali abbiano
ottenuto di esercitare un controllo assimilabile a quello derivante dal copyright: un
esempio è dato dalla National Library of Medicine (NLM), che per anni ha
limitato l’accessibilità al database contenente abstract di articoli medici,
giustificando l’applicazione di royalties26 con la necessità di evitare un uso
improprio dei materiali.
Nel 1996 gli Electronic FOIA Amendments hanno costretto la NLM ad aprire il
proprio database senza alcun costo e il mercato dell’informazione è tornato a
muoversi, significativamente, verso la struttura web dell’agenzia federale,
divenuta in breve uno dei siti in materia sanitaria più consultati dell’intera Rete.
L’ultimo fondamento normativo della c.d. information dissemination policy
americana è costituito dagli emendamenti del 1995 al Paperwork Reduction Act,
25 County of Suffolk v. Experian Information (2nd Cir. 25 July 2001), disponibile al seguente indirizzo: http://www.altlaw.org/v1/cases/1576048. 26 Il caso SDC v. Mathews, 542 F.2d 1116 (9th Cir. 1976) aveva consentito alla NLM di negare l’accesso al proprio database sulla base delle eccezioni del FOIA; nonostante tali limitazioni, e l’imposizione di royalties, il settore privato che si sviluppa attorno ai dati offerti dalla NLM conosce una costante crescita: gli utenti sono disposti a pagare tariffe più elevate di quelle imposte dall’agenzia statale in ragione di un software più potente e di migliori servizi di connessione e interrelazione ad altri database con contenuto analogo.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
15
che in quattro paragrafi illustrano nuovi requisiti per l’attività di diffusione
dell’informazione posta in atto dalle agenzie federali.
Se i primi tre paragrafi fondano le basi per un accesso effettivo, su base non
discriminatoria ed entro tempi ragionevoli, il quarto paragrafo impone invece alle
agenzie di astenersi da pratiche restrittive nell’attività di disseminazione.
Si tratta del divieto di restringere l’uso, la vendita e la ri-disseminazione
dell’informazione, anche attraverso accordi esclusivi di distribuzione, e della
proibizione di applicare a dette operazioni tariffe che superino il costo di
diffusione.
1.1.3. L’Unione Europea: dalle Linee Guida del 1989 al Libro Verde del 1998
A partire dalla metà degli anni ottanta, la Commissione Europea, sull’onda dei
rapidissimi sviluppi allora in atto nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e
osservando le strutture di base del fiorente mercato americano dell’informazione,
muove i primi passi nell’elaborazione di una cornice normativa finalizzata a
favorire il riuso e la commercializzazione27 della PSI europea.
Nel 1989 la Commissione pubblica una serie di Linee guida finalizzate a
migliorare la sinergia tra i settori pubblico e privato nell’ambito del mercato
27 Secondo quanto osserva Herbert Burkert, la commercializzazione dell’informazione del settore pubblico può essere considerata il punto culminante nel percorso di scoperta del valore dell’informazione. Sin dalla loro origine, infatti, le amministrazioni hanno documentato le proprie attività archiviando grandi moli di dati. Una distinta funzione informativa in capo allo Stato comincia a delinearsi con lo Stato liberale, dove l’informazione diventa necessaria per la pianificazione delle attività economiche e al fine di garantire la sicurezza. Ancora maggiore sarà la quantità di informazione richiesta dalle strutture dello Stato sociale e dalle relative assemblee parlamentari al fine di controllare l’attività amministrativa. Nel c.d. “Stato tecnologico”, infine, la disponibilità dell’informazione risponderà alla necessità di mettere a punto meccanismi di controllo del rischio: verranno fissati numerosi requisiti e norme di registrazione cui un apparecchio tecnologico deve rispondere per poter essere qualificato come sicuro. Tra la fine degli anni cinquanta e i primi anni sessanta prende a svilupparsi, negli USA, un’idea più ampia di Public Sector Information: i progressi nell’ambito delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione costringono infatti a prendere consapevolezza dell’enorme potenziale dell’informazione amministrativa e incoraggiano ulteriori e più accurate raccolte di dati. Le prime applicazioni di tipo informatico promettono di realizzare l’immagazzinamento di quantità di dati fino ad allora pressoché ingestibili, e scoprire relazioni di tipo inferenziale tra i diversi dati o categorie di dati. Si tratta dell’epoca dei “Planning, Programming and Budgeting Systems” e delle “National Data Banks”, dunque dell’idea di informazione come chiave per un migliore governo e una più efficiente amministrazione; ma l’interesse all’informazione è dovuto anche al particolare periodo storico e alla tensione politica della Guerra Fredda, di cui l’episodio del 1957 dello Sputnik (e il c.d., relativo, “Sputnik-Shock”) rimangono un simbolo. Si rimanda, sulla storia della Public Sector Information come risorsa programmabile e trasferibile, a H.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
16
dell’informazione28. L’obiettivo è in primo luogo quello di promuovere il
riutilizzo da parte del settore privato dell’informazione prodotta dalle
amministrazioni pubbliche nel compimento delle proprie funzioni istituzionali. Il
“settore pubblico” viene definito come comprensivo delle “pubbliche
amministrazioni centrali e locali, che amministrano e finanziano attività, di
natura essenzialmente commerciale, tese al beneficio della collettività, e delle
istituzioni i cui principali finanziamenti sono di provenienza pubblica”. Le
strutture controllate in tutto o in parte dal settore pubblico, ma operanti sotto
condizioni di mercato, vengono escluse dal campo d’applicazione delle Linee
guida.
La Commissione considera che le politiche tariffarie possono variare in relazione
alla natura dell’informazione e mantiene sul punto una posizione
complessivamente cauta: “il prezzo dovrebbe riflettere i costi di trattazione
dell’informazione e di diffusione della stessa al settore privato, ma non deve
necessariamente includere l’intero costo della sua raccolta nel corso delle
ordinarie attività amministrative. Quando l’informazione è considerata
necessaria ai fini dell’interesse pubblico, il prezzo può essere ridotto”. Sembra
dunque essere favorita una politica del costo marginale, ma di fatto non sono
escluse tariffazioni inferiori né superiori; questo atteggiamento prudente verrà
mantenuto durante gli anni fino alla formulazione della proposta di direttiva del
2002.
Le Linee guida saranno oggetto di critica e di considerazioni scettiche per una
molteplicità di ragioni: in primo luogo perché il bilanciamento tra pubblico e
privato appare marcatamente inclinato verso quest’ultimo, quindi per la scarsa
attenzione dedicata dalla Commissione alla relazione tra accesso all’informazione
del settore pubblico e sfruttamento commerciale della stessa.
Preso atto del sostanziale fallimento delle Linee guida, la Commissione Europea
finanzia tra il 1991 e il 1995 una serie di rapporti aventi ad oggetto l’esame del
rapporto tra settore pubblico e privato nel mercato europeo dell’informazione. Il
BURKERT, The Mechanics of Public Sector Information, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 4-5. 28 EUROPEAN COMMISSION, Guidelines for Improving the Synergy between the Public and private Sectors in Information Market, 1989.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
17
primo studio Publaw29 consiste in un’approfondita analisi della legislazione
europea in materia d’accesso; il secondo30 invece valuta l’impatto delle Linee
guida negli Stati Membri e, rilevato un livello di consapevolezza delle stesse
molto ridotto, raccoglie l’entusiasmo delle imprese private rispetto al progetto di
una direttiva che regoli gli accordi tra settore pubblico e privato, al fine di
rafforzare il mercato europeo dell’informazione di fronte alla fortissima
concorrenza statunitense.
Il terzo31 e ultimo studio Publaw, completato nel 1995, registra la mancanza in
quasi tutti gli Stati Membri di una politica generale di commercializzazione della
PSI e si conclude ribadendo l’urgenza di una normativa europea sul punto.
Nel giugno del 1996 la Commissione organizza a Stoccolma una conferenza dal
titolo “Access to public information. A key to commercial growth and electronic
democracy”, in occasione della quale sottolinea l’importanza della PSI nella
crescita economica e nella lotta alla disoccupazione ed esprime la necessità di
elaborare un Libro Verde entro la fine del 1996.
Solo due anni più tardi, nel 1998, la Commissione Europea pubblica il Libro
Verde sull’Informazione del Settore Pubblico nella Società dell’Informazione32, il
cui obiettivo è quello di “condurre un’ampia consultazione pubblica che
coinvolga tutti gli attori interessati, con uno sguardo alle principali questioni in
gioco, e di innescare una discussione politica a livello europeo”.
La prima questione affrontata dal Libro Verde riguarda la definizione di “settore
pubblico”, rispetto alla quale vengono suggeriti tre differenti approcci: quello
funzionale, secondo cui il settore pubblico comprende enti che hanno autorità o
compiti di pubblico servizio; quello legalista-istituzionalista, in virtù del quale
hanno carattere di settore pubblico solo gli enti esplicitamente elencati nelle leggi
29 Commission of the European Communities, Publaw: Subject report general access to information legislation, CEC Legal Advisory Board, Luxembourg, 1991. 30 Commission of the European Communities, Publaw 2: Draft final report Europe. A report to the Commission of the European Communities on an evaluation of the implementation of the Commission’s Guidelines for improving synergies between the public and private sectors of the information market, CEC Legal Advisory Board, 1993. 31 Commission of the European Communities, Publaw 3: Final report, CEC Legal Advisory Board, Luxembourg, 1995. 32 COMMISSIONE EUROPEA, Libro Verde sull’Informazione del Settore Pubblico nella Società dell’Informazione. L’Informazione del Settore Pubblico: Una Risorsa Chiave per l’Europa, COM(1998)585.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
18
ad essi relative; quello finanziario, che comprende tutti gli enti finanziati
principalmente da fondi pubblici, che non agiscono, quindi, secondo le normali
regole del mercato.33
A differenza delle Linee Guida, e in continuità con la Conferenza di Stoccolma, il
Libro Verde riallaccia il dibattito sullo sfruttamento economico dell’informazione
pubblica alla questione dell’accesso dei cittadini europei ai documenti detenuti
dagli enti pubblici. In particolare viene sollevata la questione se le differenze tra
Stati Membri, sul piano legale e tecnico, in materia d’accesso, costituiscano una
barriera allo sviluppo di un mercato europeo dell’informazione autenticamente
competitivo.
Si individuano grandi differenze tra Stati Membri, e persino tra enti di uno stesso
Stato Membro, in relazione alle politiche tariffarie, che si ritiene debbano tenere
conto di una molteplicità di interessi, tra cui l’accessibilità economica a tutti i
livelli, il potenziale di sfruttamento commerciale e meccanismi di leale
concorrenza. Altri ostacoli al riuso dell’informazione del settore pubblico sono
rappresentati da quei documenti protetti dalle norme sul diritto d’autore34 o
contenenti dati personali, secondo la nozione elaborata nell’ambito della Direttiva
del 199535 in ordine al trattamento e alla libera circolazione di tali dati.
Nel maggio del 1999 si tiene a Bruxelles una conferenza pubblica, in occasione
della quale si raggiunge una posizione unitaria sulla necessità di azioni volte a
intensificare l’accesso e lo sfruttamento dell’informazione del settore pubblico:
come già durante l’esperienza Publaw, l’industria privata pare sollecitare
Tale documento fu il risultato di un processo di consultazione, svoltosi tra il giugno del 1996 e l’inizio del 1998, che aveva coinvolto rappresentanti degli enti pubblici, dell’industria dell’informazione e delle associazioni di cittadini e di utenti. 33 Ne vengono comunque escluse le società di proprietà dello Stato che operano in condizioni di mercato e che sono soggette al diritto privato e a quello commerciale, che non rientrano in nessuna delle tre definizioni. Libro Verde, cit. 11. 34 Nella maggioranza degli Stati, i documenti ufficiali sono esclusi dalla protezione derivante dalle norme sul copyright, e in alcuni casi questa esclusione si estende al resto dell’informazione prodotta dal settore pubblico. Ciò nondimeno, l’eventualità della protezione attraverso diritti di esclusiva si fonda su due argomenti principali: l’opportunità per l’ente pubblico di trarre guadagno dalla cessione di informazioni e le esigenze di tutela della qualità delle stesse. Si veda, sul punto, JANSSEN K., DUMORTIER J., Towards a European Framework for the Re-Use of Public Sector Information: A Long and Winding Road, International Journal of Law & Information Technology, vol. 11, n. 2, 2003, p. 192, e J. PAS, L. RECHTEN, The commercialization of Government Information and the Proposal for a Directive (2002) 207 by the European Commission, Murdoch University Electronic Journal of Law, vol.9, n. 4, 2002. 35 Direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GUCE L/281, 23/11/1995, 31.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
19
un’iniziativa legislativa netta, mentre gli Stati Membri auspicano l’adozione di
ben più caute linee comuni.
1.1.4. La proposta di una Direttiva (2002)
Dopo una battuta d’arresto nei lavori di circa due anni, nel 2001 la Commissione
formula una Comunicazione36 in materia di Public Sector Information. Essa
emerge da uno studio approfondito delle osservazioni pervenute in relazione al
Libro Verde e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa eEurope37, lanciata dalla
Commissione nel dicembre 1999 al fine di “assicurare che l’Unione Europea
possa compiutamente beneficiare per generazioni a venire dei cambiamenti che la
società dell’Informazione sta comportando”38.
La comunicazione dichiara esplicitamente di rivolgersi alla questione del riutilizzo
dell’informazione pubblica, senza voler avanzare proposte in materia di accesso:
quest’ultima continua a caratterizzarsi come una questione di competenza
nazionale, regionale e locale.
Il principio guida della Comunicazione si trova nella configurazione di un
generale diritto al riuso: ogni qual volta l’informazione pubblica sia generalmente
accessibile, dovrà esserne consentito il riutilizzo commerciale39.
Infine nel 2002, a tredici anni di distanza dalla Linee Guida, la Commissione
redige una Proposta per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini
commerciali40. A differenza del Libro Verde e della Comunicazione del 2001, la
36 Commissione Europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Consiglio delle Regioni. eEurope 2002: Un quadro normativo comunitario per la valorizzazione dell’informazione del settore pubblico, COM (2001) 607 def. 37 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24221_it.htm 38 Commissione Europea, eEurope. Una Società dell’Informazione per tutti, COM (1999) 687. I principali obiettivi dell'iniziativa sono: fare in modo che ciascun cittadino, ciascuna abitazione, scuola, impresa e amministrazione entri nell'era digitale e disponga di un collegamento on-line; creare in Europa la padronanza degli strumenti dell'era digitale, con il sostegno di una cultura imprenditoriale pronta a finanziare e a sviluppare nuove idee; garantire che l'intero processo non crei emarginazione, ma rafforzi la fiducia dei consumatori e potenzi la coesione sociale. 39 La Comunicazione non chiarisce cosa debba intendersi come “generalmente accessibile”: lasciare questa nozione agli Stati Membri avrebbe naturalmente rischiato d’acuire le disomogeneità in materia d’accesso, con evidenti ricadute sul regime di riuso. 40 Commissione Europea, Proposta per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini commerciali, COM (2002) 207.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
20
Proposta fa riferimento ai “documenti del settore pubblico” anziché all’
”informazione del settore pubblico”; ciò parrebbe segnalare la propensione della
Commissione per un “sistema a base documentale” anziché per un “sistema a base
informativa”, allo specifico fine di alleggerire l’onere dell’impegno per le
amministrazioni coinvolte. Infatti, se nel primo caso la richiesta di accesso e
riutilizzo può riguardare soltanto specifici documenti detenuti dal settore pubblico,
nel secondo essa può vertere non soltanto su un documento attuale, ma anche su
una questione concreta, in relazione alla quale l’ente deve provvedere a
raccogliere informazioni da fonti diverse.
Di fatto, la Commissione rinuncia al proposito, enunciato nel 2001, di istituire un
diritto generale di riutilizzo. Al diritto al riutilizzo sono poste due restrizioni, che
sottraggono alla proposta gran parte della sua efficacia innovativa: in primo luogo,
il diritto al riutilizzo è configurabile soltanto rispetto a documenti che siano
generalmente accessibili secondo le normative nazionali in tema di accesso agli
atti amministrativi. In secondo luogo, le opportunità di riutilizzo finiscono per
dipendere non solo dalle norme sull’accesso, ma anche dalla mera volontà degli
enti pubblici di consentirne il riutilizzo.
Ciò fa sì che il diritto al riutilizzo a stento possa essere definito generale; al
contrario, esso viene a dipendere in misura determinante dalla scelte discrezionali
delle amministrazioni.
Per ciò che riguarda la definizione dei meccanismi di tariffazione, la proposta
lascia agli Stati membri un notevole margine di manovra, stabilendo che “qualora
la cessione avvenga a titolo oneroso, il totale dei ricavi non può superare i costi
di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile
sugli investimenti”.
Dunque, sebbene la proposta incoraggi il rilascio delle informazioni secondo la
politica dei costi marginali, innegabilmente essa lascia agli Stati membri un ampio
spettro di possibilità in materia di tariffazione delle informazioni. Non impedisce
Lo stesso titolo rivela una certa incertezza ed esitazione da parte della Commissione, suggerendo che possa tracciarsi una differenza tra riutilizzo commerciali e altre tipologie di riutilizzo dell’informazione pubblica, mentre la definizione di riutilizzo include entrambe le finalità, v. art 2.5 cit. Proposta.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
21
agli enti pubblici di realizzare un utile, ma si limita a stabilire che esso rimanga
nei limiti della ragionevolezza e della congruità41.
1.2. Basi giuridiche del diritto d’accesso all’informazione pubblica
1.2.1 L’accesso all’informazione detenuta dal settore pubblico: un diritto
fondamentale?
Il diritto d’accesso all’informazione detenuta dal settore pubblico appare come
elemento essenziale in una società compiutamente democratica e come tale è
riconosciuto, con diverse declinazioni, in tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea. Tale diritto presenta differenti caratterizzazioni e risponde ad una
molteplicità di obiettivi nell’ambito della società democratica, configurandosi, in
questo senso, come un principio autenticamente “multi-strato”42.
Esso si presenta, in primo luogo, come un vero e proprio fondamento legale per il
diritto dei cittadini di accedere alla documentazione degli enti pubblici e per il
correlativo obbligo, da parte dei governi, di attuare la propria missione
istituzionale secondo meccanismi di trasparenza, che assicurino, di volta in volta,
la certezza dell’azione amministrativa e la salvaguardia dall’arbitrarietà
dell’autorità pubblica.
In secondo luogo, il principio dell’accesso all’informazione è, nella totalità dei
paesi, un principio di “amplificazione della democrazia”43, il cui scopo è
primariamente quello di promuovere la partecipazione dei cittadini nel processo
decisionale e nelle politiche di governo. La trasparenza nell’accesso ai documenti
del settore pubblico offre infatti ai singoli l’opportunità di influenzare,
41 Il memorandum esplicativo della direttiva prende atto delle preoccupazioni di tipo finanziario da parte degli Stati membri, lasciando agli stessi la definizione dei criteri di tariffazione: “la proposta tiene conto del fatto che alcuni enti pubblici dipendono, nel finanziamento di parte delle proprie attività, dagli utili derivanti dalla vendita delle proprie informazioni”. D’altra parte, però, la proposta non specifica alcuno dei criteri utili a determinare la “congruità” del profitto conseguibile dalle amministrazioni. 42 Si veda, sul punto H. KRANENBORG, W. VOERMANS, Access to Information in the European Union, A Comparative Analysis of EC and Member State Legislation, European Law Publishing, Groningen, 2005, p. 10. 43 Ibidem, dove si parla del principio d’accesso all’informazione pubblica come di un “democracy amplifying principle”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
22
controllandola, l’azione di governo, contribuendo altresì a prevenire gli episodi di
corruzione e le altre degenerazioni del sistema democratico e legittimando, nel
loro complesso, le decisioni di governo.
Il terzo ed ultimo “strato” riguarda il raccordo tra l’accesso all’informazione ed il
principio della good governance, che si realizza, in primis, nel miglioramento del
rapporto di comunicazione tra il governo e i cittadini, così come tra il governo e i
vari attori coinvolti nelle politiche di governo.
La configurazione del principio d’accesso all’informazione come principio multi-
livello non implica automaticamente che tutte e tre le dimensioni siano presenti in
ugual misura in tutti gli ordinamenti degli Stati membri; evidenzia, tuttavia, come
gli elementi peculiari di ciascun livello in molti degli Stati membri coesistano e
come le diverse accezioni del principio si reggano reciprocamente.
A livello europeo, si discute se il diritto d’accesso ai documenti del Parlamento,
del Consiglio e della Commissione, garantito dall’art. 255 del trattato CE e attuato
mediante il regolamento 1049/2001, rivesta o meno la natura di diritto
fondamentale44.
L’art. 6 del Trattato UE afferma che l’Unione si impegna a rispettare i diritti
fondamentali “quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati
membri”; ebbene, la base normativa dell’accesso all’informazione sarebbe
rintracciabile, a livello europeo, proprio in questo substrato costituzionale
condiviso dai vari Stati membri.
In particolare, il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni europee viene
ribadito dall’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alla
quale l’art. 6 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore lo scorso 1 dicembre 2009,
riconosce “lo stesso valore giuridico dei trattati” 45. L’art. 42, rubricato “Diritto
d’accesso ai documenti”, afferma infatti che: “Qualsiasi cittadino dell'Unione o
44 Si rimanda a D.M. CURTIN, Citizen’s fundamental right of access to EU information: an evolving digital passepartout?, in Common Market Law Review, 2000, pp. 7-41; R.W. DAVIS, Public Access to Community Documents: a Fundamental Human Right?, European Integration online Papers, vol. 3, nr. 8, 1999, disponibile al sito http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-008.htm; M. C. BEERS, Public Access to Government Information towards the 21st Century, in W.F. KORTHALS ALTES, E. J. DOMMERING, P.B. HUGENHOLTZ, J.J.C. KABEL (a cura di), Information Law Towards the 21st century, Kluwer Law International,1992, pp. 177 ss.; D. M. CURTIN, I. DEKKER, Good Governance: The Concept and its Application by the European Union, in D.M. CURTIN, R.A. WESSEL, Good Governance and the European Union. Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia, 2005, pp. 3-19. 45 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, siglata a Nizza il 7 dicembre del 2000.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
23
qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione”.
Appare interessante notare che dodici46 del ventisei Stati membri dotati di una
Costituzione hanno conferito una collocazione costituzionale al diritto d’accesso
all’informazione pubblica; tra questi, la Svezia, Stato membro caratterizzato dalla
tradizione più risalente in materia di libertà dell’ informazione, presenta un
complesso di disposizioni costituzionali tra le più elaborate47. L’art. 110 della
Costituzione olandese, invece, demanda agli atti del Parlamento la declinazione
dei principi dell’open government, mentre la Carta Costituzionale del Belgio48
enuncia esplicitamente un diritto d’accesso agli atti amministrativi per chiunque,
suscettibile di limitazioni soltanto per via legislativa.
Ancora, il Conseil d’Etat francese49, nel 2002, ha definito il diritto d’accesso alla
documentazione amministrativa come “garanzia fondamentale, accordata ai
cittadini per l’esercizio delle proprie libertà in ambito pubblico, secondo quanto
previsto dall’art. 34 della Costituzione” .
Diversamente, le Costituzioni di Austria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e
Spagna tendono a configurare l’accessibilità dei documenti pubblici come un
obbligo per l’autorità amministrativa piuttosto che come un diritto in capo ai
singoli.
Come osservato, il diritto di accesso all’informazione del settore pubblico
presenta una stretta connessione con la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o
46 Si tratta di Belgio, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia. Il Regno Unito non rientra nel novero dei ventisei paesi di cui sopra, non essendo, per l’appunto, dotato di Carta Costituzionale. In ogni caso, per una ricerca più ampia e approfondita sulla situazione mondiale in tema di accesso alla documentazione del settore pubblico, si rinvia a D. BANISAR, Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Records Laws, disponibile all’indirizzo web: http://www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf 47 La legge sulla libertà di stampa risale al 1766 e subisce due significativi emendamenti, nel 1949 e nel 1976. Tale atto, che forma parte della seconda parte della Costituzione svedese, contiene una sezione dal titolo “Sulla natura pubblica dei documenti ufficiali” finalizzata a regolamentare nello specifico i criteri d’accesso alla documentazione del settore pubblico. Una versione inglese del Tryckfrihetsförordningen può essere consultata al sito: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____8908.aspx. L’art. 1 della seconda sezione recita: “Every citizen shall be entitled to have free access to official docuemnts, in order to encourage the free flow exchange of opinion and the availability of comprehensive information”. 48 Cfr. art. 32 della Costituzione del Belgio; più in generale, sulla trasparenza amministrativa nel sistema belga: F. SCHRAM, Executive transparency in Belgium, in Freedom of Information Review, 2001, pp. 34-41. 49 Conseil d’Etat, 29 aprile 2002, n. 228830 e 13 dicembre 2002, n. 237203.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
24
comunicare informazioni o idee, quale garantita dall’art. 10 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU). Dunque, si potrebbe affermare che detta disposizione fondi la premessa
per delineare l’esistenza di un obbligo positivo, in capo agli Stati, a diffondere
l’informazione di interesse pubblico e a consentire l’accesso alla stessa. Per
decenni, la Corte di Strasburgo ha manifestato una certa riluttanza ad ammettere
questo principio; tuttavia, negli ultimi anni la Corte pare aver aperto uno spiraglio
al legame tra diritto d’accesso e art. 10 della CEDU che, come ricordato, non si
limita a proteggere il soggetto che si fa portatore di idee o informazioni, ma offre
altresì idonea salvaguardia al complesso dei potenziali destinatari,
ricomprendendo in questa categoria anche la collettività50.
La Corte ha ripetutamente riconosciuto il diritto del pubblico ad essere
adeguatamente informato51 e il diritto ad essere edotto di una diversa
prospettiva52, come corollario della funzione, propria dei giornalisti, di divulgare
informazioni o idee su questioni di pubblico interesse; ciò nondimeno, essa non si
è spinta ad affermare l’esistenza di un obbligo, in capo all’autorità pubblica, di
provvedere alla diffusione attiva di informazione al pubblico.
In diversi dei casi in cui i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 10, tra di
essi Leander v. Svezia, Gaskin v. Regno Unito, Guerra e altri v. Italia, Sirbu e
altri v. Moldavia e Roche v. Regno Unito, la Corte rileva che “ la libertà di
ricevere informazioni (…) essenzialmente proibisce ad un governo di impedire ad
una persona di ricevere informazioni che altri vogliano o possano permettere di
fornirgli, ma non può essere interpretata come impositiva per uno Stato, in
circostanze come quelle nella fattispecie, di obblighi positivi di raccolta e
divulgazione, motu proprio, delle informazioni”53.
Con l’espressione “in circostanze come quelle nella fattispecie”, la Corte non
esclude dunque l’idea che possa darsi luogo, in talune circostanze, al
50 Si veda la riflessione svolta in W. HINS, D. VOORHOOF , Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights, European Constitutional Law Review, 3/2007, pp. 114-126. 51 C.E.D.U., 26 aprile 1979, Sunday Times(1) c. Regno Unito, § 64-66 e C.E.D.U., 29 ottobre 1992, Open Door and Dublin Well Woman c. Irlanda, § 55; ma anche, C.E.D.U., 25 giugno 2002, Colombani c. Francia e C.E.D.U., 29 marzo 2005, Ukrainian Media Group c. Ucraina, § 38. 52 C.E.D.U., 18 luglio 2000, Sener c. Turchia, § 46. 53 C.E.D.U., 9 febbraio 1998, Guerra e altri v. Italia, §53; C.E.D.U., 26 marzo 1987, Leander v. Svezia, § 74; C.E.D.U., 7 luglio 1989, Gaskin v. Regno Unito, § 52.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
25
riconoscimento per lo Stato di un obbligo positivo di “informare” fondato sull’art.
10 della Convenzione; tuttavia, nella propria giurisprudenza, la Corte ha sempre
omesso di definire con esattezza i caratteri di detta situazione.
Nello specifico, in alcuni dei casi citati, la Corte ha ritenuto di riconoscere ai
ricorrenti il diritto ad una compensazione: non però sulla base dell’art. 10, bensì in
virtù dell’art. 8, che ha ad oggetto la tutela della vita privata e familiare54.
Nel caso Gaskin, il rifiuto ingiustificato opposto dalle autorità britanniche al
rilascio di informazioni inerenti alla sua infanzia viene considerato una violazione
dell’art 8, in ragione dell’evidente legame del diritto a conoscere la propria
infanzia con il diritto al rispetto e all’integrità della vita privata55.
Analogamente, nel caso Guerra v. Italia, la Corte afferma che lo Stato italiano ha
violato un obbligo positivo derivante dall’art. 8, avendo omesso di fornire
adeguate informazioni sugli elevati rischi per la salute causati da un’industria
chimica nei pressi dell’abitazione dei ricorrenti e avendo tralasciato la diffusione
di appositi piani di evacuazione in caso di incidente. Come è naturale, la
protezione della salute inerisce alla tutela della vita privata, ma si potrebbe altresì
obiettare che l’informazione sui rischi ambientali rivesta un interesse generale e
sia perciò rilevante ai fini di un dibattito pubblico consapevole.
Sebbene la Commissione europea sui diritti umani56 accolga questa posizione,
configurando una violazione dell’art. 10 da parte delle autorità italiane, la Corte
propende invece per l’esclusione dello stesso.
Eppure non ci sono dubbi che, a partire dal 2000, la Corte abbia aperto
l’impostazione della propria giurisprudenza consolidata all’influenza di un paio di
54 In molti di questi casi, la Corte non evidenzia un’interferenza con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ma osserva che l’art. 8 impone, in capo agli Stati, l’obbligo positivo di assicurare il rispetto di tali diritti. Cfr. C.E.D.U., 9 febbraio 1998, Guerra e altri c. Italia, § 58, cit., dove la Corte afferma: “Sebbene l’art. 8 abbia essenzialmente ad oggetto la protezione degli individui contro l’interferenza arbitraria della pubblica autorità, esso non si limita ad impedire allo Stato l’esercizio di detta interferenza: oltre a questo impegno primario, infatti, potranno esserci obblighi positivi inerenti all’effettivo rispetto della vita privata e familiare”. 55 In questo caso è facilmente comprensibile la ragione per cui la Corte ha preferito applicare l’art. 8 della Convenzione europea piuttosto che l’art. 10: il rilascio dell’informazione richiesta da Gaskin presentava scarsi legami con le ragioni dell’open government e con l’opportunità di offrire alla collettività “una visione adeguata della società in cui si è inseriti”. Inoltre, il diritto d’accesso ai documenti ufficiali come garanzia di trasparenza non può venire ristretto ad uno specifico gruppo di individui, ma è un diritto esercitabile da chiunque. D’altra parte, l’obiettivo di Gaskin non era certamente quello di ottenere che le autorità britanniche consentissero un accesso indiscriminato all’informazione relativa alla sua infanzia: la natura della questione è e rimane, per l’appunto, eminentemente privata, giustificando come tale l’applicazione dell’art. 8. 56 Commissione europea sui diritti umani, 29 giugno 1996, Guerra c. Italia, § 49.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
26
prospettive, che fanno pensare ad un nuovo approccio sull’applicazione dell’art.
10 in materia di accesso ai documenti pubblici.
Nel caso Özgür Gündem v. Turchia, dove le forze dell’ordine erano rimaste
passive di fronte agli attacchi fisici e agli omicidi compiuti da parte di un gruppo
di privati ai danni della redazione di un quotidiano, la Corte così conclude: “the
Government have failed, in the circumstances, to comply with their positive
obligation to protect Özgür Gündem in the exercise of its freedom of
expression”57.
Nella propria giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto la rilevanza delle
Raccomandazioni assunte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ai fini
dell’interpretazione della Convenzione. Come osservato dalla Grande Camera
della Corte, infatti, la Convenzione è uno strumento “vivente” che deve essere
interpretato alla luce del presente: “While the Court is not formally bound to
follow its previous judgments, it is in the interest of legal certainty, foreseeability
and equality before the law that it should not depart, without good reason, from
precedents laid down in previous cases […]. However, since the Convention is
first and foremost a system for the protection of human rights, the Court must
have regard to the changing conditions within the respondent State and within
Contracting States and respond, for example, to any evolving convergence as to
the standards to be achieved […]. It is of crucial importance that the Convention
is interpreted and applied in a manner which renders its rights practical and
effective, not theoretical and illusory. A failure by the Court to maintain a
dynamic and evolutive approach would indeed risk rendering it a bar to reform or
improvement”58.
57 C.E.D.U., 16 marzo 2000, Özgür Gündem c. Turchia, § 46. In altri giudizi, la Corte osserva che l’art. 10 comporta l’adozione di misure di protezione positive nelle relazioni contrattuali tra privati. Più in generale, Alastair Mowbray, afferma che tutti i diritti fondamentali contemplati nella Convenzione europea comportano obblighi sia positivi sia negativi, sebbene, naturalmente, il bilanciamento in concreto tra le due categorie subirà delle variazioni secondo la natura del diritto di volta in volta considerato. Persino diritti “a struttura negativa”, quali la proibizione della tortura contenuta nell’art. 3, possono comportare significativi obblighi in positivo (per esempio, l’affidamento ai servizi sociali dei minori con situazioni di violenza familiare). V. A. MOWBRAY, The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, Oxford, 2004, p. 108-109. 58 C.E.D.U., 19 ottobre 2005, Roche c. Regno Unito, § 172-173. Significative nella determinazione degli orientamenti della Corte sono altresì le sentenze della Corte Interamericana dei Diritti Umani; in un caso del 2006 (Inter-American Court of Human Rights, 19 Sept. 2006, Claude Reyes and others v. Chile), avente ad oggetto il diniego, opposto dalle autorità cilene, a dare corso alla

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
27
Sempre nel 2006, nel caso Sdružení Jihočeské Matky v. Repubblica Ceca59, la
Corte apre, infine, alla possibilità di applicare l’art. 10 della Convenzione alle
circostanze del caso in oggetto: secondo la Corte, infatti, il rifiuto opposto dal
governo ceco a fornire ad una ONG ecologista l’accesso ai documenti e ai piani
relativi ad una stazione nucleare, contraddice il diritto a ricevere informazioni
fondato sull’art. 10. Sebbene la Corte abbia poi dichiarato il ricorso infondato nel
merito, avendo le autorità ceche adeguatamente motivato il diniego (in conformità
con il secondo comma dell’art. 10), la dottrina60 sottolinea il carattere innovativo
dell’apertura all’applicabilità dell’art. 10.
Nel passaggio cruciale della sentenza61, la Corte enuclea tre profili di particolare
rilevanza del caso:
- i ricorrenti avevano inoltrato una precisa richiesta d’accesso: ebbene, il
diniego dell’accesso all’informazione presenta, secondo la Corte, un
richiesta di informazione in materia ambientale avanzata da tre attivisti, la Corte Interamericana ha significativamente riconosciuto all’unanimità la violazione dell’art. 13 della Convenzione Interamericana dei Diritti Umani. Tale articolo, infatti, protegge “il diritto di ogni singolo ad inoltrare richiesta di accesso all’informazione detenuta dallo Stato, salvo le restrizioni contemplate nella Convenzione” e, in maniera assai interessante, la Corte Interamericana sottolinea lo stretto legame che intercorre tra diritto d’accesso all’informazione governativa ed effettività dei principi democratici. Nella sezione 77, la Corte interamericana considera: “ la Corte estima que el artículo 13 de la Convención (…) protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el regime de restricciones de la Convención”; nella sezione 86 la Corte osserva ancora: “El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés publico, puede permitir la partecipación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso”. 59 C.E.D.U.,10 luglio 2006, Sdružení Jihočeské Matky c. Repubblica Ceca. 60 Analizza approfonditamente la decisione, oltre ai già citati W. HINS e D. VOORHOOF, in Access to State-Held Information: A Fundamental Right, European Constitutional Law Review, 3/2007, p. 123-126 anche T. MENDEL, Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Unesco Publishing, 2008, p. 16. 61 L’originale francese recita: “Dans ses arrêts Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et decisions 1998-I, § 53), concernant l’absence d’informations de la population sur les risques encourus et sur les mesures à prendre en cas d’accident dans une usine chimique du voisinage, et Roche c. Royaume-Uni ([GC], no 32555/96, § 172, CEDH 2005-...), portant sur l’absence de toute procédure d’accès à des informations qui auraient permis au requérant d’évaluer les risques pour sa santé pouvant résulter de sa participation à des tests militaires, la Cour a conclu que ladite liberté « ne saurait se comprendre comme imposant à un Etat, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, des obligations positives de collecte et de diffusion, motu proprio, des informations ». La Cour observe également qu’il est difficile de déduire de la Convention un droit général d’accès aux données et documents de caractère administratif (voir, mutatis mutandis, Loiseau c. France (déc.), no 46809/99, CEDH 2003-XII (extraits)). En l’occurence, la requérante a demandé de consulter des documents administratifs qui étaient à la disposition des autorités et auxquels on pouvait accéder dans les conditions prévues par l’article 133 de la loi sur les constructions, contesté par la requérante. Dans ces conditions. la Cour admet que le rejet de ladite demande a constitué une ingérence au droit de la requérante de recevoir des informations”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
28
diverso tenore rispetto alla mancata diffusione della stessa, motu proprio,
da parte delle autorità. Nella propria giurisprudenza consolidata, infatti,
la Corte aveva ribadito che la libertà garantita dall’art. 10 non impone
allo Stato di procedere alla raccolta e alla diffusione attiva di
informazioni62;
- in secondo luogo, l’informazione richiesta era contenuta in documenti
amministrativi detenuti dalle autorità pubbliche. Dunque, non vi era
alcuna necessità, da parte delle amministrazioni in causa, di svolgere
un’attività di creazione o raccolta delle informazioni;
- la documentazione di cui in oggetto risultava astrattamente accessibile,
secondo le condizioni prescritte dalla legislazione ceca in materia
edilizia, non concernendo dati o registri a carattere personale.
Nel caso Sdružení Jihočeské Matky, inoltre, la Corte chiarisce che il diritto ad
accedere ai documenti pubblici non si caratterizza in senso assoluto: “En effet,
lorsque l’exercice du droit à recevoir des informations peut porter atteinte aux
droits d’autrui, à la sûrété publique ou à la santé, l’étendue du droit à l’accès aux
informations en cause est limitée par le libellé du paragraphe 2 de l’article 10 de
la Convention”.
In conclusione, ciò che è più significativo, è che per la prima volta la Corte
richiami direttamente l’art. 10 in un caso di accesso all’informazione del settore
pubblico; saranno dunque le future decisioni a consolidare, o meno, il nuovo
orientamento giurisprudenziale della Corte di Strasburgo, senza tralasciare che
l’applicazione dell’art. 10 anche da parte delle corti nazionali contribuirebbe a
definire più nettamente i contorni della tutela, in ambito europeo, del diritto
d’accesso all’informazione statale.
1.2.2. La legislazione europea sull’accesso: omogeneità e differenze
Sebbene appaia molto complicato, se non pressoché impossibile, tracciare una
linea di demarcazione tra nuovi e vecchi Stati membri quanto a tipologia di
legislazione sull’accesso, ciò nondimeno si rilevano importanti differenze nelle
62 Cfr. le citate sentenze Guerra c. Italia, Rochec. Regno Unito, Sirbu e altri c. Moldavia.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
29
tradizioni giuridiche cui sono riconducibili i regimi d’accesso all’informazione dei
27 Stati membri.
In occasione della conferenza “Transparency in Europe – II”63, Ivar Tallo,
direttore dell’ E-Governance Institute di Tallin, Estonia, presenta un’interessante
prospettiva raffigurando tre principali e distinte tradizioni. Una prima tradizione in
materia d’accesso all’informazione del settore pubblico è quella di matrice anglo-
americana, che tende a configurare lo Stato e il governo come una sorta di “male
necessario” e di costante minaccia alla libertà dei cittadini: ne deriva un’idea di
complessiva diffidenza nei confronti delle strutture governative e dunque un
regime d’accesso che, da un lato, impone alle stesse severi obblighi, e, dall’altro,
dota i cittadini di strumenti giuridici a garanzia dei propri diritti. La seconda
tradizione è invece quella di tipo continentale, presso la quale il governo è
percepito piuttosto come un’autorità meritevole di fiducia; secondo questo
modello (incarnato, ad esempio, dal regime francese e tedesco) il diritto
all’accesso esiste ed è riconosciuto, ma gli obblighi in capo alle strutture
amministrative non risultano particolarmente accentuati.
L’ultimo approccio, secondo Tallo, è quello tipico dei paesi scandinavi, dove
l’autorità governativa agisce come partner ideale rispetto alla società e ai
cittadini; essa si impegna a pianificare le politiche amministrative una volta
analizzata l’informazione disponibile, con l’effetto che la stessa normativa
sull’accesso riflette l’ideale di un rapporto fiduciario e di un consenso
autenticamente “informati”.
In particolare, al fine di evidenziare i principali elementi di convergenza e di
distinzione esistenti in ambito europeo in materia di accesso alla documentazione
pubblica, pare opportuno, innanzitutto, procedere ad un’analisi dell’ambito di
applicazione delle differenti normative europee sotto tre profili64:
63 Conferenza tenutasi all’Aja il 26 e 27 novembre 2004, su iniziativa dell’allora presidenza olandese del Consiglio dell’Unione Europea. I materiali dell’intera conferenza sono scaricabili all’indirizzo: http://www.minbzk.nl/contents/pages/43704/transparencyineuropeii.pdf; si rimanda altresì a H.R. KRANENBORG, P.J. STOLK, A. TUNOVIC, W.J.M. VOERMANS (a cura di), Transparency in Europe II, Ministry of the Interior and Kingdom Relations Constitutional Affairs and Legislation Department, The Hague, 2005. 64 Si rimanda a M. MC DONAGH, European Access Legislation: Consistence or Divergence?, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 110-112.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
30
a) la necessità o meno di un interesse qualificato che giustifichi l’accesso
all’informazione richiesta;
b) la tipologia di informazioni cui la legislazione trova applicazione;
c) le amministrazioni pubbliche coinvolte da detta normativa.
Con riguardo al primo punto, occorre premettere che le normative che poggiano
sull’idea di un generale diritto d’accesso all’informazione detenuta dal settore
pubblico si distinguono, in linea di principio, dalle leggi che riconoscono un
diritto d’accesso alle informazioni personali o che subordinano tale accessibilità
alla dimostrazione di un particolare posizione soggettiva di interesse, ma a queste
ultime esse devono necessariamente essere raccordate.
Sotto quest’ultimo profilo l’Italia rappresenta - per certi versi, assieme alla Grecia
- una peculiarità nel panorama europeo, dal momento che la l. 241/9065, al capo V,
riconosce il diritto d’accesso ai documenti amministrativi soltanto ai soggetti
“interessati”, ovvero a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso”.
Per ciò che riguarda invece la tipologia di informazione accessibile, due questioni
rilevano in particolare. La prima attiene alla definizione, in senso tecnico e
generalmente dettagliata, dell’informazione soggetta al regime d’accesso: l’art 22,
c. 1 lett. d) della legge 241/90, ad esempio, definisce come documento
amministrativo “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o
non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica
amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
La seconda, invece, concerne la tipologia di documento oggetto della normativa
sull’accesso. In alcuni Stati membri, risulta astrattamente accessibile la totalità dei
documenti detenuti dagli enti pubblici, indipendentemente dalla loro fonte o dallo
stadio di elaborazione cui sono giunti; i regimi d’accesso di Belgio, Danimarca,
Irlanda e Regno Unito, per esempio, adottano questo approccio, e, in particolare, il

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
31
sistema irlandese e quello britannico consentono l’accesso a registri e documenti
detenuti anche da terzi, quali, per esempio, imprese che forniscono servizi per
conto degli enti pubblici.
In altri Stati, per contro, le opportunità di accesso sono ristrette ai documenti a
carattere ufficiale o amministrativo, andando dunque ad escludere,
essenzialmente, i documenti a carattere interno; significative esclusioni, in questo
senso, sono contemplate dai sistemi di Svezia, Finlandia, Spagna e Portogallo66.
Rispetto alla questione degli enti e organismi pubblici cui la legislazione
sull’accesso trova applicazione, si possono descrivere tre approcci di ordine
generale: il primo, e più estensivo, considera accessibili i documenti detenuti
dall’“autorità pubblica”, senza però definire direttamente detto ambito (i sistemi di
Danimarca, Spagna, Ungheria e Romania ricadono in questo modello); al
contrario, l’approccio più restrittivo, vede l’applicazione della normativa
sull’accesso ad un insieme di enti amministrativi specificamente indicati67.
Una terza impostazione, tipica del modello britannico e di quello irlandese,
consente invece l’accesso agli atti degli organismi pubblici che si trovino elencati
in apposite tabelle allegate.
Altro punto fondamentale, anche a fini comparatistici, è rappresentato dai
meccanismi di revisione delle decisioni amministrative circa l’accesso. Se la
revisione interna delle decisioni che negano l’accesso è generalmente condotta da
un organo appartenente all’ente cui è stata rivolta la richiesta, per ciò che riguarda
invece la revisione esterna possono individuarsi, nelle legislazioni europee in
materia d’accesso, tre principali modelli.
Il primo, che si affida del tutto alle corti amministrative (le quali, però, non hanno
il ruolo di supervisori generali sulle operazioni del processo amministrativo), è il
metodo che si trova adottato in Svezia, Paesi Bassi, Finlandia, Spagna, Romania e
Ungheria.
65 Legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di processo amministrativo e accesso ai documenti amministrativi”, G.U. 192 del 18 agosto 1990, così come modificata dalla l. 15/2005 e dalla l. 80/2005. 66 V. M. MC DONAGH, op. cit., p. 111. 67 Si prenda ad esempio la legge olandese sull’accesso ai documenti amministrativi, il Wet Openbaarheid Bestuur del 31 ottobre 1991, che, alla sezione 1 A) si dichiara applicabile: a) ai ministri; b) alle autorità amministrative delle province, dei comuni, delle direzioni generali delle acque e alle organizzazioni che svolgono attività di regolamentazione a livello industriale; c) alle autorità amministrative la cui attività sia soggetta alle autorità citate ai punti a) e b).

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
32
Il secondo modello invece vede l’attuazione della revisione da parte di uno
speciale Commissario dotato del potere di emettere decisioni vincolanti in materia
d’accesso; gli Information Commissioners si trovano nel sistema irlandese e in
quello britannico, dove svolgono altresì, rispettivamente, il ruolo di difensore
civico o Ombudsman e di Commissario per la protezione dei dati personali. Gli
elementi di forza di questo sistema consistono nel fatto che, a differenza delle
corti, il Commissario è un’autorità specializzata in materia di accesso
all’informazione, con compiti di monitoraggio dell’effettività della relativa
legislazione, e il ricorso a tale autorità è pressoché privo di costi.
Un terzo approccio, caratteristico dei sistemi di Belgio, Italia, Francia e
Portogallo, coinvolge nelle decisioni in materia d’accesso un’apposita
Commissione sull’accesso ai documenti68; essa non adotta decisioni vincolanti,
ma si limita, piuttosto, ad assumere raccomandazioni in materia, la cui rilevanza è
ancora una volta legata all’alto tasso di specializzazione sull’argomento.
Le citate differenze tra Stati membri in materia di accesso all’informazione sono
destinate ad avere un sicuro impatto nel processo di implementazione e
nell’effettiva operatività della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo
dell’informazione pubblica. Infatti la direttiva affermando al considerando (9) che
le proprie disposizioni troveranno applicazione ai documenti resi accessibili per il
riuso, pare sottintendere la premessa di un approccio uniforme a livello europeo in
materia di accesso, mentre la situazione, al contrario, appare concretamente
variegata.
68 In Italia, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita nel 1991, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri. Gli interessati possono ricorrere in via amministrativa alla Commissione avverso le determinazioni (diniego, espresso o tacito, o differimento dell'accesso) concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambito ultraregionale. Inoltre, nel caso in cui le amministrazioni non adottino le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, le medesime sono adottate dalla Commissione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
33
Nel prendere atto, però, della mancanza di detta uniformità, appare interessante
notare che mentre il Libro Verde riconosceva che le differenze tra Stati membri in
materia di accesso e riutilizzo erano di ostacolo allo sviluppo di un robusto
mercato europeo dell’informazione, la considerazione della questione dell’accesso
è stata eliminata dalla Comunicazione della Commissione Europea del 2001.
Quest’ultima infatti, lungi dal prevedere meccanismi di armonizzazione
legislativa, si limita ad osservare che, fatta eccezione per la materia ambientale69,
la regolamentazione dell’accesso all’informazione del settore pubblico rimane in
primo luogo una responsabilità di ordine nazionale, regionale e in ultimo locale.
1.3. La direttiva 98/2003/CE sul riutilizzo dell’informazione pubblica
1.3.1. Oggetto e ambito di applicazione
Dopo una battuta d’arresto nei lavori di circa due anni, nel 2001 la Commissione
formula una Comunicazione70 in materia di Public Sector Information. Essa
emerge da uno studio approfondito delle osservazioni pervenute in relazione al
Libro Verde e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa eEurope71, lanciata dalla
Commissione nel dicembre 1999 al fine di “assicurare che l’Unione Europea
possa compiutamente beneficiare per generazioni a venire dei cambiamenti che la
società dell’Informazione sta comportando”72.
La comunicazione dichiara esplicitamente di rivolgersi alla questione del riutilizzo
dell’informazione pubblica, senza voler avanzare proposte in materia di accesso:
69 Il riferimento è alla direttiva 2003/4/CE, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, G.U.U.E. 14 febbraio 2003, L 41/26. 70 Commissione Europea, Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Consiglio delle Regioni. eEurope 2002: Un quadro normativo comunitario per la valorizzazione dell’informazione del settore pubblico, COM (2001) 607 def. 71 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24221_it.htm 72 Commissione Europea, eEurope. Una Società dell’Informazione per tutti, COM (1999) 687. I principali obiettivi dell'iniziativa sono: fare in modo che ciascun cittadino, ciascuna abitazione, scuola, impresa e amministrazione entri nell'era digitale e disponga di un collegamento on-line; creare in Europa la padronanza degli strumenti dell'era digitale, con il sostegno di una cultura imprenditoriale pronta a finanziare e a sviluppare nuove idee; garantire che l'intero processo non crei emarginazione, ma rafforzi la fiducia dei consumatori e potenzi la coesione sociale.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
34
quest’ultima continua a caratterizzarsi come una questione di competenza
nazionale, regionale e locale.
Il principio guida della Comunicazione si trova nella configurazione di un
generale diritto al riuso: ogni qual volta l’informazione pubblica sia generalmente
accessibile73, dovrà esserne consentito il riutilizzo commerciale.
Dunque nel 2002, a tredici anni di distanza dalle Linee Guida, la Commissione
redige una Proposta per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al riutilizzo dei documenti del settore pubblico e al loro sfruttamento a fini
commerciali74; invero, lo stesso titolo rivela una certa incertezza ed esitazione da
parte della Commissione, suggerendo che possa tracciarsi una differenza tra riuso
commerciale e altre tipologie di riuso dell’informazione pubblica, mentre l’art. 2.5
della Proposta include nella definizione di riutilizzo entrambe le finalità.
La direttiva 2003/98/CE75, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore
pubblico, viene infine adottata il 17 novembre 2003, in esito alla prevista
procedura di codecisione tra Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea. Essa si
compone di quindici articoli ed è preceduta da numerosi considerando che ne
chiariscono finalità e contesto di operatività.
Il considerando (25) ribadisce la finalità ultima della direttiva, che appare quella
di “agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo, basati sui
documenti del settore pubblico, estesi all’intera Comunità” attraverso la
promozione di “un effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del
settore pubblico da parte delle imprese private, al fine di ricavare prodotti e
servizi a contenuto informativo a valore aggiunto” e di “contribuire alla crescita
economica e alla creazione di posti di lavoro” (considerando 5).
L’art. 2, c.1, n. 4, comprende nella nozione di “riutilizzo” anche finalità non
commerciali, dal momento che costituisce riutilizzo “l’uso di documenti in
possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche o giuridiche a fini
commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei
73 La Comunicazione non chiarisce cosa debba intendersi come “generalmente accessibile”: lasciare questa nozione agli Stati Membri avrebbe naturalmente rafforzato il rischio dell’acuirsi di disomogeneità in materia d’accesso, con evidenti ricadute sul regime di riuso. 74 Si rimanda, sul punto, a PAS J., DE VUYST B., Re-Establishing the Balance Between the Public and the Private Sector: Regulating Public Sector Information Commercialization in Europe, The Journal of Information, Law and Technology, (2)2004. 75 Direttiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, G.U.U.E. L 345 del 31 dicembre 2003.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
35
compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti”, mentre
rimane escluso dalla suddetta nozione lo scambio di documenti tra enti pubblici
esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico76.
La direttiva ambisce a tracciare una disciplina generale per il riutilizzo, “in
condizioni eque, adeguate e non discriminatorie”, dei documenti del settore
pubblico, tenuto conto delle profonde differenze che la Commissione ha
riscontrato tra gli Stati Membri nella disciplina dello sfruttamento delle risorse
informative.
L’art. 3 chiarisce il principio generale, già anticipato dal considerando (9), in base
al quale ampia discrezionalità è lasciata agli Stati Membri in merito alla decisione
di autorizzare o meno il riutilizzo. La disciplina nazionale di attuazione della
direttiva è contenuta nel d. lgs. 36/200677, che ribadisce quindi la non doverosità
della messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo da parte delle
amministrazioni: l’art. 1, c. 2 afferma infatti che: a) “le pubbliche amministrazioni
e gli organismi di diritto pubblico non hanno l’obbligo di consentire il riutilizzo
dei documenti” di cui dispongono e che b) “la decisione di consentire o meno il
riutilizzo spetta all’amministrazione o all’organismo interessato, salvo diversa
previsione di legge o di regolamento”78.
La doverosità dell’attività di cessione delle informazioni pubbliche è altresì
esclusa da un secondo ordine di considerazioni, riconducibili a ciò che Ponti
indica efficacemente come la “signoria” esercitata sul regime di riutilizzo dalla
disciplina nazionale del diritto d’accesso79.
Non solo infatti la disciplina sul riutilizzo non è slegata a quella che regola
l’esercizio del diritto di accesso, ma quest’ultima condiziona nettamente la prima.
76 La nozione di “servizio pubblico” è utilizzata, nel Libro Verde del 1998, quale criterio per definire il settore pubblico in senso funzionale; in virtù di tale concetto, il settore pubblico comprende “enti che hanno autorità o compiti di pubblico servizio”, Libro Verde, cit., 6. 77 D. lgs. del 24 gennaio 2006, n. 36 di attuazione della direttiva 2003/98/CE, G.U. 37 del 14 febbraio 2006. 78 Le disposizioni del d. lgs. 36/2006 che impongono modalità eque e non discriminatorie nell’attività di cessione delle informazioni non si ritengono idonee a condizionare la scelta in ordine all’ an del riutilizzo, in quanto la presuppongono come già avvenuta; secondo D’Elia, questa scelta “sembra, in effetti, configurarsi come esercizio di un indefinito potere autoritativo, più che come una funzione volta a realizzare gli obiettivi della direttiva”, I. D’ELIA, La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo comunitario e nazionale: problemi e prospettive, in Informatica e Diritto, 1/2006, p. 44. 79 Sulla “signoria” del regime di accesso su quello di riutilizzo nel contesto europeo, v. B. PONTI, Il patrimonio informative pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, Diritto Pubblico, n.3/2007.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
36
In particolare, i requisiti di legittimazione soggettiva che costituiscono il
presupposto del diritto d’accesso ai documenti della pubblica amministrazione
italiana80, impediscono oggettivamente di ritenere doverosa l’attività di cessione,
per l’impossibilità di subordinare la richiesta di riutilizzo alla dimostrazione di
una condizione soggettiva, ulteriore e diversa da quella, aspecifica, dell’interesse
al riutilizzo. Nei paesi in cui però siano previste soltanto limitazioni di tipo
oggettivo (laddove, pertanto, sia consentito un accesso generalizzato
all’informazione del settore pubblico), è ben possibile delineare come doverosa la
cessione a fini di riutilizzo: così è, ad esempio, in Francia e nel Regno Unito, dove
strumenti appositi sono stati predisposti a tutela degli interessati di fronte ad
ingiustificati dinieghi81.
La direttiva 2003/98/CE si preoccupa di tracciare il perimetro, rispetto al
complesso delle informazioni prodotte e detenute dal settore pubblico, del
sottoinsieme di documenti cui risultano applicabili gli istituti finalizzati al
riutilizzo; ciò avviene innanzitutto in negativo, con l’individuazione delle
categorie di dati esclusi dalla disciplina in esame.
L’art. 1, c.2 prevede che la direttiva non si applichi:
a) ai documenti la cui fornitura è un’attività che esula dall’ambito dei
compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione, definiti dalla
legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro o, in assenza di tali
norme, dalle comuni prassi amministrative dello Stato membro
interessato;
b) ai documenti su cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale;
c) ai documenti esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso degli
Stati membri, anche per motivi di:
80 La configurazione della messa a disposizione di informazioni a fini di riutilizzo come attività amministrativa doverosa offrirebbe, nel caso italiano, uno strumento più efficace e ricco di implicazioni del diritto d’accesso delineato dalla l. 241/1990, che richiede la dimostrazione di una condizione soggettiva legittimante. Sulla peculiarità del caso italiano, quanto alla legittimazione soggettiva come presupposto dell’accesso, si v. S. MEZZACAPO, The Right of Access to Public Bodies’ Records in Italy and UK: “Actio ad Exhibendum” and Freedom of Information. Risks and Opportunities for Private Companies, European Business Law Review, 2006, pp. 959 ss.; e M. MC DONAGH, European access legislation: Consistence or Divergence?, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 108 ss. 81 Si vedano sul punto i contributi di P.J. BIRKINSHAW, A. HICKS e P. SUCEVIC in B. PONTI (a cura di), Il Regime dei Dati Pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Maggioli Editore, 2008.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
37
-tutela della sicurezza nazionale (ossia della sicurezza dello Stato), difesa o
sicurezza pubblica;
-segreto statistico o commerciale;
d) ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle
società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate
per l’adempimento di un compito di radiodiffusione servizio pubblico;
e) ai documenti in possesso di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuole,
università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese, ove
opportuno, organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della
ricerca;
f) ai documenti in possesso di enti culturali quali musei, biblioteche,
archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri.
Ne deriva dunque che il regime finalizzato al riuso ha ad oggetto soltanto le
informazioni sulle quali né l’amministrazione, né terzi, possono vantare diritti di
godimento o uso esclusivi. Particolarmente significativi risultano in questo senso
sia il considerando (22), che afferma la non incidenza della direttiva “sui diritti di
proprietà intellettuale” (intendendo come tali esclusivamente il diritto d’autore e i
diritti connessi, comprese le forme di protezione sui generis) e “sui documenti
soggetti a diritti di proprietà industriale, quali brevetti, disegni, modelli registrati
e marchi”, sia l’art. 2, c.5, che subordina l’applicabilità degli obblighi di cui alla
direttiva alla compatibilità degli stessi “con le disposizioni di accordi
internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare
la convenzione di Berna e l’accordo TRIPS”.
Le lettere e) ed f) dell’art 1, c.2 sottraggono all’ambito di applicazione della
direttiva i documenti detenuti dagli istituti di ricerca e di istruzione e dagli enti
culturali, in coerenza con quanto già previsto dalla proposta di direttiva del 2002
ma in contrasto con la posizione di alcuni rappresentanti del Parlamento,
favorevoli invece ad emendamenti di tipo inclusivo82.
82 Durante la fase parlamentare della procedura di co-decisione, il deputato Van Velzen, peraltro relatore dell’apposita commissione parlamentare, propone l’eliminazione delle citate eccezioni, ma incontra l’opposizione della maggioranza, che argomenta la contrarietà a tali emendamenti con la necessità di evitare che la totalità delle istituzioni finanziate attraverso fondi pubblici vengano ricomprese nel quadro normativo tracciato dalla direttiva. Secondo quest’ultima posizione infatti, proprio gli istituti culturali e di ricerca, che hanno visto i fondi in loro sostegno ridursi negli anni,

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
38
Altrettanto fondamentale è la disposizione di cui all’art 2, c.4, attraverso la quale è
fatta salva la disciplina relativa alla protezione dei dati personali contenuta nella
direttiva 95/46/CE. Con essa la direttiva esplicita la volontà di agire in conformità
con il diritto del cittadino di accedere ai propri dati personali di cui
l’amministrazione sia in possesso, potendo avere conto dell’eventuale trattamento
e riutilizzo cui i dati siano sottoposti.
Esaminata dunque una richiesta di riutilizzo, gli enti pubblici mettono a
disposizione il documento possibilmente per via elettronica o, “se è necessaria
una licenza, mettono a punto l’offerta di licenza per il richiedente entro un lasso
di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l’esame delle richieste di
accesso ai documenti”83.
1.3.2. La definizione di “settore pubblico” e le tipologie di informazione
governativa
La direttiva 2003/98/CE adotta una definizione di settore pubblico di tipo
funzionale, secondo la nozione che emerge dalle direttive sugli appalti pubblici di
servizi84. L’art. 2, c.1, infatti, ricomprende nella definizione di “ente pubblico” le
autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni
formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto
pubblico. Il secondo comma, invece, traccia la nozione di “organismo di diritto
pubblico”, definendo come tale ogni organismo che risponda a tre criteri
cumulativi: l’essere istituito al fine di soddisfare bisogni d’interesse generale
aventi carattere non industriale e non commerciale; l’essere dotato di personalità
giuridica e infine il condurre un’attività finanziata in modo maggioritario dallo
Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure
necessitano in maniera più marcata di reperire fonti alternative di finanziamento (quali, per esempio, la vendita dell’informazione da essi prodotta a prezzi allineati con il mercato). I deputati contrari all’emendamento, in particolare, hanno illustrato le enormi conseguenze giuridiche che deriverebbero dall’inevitabile contrasto con le convenzioni e i trattati internazionali che regolano la materia dei diritti degli istituti culturali in qualità di “creatori”. 83 Cfr. art. 4, c.2: “Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l’offerta di licenza per il richiedente non più di 20 giorni lavorativi dopo aver ricevuto la richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di altri 20 giorni ove le richieste siano cospicue o complesse”. 84 Direttiva 93/37/CEE, G.U.C.E. 1993 L 199/54 e direttiva 92/50/EEC, G.U.C.E. 1992 L 209/1.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
39
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione e di vigilanza sia costituito da membri più della
metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri
organismi di diritto pubblico.
In numerose pronunce, la Corte di Giustizia europea ha chiarito cosa esattamente
debba intendersi per “ente pubblico” secondo la suddetta definizione: i bisogni di
interesse generale, privi di carattere commerciale o industriale, sarebbero dunque
necessità che trovano soddisfazione in maniera diversa rispetto all’ ordinaria
fornitura di beni e servizi in un regime di mercato e a cui, per ragioni legate
all’elemento dell’interesse generale, lo Stato decide di provvedere direttamente o
comunque conservando un’influenza decisiva. Al fine poi di determinare la
presenza o meno di carattere commerciale, tutti i fatti e le circostanze necessitano
di analisi; tra di essi, in primo luogo “la mancanza di competizione sul mercato, il
fatto che l’obiettivo fondamentale non è la realizzazione di profitto, la non
assunzione dei rischi associati all’attività e in generale ogni finanziamento
pubblico dell’attività in questione”85.
Un organismo la cui attività di interesse pubblico costituisca una porzione
relativamente ristretta del complesso si attività da esso svolte, può nondimeno,
secondo la Corte, essere considerato un organismo di diritto pubblico secondo la
nozione che ne offrono le direttive sugli appalti pubblici e la direttiva sul riutilizzo
della PSI86.
L’utilizzo di alcune categorie può risultare utile nel tentativo di accorpare e
distinguere le disparate tipologie in cui si articola l’informazione detenuta dal
settore pubblico; la Van Eechoud suggerisce, a questo proposito, una suddivisione
tratta dal regime olandese di accesso all’informazione pubblica ma funzionale
anche rispetto all’oggetto della direttiva del 2003, che distingue tra ricerche,
registri pubblici, documentazione pubblica, dati amministrativi e dati ausiliari87.
85 Caso C-283/00, Commissione Europea c. Spagna, [2003] ECR I-11697. 86 La Corte di Giustizia europea ha per esempio stabilito, nel caso Mannesmann c. Strohal, che la stampa di documenti ufficiali da parte della Osterreichische Staatsdruckerei soddisfa un bisogno di interesse pubblico ed è privo di carattere commerciale; caso C-44/96 Mannesmann c. Strohal [1998]. 87 M. VAN EECHOUD, The Commercialization of Public Sector Information, in L. GUIBAULT, P.B. HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, The Hague, Kluwer Law International, 2006, pp. 281-282.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
40
I dati contenuti nelle ricerche sono generalmente il frutto dell’attività di raccolta
di informazioni svolta da alcuni organismi pubblici e sono destinati, in primis, ad
altri enti governativi, che li utilizzano nell’attività di pianificazione delle politiche
amministrative, ma anche ad organizzazioni internazionali di tipo governativo e in
generale alla cittadinanza, comprese le imprese private che utilizzano i dati come
base per la creazione di prodotti e servizi informativi; in ambito italiano, si tratta
per esempio delle ricerche svolte dagli Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),
dal Servizio Meteorologico Nazionale o ancora dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV).
I registri pubblici contengono invece dati raccolti sulla base di specifiche leggi e
regolamenti e perseguono la finalità generale di consolidare la certezza di
determinate situazioni giuridiche. Tra gli esempi più significativi è possibile citare
il registro delle imprese, i registri di marchi e brevetti, l’anagrafe, i registri
automobilistici e catastali. Sia rispetto ai suddetti registri, sia rispetto al complesso
di documentazione pubblica in cui confluiscono leggi, regolamenti, decisioni
giurisprudenziali e verbali delle sedute degli organi amministrativi, vale il
principio del libero accesso (fatti salvi i profili di rilievo in termini di privacy) e la
regola generale è quella della gratuità o del costo massimo di riproduzione.
Dati quali quelli contenuti nei registri fiscali, nei registri delle forze dell’ordine o
nelle autorizzazioni urbanistiche si configurano invece come dati amministrativi,
che risultano dall’esercizio di una particolare attività pubblica direttamente rivolta
ai cittadini o alle imprese private e che, in virtù della normativa a protezione dei
dati personali, risulteranno spesso, in linea di principio, preclusi ad altri organismi
pubblici e ai privati.
Le tipologie di informazione non riconducibili ad alcuna delle categorie sopra
descritte confluiscono nell’ambito dei dati c.d. ausiliari, raccolti da soggetti anche
esterni al settore pubblico e di generale supporto alla pianificazione e
all’attuazione delle politiche governative.
1.3.3. Politiche tariffarie e rispettivo impatto economico
Il criterio di determinazione del “prezzo” da versare alle amministrazioni, a fronte
della cessione di informazioni a fini di riutilizzo, costituisce un indicatore

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
41
significativo del complessivo orientamento della politica pubblica rispetto alla
valorizzazione del patrimonio informativo che, in virtù della missione istituzionale
di cui è investito, il settore pubblico detiene.
La direttiva 2003/98/CE rimette quasi del tutto la scelta dei meccanismi di
tariffazione ai criteri definiti dagli Stati membri nelle rispettive discipline
nazionali di attuazione. La direttiva infatti, limitandosi a suggerire una preferenza
per il criterio del marginal cost recovery88, stabilisce l’unica indicazione
vincolante all’art. 6, dove sostanzialmente vieta il ricorso a criteri di mercato,
fondati cioè sull’incontro tra la domanda e l’offerta89.
Non vi è dubbio che la direttiva ometta di dettare, sul punto, una posizione netta e
che, anzi, sembri prediligere un atteggiamento di moderata rinuncia alle intenzioni
di uniformazione della disciplina; tale atteggiamento sarebbe il risultato della
natura compromissoria dell’intervento normativo comunitario che, pur tendendo
in linea di principio al modello dell’open access statunitense, non ha però potuto
ignorare le differenze -spesso ampie- tra le prassi amministrative dei paesi
membri, molti dei quali sono orientati piuttosto alla filosofia del cost recovery.
Le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo e, correlativamente, i
meccanismi tariffari si trovano dunque di fronte a due fondamentali opzioni. La
prima consiste nell’adozione di una politica di recupero dei soli costi marginali di
riproduzione e diffusione, in cui la valorizzazione delle informazioni di fatto è
rimessa alla commercializzazione di prodotti e servizi a valore aggiunto,
sviluppati a partire dai dati riutilizzati; nella seconda, invece, una porzione
rilevante della creazione di valore è direttamente attribuibile alla cessione delle
informazioni, attraverso la generazione di un utile per l’amministrazione cedente.
88 Cfr il considerando (14) della direttiva 2003/98/CE, che, in caso di cessione delle informazioni a titolo oneroso, incoraggia l’idea di un corrispettivo non superiore ai costi marginali di riproduzione e diffusione dei documenti, secondo un criterio che corrisponde al principio statunitense dell’open access. 89 L’art. 6 della direttiva determina un “tetto massimo” di prezzo per l’accumulo di elementi di costo, stabilendo che, in caso di cessione a titolo oneroso, il totale dei ricavi non possa superare” i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un congruo utile sugli investimenti”. Dunque la previsione di un ampio margine di manovra a livello tariffario, che consente di spaziare tra la cessione a titolo gratuito e il menzionato tetto massimo, farebbe escludere che il prezzo possa determinarsi secondo le dinamiche di mercato, poiché la condizione, di fatto monopolistica, dell’amministrazione consentirebbe a quest’ultima di fissare un prezzo facilmente superiore alla struttura dei costi. Osserva però Ponti che l’estrema vaghezza del criterio di “congruo utile sugli investimenti” conferisce alle amministrazioni un margine non indifferente di discrezionalità, attenuando così il vincolo prescrittivo della disposizione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
42
Lo studio PIRA, commissionato dalla Direzione Generale della Società
dell’Informazione presso la Commissione Europea e pubblicato nel 2000, si
propone di quantificare il potenziale economico della PSI europea e di suggerire
un complesso di opportune politiche e good practices tali da stimolarne lo
sfruttamento commerciale. Osservata la limitatezza dello sfruttamento economico
della PSI europea a confronto con il mercato dell’informazione statunitense, che -
come anticipato - si approssima ad un fatturato medio annuo di 750 miliardi di
euro e ha assistito ad una crescita annuale delle industrie chiave del settore tra
l’11% e il 37% nei sei anni precedenti la rilevazione, il report operativo dello
studio articola in tre punti principali le sfide che i governi europei dovrebbero
assumere al fine di colmare il deficit di sviluppo rispetto agli USA.
Si tratterebbe, in primo luogo, di avvicinare i livelli di investimento europei in PSI
a quelli del governo federale americano, quindi di accrescere le risorse umane
(optando in molti casi per profili ad alta specializzazione tecnica) e, infine, di
riconsiderare i meccanismi di tariffazione finalizzati a generare un utile
immediato. Lo studio PIRA osserva dunque che: “ Cost recovery looks like an
obvious way for governments to minimise the costs related to PSI and contribute
to maximising value for money directly. In fact, it is not clear at all that this is the
best approach to maximising the economic value of PSI to society as a whole.
Moreover, it is not even clear that it is the best approach from the viewpoint of
government finances. […] Estimates of the US PSI market place suggest that it is
up to five times the size of the EU market (see note of caution above). But the EU
market would not even have to double in size for governments to recoup in extra
tax receipts what they would lose by removing all charges for PSI “90; e ancora:
“Policy-makers in Europe accept relatively easily the concept that more PSI
should be given to citizens in the context of participation in a modern democracy.
[…] However, the concept of commercial companies being able to acquire, at
very low cost, quantities of public sector information and resell it for a variety of
unregulated purposes to make a profit is one that policy-makers in the EU find
uncomfortable”91.
Le principali conclusioni dello studio PIRA dunque sono le seguenti:
90 PIRA INTERNATIONAL, Commercial Exploitation of Public Sector Information, Final Report for the European Commission, Directorate General for the Information Society, 2000, p. 10;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
43
- applicare alla cessione dell’informazione pubblica tariffe basate sui
principi del cost recovery può essere controproducente, anche nella
semplice prospettiva di realizzare degli utili sul breve periodo;
- enti e organismi pubblici dovrebbero, di preferenza, rendere disponibile
la PSI in formato digitale ad un prezzo non superiore ai costi di
disseminazione;
- anche senza giungere ad un raddoppio di proporzione del mercato
europeo dell’informazione, per gli Stati sarebbe già possibile incamerare
in forma di tasse più di ciò che essi hanno perduto omettendo di praticare
un recupero diretto dei costi;
- rinunciando a realizzare un utile immediato i governi soddisfano però due
obiettivi di tipo finanziario:
a) più elevate entrate fiscali grazie all’aumento nelle vendite di prodotti
basati sull’informazione pubblica;
b) più elevate entrate fiscali e minori erogazioni in termini di previdenza
sociale in conseguenza dell’aumento del tasso di occupazione92.
Come ricorda Weiss, anche in ambito statunitense si sono effettuati dei tentativi,
sia a livello statale sia a livello federale, di adozione delle politiche di full cost
recovery; secondo l’analista americano autore, tra gli altri, della circolare A-130
dell’Office of Management and Budget93, gli esiti fallimentari di queste
esperienze non farebbero che dimostrare concretamente le conseguenze pratiche,
anche sul breve periodo, dell’adozione di politiche restrittive in materia di PSI94.
91 Ivi, p. 22. 92 Uno studio commissionato dai rappresentanti privati del Comitato Federale Olandese per l’informazione geografica (Ravi Bedrijvenplatform, 2000) giunge a conclusioni non dissimili: in primo luogo, sia i consumatori sia il settore privato possono significativamente beneficiare delle politiche di open access rispetto all’ informazione pubblica; in secondo luogo, si stima che la riduzione del 60% del prezzo dell’informazione pubblica geografica consentirebbe un aumento del 40% del fatturato annuale, assieme alla creazione di circa 800 nuovi posti di lavoro su base nazionale. 93 United States Office of Management and Budget, Circular A-130 on Management of Information Resources, 2000, disponibile al sito: http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a130_a130trans4/; la circolare in questione definisce la gestione delle risorse rispetto all’informazione federale, affidata all’Office of Management and Budget. 94 P. N. WEISS, Conflicting PSI Policy and their Economic Impacts, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 150-153.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
44
Un primo esempio riguarda l’Automated Tariff Filing and Information System
(ATFI), creato dalla Federal Maritime Commission (FMC) con la finalità di
raccogliere, gestire e diffondere informazioni sui prezzi applicati dalle società di
trasporti via mare, sui tipi di cargo, sulle destinazioni e i termini del contratto di
servizio. Nel novembre del 1992, il Congresso stabilisce con l’“High Seas Driftnet
Fisheries Enforcement Act” che la FMC esiga dagli utenti dell’ATFI il pagamento
di una tariffa: l’obiettivo è quello di realizzare 810 milioni di dollari nell’arco di
tre anni, applicando un costo di 46 cent/minuto nell’operazione di offerta delle
informazioni. Il fatturato finirà però per ammontare, nel 1995, a soli 438.800
dollari (vale a dire lo 0,05% di quanto preventivato)95, segnando un assoluto
fallimento dell’iniziativa. Secondo Weiss tale esito sarebbe da attribuirsi non solo
all’eccessivo ottimismo circa l’inelasticità della domanda di dati, ma anche alla
mancata considerazione delle fonti alternative a disposizione degli utenti nel
reperimento delle informazioni.
Un altro esempio eclatante del frequente fallimento delle politiche di cost
recovery ha avuto luogo nello Stato della California, dove, a metà degli anni
novanta, le agenzie statali sono state incoraggiate a vendere agli organismi
pubblici locali prodotti e servizi di informazione ottenuti a partire dalla
rielaborazione di dati forniti dagli stessi enti locali. In conseguenza di ciò, ben
presto le amministrazioni locali hanno cessato di potersi permettere l’acquisto di
dati che in precedenza ricevevano gratuitamente, venendosi peraltro a creare una
situazione di globale disincentivo alla fornitura allo Stato di dati aggiornati.
Accade, dunque, che nel momento in cui lo Stato della California decide di
tornare alla politica di libero accesso ai dati delle agenzie statali, alcuni organismi
locali che, nel frattempo, avevano preso ad applicare tariffe all’informazione da
essi stessi prodotta, seguono ad operare secondo quest’ultima prassi.
Il risultato di ciò si è tradotto negli elementi di incompletezza e disomogeneità che
caratterizzano molti progetti statali di applicazione regionale, abbondanti di dati in
riferimento a determinate aree e , per contro, gravemente carenti rispetto ad altre.
Il dibattito rispetto a tali problematiche si è acuito in seguito ad alcune gravi
emergenze pubbliche (in primis, i violenti incendi che con frequenza, negli ultimi
95 United States General Accounting Office, Accounting and Management Division, GAO/AIMD-95-93R ATFI User Fees, Washington, 1995;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
45
anni, hanno devastato vaste aree californiane), quando in più occasioni
l’operatività dei soccorsi è stata ritardata o ridotta dalla mancata disponibilità di
dati completi e accuratamente aggiornati96.
Nel Regno Unito, nazione che, a livello europeo, vanta la tradizione più antica in
termini di commercializzazione dell’informazione pubblica, il Ministero del
Tesoro ha esposto in passato le proprie perplessità in ordine al fatto che il modello
dei costi marginali possa effettivamente incrementare il benessere economico e
sociale. Si osserva, infatti, che se ai c.d. trading funds, quali per esempio
l’Ordnance Survey97, non è consentito di recuperare direttamente i loro ampi costi
fissi, l’attività da essi svolta dovrà necessariamente essere finanziata attraverso
una maggiore pressione fiscale (che, come tale, finirebbe per sopravanzare in
negativo i benefici di una migliore allocazione delle risorse nel mercato
dell’informazione).
Per converso, il governo britannico ha preso atto dello scarso stimolo al riutilizzo
privato che deriva dalle politiche di recupero dei costi. Coerentemente a ciò, in
seguito ad una riforma del 2000 che ha coinvolto l’istituto del Crown copyright e
l’accesso all’informazione pubblica, il Regno Unito ha assunto a principio
generale la regola della cessione a costi marginali dell’informazione sottoposta al
copyright della Corona.
Il principio enunciato contempla però una serie di eccezioni di non poco conto: in
primo luogo, tutti gli organismi pubblici seguono ad essere liberi di sviluppare
96 Il prof. Brian Fitzgerald , della Queensland University of Technology, riporta un caso analogo in occasione del quinto Workshop di Communia, dal titolo “Accessing, Using, Re-using Public Sector Content and Data” (http://www.communia-project.eu/ws05). In occasione degli incendi che attorno al 7 febbraio 2009 (“Black Saturday bushfires”) hanno devastato lo stato australiano di Victoria -provocando 173 morti e oltre 400 feriti- Google Australia collaborava con la Country Fire Authority (che interviene per gli incendi su terreni privati) per riportare su Google Maps i dati in possesso dell’autorità e dunque mappare in tempo reale i luoghi via via interessati dagli incendi. L’intenzione di Google era quella di localizzare altresì sulle proprie mappe gli incendi scoppiati sul suolo pubblico, grazie ai dati in possesso del Dipartimento per l’Ambiente di Victoria. Dal momento però che tali dati sono coperti dal Crown copyright e si rende necessaria un’autorizzazione governativa prima di procedere al loro utilizzo, di fatto a Google viene negato il permesso di utilizzare i dati e di riportarli utilmente sulle proprie mappe. La collaborazione tra governo di Victoria e Google Australia si realizza dunque solo all’indomani dell’emergenza più acuta, con la Victorian Bushfires Events Map, che fornisce indicazioni ai cittadini di Victoria circa gli eventi e le raccolte di denaro finalizzate a sostenere le vittime degli incendi. Per più estese riflessioni e ulteriori esempi, si rimanda ai materiali della conferenza Communia: http://www.communia-project.eu/node/223. 97 Si tratta dell’agenzia nazionale britannica di cartografia, tra i più significativi produttori di mappe a livello mondiale; per un’idea circa l’accuratezza e la varietà dei servizi offerti, il riferimento web è: www.ordnancesurvey.co.uk.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
46
prodotti a valore aggiunto e di trarre un utile da essi; da ciò deriva che soltanto
l’informazione coessenziale alla missione istituzionale del settore pubblico deve
essere ceduta secondo criteri di costo marginale. In secondo luogo, i trading funds
(quali Ordnance Survey o Meteorological Office) sono autorizzati a mantenere un
modello di cost recovery, in quanto offrono servizi di tipo differente da quelli
valutati come essenziali dell’attività governativa.
La terza eccezione, infine, riguarda la lealtà della concorrenza: laddove il servizio
d’informazione sia fornito in una situazione di concorrenza con il settore privato,
la tariffa applicata dovrebbe certamente inglobare un margine di profitto e dunque
approssimarsi al prezzo di mercato.
Rispetto alle variabili finora elencate, risulta chiaro che la disciplina italiana di
attuazione della dierttiva, contenuta nel d. lgs. 36/2006, opti per la valorizzazione
del patrimonio informativo nei termini di diretta produzione di valore per le
amministrazioni cedenti: il criterio di tariffazione, infatti, è diretto non soltanto a
recuperare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, ma anche a
realizzare un “utile”da determinare sulla base delle spese per investimenti
sostenute nel triennio precedente98.
La politica nazionale di riutilizzo dell’informazione pubblica, dunque, appare
marcatamente orientata nel senso della commercializzazione dei dati pubblici con
finalità, innanzitutto, di autofinanziamento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione.
Per concludere, si osservi che la scelta di una determinata politica tariffaria e
l’elaborazione di criteri con essa coerenti appaiono inscindibili da un’approfondita
valutazione circa l’impatto economico delle diverse politiche di prezzo. Se, da un
lato, è possibile prevedere con una certa sicurezza che prezzi più elevati della
materia prima informazione pubblica determinino un generale effetto depressivo
dei prodotti informativi elaborati a partire da essa, restano da valutare gli effetti
sulle casse del settore pubblico.
98 Cfr. art 7, co. 2 del d.lgs. n. 36/2006, dove vengono inclusi anche i costi di raccolta/produzione oltre a quelli, marginali, di riproduzione e diffusione. In coerenza con questa previsione, il successivo co. 5 prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione di tali tariffe sono destinati a confluire nel bilancio delle amministrazioni cedenti. La determinazione delle tariffe è quindi rimessa alle stesse amministrazioni (cfr. co. 1 e 6) e di esse va data pubblicità non solo mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma anche tramite i siti ufficiali delle amministrazioni interessate.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
47
La quasi totalità dei casi osservati in letteratura99 mostrano che i maggiori incassi
diretti derivanti da tariffe più elevate sono più che compensati in negativo dalle
minori entrate indirette derivanti dalla tassazione dei prodotti informativi; ciò
sarebbe riconducibile ad elementi –intrinseci al mercato dell’informazione- quali
l’elevata elasticità della domanda, assieme ad una tendenza da parte del settore
pubblico ad assumere, nel momento della commercializzazione dei propri dati,
atteggiamenti anticompetitivi.
In ogni caso, risulta evidente che un sistema che rimette alle amministrazioni non
solo la scelta circa la politica di riutilizzo, ma anche la scelta sulle politiche di
prezzo, innegabilmente tende a favorire la prospettiva dei profitti diretti delle
singole amministrazioni e a trascurare, invece, il soddisfacimento di un interesse
generale che si realizza in maggiori entrate erariali e, soprattutto, in un mercato
dell’informazione autenticamente competitivo.
1.3.4 Gli istituti pro-concorrenziali nella disciplina del riutilizzo
L’obiettivo di costituire le condizioni per la crescita di un robusto mercato
europeo dei prodotti informativi, fondato sul riutilizzo dei dati pubblici, non
poteva che essere perseguito mediante l’elaborazione di una disciplina pro-
concorrenziale, capace di aprire il mercato a nuove imprese contribuendo allo
stesso tempo a contenere o a ridurre i costi dei dati come materia prima. Per ciò
che attiene al secondo punto, la direttiva presenta –come osservato- diversi limiti,
in alcuni casi accentuati dalla sua attuazione nei vari ordinamenti nazionali.
Sicuramente più efficace, invece, appare il capitolo dedicato alle misure
antidiscriminatorie e a tutela della concorrenza. Quelle previste dal d.lgs. 36/2006,
che accolgono le soluzioni delineate nella direttiva, si articolano sostanzialmente
su tre punti:
99 Per un’analisi comparativa fondata su dati empirici, dell’impatto delle politiche di open access rispetto all’approccio di cost recovery, si veda, oltre a P. N. WEISS, Conflicting PSI Policy and their Economic Impacts, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 137 ss., anche BOOZ ALLEN & HAMILTON, La valorizzazione dei dati pubblici, 2006; LONGHORN R., BLAKEMORE M., Re-visiting the Valuing and Pricing of Public Sector Information, Journal of Digital Information, vol. 3, n. 2, 2003, nonché PIRA, Commercial Exploitation of Europe’s Public Sector Information, Final Report to the European Commission, Directorate General for the Information Society, 2000.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
48
a) il dovere di cedere le informazioni a tutti gli operatori di mercato
interessati e, in generale, a tutti coloro che le richiedano, anche per
finalità non commerciali, una volta che si sia stabilito di consentire il
riutilizzo;
b) il dovere di cedere le informazioni dello stesso tipo alle medesime
condizioni;
c) il divieto di accordi di esclusiva, salvo il caso in cui tale accordo sia
indispensabile per l’assolvimento di un servizio di interesse generale.
In realtà si tratta degli strumenti più tradizionali utilizzati per la promozione di
dinamiche concorrenziali in quei settori caratterizzati da condizioni di monopolio
nella fornitura di c.d. essential facilities100, situazione cui è assimilabile la
situazione della p.a. nella cessione delle informazioni suscettibili di riutilizzo.
Per ciò che riguarda invece le attività di riutilizzo intraprese dalle amministrazioni
stesse, il legislatore si è limitato a stabilire che, fuori dei casi in cui lo scambio tra
amministrazioni sia funzionale ai rispettivi compiti istituzionali, deve trovare
applicazione la disciplina sul riutilizzo, in particolare quando la cessione sia
finalizzata ad un riutilizzo commerciale da parte dell’amministrazione richiedente.
A differenza della disciplina comunitaria101, quella nazionale non affronta nel
dettaglio il tema del riutilizzo commerciale posto in essere direttamente
dall’amministrazione titolare dei dati. Troveranno dunque applicazione diretta
principi e regole in materia di concorrenza, anche previa disapplicazione della
disciplina nazionale di settore che contrasta con i suddetti principi. Questi ultimi
sostanzialmente impongono l’adozione di meccanismi operativi e di trasparenza
tali da rendere chiare le condizioni economiche del riutilizzo, tenendo presente
100 Di norma, le condizioni per l’applicazione della dottrina delle essential facilities di individuano: a) nel controllo monopolistico sulla risorsa da parte del titolare; b) nella essenzialità della risorsa per lo svolgimento dell’attività da parte del richiedente; c) nell’inesistenza di ragioni obiettive che giustifichino il rifiuto della richiesta da parte del titolare della risorsa. Sulla citata dottrina e sull’applicazione ai casi di monopolio legale sui dati delle amministrazioni, v. B. PONTI, op. cit., p. 21; con particolare riguardi ai dati conservati nei registri immobiliari dell’Agenzia del Territorio, C.E. MEZZETTI, Dati pubblici ed abuso di posizione dominante, nota a commento delle ordd. Trib. App. di Milano, 2 maggio e 5 luglio 2005, in Giuri. It., III, 2006, pp. 549 ss. 101 Il considerando (9) della direttiva 2003/98/CE afferma che “al fine di evitare sovvenzioni incrociate, il riutilizzo dovrebbe comprendere l’ulteriore uso di documenti all’interno della propria organizzazione per attività che esulano dall’ambito dei compiti di servizio pubblico. Le attività che esulano dai compiti di servizio pubblico comprenderanno, di norma, la fornitura dei documenti che sono prodotti e per i quali viene chiesto un corrispettivo in denaro esclusivamente su base commerciale e in concorrenza con altri sul mercato”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
49
che dette condizioni devono essere garantite anche agli altri operatori presenti sul
mercato, o in procinto di entrarvi.
Meritevole di approfondimento appare, in particolare, la clausola che ammette gli
accordi in via esclusiva, a condizione che tale accordo risulti necessario ai fini
dell’erogazione di un servizio di pubblico interesse. Se si considerano le
peculiarità del bene oggetto della disciplina, ovvero l’informazione, ne deriva che
l’accordo in via esclusiva potrà trovare spazio solo nella misura in cui il motivo di
pubblico interesse perseguito consista nell’offerta dei prodotti e servizi, frutto
dell’attività di riutilizzo, ad un prezzo inferiore a quello concretamente praticabile
dalle imprese in concorrenza tra loro sul mercato. Tale situazione appare possibile
solo qualora il terzo non svolga un’attività imprenditoriale in senso proprio oppure
l’amministrazione cedente accetti di accollarsi una parte dei costi di produzione
del servizio.
Nel primo caso ci si troverebbe di fronte ad un’ipotesi di cessione o scambio dei
dati all’interno del settore pubblico, in ogni caso ad una ipotesi di riutilizzo di tipo
non commerciale; nella seconda ipotesi, invece, la riserva dell’attività di riutilizzo
in capo ad un soggetto imprenditoriale presupporrebbe, in conformità con i
principi comunitari, l’assegnazione del servizio (di interesse pubblico) mediante
gara, o in ogni caso attraverso una procedura aperta e non discriminatoria.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
50
Capitolo secondo
I diritti di proprietà intellettuale sulla PSI e le licenze di
utilizzo
2.1. I dati pubblici e la tutela del diritto d’autore
Ogni riflessione circa lo status dell’informazione pubblica in termini di proprietà
intellettuale trova la sua premessa necessaria nella Convenzione di Berna102, che
non contiene disposizioni specificamente volte a disciplinare tale ambito, ma
piuttosto autorizza scelte discrezionali, da parte degli Stati firmatari, circa il
livello di protezione da accordarsi alle opere di cui lo Stato sia autore, in
particolare ai testi ufficiali. L’art. 2, c. 4 della Convenzione di Berna riserva infatti
“alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare
ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle
traduzioni ufficiali di questi testi”.
In particolare, la normativa italiana sul diritto d’autore, contenuta nella legge
633/41103, esclude all’art. 5 che la legge in oggetto si applichi“ai testi degli atti
ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere”.
Tale scelta si pone in coerenza con quella compiuta dalla maggioranza degli Stati
membri dell’Europa continentale (oltre all’Italia, possiamo citare Danimarca,
Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia), che,
nello spazio di discrezionalità loro riconosciuto dalla Convenzione di Berna,
hanno escluso parti consistenti dei materiali ufficiali dalla tutela del diritto
1 Convenzione di Unione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. 103 Legge del 22 aprile 1941 n. 633, relativa alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
51
d’autore. D’altra parte, negli Stati in cui questa scelta non è stata compiuta per via
legislativa, per esempio in Francia, l’esclusione è stata poi invece operata
attraverso le decisioni della giurisprudenza.
Di verso opposto, invece, la tradizione che il Regno Unito condivide con altri
paesi appartenenti Commonwealth delle Nazioni - e che sarà più avanti oggetto
d’analisi- che prevede l’imposizione di un copyright c.d. della Corona (Crown
copyright) sui testi di natura ufficiale; un indirizzo analogo, peraltro, è seguito da
diversi Paesi che appartengono al citato Commonwealth delle Nazioni, i quali non
conoscono la figura specifica del copyright della Corona, ma che tuttavia
includono i materiali ufficiali nella tutela del copyright104.
Già si è fatto riferimento, nel capitolo precedente, al Copyright Act statunitense,
che alla sezione 105 esclude dalla protezione del copyright i materiali del governo
federale (“Works of the United States government”), qualificando come tali “[the
works] prepared by an officer or employee of the United States Government as
part of that person’s official duties”105 e collocando gli stessi nell’ambito del
pubblico dominio.
Efficacemente rappresentative del quadro fin qui tracciato sono due
rappresentazioni grafiche elaborate da Pamela Samuelson nel tentativo di offrire
una mappatura schematica, di valore il più possibile internazionale, dell’area del
pubblico dominio. La prima delle mappe proposte dalla studiosa di Berkeley
colloca chiaramente il complesso di materiale legislativo, amministrativo e
giurisprudenziale entro l’ambito del pubblico dominio, che risulta raffigurato
nella maniera che segue106:
104 V., sul punto, E. F. JUDGE, Crown Copyright and Copyright Reform in Canada, in M. GEIST (ed), In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law, Irwin Law, September 2005, p. 550-594 e M. PERRY, Acts of Parliament: Privatisation, Promulgation, Crown Copyright — is there a need for a Royal Royalty?, New Zealand Law Review, 1998, pp. 493-529. 105 V. United States Code, Title 17, Chapter 1, Section 101. 106 P. SAMUELSON, Challenges in Mapping the Public Domain, in L. GUIBAULT, P. B. HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, The Hague, Kluwer Law International, 2006, p. 9.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
52
È la stessa Samuelson ad avvertire, però, che il proposito di costruire uno schema
dotato di un buon grado di universalità si trova in gran parte frustrato
dall’inserimento, nell’ovale del pubblico dominio, della voce “Laws, Regulations,
Judicial Opinions”: si tratta, infatti, di una scelta certamente coerente con la
sensibilità americana, ma tale da rendere la “mappa” qualificabile come “US-
centric”, posto che diversi Stati - tra cui Regno Unito, Canada e Australia -
riconoscono la tutela del copyright alle menzionate categorie di contenuti. Da ciò
nasce la necessità di elaborare una seconda rappresentazione, emendata delle voci
di cui sopra, e capace di attrarre un consenso più generale. In essa, i testi ufficiali
scompaiono dallo spazio del pubblico dominio, per venire ad avvicinarsi - in via
di prima approssimazione - alla murky area, lo spazio opaco che tiene conto del
carattere complesso di determinati materiali e delle specificità nazionali. Ne
deriva, dunque, una rappresentazione grafica così strutturata107:
107 Ivi, p. 12.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
53
Sebbene, dunque, la maggioranza degli Stati abbia optato per escludere dalla
tutela del copyright il complesso di atti ufficiali da essi prodotti, bisogna
constatare che la parte più consistente del complesso di informazione pubblica
presenta una natura non ufficiale e che, nonostante il carattere per lo più
funzionale della stessa, determinati materiali possano comunque qualificarsi per la
tutela del copyright, fatti salvi, naturalmente, i livelli di originalità e creatività a
ciò necessari.
In linea di principio, dunque, le opere create dalle amministrazioni pubbliche, o
per conto delle stesse, sono trattate alla stregua di ogni altra opera e agli enti
medesimi è riconosciuto il diritto di divenire titolari di diritti di proprietà
intellettuale sull’informazione da essi detenuta; dal momento, però, che la
legislazione sul diritto d’autore presenta peculiarità proprie in ogni Paese - pur
essendo per lo più ispirata a linee di fondo comuni- il regime dell’informazione di
fonte pubblica, nonché le opportunità di riutilizzo della stessa, presenteranno
specificità proprie a seconda dei confini nazionali.
La legge italiana sul diritto d’autore prevede, all’art. 11, che “Alle
amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni spetta il diritto d’autore
sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”
(estendendo al secondo comma tale regola anche “agli enti privati che non

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
54
perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere
pubblicate”).
Secondo la prevalente dottrina, la disposizione in oggetto sarebbe mirata,
soprattutto, a determinare l’effetto legale dei contratti di lavoro autonomo e
subordinato conclusi con gli autori dallo Stato e dagli altri enti pubblici per la
creazione di opere destinate ad essere pubblicate a nome degli enti stessi,
sottolineando che lo Stato e gli altri enti indicati dall’art. 11 in tanto acquistano (a
titolo derivativo) il diritto d’autore in quanto le opere siano state create in
esecuzione di un contratto di lavoro subordinato o autonomo in vista della
pubblicazione a nome e a spese dell’ente.
L’art. 29, quindi, fissa in vent’anni a partire dalla prima pubblicazione “la durata
dei diritti esclusivi di utilizzazione economica” spettanti allo Stato e agli altri enti
ai sensi dell’art. 11108.
Come esempio di altra normativa europea, che condivide con quella italiana
l’esclusione dei testi ufficiali dalla tutela del copyright, ma che presenta, allo
stesso tempo, connotati propri, si può richiamare quella dei Paesi Bassi, così come
definita nella legge olandese sul diritto d’autore. L’art. 15, lett. b) di detta legge,
così come l’art. 8, c. 2 della legge olandese sulla tutela del database, contiene una
sorta di reservation rule, in virtù della quale un’autorità pubblica può esercitare il
proprio diritto d’autore e diritto sui generis solo nella misura in cui tale riserva sia
esplicitamente formulata in via generale, per legge, ordinanza o delibera, oppure
in via specifica, attraverso un apposito avviso inserito nell’opera o nel database in
questione, sempre che questi siano stati comunicati al pubblico.
Le riserve di tipo generale appaiono particolarmente scarse, soprattutto presso gli
enti locali: il che suggerirebbe non tanto la scelta di collocare l’informazione
pubblica locale nell’area del pubblico dominio, quanto piuttosto una scarsa
consapevolezza da parte degli enti pubblici circa il particolare status, in termini di
proprietà intellettuale, dell’informazione da essi detenuta.
108 Sembra ragionevole ritenere che il legislatore abbia attribuito alle amministrazioni dello Stato e agli altri enti un diritto di utilizzazione limitato nel tempo, lasciando però impregiudicato il diritto spettante agli autori, che quindi alla scadenza dei vent’anni riacquistano la piena disponibilità del diritto. Si vedano le considerazioni svolte sul punto da P. AUTERI, Il diritto d’autore dello Stato e di alcuni enti pubblici e privati, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, II ed., Giappichelli Editore, Torino, 2005, pp. 538-539.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
55
Per ciò che riguarda, invece, le riserve di tipo specifico, la situazione è più
diversificata: da un lato, gli enti che hanno come compito istituzionale la raccolta
e la diffusione di determinate tipologie di informazione (quali il Catasto, o
l’Istituto Meteorologico Nazionale), presentano una maggiore consapevolezza
circa i profili di proprietà intellettuale; dall’altro, come efficacemente illustrato da
uno studio di Mireille Van Eechoud e Brenda Van del Wal, il semplice passaggio
in rassegna di alcuni significativi siti Internet istituzionali è sufficiente a rendere
l’idea di una situazione di generale disomogeneità, che interessa tanto le modalità
con cui le riserve sono formulate (e la loro collocazione nell’ambiente web),
quanto la misura delle riserve medesime109.
109 Si riporta uno dei passaggi più illuminanti dell’analisi svolta da M. VAN EECHOUD e B. VAN DER WAL, Creative Commons Licensing for Public Sector Information. Opportunities and Pitfalls, Institute for Information Law, University of Amsterdam, 2008, pp. 25-26: “A quick check of websites published by public authorities, shows that a number ministries and of a number of non-departmental public bodies
do not reserve copyrights, so the works offered on the website
would appear to be free for reproduction and further communication to the public. However, most websites of (other) public authorities do contain reservations, either on the bottom of each sub page or in the colophon of their website, or both. The examples below show that there is no consistency in the way copyright reservations are expressed, nor in the scope of the reservation itself: − City of Amsterdam (www.amsterdam.nl.): every sub page contains a ©-sign and the copyrights are explicitly reserved in the ‘Disclaimer & Copyright’-section. − Royal family at www.koninklijkhuis.nl: every sub page published by the RVD (Government Information Service/Central Office of Information), contains ‘© RVD’. Clicking the ©-sign directs a visitor to a page
on which the RVD gives permission to use photos published on the website for
personal and educational use. For every other use permission must be requested, with the notification that commercial use will not be permitted. − Office of the Prime Minister/Ministry of General Affairs at www.minaz.nl: shows a ©-sign on the bottom of every sub page, linking to a sub page
on the copyright restriction. The website gives
permission to use parts of the website under the condition that the source is acknowledged. − Ministry of Transport and Public Works at www.minvenw.nl: reservation in the ‘help’-section, with explicit permission for all uses on condition that the source is acknowledged. − Ministry of Transport and Public Works, Department of Waterways and Public Works at www.rijkswaterstaat.nl: only through use of search function are several ‘disclaimer’ sub pages are found, containing a copyright reservation.
The scope of the reservations is unclear. The
wording can be interpreted as all copyrights in all works on the website of the Department of Waterways and Public Works are reserved, or as only governing the sub pages. − Ministry of Education, Culture and Science at www.minocw.nl: reservation in the ‘help’-section, with explicit permission for all use of text and photography on the website, on condition that the source is acknowledged. […] - Chambers of Commerce at www.kvk.nl: broad reservation on disclaimer page, authorizing only copying for private use. − Vehicle Registry at www.rdw.nl: only copyright notice on individual pages. The examples show that reservations may be difficult to find for users, as information on rights of use requires an active search. When the public sector body only includes a copyright notice (the © sign) or only the name and year (source) this can hardly be regarded as a copyright reservation within the meaning of article 15b Copyright Act, for lack of being explicit. Another problem is that a reservation of rights in a colophon or disclaimer section does not clarify the extent of the reservation. It is often not clear whether all elements of the website and all works available on the website, including downloadable maps and brochures, fall under the reservation. Public sector

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
56
Ciò determina, nel complesso, una situazione di scarsa chiarezza circa i possibili
utilizzi dell’informazione del settore pubblico, quando non addirittura di
incoerenza con un regime di riutilizzo effettivo, quale quello delineato dalla
direttiva 2003/98/CE: si tratta, in ogni caso, di una situazione per lo più condivisa
dalla totalità degli Stati membri - che raggiunge, nel caso dell’Italia, livelli di
eloquente disorganicità - e che sarà, ancora, oggetto di analisi nei paragrafi
successivi.
Meritano ancora un approfondimento, infine, le peculiarità dell’istituto britannico
del Crown copyright, soprattutto alla luce dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2005,
delle Re-use of Public Sector Information Regulations, con cui il Regno Unito, a
dispetto di una forte tradizione di controllo sull’informazione di fonte governativa,
ha proceduto ad una delle soluzioni di più brillante implementazione della
direttiva 2003/98/CE.
Il Copyright, Designs, Patents Act del 1988 così recita alla sezione 163: “Where a
work is made by Her Majesty or by an officer or servant of the Crown in the
course of his duties: (a) the work qualifies for copyright protection […]; (b) Her
Majesty is the first owner of any copyright in the work”; tale copyright della
Corona ha una durata di 125 anni dalla realizzazione dell’opera o dell’atto, o di 50
anni dalla pubblicazione commerciale degli stessi e sussiste, inoltre, in tutti gli atti
del Parlamento e nei provvedimenti del Sinodo Generale della Chiesa
d’Inghilterra110.
La sezione 165 regolamenta, invece, un’altra tipologia di copyright, il
Parliamentary copyright: “Where a work is made by or under the direction or
control of the House of Commons or the House of Lords: (a) the work qualifies for
copyright protection […]; (b) the House by whom, or under whose direction or
control, the work is made is the first owner of any copyright in the work, and if the
work is made by or under the direction or control of both Houses, the two Houses
are joint first owners of copyright; detta tutela, che ha una durata prevista di 50
bodies are often not clear on the uses that the copyright and database acts exempts (private copying, right to quote, etc.), although one may assume that an unrestricted reservation does not aim to curtail such exempt uses.” 110 V. L. BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law, III edition, Oxford University Press, 2009, p. 131. Per una panoramica sul Crown copyright, così come per l’elenco dei principali enti che fanno capo alla Corona, si veda la pagina web http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/uk-crown-bodies, che contiene altresì una lista esaustiva dei più significativi enti qualificabili come “Non-Crown bodies”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
57
anni dalla realizzazione dell’opera, cessa di esistere quando sul progetto di legge
intervenga il consenso della regina, oppure lo stesso sia ritirato o rigettato111.
A partire dal 1889 e su nomina della regina Vittoria, l’istituto con la principale
responsabilità della gestione del copyright della Corona è stato l’Her Majesty
Stationery Office (HMSO), che le Regulations del 2005 hanno inglobato
nell’Office of Public Sector Information (OPSI), l’ente appositamente creato dal
governo inglese come responsabile della regolamentazione e dell’attuazione delle
politiche di riutilizzo della PSI, quali rese necessarie dal recepimento della
direttiva 98/2003/CE.
La scelta di istituire un simile organo, e di affiancarlo ad un altro ente
specializzato con competenze consultive, l’Advisory Panel on Public Sector
Information (APPSI)112, configura una delle tappe più significative del percorso
intrapreso dal governo britannico a partire dalla fine degli anni novanta, nella
direzione di rendere l’informazione ufficiale più autenticamente accessibile113.
Nel solco del medesimo orientamento si colloca altresì la scelta, compiuta dal
governo nel 2001, di sottrarre al regime del Crown copyright significative
categorie di materiali (tra essi, in primo luogo, la legislazione primaria e
secondaria, le note esplicative alle leggi e i comunicati stampa del governo) i
quali, dunque, risultano utilizzabili a titolo gratuito e senza necessità di una
111 Ivi, p. 132. 112 Nel modello inglese la funzione di coordinamento, supporto e promozione, in capo all’OPSI, risulta disgiunta da quella di garanzia, che, appunto, fa capo all’APPSI; nell’esperienza francese, invece, l’attuazione della direttiva 2003/98/CE ha comportato l’integrazione delle funzioni contenziose della Commission d’accès aux documents administartifs anche in relazione alle istanze di riutilizzo. Secondo quanto osserva Ponti, i limiti della disciplina italiana in materia di riutilizzo dell’informazione pubblica sono tutti riconducibili, essenzialmente, alla mancata individuazione di una funzione di supporto, di guida e di garanzia quanto alla concreta attuazione di tale istituto da parte del settore pubblico. Al di là della corretta identificazione della situazione giuridica soggettiva cui ricondurre l’interesse al riutilizzo della PSI, la previsione di un meccanismo contenzioso di tutela rappresenterebbe già di per sé una modalità efficace di tutela di detto interesse. Ma è evidente che un simile meccanismo implichi anche la costituzione di una figura istituzionale, indipendente, che possa garantire la credibilità e l’operatività dello stesso. Cfr. B. PONTI, Il patrimonio informative pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, Diritto Pubblico, n.3/2007, p. 1004. 113 L’evoluzione verso un modello di open government si trova testimoniata in diversi documenti governativi, tra cui risultano particolarmente significativi: Your Right to Know: the Government’s proposal for a Freedom of Information Act, Presented to Parliament by the Chancellor of the Duchy of Lancaster by Command of Her Majesty , HMSO, December 1997; Crown Copyright in the Information Age, 1998, disponibile all’indirizzo web http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/crown-copyright-in-the-information-age.pdf; The Future Management of Crown Copyright, 1999. per un eccellente contributo sull’evoluzione delle politiche di governo britanniche in tema di informazione pubblica, si rimanda a: S. SAXBY,

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
58
specifica licenza, a patto che la Corona sia riconosciuta come autore del materiale,
che lo stesso venga accuratamente riprodotto, mantenuto aggiornato e non
utilizzato in maniera fuorviante114.
Uno dei servizi chiave gestiti dall’OPSI, supportato peraltro da una struttura
Internet che spicca in ambito europeo per chiarezza delle soluzioni e capacità
divulgativa, consiste nell’offerta di un set di licenze finalizzate a regolamentare il
riutilizzo dell’informazione soggetta a Crown copyright, nonché a Parliamentary
copyright, e della PSI in generale. Dalla creazione dell’OPSI, le tipologie di Click-
Use Licences sono state essenzialmente tre: la PSI Licence, che copre la parte più
consistente dell’informazione soggetta a copyright della Corona e in generale la
PSI; la Parliamentary Licence, che riguarda i bills del Parlamento; infine, la Value
Added Licence, avente ad oggetto la “Crown copyright information” dotata di
valore aggiunto e unica tra le tre licenze a contemplare l’eventualità
dell’applicazione di tariffe, variabili a seconda della tipologia di informazione
destinata al riutilizzo. Dal 1 dicembre 2009, però, in linea con la politica
governativa tesa a rendere gratuitamente riutilizzabile la maggior quantità
possibile di informazione amministrativa, l’OPSI ha eliminato quest’ultima
tipologia di licenza e ha ora reso i contenuti in precedenza diffusi secondo i
termini della Value Added Licence accessibili senza alcun costo secondo lo
schema della PSI Licence: l’unica eccezione a ciò è rappresentata da quegli enti
amministrativi – primi fra tutti i Trading funds – autorizzati da una delega
dell’HMSO a licenziare autonomamente l’informazione da essi prodotta secondo
modalità di tipo commerciale115.
Sebbene, dunque, le recenti iniziative del governo circa la gestione del Crown
copyright si pongano in assoluta coerenza con quanto disposto dalla direttiva sul
riutilizzo della PSI, l’efficacia delle stesse è frenata, come osservano Birkinshaw e
Crown Copyright Regulations in the UK- Is the Debate Still Alive?, International Journal of Law and Information Technology, vol.13, n.3, 2005, pp. 299-335. 114 Il sito dell’OPSI, nella sezione Waiver of Crown copyright, indica anche le seguenti categorie di documenti come suscettibili di libere utilizzazioni: Published papers of a scientific, technical or medical nature, Unpublished public records, Government forms, Government consultative documents, Government documents featured on official departmental websites except where expressly indicated on the website in question, Headline statistics, Text of ministerial speeches and articles, Typographical arrangement. V. http://www.opsi.gov.uk/advice/crown-copyright/copyright-guidance/waiver-of-crown-copyright.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
59
Hicks in un interessante contributo del 2007, da tre classi di fattori116. In primo
luogo, molti enti pubblici continuano a vedere la PSI come una risorsa di loro
proprietà, piuttosto che come un complesso di materiali che è liberamente
condiviso o fornito. In secondo luogo, si rileva un atteggiamento di certa inerzia a
livello dipartimentale: le iniziative sulla PSI non figurano tra le priorità politiche e
c’è carenza di dialogo tra i ministeri e il principale organo responsabile delle
politiche di PSI, l’APPSI117. Infine, soprattutto, il governo tratta l’informazione in
maniere conflittuali: da un lato abbraccia l’idea di sostenere Internet e le politiche
di libero accesso all’informazione pubblica; dall’altro, però, gli enti sono
incoraggiati a proteggere il copyright e a sfruttarlo commercialmente. L’esempio
più significativo di tale indirizzo riguarda, ancora una volta, i Trading Funds,
chiamati ad autofinanziarsi attraverso attività commerciali (prima fra tutte, la
“vendita” della propria PSI) e a versare parte degli introiti al Tesoro118.
Le considerazioni che precedono sono sostanzialmente condivise da Richard
Susskind, presidente dell’APPSI dal 2003 al 2008, che denuncia una certa
frammentazione delle politiche governative in rapporto alla PSI e osserva che
nonostante la proprietà intellettuale sia il principale strumento giuridico di
gestione del riutilizzo della PSI, il regime del copyright nel settore pubblico
manifesta troppo spesso caratteri di disomogeneità. Ad esempio, alcuni organi
115 Maggiori informazioni su queste recentissime iniziative di accorpamento e riorganizzazione delle licenze sono reperibili alla pagina http://www.opsi.gov.uk/click-use/value-added-licence-information/index. 116 P. J. BIRKINSHAW, A. HICKS, The Law and Public Information on UK: Quality, Access and Re-Use, in B. PONTI (a cura di), Il regime dei dati pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Maggioli Editore, 2008, pp. 34-46. 117 L’assenza di un deciso interesse a livello ministeriale nelle politiche di sostegno alla PSI è sottolineato in particolare nella relazione annuale dell’APPSI del 2006 (2006 Annual Report, p. 9), che denuncia l’assenza di significativi incontri con alcuno dei ministri nei 18 mesi precedenti. 118 Le Regulations del 2005 recepiscono quanto previsto dall’art. 1, c. 2 della direttiva PSI, che esclude dal campo d’applicazione i “documenti la cui fornitura è un'attività che esula dall'ambito dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici in questione”. Il Review Board dell’APPSI ha rilevato che i criteri elaborati per definire il concetto di “compiti di servizio pubblico” hanno carattere troppo generale e che, soprattutto nel caso dei Trading Funds, risulta complicato distinguere ciò che è incluso e ciò che, invece, resta escluso da tale definizione. Secondo l’opinione del Review Board, è verosimile che i documenti prodotti con finalità di sfruttamento commerciale ricadano fuori dai compiti istituzionalmente accordati ai Trading Funds, andando dunque a sottrarre al campo d’applicazione delle Regulations alcune tra le categorie più redditizie della PSI britannica. Sebbene, infatti, vi siano nel Regno Unito oltre 110,000 enti amministrativi, la PSI più economicamente significativa è concentrata in poche mani. Nell’anno 2004/2005, ad esempio, gli introiti complessivi derivanti dalla fornitura di informazione pubblica ammontavano a 400,000 sterline. Ma di questi, più di 290,000 sterline sono stati guadagnati da solo cinque enti: l’Ordnance Survey (100 £); The Met Office (90 £); UK Hidrographic Office (57.2 £); HM Land

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
60
centrali di governo, che si suppongono facenti capo alla Corona e quindi soggetti,
come tali, alla disciplina del Crown copyright, non sono invece per ragioni
tecniche organi della Corona e seguono regole sul copyright diverse a seconda
dello specifico ente; ancora differenti sono poi le norme applicabili
all’informazione degli enti locali e ai documenti soggetti a copyright
parlamentare, sebbene quest’ultimo sia anch’esso gestito dall’OPSI119.
A dispetto della critiche riportate, pare in ogni caso doversi dare conto degli
elementi d’eccellenza dell’esperienza inglese, espressione, tra le più riuscite, di
una sinergia strategica tra il diritto d’accesso – generalizzato- delineato dal FOIA
del 2000 e la piattaforma di coordinamento resa necessaria dalle Regulations del
2005: tutte le più recenti iniziative intraprese dal governo britannico vanno nella
direzione di ribadire, e di potenziare, questo intento, compreso il progetto,
annunciato dall’OPSI i primi di dicembre 2009, di ricondurre sotto lo schema
della PSI Licence una parte consistente dell’informazione locale e di quella
statistica, nazionale, entrambe attualmente rese disponibili a pagamento.
In conclusione di paragrafo, pare opportuno raccordare la breve panoramica fin
qui rappresentata al tema generale della proprietà intellettuale sulla PSI e in
particolare a quello del rapporto tra questa e il riutilizzo, così come delineato dalla
direttiva 2003/98/CE.
Il testo della direttiva non affronta direttamente il tema del conflitto tra i diritti di
proprietà intellettuale sull’informazione di cui il settore pubblico è titolare e
l’impegno a consentire il riutilizzo della stessa. Le sole indicazioni, in questo
senso, sono contenute nei considerando 22 e 24, il cui contenuto è ribadito in
particolare dal comma 5 dell’art. 1.
Il considerando 22 sottrae innanzitutto al campo d’applicazione della direttiva i
materiali su cui i terzi siano titolari di diritti di proprietà intellettuale, specificando
che con i termini «diritti di proprietà intellettuale» si indicano esclusivamente il
diritto d'autore e i diritti connessi, comprese le forme di protezione sui generis.
Registry (29.4 £); Companies House (29,4 £). V. Office of Fair Trading (OFT), Commercial Use of Public Sector Information, December 2006, par. 3.1-3.10. 119 R. SUSSKIND, The Public Domain and Public Sector Information, in C. WAELDE, H. MACQUEEN (a cura di), Intellectual Property. The Many Faces of the Public Domain, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2007, pp. 166-171.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
61
Il testo del considerando, dunque, così prosegue: “La direttiva lascia
impregiudicate l'esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da
parte degli enti pubblici e non limita in alcun modo l'esercizio dei diritti al di là di
quanto da essa stabilito. Gli obblighi di cui alla presente direttiva si dovrebbero
applicare soltanto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni degli
accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in
particolare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (la «convenzione di Berna») e l'accordo sugli aspetti dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio (l'«accordo TRIPS»)120, ma si
conclude, alquanto contraddittoriamente rispetto a quanto appena riportato,
affermando che “gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio
diritto di autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo dei documenti”.
È infatti innegabile che la direttiva ignori, di fatto, un punto che sarebbe stato
fondamentale sviluppare ai fini di un adeguata armonizzazione in materia di
riutilizzo della PSI, vale a dire se sia davvero opportuna l’esistenza di diritti di
proprietà intellettuale, in particolare di diritto d’autore, sull’informazione del
settore pubblico. Su questo punto si levano, dalla dottrina, opinioni contrastanti:
secondo Estelle Derclaye, che denuncia il carattere insoddisfacente del quadro
normativo tracciato dalla direttiva, “arguably excluding all PSI from IPR would
be the clearest, simplest and most effective solution. […] More needs to be done
if EU information industry is to compete on a level-playing field with the USA but
more importantly for the citizen and in fact the whole world to be adequately
informed. This is of the utmost importance in our times in view of the increasing
dangers caused by humans to the planet, not to mention global warming. If we
want to react adequately, we need information and this information is generally
detained by governments. As we have all subsidised it, we arguably all have a
right to have this information available free of charge and to re-use it as free as
120 Tale indirizzo è ribadito e, allo stesso tempo, specificato dal considerando 24 della direttiva, che recita quanto segue: “La presente direttiva lascia impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione e la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati. Essa definisce le condizioni di esercizio dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno dell'informazione da parte degli enti pubblici, laddove permettano il riutilizzo di documenti”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
62
possible. For such acute global problems, time is of essence. Public sector
information needs to be freed now not in five or ten years’ time”121.
Diversa, invece, l’opinione di Mireille van Eechoud, che enfatizza l’opportunità di
rifondare, sugli stessi diritti di proprietà intellettuale, paradigmi alternativi di
gestione dell’informazione pubblica: “As regards intellectual property, it is not
realistic to propose the exclusion of public sector information from protection. It
may even be counterproductive. As put forward by the open source and open
archives movement, intellectual property rights may be used to counter overbroad
claims in products or services based on government information”122;
“Dissemination based on so-called ‘open’ information models, notably Creative
Commons, could be a viable option for a large quantity of government information.
Open information models use intellectual property in an alternative way, to
essentially further the non-discriminatory distribution of information at standardized
and liberal terms, at no charge for the use of the information itself (royalty free)”123.
Si tratta, in ogni caso, di divergenze che non coinvolgono la sostanza della
questione, e che trovano origine in una constatazione su cui si raduna il consenso
di tutti i commentatori: l’assenza, cioè, di una presa di posizione netta, da parte
della direttiva, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale di cui sono titolari i
vari Stati membri, omissione che è frutto, come già più volte sottolineato, di un
compromesso tra stati fautori dell’open access e altri, invece, più ancorati a
logiche di tipo proprietario.
2.2. L’informazione governativa e la direttiva 96/9/CE: un diritto sui
generis sulle banche dati pubbliche?
121 E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s database sui-generis right?, in J. GASTER, E. SCHWEIGHOFER, P. SINT (a cura di), Knowledge Rights – Legal, societal and related technological aspects, Austrian Computer Society, 2008, pp. 168- 169. 122 M. VAN EECHOUD, The Commercialization of Public Sector Information, in GUIBAULT, HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain, cit., p. 301. 123 M. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 2.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
63
Con la direttiva 96/9/CE124 il legislatore comunitario è intervenuto vincolando gli
Stati membri ad accordare alle banche dati una duplice tutela: quella generale del
diritto d’autore alle banche dati che “per la scelta o per la disposizione del
materiale costituiscono una creazione dell’ingegno propria del loro autore” (art.
3 n. 1 della dir. e ora art. 1.2 l. aut.) e una tutela sui generis125 della durata di 15
anni alle banche dati nelle quali “il conseguimento, la verifica e la presentazione”
del contenuto abbia richiesto “un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo
o quantitativo” (art. 7, n. 1 della dir. e ora art. 102-bis l. aut.)126.
La prima forma di tutela ha ad oggetto la “forma espressiva” (art. 5 e ora art. 2, n.
9, l. aut.), vale a dire il modo in cui il materiale informativo è selezionato e
organizzato ( e in ciò la direttiva non fa che confermare quanto poteva evincersi
dal diritto vigente); la tutela sui generis ha invece un contenuto fortemente
innovativo, in quanto essa ha ad oggetto il contenuto informativo della banca dati
nella misura in cui “il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale
contenuto” 127 abbia richiesto un investimento rilevante in termini di “risorse
124 Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche dati, G.U.U.E. 1996 L 077/20. 125 Sull’implementazione in Italia della direttiva 96/9/CE, v. P. AUTERI, Le banche dati tra tutela sui generis e diritto d’autore, in P. AUTERI, G. FLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, Diritto industriale, cit., pp. 505-508. Per un inquadramento generale, e aggiornato alla luce della più recente dottrina, v. L. BENTLY, B. SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2009, pp. 310-318. Ricchi di spunti critici, ed elementi di comparazione con il modello statunitense, E. DERCLAYE, The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2008, p. 43-144 e M. DAVISON, Database Protection: The Commodification of Information, in GUIBAULT, HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain, cit., pp. 168-183. 126 Secondo quanto stabilito dall’art. 7, il diritto, per il costitutore della banca dati, di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, matura in presenza di un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo. Non compare una definizione vera e propria di “investimento”: dall’interpretazione dei considerando della direttiva, e degli articoli della stessa, emerge chiaramente che esso può avere natura finanziaria, materiale (ad esempio, acquisizioni di tecnologie informatiche) o umana (in termini di unità di personale, o ore di lavoro). La direttiva tralascia di definire, altresì, il carattere “rilevante” che l’investimento deve rivestire ai fini di accedere alla tutela: come ricorda la Derclaye, diverse corti nazionali e l’avvocato generale presso la Corte di Giustizia Stix-Hackl hanno interpretato questo elemento come di livello piuttosto ridotto: ad esempio, alcuni giorni di lavoro o poche centinaia di euro possono risultare sufficienti a giustificare la tutela. Nell’opinione della Corte di Giustizia, il carattere quantitativo dell’investimento si riferisce alla quantità di tempo e/o di denaro investiti nel conseguimento, nella verifica e nella presentazione della banca dati, mentre il profilo qualitativo sarebbe da relazionarsi agli sforzi e alle energie profuse in dette attività. 127 La Corte di Giustizia ha inteso il termine “conseguimento” come limitato alla collezione degli elementi costitutivi della banca dati, cosa che esclude, dunque, il momento della loro creazione. Tale interpretazione, come si vedrà, riveste un’importanza fondamentale, poiché diversi c.d. “spin-off databases” sono ora esclusi dalla tutela del diritto sui generis: in sostanza, quindi, qualora l’investimento rilevante nella raccolta, nella verifica e presentazione dei dati sia inseparabile dalla

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
64
umane, tecniche e finanziarie” (art. 7 della direttiva). Innanzitutto, la tutela
riconosce al costitutore della banca dati il potere di vietare ai terzi l’estrazione e il
reimpiego dell’intera raccolta o di parti sostanziali di essa, ma gli consente altresì
di limitare i trasferimenti di parti non sostanziali, quando essi, a causa del
carattere ripetuto e sistematico, conducano alla ricostituzione di una parte
sostanziale attraverso la creazione di un’altra banca dati.
Nel 2004, la Corte di Giustizia europea ha elaborato un’interpretazione del diritto
sui generis che ha contribuito ad ridefinire e ridurre alcuni caratteri di eccessiva
vaghezza e generalità dello stesso. Si tratta, in particolare, di quattro decisioni
correlate del 9 novembre 2004128, il cui effetto è quello di ridurre in maniera
significativa l’ambito applicativo della direttiva, pur permanendo considerevoli
difficoltà applicative. Le quattro sentenze riguardano la direttiva relativa alla
tutela giuridica delle banche di dati e, più in particolare, l’ampiezza della tutela in
un contesto di banche di dati sportivi (calcio e ippica). La nozione di
"investimento rilevante", da cui dipende la tutela del costitutore di una banca di
dati contro atti non autorizzati di riproduzione e di diffusione tra il pubblico,
comprende solo i lavori di ricerca, di raccolta, di verifica e di presentazione di
elementi esistenti e non invece i mezzi impiegati per la creazione degli elementi
costitutivi della banca di dati. Dunque, nello specifico, né il conseguimento, né la
verifica, né la presentazione del contenuto dei calendari di incontri di calcio o di
corse di cavalli attestano un investimento rilevante meritevole di tutela contro
l’uso dei dati da parte dei terzi.
rilevanza dell’investimento nella creazione dei dati stessi, la banca dati non presenterà i requisiti necessari per accedere alla tutela. Più lineare, invece, appare la definizione offerta ai termini “verificare” e “presentare”: verificare significa sostanzialmente assicurare l’affidabilità dell’informazione contenuta nella banca dati e monitorarne l’accuratezza, mentre la presentazione attiene alle risorse finalizzate ad organizzare i dati secondo in maniera sistematica e metodica e a predisporne l’accessibilità individuale. 128 Causa C-338/02, Fixtures Marketing Ltd v. Svenska AB, [2004] ECR I-10497; causa C- 444/02, Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou EG, [2004] ECR I-10549; causa C-46/02, Fixtures Marketing Ltd v. Oy Veikkaus Ab, [2004] ECR I- 10365; causa C- 203/02, British Horseracing Board Ltd v. William Hill Organization Ltd, [2004] ECR I- 10415. Si tratta di quattro decisioni correlate: la Fixtures Marketing e la British Horseracing Board (BHB), infatti, hanno lamentato che le altre imprese abbiano leso i diritti collegati alle proprie banche dati sportive.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
65
Prima ancora delle decisioni della Corte europea, i fautori della c.d. “spin-off
theory”129 hanno sostenuto che data la ratio della direttiva 96/9/CE - favorire la
produzione di banche dati accurate e prodotti informativi competitivi- soltanto
dagli investimenti specificamente diretti a produrre una particolare banca dati
possa scaturire la tutela del diritto sui generis. Traslando detto criterio alle banche
dati prodotte dal settore pubblico, ne deriva che i costi associati alle collezioni di
dati che rientrano nelle attività istituzionali delle vari enti (quali, ad esempio, il
monitoraggio dell’inquinamento ambientale, la pianificazione delle infrastrutture
di trasporto pubblico e le ispezioni nelle strutture scolastiche) non si qualificano
come investimento rilevante ai fini della tutela.
In ogni caso, la dottrina non pare aver indagato eccessivamente sul profilo della
estensibilità di una simile forma di tutela ai soggetti pubblici, dal momento che
sono scarsi i riferimenti specifici al problema; d’altra parte, neppure la lettera
della direttiva 96/6/CE offre un aiuto decisivo nell’elaborazione di un quadro
interpretativo univoco. Si evidenzia però un sostanziale accordo tra i
commentatori nell’osservare che il referente costituzionale del diritto sui generis,
a differenza del diritto d’autore, che troverebbe fondamento nel principio dell’art.
9 Cost. (“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica”), sia costituito essenzialmente dagli art. 41 e 42 Cost., cioè da
disposizioni dirette a tutelare lo svolgimento di attività di impresa ed il diritto di
proprietà130.
Come osservato da Cardarelli, il vincolo di scopo dell’attività amministrativa,
anche rispetto alla realizzazione e gestione di banche dati, rende in gran parte di
scarso rilievo il profilo della tutela giuridica mediante il cd. diritto sui generis131:
infatti, sulla base della direttiva 96/9/CE, la tutela sui generis consiste
129 D. J. G. VISSER, The Database Right and the spin-off theory, in SNIJDERS, WEATHERILL (a cura di), E-commerce Law, Kluwer Law International, 2003, pp. 105-110; E. DERCLAYE, Database sui generis right: should we adopt the spin-off theory?, European Intellectual Property Review, 2004, pp. 402-412. Eccellente contributo a commento delle decisioni della Corte di Giustizia è, invece, M. J. DAVISON, P. B. HUGENHOLTZ, Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right, European Intellectual Property Review, n. 3, 2005. 130 Così M. S. SPOLIDORO, Il contenuto del diritto connesso sulle banche dati, AIDA, 1997, p. 48. Altri commenti, invece, pongono in evidenza la circostanza che il considerando 41 della direttiva restringe la figura del costitutore ai soggetti che prendono l’”iniziativa” e assumono su di sé il “rischio” dell’investimento, con esclusione del subappaltatore. V. L. CHIMIENTI, Banche dati e diritto d’autore, Milano, Giuffrè, 1999, p. 63.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
66
nell’accordare al costitutore una protezione diretta a salvaguardare l’investimento
(in termini di mezzi finanziari e/o di tempo, lavoro ed energia) effettuato per
costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca dati. L’interesse
protetto, quindi, si caratterizzerebbe per una natura sostanzialmente
imprenditoriale, che non appare di facile conciliazione con le finalità pubbliche
perseguite dalle amministrazioni, le quali non presentano carattere industriale o
commerciale: prova ne sia che la medesima direttiva, riferendosi ai soggetti
costitutori di una banca dati, e cioè ai soggetti ai quali va imputato l’investimento
“rilevante sotto il profilo quantitativo o qualitativo” (art.7), espressamente indica i
cittadini di uno Stato membro, ovvero imprese e società istituite secondo la
disciplina di uno Stato membro (art.11), con esclusione, almeno sotto il profilo
strettamente letterale, di soggetti annoverabili nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni132. Tali considerazioni condurrebbero, in via di prima
approssimazione, ad una sostanziale esclusione della fattispecie del diritto sui
generis rispetto alle banche dati pubbliche, in quanto il perseguimento di un
pubblico interesse non richiede, se non in particolari casi, lo svolgimento di
attività in forma imprenditoriale133. La conclusione, tuttavia, merita qualche
temperamento.
Infatti, la direttiva (che pure non affronta specificamente la questione) e i suoi
materiali preparatori paiono implicitamente indicare che gli enti pubblici possano
beneficiare della tutela sui generis, sempre che, naturalmente, vengano soddisfatti
131 V. F. CARDARELLI, Le banche dati pubbliche: una definizione, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, Giuffrè, 2002, p. 250. 132 Ivi, p. 252. 133 Sul punto, si vedano le considerazioni svolte da D. REDOLFI, F. VEUTRO, La tutela giuridica delle banche dati della pubblica amministrazione, in www.interlex.it: “Tale diritto, tuttavia, è riconosciuto dal decreto solo ai cittadini di uno stato membro dell'Unione europea e alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione. Non è quindi riconosciuto alle pubbliche amministrazioni. In ragione di ciò, le amministrazioni non hanno alcun diritto di impedire l'estrazione o il reimpiego delle informazioni contenute nelle banche dati da esse costituite; evidentemente, a meno che ciò non sia disposto da un'altra fonte primaria. La "logica proprietaria" con cui spesso le amministrazioni pubbliche gestiscono le proprie banche dati impedendo l'estrazione delle informazioni e il loro riutilizzo per fini commerciali non ha quindi nella maggior parte dei casi alcun preciso fondamento giuridico. In particolare, non ne hanno quelle disposizioni, di natura contrattuale o regolamentare, purtroppo piuttosto frequenti, che vietano o limitano l'elaborazione, la commercializzazione, la riproduzione di dati estratti da registri dei quali il dettato normativo chiarisce la funzione di pubblicità, concedendone a chiunque l'accesso. In tali casi, infatti, l'amministrazione difficilmente può far valere la titolarità del diritto d'autore e al contempo in via generale non le è riconosciuto l'esercizio del cosiddetto diritto sui generis”. In senso concorde, B. PONTI, Titolarità e riutilizzo dei dati pubblici, cit., p. 252.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
67
i presupposti della protezione stessa. Significativa, in questo senso, appare
l’eliminazione dell’art. 8 della Proposta di direttiva134 dal testo definitivo della
stessa. Tale articolo prevedeva che l’estrazione e il reimpiego a fini commerciali
della totalità del contenuto di una banca dati, o di una sua parte sostanziale,
dovessero essere consentite a condizioni eque e non discriminatorie per i casi in
cui la banca dati venga messa a disposizione del pubblico e costituisca l’unica
fonte delle informazioni; tali attività, inoltre, avrebbero dovuto essere consentite,
alle medesime condizioni, qualora la banca dati venisse resa pubblicamente
disponibile da enti e organismi pubblici creati allo scopo di raccogliere o
divulgare informazioni, o a ciò tenuti in forza di leggi o regolamenti, ovvero in
forza di un obbligo generale.
Inoltre, come ancora osserva Cardarelli, appare attività orientata al perseguimento
di interessi pubblici anche lo svolgimento di servizi pubblici in forma
imprenditoriale. In tal caso la costituzione di una banca dati (ad esempio, di tipo
cartografico o territoriale per i servizi pubblici di trasporto), appare sia funzionale
allo svolgimento di attività di impresa, sia finalizzata al perseguimento di un
interesse pubblico di cui è titolare l’amministrazione, la quale imputa a sé i
risultati della gestione del servizio. In tali casi sembra ipotizzabile, anche nei
confronti della banca dati pubblica, una forma di protezione basata sul diritto sui
generis: ciò in quanto l’ investimento rilevante viene sostanzialmente affrontato
da imprese (ancorché assimilabili ad organismi di diritto pubblico, come nel caso
delle società miste) con criteri di iniziativa ed assunzione di rischio; ma sembra
rilevare soprattutto, in simili casi, l’immediata funzionalizzazione delle
informazioni raccolte (ai fini della gestione del servizio) allo svolgimento di una
attività di impresa (che è appunto quella del gestore del servizio)135.
134 Proposta per una direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica delle banche dati COM (92) 24 finale – SYN 393 Bruxelles, 13 maggio 1992. 135 Ovviamente l’obiettiva “pubblicità” dei dati comporta due conseguenze facilmente intuibili: per un verso, e ciò è frutto di una espressa previsione normativa, i dati e le informazioni contenute in suddette banche dati sono considerabili alla stregua di documenti amministrativi, e perciò accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 241/90; per altro verso, il carattere potenzialmente “riservato” di informazioni strumentali allo svolgimento di servizi pubblici in forma imprenditoriale, recede in tutti i casi in cui la gestione di detto servizio debba essere sottoposta all’applicazione di regole di concorrenza ai fini del suo affidamento: in altri termini se le banche dati contengono informazioni necessarie alla pianificazione ed alla strutturazione dell’attività di impresa, esse devono poter essere messe a disposizione di tutti i soggetti potenzialmente interessati allo svolgimento di attività imprenditoriali necessarie per l’espletamento di detto servizio, sia nel caso di concorrenza nel

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
68
In sintesi, dunque, sembra possibile ricostruire la categoria delle banche dati
pubbliche, ovvero delle banche dati realizzate e gestite, direttamente o
indirettamente, da pubbliche amministrazioni ovvero da organismi di diritto
pubblico, secondo una serie di elementi caratterizzanti:
- tali banche dati pubbliche sono generalmente accessibili dagli utenti in base ai
principi generali sull’accesso ai documenti amministrativi, e possono essere
sottratte al principio dell’accesso solo in caso di limiti legislativi afferenti al
segreto, alla tutela dei dati personali (in particolare di quelli sensibili), ed in caso
di banche dati funzionali allo svolgimento di attività a carattere strettamente
imprenditoriale o commerciale;
- esse sono proteggibili, se ricorre il requisito della creatività, in forza del
diritto d’autore, ovvero sono proteggibili sulla base del diritto sui generis solo nel
caso in cui l’investimento realizzato, direttamente o indirettamente, sia stato
rilevante rispetto al normale svolgimento dell’attività amministrativa, e solo in
presenza delle garanzie di cui a seguire;
- l’insieme dei dati e delle informazioni in esse contenuti, se rilevanti sotto il
profilo commerciale, non possono essere resi disponibili in via esclusiva ad un
soggetto privato, ma devono poter essere resi accessibili ai soggetti che ne
facciano richiesta in base a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e
sulla base di criteri di remuneratività che siano orientati ai costi e che, in ogni
caso, non siano di per sé ostacolo allo svolgimento di attività in regime di
concorrenza.
Una delle più recenti e brillanti riflessioni sul rapporto tra diritto sui generis sulle
banche dati statali e direttiva PSI è indubbiamente quella svolta da Estelle
Derclaye, che sin dal titolo della sua analisi (“Does the Directive on the Re-Use of
Public Sector Information affect the State’s database sui generis right?”, e
ancora, “Does the PSI Directive trump or dampen down objectionable State’s sui
generis right?”) pare mettere in discussione l’efficacia della direttiva 2003/98/CE
nel neutralizzare o, quantomeno, nel limitare la portata di una tutela tanto
controversa quanto quella che promana dal diritto sui generis sulle banche dati
degli enti pubblici.
mercato, sia nel caso di concorrenza per il mercato (ad esempio in caso di svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, ovvero per la scelta di un socio

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
69
Al fine di risolvere tali questioni è necessario, in primo luogo, dare risposta ad una
domanda preliminare, e cioè se il diritto sui generis sussista effettivamente sulla
maggioranza dei database pubblici. Valgono, a questo proposito, le considerazioni
fin qui svolte sulla lettera della direttiva 96/9/CE e sulle intenzioni del legislatore
quali desumibili dai materiali preparatori; piuttosto, la Derclaye pone l’accento su
un altro aspetto della medesima questione: lo Stato può davvero qualificarsi come
produttore di banche dati e attrarre, come tale, la tutela del diritto sui generis?
Interrogando il considerando 41 della direttiva 96/9/CE se ne ricava che un
produttore di database è “la persona che assume l’iniziativa e il rischio
dell’investimento nella creazione del database”: ebbene, non si può negare che il
più delle volte lo Stato effettivamente assuma l’iniziativa nella creazione della
banca dati; più discutibile, invece, che lo Stato assuma un rischio nella creazione
di un database, poiché l’investimento su cui esso si basa è finanziato dal
contribuente e, di fatto, non richiede necessariamente un recupero di denaro sul
mercato136.
Si sviluppa su analoghe argomentazioni il caso Landmark, deciso dal Consiglio di
Stato olandese nell’aprile 2009 e richiamato dal prof. Bernt Hugenholtz in
occasione della conferenza Communia che si è tenuta a Torino due mesi più
tardi137. Nello specifico, la causa ha visto contrapposti Landmark, uno dei gruppi
leader in Europa nella fornitura di informazione geografica e nell’elaborazione di
studi sui rischi ambientali, e la città di Amsterdam, che, vantando un diritto sui
generis sulle proprie banche dati, consentiva l’accesso ai propri dati solo dietro
pagamento di ingenti tariffe - di mercato- e pretendeva di apporre diverse
condizioni limitative del riutilizzo degli stessi138. Secondo il Raad van State, tali
privato per società a partecipazione pubblica locale). 136 “Public authorities collect and maintain governmental data because they have a legal mandate to do so; unlike private authors and publishers they do not need economic incentives to do their legal duty” , v. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-Use of Public Sector Information affect the State’s database sui generis right?, in GASTER, SCHWEIGHOFER, SINT, Knowledge Rights, cit. p. 161. 137 Tra il 28 e il 30 giugno 2009 si è svolta a Torino la seconda conferenza internazionale di Communia (il network tematico sul pubblico dominio digitale finanziato dalla Commissione europea), dal titolo “Global Science & Economics of Knowledge Sharing Institutions”. Il professor Hugenholtz, dell’Università di Amsterdam, ha effettuato un intervento dal titolo “Owning Science. IPR’s as Impediments to Knowledge Sharing”; le slides della presentazione sono reperibili all’indirizzo: http://communia-project.eu/downloads?page=2&op0=OR&filter0[0]=27. 138Materiali sul caso Landmark possono essere reperiti al sito della piattaforma Epsiplus, all’indirizzo:

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
70
limitazioni potevano essere giustificate soltanto dalla presenza contemporanea di
due elementi: non solo, infatti, ci si doveva trovare in presenza di un database, ma
l’ente pubblico doveva altresì potersi considerare il costitutore dello stesso. Sulla
base di tale premessa, la Corte ha infine deciso che sebbene i dati formino, di
fatto, una banca dati poiché esiste un investimento rilevante139, il rischio di tale
investimento, nella sostanza, non grava sulla città di Amsterdam, con la
conseguenza che la stessa, non potendo qualificarsi come produttore della banca
dati, allo stesso modo non è legittimata a imporre condizioni finanziarie eccessive
e limitazioni al riutilizzo dei dati.
In ogni caso, è evidente che con l’applicazione congiunta dei criteri elaborati dalla
Corte di Giustizia europea nel 2004 (che operano nel senso di escludere le banche
dati di tipo “spin-off” dalla tutela sui generis)140 e dal Consiglio di Stato olandese
in occasione del caso Landmark, il terreno a disposizione delle amministrazioni
per reclamare un diritto sui generis si fa piuttosto ristretto. Ciò nonostante, per i
casi in cui è appurato che lo Stato sia titolare di detta tutela, può trovare spazio la
riflessione proposta dalla Derclaye cui si è prima accennato e che è la seguente: il
diritto sui generis sulle banche dati degli enti pubblici è, in qualche modo,
superato, “scavalcato”, per così dire, dalle disposizioni della direttiva
http://www.epsiplus.eu/examples/cases/landmark_nederland_bv_v_amsterdam_city_council; “Landmark had in May 2006 filed a request on the basis of the Dutch Government Information Act (“WOB”) for an address list of 12,000 locations in the city, indicating whether a soil contamination survey had been carried out. Landmark wished to use this information for its Enviroscan reports on the environment of specific locations, which it provides on request to real estate agents. After initial refusal, the Council claimed a database right on the information and invoked the Public Sector Information Re-use Directive. In the Netherlands, the Directive has been implemented in the WOB and the government has decided that in principle information should be provided for re-use against payment of the costs of the carrier of the data (cd-rom, dvd etc.). However, if the information requested for re-use is contained in a database in which a government agency owns a database right the government agency may request compensation of the actual costs of the database. On the assumption that it holds a database right in the relevant information, the Amsterdam Council demanded payment of an annual fee and imposed license restrictions on the use of the information. In addition to the one year limit on the license, the Council restricted the purpose for which the information could be used and prohibited transfer of the information to a third party”. 139 La corte distrettuale di Amsterdam, nel giudizio di primo grado a favore di Landmark, non solo aveva negato alla città lo stato di costitutore dei database, ma aveva altresì escluso la tutelabilità delle banche dati in questione, stante la mancanza di ogni prova circa investimenti sostanziali diretti specificamente a finanziare “il conseguimento, la verifica e la presentazione” dei contenuti delle stesse. 140 Come sottolineato da diversi commentatori, la Corte non dovrebbe, in particolare, consentire l’aggiramento della direttiva PSI attraverso l’esternalizzazione delle attività di produzione dei database alle imprese private. V. E. DERCLAYE, Does the Directive on the Re-Use of Public Sector Information affect the State’s database sui generis right?, in GASTER, SCHWEIGHOFER, SINT, Knowledge Rights, cit., p. 164.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
71
2003/98/CE?141 Secondo la docente di Nottingham, la risposta, a seconda di come
si interpreti la questione, può essere: “non è certo”, “non del tutto” o
“assolutamente no”. Infatti la direttiva PSI, al considerando 9 e all’art. 3, non
obbliga gli stati a consentire il riutilizzo dell’informazione di cui essi sono titolari,
ma pare, come già osservato, imporre un mero dovere morale a facilitare il riuso
della stessa. Tale punto, in ogni caso, rimane controverso, soprattutto a causa dei
considerando che paiono in conflitto tra loro (in particolare, 9, 22, e 24) e che
rendono la direttiva suscettibile di critiche per avere, evidentemente, tralasciato il
nucleo del problema: ancora una volta, cioè, se sia opportuno che lo Stato sia
titolare di un diritto d’autore e di un diritto sui generis sui propri documenti.
Quanto all’aspetto della tariffazione, la direttiva 2003/98/CE prevede che le
amministrazioni possano applicare delle tariffe (non propriamente, come già
osservato, dei prezzi) per i costi di raccolta, produzione, riproduzione e
disseminazione della PSI, assieme ad un congruo utile sull’investimento: posto
che il divieto di applicare prezzi eccessivi era già fissato dalle norme europee sulla
concorrenza, secondo diversi commentatori le citate previsioni avvicinerebbero
molto le tariffe della PSI al prezzo che troverebbe applicazione in un ambiente di
libero mercato, rimanendo, peraltro, altamente discutibile che la missione del
settore pubblico sia quella di realizzare profitti.
In assenza di un quadro normativo del tutto in linea con gli obiettivi della direttiva
2003/98/CE, sono particolarmente degne di nota, secondo la Derclaye, le
soluzioni di due Stati membri, Paesi Bassi e Francia, che hanno il merito di
attutire alcuni degli aspetti di più stridente incoerenza tra la direttiva 96/9/CE e lo
spirito della normativa sul riutilizzo.
Si tratta, in particolare, dell’art. 8 della legge olandese sulla tutela giuridica delle
banche dati, che esclude, innanzitutto, la configurabilità del diritto sui generis per
141 Di estremo interesse sul punto le questioni proposte di fronte alla Corte di Giustizia europea nel caso Verlag Schawe GmbH v. Sächsisches Druckund Verlagshaus AG C-215/07, OJ C 155, 7 July 2007, p. 12, (infine però respinto dalla Corte): “Do Article 7(1) and (5) and Article 9 of Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases (1) prohibit a legal provision of a Member State, according to which an official database which is published as a matter of general information for official purposes (in this instance: a systematic and complete collection of all calls for tender documents emanating from a German Land) does not benefit from sui generis protection under the directive?”; “If the answer to Question 1 is in the negative: is this also the case where the database is constructed not by a public body but by a private undertaking on its behalf, to which all bodies of this Land issuing calls for tender must directly submit their calls for tender documents for publication?”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
72
i database creati dagli enti pubblici e contenenti documenti legislativi e decisioni
giurisdizionali e amministrative; ancora, la tutela sui generis è esclusa, in linea di
principio, per le banche dati pubbliche, salvo che essa sia espressamente riservata
in via generale attraverso una legge, un’ordinanza o una delibera oppure in via
speciale, attraverso un’indicazione all’interno della banca dati, o quando la stessa
è resa pubblica142.
Ugualmente degno di nota è un decreto francese del 2002, che - a differenza
dell’esperienza olandese - istituisce in capo al governo un vero e proprio dovere
giuridico a creare banche dati contenenti legislazione e giurisprudenza nazionale e
comunitaria e a rendere disponibili detti contenuti su Internet licenziandoli al solo
costo marginale di distribuzione143.
2.3. Informazione pubblica e pubblico dominio
L’orientamento che configura l’informazione pubblica come bene suscettibile di
divenire oggetto di pretese proprietarie si colloca all’interno di una dinamica più
ampia, tesa all’affermazione del principio per cui il riconoscimento di diritti
esclusivi sulle informazioni (rectius, come osserva Ponti, su ogni frazione del
processo di produzione, riproduzione e diffusione dell’informazione)
rappresenterebbe la soluzione più idonea a stimolare il progresso scientifico, la
crescita economica e l’accumulazione delle conoscenze.
Si tratta di un indirizzo ideale, foriero di effetti giuridici significativi (soprattutto
sul piano globale), e che, con un’efficace richiamo all’istituto delle chiudende, è
stato recentemente descritto da Boyle con l’immagine di Second Enclosure
Movement144.
Tale indirizzo, sottoposto ad attenta analisi, è stato oggetto di forti critiche
soprattutto nella misura in cui si propone di applicare soluzione escogitate per
142 Databankenwet, 8 luglio 1999, Staatsblad, 303. In sostanza, dunque, la normativa olandese in materia di tutela sui generis delle banche dati ha adottato le eccezioni previste dalla legge sul diritto d’autore agli art. 11 e 15 (b), commentati al paragrafo precedente. 143 Decreto n. 2002/1064 del 7 agosto 2002, relativo al pubblico servizio di diffusione su Internet dei documenti legislativi e giurisprudenziali francesi, OJFR 2002, n. 185, 9 agosto 2002, p. 13655. Per un’idea del servizio offerto, si rimanda al sito: www.legifrance.gouv.fr.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
73
fronteggiare la c.d. Tragedy of Commons145 ad un bene, appunto l’informazione,
che dal punto di vista strutturale è del tutto dissimile dai commons
tradizionalmente intesi146.
I caratteri specifici del bene-informazione, che forma oggetto del regime di
“appartenenza” pubblica delle informazioni, si condensano, in particolare, nella
natura incorporale dell’entità oggetto del rapporto. Dalla non corporalità o
immaterialità dell’informazione deriva una conseguenza essenziale: dal punto di
vista strutturale essa è illimitatamente riproducibile e, in ragione di tale
caratteristica, la stessa si configura come bene strutturalmente non rivale, poiché
144 V. J. BOYLE, The Second Enclosure Movement and the construction of Public Domain, in Law & Contemporary Problems, vol. 63, 2003, pp. 33 ss. 145 Si rimanda sul punto a G. HARDIN, The Tragedy of the Commons, in Science, vol. 162, 1968, p. 1243 ss. Secondo l’ impostazione di Hardin, dalla libera accessibilità di un bene che non è di proprietà di alcuno, scatta la tendenza a sovrasfruttarlo. L’individuo che si appropria del bene comune, dunque, deteriorandolo gode per intero del beneficio, mentre sostiene solo una piccola parte del costo, poiché tale costo verrà socializzato. Dal momento che i più ragionano secondo schemi analoghi, il risultato è, di fatto, un materiale saccheggio del bene, sebbene sia evidente che un simile comportamento, sul lungo periodo, è rovinoso per la collettività. Allo stesso modo, nessuno è incentivato a darsi da fare per mantenere e migliorare il bene, poiché verrebbe a sostenere un costo a fronte di un beneficio soltanto parziale. Il ragionamento di Hardin parte dall’esempio delle enclosures inglesi, precondizione della Rivoluzione industriale. La recinzione delle terre comuni, in questa visione, costituiva il necessario presupposto di una gestione evidentemente razionale ed efficiente: se, da un lato, in regime di libero accesso il pascolo indiscriminato stava portando alla rovina del territorio, dall’altro, il proprietario privato, in quanto detentore del surplus, aveva l’interesse a sfruttare il bene in modo ottimale e a investire per il suo miglioramento. 146 Si vedano le considerazioni sviluppate da D. BOLLIER in Silent Theft. The Private Plunder of our Common Wealth , Routledge, 2003, pp. 15-55, ma anche le analisi condotte da E. M. SALZBERGER, Economic Analysis of the Public Domain e da P. SAMUELSON, Challenges in Mapping the Public Domain in GUIBAULT, HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain, cit., rispettivamente pp. 27-57 e 7-21. Un’analisi illuminante del ruolo dei commons è quella svolta dall’economista premio Nobel 2009 Elinor Ostrom, che ha ipotizzato l’esistenza di una “terza via” tra Stato e mercato, attraverso l’esame delle condizioni che devono verificarsi affinché le common properties non degenerino. La Ostrom prende le mosse dal lavoro dello svizzero tedesco, naturalizzato americano, Ciriacy-Wantrup, che ancora negli anni Cinquanta osservava che vi sono nel mondo molti esempi di commons (quali, ad esempio, le foreste e i pascoli alpini) che sfuggono al destino preconizzato da Hardin. Egli distingueva, infatti, le “common pool resources” (res communis omnium) dai “free goods” (res nullius): il primo caso si distingue in particolare, pur in assenza di un’entità che possa vantare diritti di proprietà esclusivi, per l’esistenza di una comunità, l’appartenenza alla quale impone agli individui certi diritti di sfruttamento del bene comune, ma anche determinati doveri di provvedere alla sua gestione, manutenzione e riproduzione: su questo complesso di diritti e di doveri la comunità sorveglia, attraverso l’inclusione di chi ne rispetta le regole e l’esclusione di chi non le osserva. Nella sua opera più importante, Governing the Commons, la Ostrom sviluppa una teoria complessiva che identifica le condizioni che devono valere affinché una gestione “comunitaria” possa rimanere sostenibile nel lungo termine; l’analisi che ne deriva intreccia con grande sensibilità la teoria delle istituzioni, il diritto e la teoria dei giochi (quindi il vantaggio dei comportamenti cooperativi, che vengono poi codificati nelle citate istituzioni) senza tralasciare le scienze sociali e l’antropologia; E. OSTROM, Reformulating the Commons, Swiss Political Science Review, 6(1), 2000, pp. 29-52.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
74
il suo godimento da parte di un soggetto non è incompatibile con il godimento
altrui e poiché detto godimento non determina il consumo o il deperimento del
bene.
Le menzionate caratteristiche incidono in maniera determinante sul regime di
appartenenza delle informazioni: in linea di principio è da escludersi l’esistenza di
una clausola generale che consenta la rivendicazione di diritti di esclusiva
sull’informazione in quanto tale147, dal momento che tale pretesa è condizionata al
verificarsi di ulteriori requisiti della stessa, relativi alla originalità/creatività
dell’idea o della struttura di cui l’informazione si compone148.
Un’altra serie di conseguenze, legate ai caratteri intrinseci dell’informazione,
riguarda l’inadeguatezza non tanto del regime dei beni pubblici, quanto piuttosto
della stessa ratio sottesa a tale regime149, se riferita all’informazione pubblica:
come osservato da Merloni150, infatti, anche i più recenti istituti finalizzati alla
conservazione della destinazione dei beni pubblici151 appaiono non congruenti,
quando non addirittura del tutto inadatti a fronte di beni strutturalmente non rivali.
147 L’assenza di una clausola generale che consenta l’appropriabilità dell’informazione in quanto tale, d’altra parte, pare direttamente finalizzata a non ostacolare la più ampia circolazione e condivisione dell’informazione e della conoscenza, a maggior ragione in un contesto tecnologico, economico e sociale che tendenzialmente continuerà ad abbattere i costi e a potenziare la velocità e la capillarità di tale circolazione. 148 È il caso dei diritti di proprietà intellettuale e della privativa industriale, il cui riconoscimento e la cui tutela sono subordinati ai connotati aggiuntivi di novità/originalità o novità/industrialità delle informazioni. Inoltre, all’inizio del XXI secolo la classica prospettiva favorevole al riconoscimento di tali diritti, ispirata alla Tragedy of Commons, pure ancora ampliamente dominante, è sottoposta a profonda critica, a partire dalla considerazione dell’informazione, come elemento base dell’economia della conoscenza; v. M.A. HELLER, The Tragedy of the Anticommons, in Harvard Law Review, January 1998, e J. BOYLE, An Environmentalism for Information, in The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind, Yale University Press, 2008, pp. 230-248. 149 In Voce Beni Pubblici di M. RENNA, in Dizionario di Diritto Pubblico, diretto da S. CASSESE, Giuffrè, Milano, 2006, Vol. I, pp. 714-725, l’autore osserva che il regime dei beni pubblici consiste “in una disciplina particolarmente protettiva dei medesimi beni, diretta ad assicurare che questi, direttamente ed immediatamente strumentali all’esercizio dei diritti collettivi o di funzioni e servizi pubblici, si conservino integri e non siano sottratti alla loro destinazione istituzionale dalla stessa pubblica amministrazione o da soggetti terzi”. 150 Anche nell’ottica per cui le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni (con l’eccezione, ad esempio, dei dati personali) vadano trattate alla stregua di beni pubblici in senso oggettivo, ossia beni da destinare alla fruizione del pubblico, è evidente che sia il tradizionale schema della proprietà pubblica in senso stretto, sia quello più attuale della destinazione pubblica non appaiono soluzioni del tutto soddisfacenti, né adeguate. Si rimanda a F. MERLONI, Coordinamento e governo dei dati nel pluralismo amministrativo, in B. PONTI (a cura di), cit., pp. 153-180. 151 In seguito ai processi di privatizzazione (dei beni o degli enti proprietari), l’asse della specialità del regime va collocandosi non più sulla necessaria, formale e soggettiva “appartenenza” pubblica dei beni, ma piuttosto sulla sostanziale e oggettiva loro “destinazione pubblica”; resta inoltre immutata le finalità delle misure dirette a garantire integrità dei beni e loro destinazione. V, sul

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
75
In sostanza, dunque, la stessa commercializzazione delle informazioni pubbliche
(in luogo delle loro cessione e piena fruibilità a costi marginali che, per effetto
dell’affermazione delle modalità digitali di gestione dei dati pubblici, dovrebbe
seguire una curva decrescente) rappresenta, agli occhi di una parte consistente
della dottrina, un aspetto della progressiva erosione del pubblico dominio, che, in
quanto tale, pretenderebbe una giustificazione stringente. Nello specifico, le
esigenze di garantire l’integrità del bene o la sua destinazione, di fatto non trovano
adeguata tutela nelle formule dell’appropriazione pubblica del bene, salvo a voler
optare per una conclusione di cui Ponti enfatizza il carattere paradossale, e cioè
che le informazioni pubbliche non costituiscono, oggettivamente, beni pubblici.
Tale prospettiva sembrerebbe peraltro incompatibile con l’altra finalità che fin
dall’inizio ha animato l’iniziativa comunitaria, (sebbene uscita complessivamente
ridimensionata dal carattere compromissorio della direttiva 2003/98/CE), che ha
visto nel riutilizzo, soprattutto non commerciale, uno strumento ulteriore per
ampliare il diritto alla conoscenza come presupposto basilare di una democrazia
partecipata.
Interessante ai fini dell’analisi del rapporto che intercorre tra PSI e ambito del
Pubblico Dominio è lo studio pubblicato nel maggio 2009 e finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del progetto “Public Domain in Europe”, dal
titolo “Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural
Institution and PSI Directive”152. Lo studio è finalizzato ad analizzare pro e
contro della possibile estensione del campo d’applicazione della direttiva nel
senso del settore culturale e a supportare l’analisi di tale materia da parte della
Commissione nell’ambito del procedimento di riesame153 della direttiva. Secondo
l’art. 1 comma 2 della direttiva 2003/98/CE, infatti, la stessa non si applica:
punto, M. RENNA, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Giuffrè, Milano, 2004. 152 R. DAVIES (MDR Partners), Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural Institution and PSI Directive, 5 maggio 2009, disponibile al sito: http://www.epsiplatform.eu/psi_library/reports/economic_and_social_impact_of_the_public_domain_eu_cultural_institutions_and_the_psi_directive_may_2009 153 COM (2009) 212 definitivo, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Riesame della direttiva 2003/98/CE, Bruxelles, 7 maggio 2009.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
76
- “ai documenti in possesso delle emittenti di servizio pubblico e delle
società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate
per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio
pubblico”;
- “ai documenti in possesso di istituti di istruzione e di ricerca quali scuole,
università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese, ove
opportuno, organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della
ricerca”;
- “ai documenti in possesso di enti culturali quali musei, biblioteche,
archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri”.
Ebbene, la questione di partenza dell’indagine è data dalla domanda se sia o meno
il momento di includere le istituzioni culturali nell’ambito d’applicazione della
direttiva. A questo proposito, le conclusioni dello studio significativamente
recitano: “whilst there is little doubt that PSI held by the cultural sector has a
significant potential value for re-users, the advantages of including cultural
heritage institutions within the scope of the Directive are currently difficult to
assess and require further investigation over time. The practical and financial
disadvantages to the sector, given the nature of its institutions and their
collections, should not be allowed in the longer term to outweigh the possible
advantages to the economy, industry and society”154.
Molte istituzioni culturali nutrono la preoccupazione che l’essere ricomprese
nell’ambito d’applicazione della direttiva imporrà più alti costi a fronte di introiti
relativamente ridotti (i quali, peraltro, potrebbero subire ulteriori riduzioni in
conseguenza delle obbligazioni derivanti dalla direttiva)155. L’obbligo di
rispondere alle richieste dei riutilizzatori, infatti, potrebbe condurre a più elevati
154 R. DAVIES (MDR Partners), Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural Institution and PSI Directive, cit., p. 5. 155 Mentre le istituzioni culturali aderiscono ampiamente al principio del garantire un libero accesso agli utenti finali (il pubblico in generale, studiosi e ricercatori), tendenzialmente considerano il riuso commerciale come una questione separata, per la quale dovrebbero ricevere adeguato compenso e che presenta un alto potenziale di guadagno. Il 76% degli istituti che hanno partecipato allo studio offrono libero accesso ai contenuti ai loro utenti, mentre il restante 24% applica qualche forma di tariffa per l’accesso ad almeno alcuni dei suoi contenuti. In ogni caso, il 32% degli istituti che hanno risposto applicano dei costi ai contratti di licenza per il riutilizzo dei contenuti, mostrando una tendenza a distinguere tra uso “ordinario” e riutilizzo commerciale nelle loro politiche tariffarie.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
77
costi di trattamento dell’informazione, compresa l’identificazione e la trattativa
coi titolari dei diritti: non si può infatti tralasciare di considerare che le istituzioni
culturali costituiscono un settore ibrido, in cui gran parte dei materiali raccolti e
conservati sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi.
Soltanto poche istituzioni culturali di spicco sono attrezzate, al momento, per
sviluppare un sistema di messa a punto delle licenze, secondo quanto previsto
dalla direttiva. Salvo alcune eccezioni, infatti, il numero di istituti culturali che
gestiscono servizi di licenza di massicce quantità di contenuti sono piuttosto
ridotte, e contano sull’equivalente di unità di personale a tempo pieno comprese –
di norma- tra uno e cinque. Tale attività porterebbe con sé significative iniziative
di riorganizzazione e considerevoli costi associati, sebbene l’adozione di modelli
di licenze “click-through”, possibilmente con una base volontaria quali le licenze
Creative Commons, trovi sostegno e meriti in ogni caso ulteriore scrutinio156.
156 Il report analizza alcuni “case studies”, sia nella prospettiva degli enti pubblici culturali, sia in quella dei soggetti interessati al riutilizzo. Significativo della prima prospettiva è il caso del Ministero della cultura e della Comunicazione francese, che ha creato un Gruppo di lavoro sulla disseminazione e il riutilizzo dell’informazione culturale pubblica e che avrà la funzione di inoltrare al ministero raccomandazioni circa il potenziamento del riuso della PSI culturale. Le soluzioni proposte in questa direzione comprendono la creazione di un ufficio centralizzato, cui verranno inoltrate le richieste di riutilizzo e che elaborerà i piani tariffari da applicare; l’incoraggiamento dei titolari di informazioni ad affidare progetti di riutilizzo a specifiche agenzie (in particolare, la Réunion de Musées Nationaux e l’Institut National de l’Audiovisuel); più in generale, la promozione del riuso di dati culturali coperti da diritti di proprietà intellettuale. Sul versante degli attori del riutilizzo, caso significativo è quello della Creative and Media Business Alliance (CMBA), network informale che raccoglie le maggiori società e associazioni di categoria attive su scala europea nell’ambito della pubblicità, della programmazione televisiva, del cinema, della musica e dell’editoria. La CMBA sostiene in linea di principio l’ampliamento dell’ambito di attuazione della direttiva nel senso dell’inclusione di enti culturali, istituti d’istruzione e ricerca ed emittenti pubbliche e sottolinea, allo stesso tempo, l’importanza del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Essa ritiene che le opere detenute da enti culturali finanziati pubblicamente debbano essere escluse dalla tutela del copyright e del diritto sui generis (in analogia con quanto accade negli Stati Uniti), osservando che, in ogni caso, i rischi associati alla titolarità in capo alle amministrazioni di diritti di proprietà intellettuale sulla PSI culturale sarebbero efficacemente neutralizzati da politiche di tariffazione eque (che consistono dunque in un bilanciato recupero dei costi) nel momento dell’offerta in licenza dell’informazione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
78
Capitolo terzo
Le licenze Creative Commons: un modello applicabile
all’informazione pubblica?
3.1. La diffusione dell’informazione pubblica sotto licenza Creative
Commons: inquadramento generale
Nell’ultimo decennio le amministrazioni pubbliche di molti Paesi hanno lanciato
sempre più numerosi progetti finalizzati, nel loro complesso, a cogliere le
opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell’informazione, nella direzione di
una migliore gestione delle risorse informative e dell’obbedienza a criteri di
trasparenza, soprattutto attraverso la messa a disposizione di informazione
pubblica su Internet. È in seno a tali iniziative che numerosi enti pubblici hanno
manifestato un interesse crescente per l’adozione di modelli informativi più
“aperti” (si tratta, essenzialmente, dei modelli che si collocano nell’alveo
dell’esperienza del software libero e open source e di quello, connesso, del
copyleft)157, in grado di semplificare e chiarire le modalità di accesso, e più
157 Alla fine degli anni Novanta, il mondo della produzione artistica e culturale (sia essa editoriale, musicale, cinematografica o multimediale) si è trovato ad essere sostanzialmente destabilizzato dal fenomeno più innovativo, dal punto di vista economico e sociale, dai tempi della rivoluzione industriale: vale a dire, l’avvento della tecnologia digitale di massa e dell’interconnessione telematica su scala mondiale. Si iniziò a non considerare più l’opera creativa come un tutt’uno con il supporto fisico su cui essa veniva resa fruibile e si incrinò significativamente, dunque, il modello tradizionale di copyright rimasto pressoché intatto dal momento della sua nascita, avvenuta nell’Inghilterra del 1700. Nello stesso periodo, si ebbe l’affermazione di un altro interessante fenomeno socio-culturale: quello del software libero e open source (anche noto con l’acronimo FLOSS, Free Libre and Open Source Software). Questo modello alternativo di gestione del diritto d’autore, quindi, aveva già raggiunto un apprezzabile livello di maturità in ambito informatico e aveva visto interessanti sperimentazioni in altri ambiti della creatività fra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo millennio: ci si riferisce a licenze come la Open publication license (diffusa nel 1998 ad opere dell’Open Content Project), la Free documentation license (diffusa nel 2000 con il progetto GNU), le licenze per opere musicali Free music public license (rilasciata solo in una versione provvisoria) e Open music license (nelle tre versioni Green, Yellow, Red).

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
79
recentemente di riutilizzo, dei contenuti digitali resi disponibili dalle
amministrazioni. Negli ultimi anni l’attenzione degli enti pubblici di diversi paesi
si è concentrata, in modo particolare, sul modello di licenze Creative Commons,
l’origine del quale si innesta su quell’onda di sperimentazione che, a partire dagli
anni novanta, mette sempre più in discussione il modello di copyright tradizionale
(basato sul concetto di “tutti i diritti riservati”) e si dimostra decisa ad individuare
un modello alternativo di gestione dei diritti d’autore, attraverso l’adozione di
licenze d’uso innovative158.
Il progetto Creative Commons, nato dall’iniziativa di alcuni giuristi della
californiana Stanford University159, risulta al momento localizzato in oltre
cinquanta Paesi del mondo, tra cui, dal 2004, l’Italia160 ed è sostenuto da numerosi
intellettuali di rilievo.
In ogni caso, per una ricostruzione storica più approfondita dell’affermazione del modello copyleft, si rimanda a S. ALIPRANDI, Copyleft & Opencontent. L’altra faccia del copyright, PrimaOra, Lodi, 2005, disponibile alla pagina web www.copyleft-italia.it/libro. Per un’analisi sul coinvolgimento del settore pubblico nell’esperienza open source, v. M. VAN DER BOOMEN, M. T. SCHAEFER, Will the Revolution be open-sourced?How open source travels through society, in M. WYNANTS, J. CORNELIS (a cura di), How open is the future? Economic, Social & Cultural Scenarios inspired by Free & Open-Source Software, Brussels, VUB Brussel University Press / Cross Talk, 2005. 158 Per un’efficace inquadramento in lingua italiana circa il modello Creative Commons e lo spirito dello stesso, si v. S. ALIPRANDI, Creative Commons: manuale operativo. Guida all'uso delle licenze e degli altri strumenti CC, Stampa Alternativa, 2008, pp. 17-24; 159 Nel maggio del 2002 l’organizzazione no-profit Creative Commons, nata nel corso del 2001, viene presentata al pubblico (il comunicato stampa si trova all’indirizzo http://creativecommons.org/press-releases/entry/3421). Il Chairman è il professor Lawrence Lessig, docente della Stanford Law School e fondatore, presso la medesima università, del “Center for Internet and Society”; sono presenti, tra gli altri, il prof. James Boyle (del “Center for the Public Domain” della Duke Law School) e l’eminente informatico del M.I.T., Hal Abelson. Fra le opere di Lessig, si rimanda in particolare a L. LESSIG, Cultura libera. Un equilibrio fra anarchia e controllo, contro l’estremismo della proprietà intellettuale, Apogeo, 2005, disponibile online alla pagina www.copyleft-italia.it/pubblicazioni; L. LESSIG, Il futuro delle idee, Feltrinelli, Milano, 2006. Di grande interesse anche l’ultimo dei saggi di Lessig, recentemente pubblicato in Italia: L. LESSIG, Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni), Etas, 2009. 160 Il 18 novembre 2003 Lawrence Lessig annuncia a Torino l'inizio ufficiale del lavoro di traduzione e adattamento delle licenze Creative Commons (per il comunicato stampa, “Italy builds out the Creative Commons”, si rimanda all’indirizzo http://creativecommons.org/press-releases/entry/3911). Attualmente il progetto Creative Commons Italia, con il relativo gruppo di lavoro, fa capo a due Affiliate Institutions: il Dipartimento di Studi giuridici dell’Università di Torino per quanto riguarda gli aspetti legali e l’IEIIT-CNR di Torino per quanto riguarda gli aspetti tecnico-informatici. Il primo Project Lead, ovvero supervisore e referente del progetto, è stato fino al gennaio 2005 il prof. Marco Ricolfi dell’Università di Torino; successivamente, il ruolo di coordinatore è passato al prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino, che si occupa di guidare le attività sia a livello di ricerca tecnologica che di promozione e divulgazione. In particolare, il gruppo di lavoro giuridico di Creative Commons Italia e' composto da: prof. Marco Ricolfi (coordinatore scientifico), avv. Marco Ciurcina, avv. Massimo Travostino, avv. Nicola Bottero, dott. Alessandro Cogo, avv. Deborah De Angelis, dott. Thomas Margoni, dott. Federico Morando. Durante la Fase 1 (traduzione e porting delle licenze 2.0), hanno collaborato all'attività del gruppo anche l'Avv. Samantha Zanni, dott. Lorenzo Benussi e l'avv. Alberto Gilardi.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
80
Obiettivo principe del progetto è la promozione di un dibattito, a livello globale,
sui nuovi paradigmi di gestione del diritto d’autore e la diffusione di strumenti
giuridici e tecnologici (quali le licenze e i servizi ad esse connesse) che
consentano l’affermazione di un modello “alcuni diritti riservati” nella
distribuzione di prodotti culturali161. Lo spirito del progetto, dunque, sarebbe
efficacemente reso dall’immagine con cui Creative Commons è descritto come
una sfumatura intermedia tra il modello “tutti i diritti riservati”, caratteristico del
copyright tradizionale, e il modello “nessun diritto riservato”, tipico del pubblico
dominio integrale o di una sorta di modello no-copyright.
Uno degli aspetti di maggiore peculiarità delle licenze Creative Commons, senza
dubbio elemento determinante del successo delle stesse, nasce dall’idea dei
fondatori del progetto di “confezionare” ogni licenza in tre versioni, differenti
nella forma ma coincidenti nella sostanza.
La prima di esse, rappresentata dal c.d. Legal code, costituisce la licenza vera e
propria, rilevante a livello giuridico: si tratta di un testo sviluppato attorno ad
alcune premesse e ad otto articoli, in cui si disciplina la distribuzione dell’opera e
l’applicazione della licenza.
Dal rilievo, però, che questa tipologia di documento spesso non risulta del tutto
accessibile all’utente medio, soprattutto in ragione del lessico giuridico
specialistico adoperato (che, a sua volta, potrebbe dare spazio anche al rischio che
le licenze siano utilizzate con scarsa consapevolezza e imprecisione), emerge
l’idea di elaborare delle versioni sintetiche del Legal code, espresse attraverso un
Nella medesima fase e sino al rilascio delle licenze 2.5, nonché nella fase di stesura delle licenze 3.0 ha collaborato all'attività del gruppo il dott. Andrea Glorioso. 161 All’indirizzo web http://craetivecommons.org/about/ si trova un breve testo di presentazione del progetto Creative Commons e delle sue finalità, di cui Aliprandi offre una traduzione italiana: “Troppo spesso il dibattito sul controllo della creatività tende verso due estremi. Da un lato c’è una visione di totale controllo: un mondo in cui ogni singolo utilizzo di un’opera è regolamentato e in cui la formula “tutti i diritti riservati” è la norma. Dall’altro lato c’è una visione di anarchia: un mondo in cui i creatori di opere scelgono un ampio spettro di libertà ma sono lasciati in balia degli abusi. Equilibrio, compromesso e moderazione – un tempo i principi cardine di un sistema di copyright che incentivasse contemporaneamente innovazione e protezione – sono diventate specie in pericolo. Creative Commons intende lavorare per riportarli in auge. Usiamo diritti privati per creare beni pubblici: opere creative rilasciate liberamente per specifici usi. Lavoriamo per offrire agli autori gli aspetti migliori delle due visuali: protezione (grazie alle tutele offerte dal diritto d’autore) e nello stesso tempo maggiore diffusione delle opere. In poche parole, “alcuni diritti riservati”. V. ALIPRANDI, Creative Commons: manuale operativo, cit., p. 20. Ancora, dal medesimo sito: “A single goal unites Creative Commons’ current and future project: to build a layer of reasonable, flexible copyright in the face of increasingly restrictive default rules”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
81
interfaccia schematica e graficamente amichevole. Questa seconda “veste” delle
licenze, che è chiamata Commons deed (letteralmente, “atto per persone comuni”)
non ha, naturalmente, valore di licenza, ma rappresenta un utile riassunto,
comprensibile da chiunque, di alcuni degli aspetti chiave della stessa.
La terza versione della licenza è quella chiamata Digital code, costituita da una
serie di metadati che, attraverso un efficace sistema di embedding, sono
incorporate all’interno del file in modo da risultare rilevabili ai principali motori
di ricerca, che hanno sviluppato appositi strumenti di rilevazione162.
Tutte le licenze Creative Commons, in ragione della loro fondamentale natura di
licenze standardizzate, condividono alcune importanti caratteristiche di fondo163.
Ogni licenza permette che i licenziatari, a patto che rispettino le condizioni poste
dal licenziante e senza la corresponsione di alcuna compensazione pecuniaria (ciò
che rende le licenze CC a base royalty-free)164:
- facciano copie dell’opera con qualsiasi mezzo e su qualsiasi tipo di
supporto;
- distribuiscano l’opera attraverso i più disparati circuiti, con l’esclusione,
in determinati casi, dei circuiti prevalentemente commerciali (come si
avrà modo di precisare più avanti, nell’esame delle clausole base delle
licenze);
- comunichino al pubblico, rappresentino, eseguano, recitino o espongano
l’opera in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell’opera;
- cambino il formato dell’opera.
Ogni licenza richiede che il licenziatario:
162 Delle tre forme di licenza cui si è fatto riferimento, soltanto il Legal code è sottoposto ad un vero e proprio lavoro di porting, poiché soltanto quella è la forma di licenza di cui rilevano gli aspetti giuridici. Il Commons deed, infatti, ha soltanto uno scopo informativo/divulgativo, mentre il Digital code rimane identico ovunque nel mondo, poiché espresso in un linguaggio informatico. 163 Per una riflessione brillante sui principi ispiratori del modello Creative Commons e della piattaforma di licenze, si rimanda altresì a N. ELKIN-KOREN, Exploring Creative Commons: A Skeptical View of a Worthy Pursuit, in L. GUIBAULT, P. B. HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain, cit., pp. 325-345. 164 Particolarmente efficace, ai fini dell’illustrazione dei caratteri comuni delle licenze Creative Commons, lo schema rappresentato alla pagina web:http://www.creativecommons.it/Licenze/Spiegazione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
82
- mantenga l’indicazione di diritto d’autore intatta su tutte le copie del
lavoro, in modo tale che il licenziante, quale titolare dei diritti, sia sempre
chiaramente individuabile, così come il tipo di licenza per cui questi
abbia optato;
- inserisca nelle copie dell’opera un link alla licenza CC e, nel caso di
copie non digitali, indichi chiaramente come poter risalire al testo della
licenza (che dovrà necessariamente includere la clausola circa la
limitazione di responsabilità del licenziatario e quella che esclude
dichiarazioni e garanzie di qualunque tipo con riguardo all’opera);
- non utilizzi mezzi tecnologici atti ad impedire ad altri licenziatari di
esercitare uno qualsiasi degli usi consentiti dalla legge (il riferimento è ai
sistemi di Digital Rights Management, DRM o Technical Protection
Measures, TPM).
Ogni licenza Creative Commons autorizza l’ uso dell’opera a livello mondiale e su
base non esclusiva; la durata della licenza corrisponde a quella del copyright
sull’opera ed è tendenzialmente irrevocabile nei confronti dei licenziatari:
certamente il licenziante potrà cessare in ogni momento di offrire l’opera secondo
i termini della licenza Creative Commons, ma tale scelta non andrà ad intaccare i
diritti relativi alle copie che sono già in circolazione sotto licenza CC (incluso
quello di distribuire l’opera a terzi sulla base della medesima licenza).
In linea di principio le licenze Creative Commons sono strutturate in due parti:
una prima parte in cui si indicano quali sono le libertà che l’autore vuole
concedere sulla sua opera; dunque, una seconda parte che chiarisce a quali
condizioni è possibile utilizzare l’opera.
Per quanto riguarda la prima parte, si può affermare, in sintesi, che tutte le licenze
Creative Commons consentono la copia e la distribuzione dell’opera, mentre solo
alcune consentono anche la modifica della stessa. Per ciò che attiene invece alla
seconda parte, dedicata alle condizioni che il licenziante pone per l’utilizzo
dell’opera, si può dire che le licenze Creative Commons si articolano in quattro
clausole base, che il licenziante potrà scegliere e combinare a seconda delle
proprie specifiche esigenze:

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
83
- Attribuzione (nella versione inglese, Attribution): si tratta di una clausola
presente di default in tutte le licenze; sta ad indicare che ogni qual volta
l’opera venga utilizzata, il licenziatario sarà tenuto a mantenere intatte
tutte le informative sul diritto d’autore, riconoscendo una menzione
all’autore originale o ad eventuali terze parti designate, adeguata rispetto
al mezzo di comunicazione o supporto utilizzato.
- Non commerciale (nella versione inglese, Non commercial): in base a
tale clausola, i diritti sull’opera concessi dalla licenza non possono essere
esercitati in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al
perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario
privato; a tale proposito, è necessario chiedere uno specifico permesso
all’autore165.
- Non opere derivate: in virtù di questa clausola, la modifica, correzione,
traduzione e remix dell’opera sono subordinate all’ottenimento di uno
specifico permesso da parte del titolare dei diritti;
- Condividi allo stesso modo (nella versione inglese, Share Alike):
analogamente a quanto accade nello schema su cui si fonda il software
libero, questa clausola garantisce che, per il caso in cui l’opera venga
alterata, trasformata o sviluppata, l’opera derivata sia a sua volta
distribuita solo per mezzo di una licenza identica a quella originale166
165 Si tratta di una delle clausole che destano i maggiori problemi in sede interpretativa; l’art. 4, lett. b) della licenza “Non Commerciale 2.5”, versione italiana, prevede inoltre che “lo scambio dell’Opera con altre opere protette dal diritto d’autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d’autore”. 166 Cfr. art. 4, lett. b) della licenza “Condividi allo stesso modo 2.5”, che recita quanto segue: “Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico un’Opera Derivata, anche in forma digitale, solo assicurando che siano rispettati i termini di cui alla presente Licenza, di una versione successiva di questa Licenza con gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza o di una licenza Creative Commons iCommons che contenga gli stessi Elementi della Licenza come questa Licenza (ad es. Attribuzione-Condividi allo stesso modo 2.5. Giappone). Insieme ad ogni copia dell’Opera Derivata (o supporto fonografico su cui è registrata l’Opera Derivata) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o dell’altra Licenza di cui alla frase precedente o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all’Opera Derivata che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l’esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi e devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all’esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera Derivata, neanche in forma digitale, provvista di misure tecnologiche

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
84
(così garantendo che le libertà concesse dal licenziante si mantengano
anche sulle opere derivate, e, con un effetto a cascata, sulle derivate dalle
derivate).
Dalla combinazione di queste quattro clausole base nascono le sei licenze
Creative Commons, poi denominate attraverso il richiamo alle clausole stesse.
Ordinate dalla più permissiva a quella maggiormente restrittiva, e affiancate dai
relativi Commons deed, esse sono:
- Attribuzione;
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo;
- Attribuzione - Non opere derivate;
- Attribuzione - Non commerciale;
- Attribuzione - Non commerciale -
Condividi allo stesso modo;
- Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate.
Due aspetti essenziali emergono, in particolare, da un primo esame di questo
elenco di licenze: da un lato, che la clausola “Attribuzione” è presente di default
in tutte le licenze; dall’altro, che le clausole “Non opere derivate” e “Condividi
allo stesso modo” sono fra loro incompatibili logicamente, poiché la prima nega a
priori la possibilità di modifica, mentre la seconda implica necessariamente tale
possibilità.
In esito al quadro sintetico fin qui tracciato, pare potersi osservare che il modello
Creative Commons, per quanto non progettato, in origine, a misura delle necessità
legate all’accesso e al riutilizzo dell’informazione di cui gli enti pubblici sono
titolari, innegabilmente presenta più di un elemento d’attrattiva per il settore
miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
85
pubblico. È infatti pressoché intuitivo che il messaggio “some rights reserved”,
così come veicolato dal sistema Creative Commons (anche nell’ambito di alcuni
progetti tematici ad esso sottesi, che si distinguono per valore e lungimiranza
culturale), si muova in senso convergente rispetto ai principi cui il settore
pubblico si dichiara improntato, specie se si tiene presente la natura della PSI
quale risultato di un mandato istituzionale finanziato pubblicamente.
L’adozione delle licenze Creative Commons presenterebbe, quindi, una serie
cospicua di vantaggi per le amministrazioni, in ragione, innanzitutto, della
struttura standardizzata e della loro natura di licenze “pronte all’uso”. Ciò implica
che, da un lato, il settore pubblico non necessiti di elaborare nuove licenze di
propria iniziativa, ma possa efficacemente avvalersi della competenza condensata
nell’esperienza Creative Commons (potendo, peraltro, godere di una misura
apprezzabile di flessibilità nella scelta della licenza più adeguata agli specifici
contenuti), e che, dall’altro, i cittadini-licenziatari possano contare su un maggiore
livello di chiarezza quanto ai possibili utilizzi dell’informazione in oggetto, anche
grazie alla veste grafica dei Commons deed. In secondo luogo, l’uso delle licenze
CC sta conoscendo una forte espansione, non solo a livello internazionale ma
anche sul piano interno, sostanziando il progetto di riconoscimento e accettazione.
Ancora, l’allacciamento delle licenze ai contenuti, in modo indissolubile e
rilevabile dai motori di ricerca167, non farebbe che obbedire alle esigenze di un più
agevole reperimento dei contenuti e, ancora una volta, alla necessità di trasparenza
circa gli usi autorizzati dei contenuti messi a disposizione dagli enti, su propria
iniziativa come in seguito a richiesta. Inoltre, la tendenza di Creative Commons (e
iCommons) è, in generale, quella di stimolare l’interoperabilità delle proprie
licenze con altri modelli aperti d’informazione.
167 Come spiega Aliprandi, all’indirizzo web http://search.creativecommons.org si trova la pagina creata da Creative Commons per la ricerca di opere con licenza CC, che non è altro che un motore di ricerca impostato per essere sensibile ai metadati identificativi delle licenze e che opera una volta che si siano inserite una o più parole chiave nel campo di ricerca e che si sia specificato l’uso che si intende fare dell’opera, e cioè: a) uso commerciale; b) modifica, adattamento, sviluppo. Dalla stessa pagine è anche possibile utilizzare i motori di ricerca di Google e Yahoo, impostando una ricerca mirata specificamente a contenuti sotto licenza Creative Commons. Infine, la medesima ricerca è attuabile attraverso le versioni più recenti del browser Mozilla Firefox, che riportano in alto a destra, di fianco all’indirizzo web, un piccolo campo di ricerca, una “tendina” che di default riporta la G di Google e che se cliccata offre la doppia C di Creative Commons. V. S. ALIPRANDI, Creative Commons: manuale operativo, cit., pp. 63-64.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
86
Come anticipato, in anni recenti diversi governi hanno manifestato interesse nei
confronti dell’applicabilità del set di licenze Creative Commons al complesso
della PSI da essi prodotta, stimolando ricerche dirette a valutare i vantaggi, e, per
contro, i profili di scarsa compatibilità con un simile progetto.
In questo senso, uno dei report operativi più interessanti è quello che risulta in
esito ad uno studio del 2006 finanziato dal governo dello stato australiano del
Queensland, dal titolo “Government Information and Open Content Licensing: An
Access and Use Strategy”168, preceduto da una serie di iniziative e dibattiti di alto
livello di cui si è fatta promotrice la Queensland University of Technology
(QUT)169. Lo studio in questione rappresenta la seconda fase di un progetto che è
terminato con il sostegno da parte del Queensland Spatial Information Council
(QSIC) e dell’Information Queensland Steering Committee all’idea di adottare
licenze Creative Commons, e che ha determinato in una percentuale prossima
all’85% la porzione di informazione che il governo del Queensland potrebbe
licenziare secondo detto schema.
Lo studio, che dà conto della direttiva 2003/98/CE, qualificandola come una delle
una delle più significative iniziative sul piano internazionale nella direzione
dell’effettivo riutilizzo della PSI, colloca in esordio al report le seguenti
“recommendations”170: “That the Queensland Government establish a policy
position that, while ensuring that confidential, security classified and private
information collected and held by government continues to be appropriately
protected, enables greater use and re-use of other publicly available government
data and facilitates data-sharing arrangements; that the CC open content
licensing model be adopted by the Queensland Government to enable greater use
168 Queensland Spatial Information Office, Office of Economic and Statistic Research, Queensland Treasury, Government Information and Open Content Licensing: An Access and Use Strategy. Government Information Licensing Framework Project Stage 2 Report, October 2006, pp. 87, disponibile al sito www.qsic.qld.gov.au. 169 Nel gennaio del 2005 la Queensland University of Technology di Brisbane ha ospitato una serie di conferenze cui hanno preso parte, tra gli altri, il prof. Lawrence Lessig, alcuni esponenti del governo australiano, membri della Corte Suprema del Queensland e rappresentanti dell’industria creativa australiana. Una delle sessioni, in particolare, è stata dedicata all’applicazione delle licenze Creative Commons in ambito pubblico; la questione è stata discussa da docenti del QUT e rappresentanti del governo in due sessioni: “The Government’s Role in Supporting Creative Innovation” e “Why Government and Public Institutions Need To Understand Open Content Licensing”. Gli interessanti atti della conferenza si trovano riportati in B. FITZGERALD, Open Content Licensing: Cultivating the Creative Commons, Sidney University Press, 2008, pp. 67-92. 170 Ivi, pp. 1-2.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
87
of publicly available government data and to support data-sharing
arrangements”.
Nella sezione dedicata ad analizzare le questioni inerenti la “migrazione” al set di
licenze Creative Commons, lo studio così prosegue: “Background research
undertaken during this stage has confirmed that a range of jurisdictions are
moving to more open content models for licensing data and information and that
governments particularly are improving the control of intellectual property in
their data assets, as well as access to and re-use of public sector information by
using models such as CC” […] “A considerable number of Queensland
Government agencies would, by adopting certain of the present CC licences, be
able to meet all their business or operational requirements. The majority of
Queensland Government databases could be made available under the simplest of
the CC licences, namely the Attribution (or BY) licence, where there are no issues
of privacy, confidentiality, statutory constraints or policy constraints. Using this
licence, agencies could make such datasets readily available online:
as free data or where a statutory charge or fee is payable
without imposing any substantive requirements or limits on the initial
recipient (licensee) or later recipients if the State’s ownership of
copyright is recognised at all times during any use by the original or
subsequent recipients (licensees)171”.
L’analisi dei modelli di licenza al momento adoperati dal settore pubblico, non
solo a livello di stato del Queensland, bensì anche a livello federale, australiano,
ed al di fuori dei confini dell’Oceania, evidenzia una tendenza da parte degli enti a
171 Ivi, p. 19-21. Interessanti anche le considerazioni che seguono, e che evidenziano i vantaggi del modello CC nella duplice prospettiva del licenziante-ente pubblico e del licenziatario-cittadino/impresa: “From the perspective of the agency or Department there would be: consistency and transparent treatment of digital resources; improved perception of ‘value for money’ by the general public; reduction in effort of dealing with enquiries for information/resources; reduction in effort of developing a re-use policy by sharing a common policy; reduction in legal input through the adoption of existing licences rather than drafting new licences in each agency/department; enhanced public relations, potentially leading to increased use of other services; choice of licences offering flexibility; a framework of rights clearances conditions in future projects or databases. From the perspective of the users of public sector information, the benefits would be: wider access to previously unavailable digital resources; clear, unambiguous and permissive conditions of use; usability at the point of discovery; reduced confusion through a common set of well-recognised licences and symbols; peace of mind through knowing that re-use is legal and encouraged; ability to re-distribute and make derivative works (in permitted cases); ability of search engines to offer searches based on the conditions of use”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
88
mantenere un controllo “a valle” sull’informazione licenziata: “Many of the
licences, including those presently in use by the Department of Natural Resources
and Water reflect a policy or philosophy focusing on the maintenance of control
over the use of data downstream after it has been made available initially under
the licence. These provisions are designed to maintain control over the use that
may be made of the information through a chain or series of end-to-end
interlocking contractual provisions. The legal measures used are essentially
contract-based rather than copyright-based”172; tra gli enti in questione si colloca
anche l’Australian Bureau of Statistics (ABS)173, il quale, però, ha segnato una
decisa inversione di tendenza annunciando, nel dicembre 2008, l’adozione della
licenza Creative Commons Attribution per la maggior parte dei suoi contenuti on-
line. Di fatto la nuova politica dell’ABS non fa che muoversi coerentemente con
l’onda di generale innovazione che negli ultimi mesi ha coinvolto numerose
agenzie pubbliche australiane e, in particolare, lo stato del Queensland, nell’alveo
del Government Information Licensing Framework (GILF)174, l’ambizioso
programma con cui il Queensland si sta imponendo al mondo come leader nelle
politiche di sostegno al riutilizzo creativo ed innovativo della PSI, attraverso
l’applicazione organica e generalizzata delle licenze Creative Commons al
complesso dell’informazione pubblica.
Diverse delle conclusioni cui giunge la ricerca del Queensland sono condivise da
uno studio di un anno precedente, commissionato dal Common Information
Environment (CIE)175 e condotto da due gruppi di ricerca facenti capo
172 Ivi, p. 14. 173 Il riferimento alla più “generosa” delle licenze Creative Commons è presente nel colophon del sito www.abs.gov.au. 174 Per maggiori informazioni sulla struttura e sulle origini del progetto, si rimanda al sito www.gilf.gov.au, che così esprime i principali vantaggi del network tematico: “The benefits of GILF are that it: provides a clear, simple and methodical process for identifying and respecting intellectual property and other rights in material; provides a method of licensing material that enables information providers to apply terms and conditions to products with reduced need for legal advice; uses a limited suite of standardised licences expressed in plain English that can readily be understood; provides a simple licensing system that can replace many complex licensing practices currently in use”. Interessante anche l’articolo dell’aprile 2009, dal titolo “Queensland Government lead the world in embracing Creative Commons for Information Licensing (GILF)”, disponibile all’indirizzo: http://freedomofcommunication.org/tag/gilf/. 175 Si tratta di un gruppo di enti pubblici con un ruolo chiave nel Regno Unito e che include Becta, British Library, Department for Education & Skills, e-Science Core Programme, Joint Information Systems Committee, Museums Libraries & Archives Council, National Archives, National Electronic Library for Health, Scottish Library & Information Council, BBC, Culture Online, English Heritage, National Library of Scotland and UKOLN.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
89
all’Università di Edimburgo, dal titolo “The Common Information Environment
and Creative Commons”176.
La finalità dello studio è quella di chiarire la potenzialità delle licenze Creative
Commons nel chiarire e semplificare il processo di messa a disposizione di risorse
digitali disponibili al riutilizzo: i membri del CIE, infatti, finanziano attività volte
ad arricchire la mole di contenuti digitali accessibili, così che risulta
particolarmente importante consentire ai potenziali utenti di valutare con facilità
quali utilizzi della risorsa siano consentiti e venga garantita, allo stesso tempo,
un’adeguata tutela ai titolari dei diritti sui contenuti.
In particolare, uno dei maggiori meriti della ricerca scozzese è quello di
analizzare, oltre al modello Creative Commons, anche i principali sistemi di
licenza a base open-content in uso nel Regno Unito e nel resto del mondo: si
tratta, soprattutto, dei sistemi di licenze Click-Use177, Creative Archive178,
AEShareNET 179e GNU180.
176 Intrallect Ltd, AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, University of Edinburgh, The Common Information Environment and Creative Commons. Final Report to the Common Information Environment Members of a study on the applicability of Creative Commons Licenses, October 2005, pp. 39. 177 Le licenze Click-Use sono state introdotte nell’aprile 2001 dal già citato Office of Public Sector Information (OPSI), in cui è confluito l’ Her Majesty’s Stationery Office (HMSO), che per più di due secoli è stato organo responsabile della gestione del Crown copyright. Si tratta di uno schema di licenza on-line, attraverso il quale sono autorizzate varie forme di riutilizzo di ampie porzioni del materiale coperto da copyright della Corona. Il 12 agosto 2005 l’OPSI ha lanciato anche una particolare versione delle licenze Click-Use, che copre il materiale prodotto dal Parlamento di Westminster. 178 La licenza Creative Archive è utilizzata dal Creative Archive Group (BBC, Channel 4, The Open University e British Film Institute) per rendere disponibili programmi tratti dal proprio archivio ed è paragonabile, nella sostanza, alla licenza Creative Commons BY-NC-SA. L’eventualità di utilizzare le licenze CC è stata vagliata dal Creative Archive Group, ma infine rigettata per fondamentali due ragioni: la prima è che le licenze CC, non contemplando alcuna restrizione geografica, non consentono di limitare l’uso delle risorse al Regno Unito; la seconda è rappresentata dall’assenza, nelle licenze CC, di una condizione “no endorsement or derogatory use”, che sarebbe invece necessaria per impedire l’utilizzo dei contenuti a fini di propaganda politica o di beneficenza. 179 Il sistema di licenze AEShareNET è stato sviluppato dalla AEShareNET Ltd, che è un ente senza scopo di lucro creato dal Ministero australiano per l’Educazione e la Formazione, con la finalità di favorire la condivisione e lo sviluppo di materiali didattici. Si tratta di quattro licenze - Free for Education; Unlocked Content; Share and Return; Preserve Integrity- a carattere standardizzato, che non richiedono alcuna transazione, con efficacia per tutta la durata del copyright e senza limitazioni geografiche. Si rimanda, in ogni caso, al sito: www.aesharenet.com.au/. 180 La GNU Free Documentation License (GFDL) è la licenza utilizzata dalla Fondazione per il Software libero rispetto ai materiali diversi dal software (ad esempio, manuali) ed è, altresì, il tipo di licenza con cui è nata l’enciclopedia Wikipedia. Essa presenta una struttura molto simile a quella della licenza CC-Share Alike, poiché consente la copia, la distribuzione e l’adattamento di un contenuto per finalità commerciali o non commerciali; la licenza, inoltre, trova applicazione in tutto il mondo e non ha limiti di durata. Le principali condizioni sono le seguenti: che ogni

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
90
Lo studio conclude che gran parte181 delle risorse prodotte dagli istituti del CIE si
adattano ad essere rese disponibili al riutilizzo sotto licenza Creative Commons;
per i casi in cui queste non risultino applicabili, gli altri modelli di licenza
standard cui si è fatto riferimento configurano un’alternativa valida e praticabile,
per quanto, certamente, da limitare il più possibile nell’uso ai fini di non frustrare i
benefici derivanti dall’utilizzo della piattaforma Creative Commons. 182
Tra le ricerche finora svolte sul tema dell’applicabilità delle licenze CC al
complesso della PSI spicca senza dubbio, per completezza e analiticità, quella
pubblicata nel gennaio 2008 dall’Instituut voor Informatierecht (IViR)
dell’Università di Amsterdam in collaborazione con CC Nederland. Dal titolo
“Creative Commons Licensing for Public Sector Information. Opportunities and
Pitfalls”, lo studio - a quanto consta, unico finora in Europa a svolgere un’analisi
sistematica di così ampio respiro- si distingue in particolare per il rigoroso esame
critico e comparativo degli gli elementi di compatibilità tra il set di licenze
Creative Commons - e i principi cui le stesse si richiamano - e l’ambito
dell’informazione pubblica, sotto il duplice aspetto dell’accesso alla PSI e del
riutilizzo della stessa, quale regolamentato dalle disposizioni della direttiva
2003/98/CE.
Infine, per ciò che riguarda la situazione italiana, si deve prendere atto del fatto
che, salvo alcune iniziative e dibattiti di valore, ma isolati, la consapevolezza circa
indicazione circa la tipologia di licenza e il diritto d’autore rimanga intatta su tutte le copie dell’opera, che non vi sia alterazione dei termini della licenza e che, al tempo stesso, ogni opera derivata venga distribuita mediante un’identica licenza. V. www.gnu.org/copyleft/fdl.html 181 Dai diversi workshops cui hanno preso parte le istituzioni componenti il CIE, emerge che una percentuale prossima al 75% dei materiali da esse detenuti sono suscettibili di essere licenziati secondo il modello Creative Commons; il restante 25%, invece, non risulta adatto a tale schema, per ragioni inerenti l’alto valore commerciale dei contenuti o per il fatto che parte di essi sono nella titolarità di terzi, che hanno licenziato i materiali secondo termini particolari. In ogni caso, per la cospicua porzione di materiali per cui il modello Creative Commons pare adatto, le due licenze che le istituzioni in esame sarebbero più propense ad adottare sono la BY-NC-NC (attribuzione - non opere commerciali – non opere derivate) e la BY-NC-SA (attribuzione - non commerciale - condividi allo stesso modo), che, peraltro, sono attualmente le più diffuse su scala mondiale. 182 Tra le recommendations in esito alla ricerca si legge infatti: “CIE organizations that are publishing materials for reuse should use Creative Commons wherever possible but when resources cannot be licensed under Creative Commons the first choice should be another commonly used licence such as Creative Archive or Click-Use, in order to minimise the number of licences used. However some resources may exist under conditions which would not allow a standard licence to be used and these resources could be made available under a customised licence. Customised licences should be based on Creative Commons baseline rights as much as possible”. V. Intrallect Ltd, AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
91
il valore della PSI e circa le modalità di valorizzazione della stessa rimane
complessivamente piuttosto scarsa. In questo senso, non si può tralasciare di
menzionare, come elemento indicativo di tale situazione generale, la procedura
d’infrazione che la Commissione europea ha avviato il 19 marzo 2009 contro
l’Italia, per scorretta e incompleta trasposizione della direttiva 2003/98/CE
nell’ordinamento nazionale183.
Le carenze nel panorama italiano si concentrano in particolare attorno a due
ostacoli: il primo, indubbiamente di natura tecnologica, si traduce nella difficoltà a
rendere informazioni e dati pubblici effettivamente disponibili in formato
elettronico e a indicizzare tali informazioni in elenchi completi e facilmente
consultabili - passaggi, questi, indispensabili ai fini di favorire l’accesso,
l’interscambio e la fruibilità degli stessi e di accentuarne le possibilità di effettivo
utilizzo e valorizzazione, altrimenti soltanto teoriche.
Il secondo ostacolo, non meno complesso, deriva piuttosto da una mancanza di
chiarezza pressoché assoluta circa lo status di gran parte dell’informazione
pubblica sotto il profilo della proprietà intellettuale, che inevitabilmente frustra la
capacità dei cittadini di valutare con facilità gli usi consentiti della stessa, e
zavorra pesantemente quell’attribuzione di valore aggiunto che costituisce
obiettivo primario della direttiva 2003/98/CE.
Una prima linea di azione, da questo punto di vista, consisterebbe dunque nel
predisporre indicazioni sugli assets di informazioni detenute dalle amministrazioni
(in termini di tipologia, formato, consistenza, ordine cronologico): il che
consentirebbe alle imprese interessate al riutilizzo di verificare preliminarmente la
consistenza della “materia prima”, calibrando investimenti e sviluppo di prodotti e
Technology Law, University of Edinburgh, The Common Information Environment and Creative Commons, cit. p. 32. 183 Nella sezione comunicati stampa del sito ufficiale dell’Unione europea, si legge, in data 19 marzo 2009, quanto segue: “La Commissione europea ha avviato oggi una procedura d'infrazione contro l'Italia in quanto per diversi aspetti della direttiva PSI il recepimento nella normativa nazionale è avvenuto in modo scorretto oppure non ha avuto luogo. Uno dei punti problematici è l’esclusione dei dati catastali e ipotecari, che comprendono le informazioni catastali nonché dettagli concernenti la proprietà, la titolarità, l’ubicazione precisa, i confini di ogni parcella di terreno e l’utilizzazione dei beni immobili per garantire l’assunzione di prestiti. Tra le altre disposizioni non inserite nella normativa italiana figurano la portata e la definizione del riutilizzo, i requisiti procedurali in materia di trattamento delle richieste di riutilizzo, le relative condizioni specifiche, inclusi i formati disponibili e la tariffazione, e la non discriminazione.” V. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/425&format=HTML&aged=0&language=IT&guiLanguage=en.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
92
servizi184. Una seconda linea di azione consisterebbe, invece, nel promuovere
l’adozione, da parte delle diverse amministrazioni, di regole il più possibile
uniformi per il riutilizzo, particolarmente attraverso l’adozione di licenze standard
(predisposte, per esempio, da un’autorità centrale)185.
Questa situazione, di scarsa chiarezza e di estrema disomogeneità, quanto ai diritti
di proprietà intellettuale di cui gli enti pubblici siano titolari e quanto agli usi
consentiti dell’informazione gravata dagli stessi, emerge in maniera significativa
dal semplice passaggio in rassegna di alcuni siti web istituzionali, con un esame
analogo a quello svolto dalla Van Eechoud sul contesto istituzionale olandese (v.
nota 15). La quasi totalità dei risultati esprime in maniera eclatante la non
conformità dello stato dell’arte rispetto alle linee espresse dalla direttiva PSI e, in
particolare, dal considerando 22, che recita: “Gli enti pubblici dovrebbero
comunque esercitare il proprio diritto di autore in maniera tale da agevolare il
riutilizzo dei documenti”; gli esempi a seguire, in particolare, mostrano una
grande disomogeneità nelle modalità in cui le riserve sono espresse (e collocate,
necessitando una ricerca attiva e spesso non agevole per gli utenti) e, per contro,
una generale uniformità nella tendenza a formulare riserve molto estese:
- Città di Torino (www.comune.torino.it): il simbolo © è riportato nel
colophon della pagina principale e le riserve sono esplicitate, in modo
piuttosto sommario, nella sezione “Norme e condizioni d’uso”: “Tutti i
contenuti - testi, grafica, files, immagini e quant'altro pubblicato in
qualsiasi formato digitale - presenti all'interno dei siti della Città sono
protetti dal diritto d'autore (artt. 65 e 101 Legge 22 aprile 1941 n. 633 e
s.m.i.)”. Non tutte le sotto-pagine contengono indicazioni sul copyright e,
quand’anche presenti, le stesse non sono dotate di collegamento
ipertestuale alle condizioni d’uso.
184 Le indicazioni presenti nella disciplina nazionale sono, su questo punto, molto scarne: il d. lgs. 36/2006, infatti, si limita ad una previsione generica e non vincolante circa la creazione di metadati volti a favorire la ricerca di contenuti riutilizzabili, ma tali iniziative sono del tutto rimesse alle singole amministrazioni senza alcuna istanza di coordinazione. 185 Anche in questo caso, la disciplina italiana non offre spunti significativi, poiché la predisposizione delle licenze è completamente rimessa alle amministrazioni titolari dei dati (cfr. art. 9 d. lgs. 36/2006) e le poche indicazioni di principio sono finalizzate a vietare condizioni sproporzionate o anticoncorrenziali da parte dell’amministrazione cedente. V. B. PONTI, Il patrimonio informative pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 1003.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
93
- Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it): la pagina principale non
riporta alcun simbolo né una sezione sul modello “Avviso legale”, il che
potrebbe indurre gli utenti a ritenere testi e contenuti liberamente
riproducibili e riutilizzabili. Solo dopo una ricerca del tutto empirica, si
approda alla sezione “Note legali” dal link, per nulla evidenziato,
“Redazione del sito”. Le riserve sono, ancora una volta, estese e
formulate genericamente: “Tutti i testi, la grafica e il software presenti
all'interno di questo sito sono protetti ai sensi delle normative sul diritto
d'autore, sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale”.
- Il confronto con i siti istituzionali di altre amministrazioni regionali
evidenzia un panorama estremamente differenziato: in alcuni siti, quali
quello della Regione Sicilia186, non sono presenti indicazioni sulla pagina
principale, né su quelle secondarie, e neppure attivando la funzione
“Cerca nel sito” si giunge ad informazioni utili circa eventuali riserve sui
contenuti web. Il sito della Regione Emilia Romagna187 riporta invece nel
colophon la voce “Copyright”, ma la pagina cui si giunge, pure intitolata
“Copyright”, si limita a specificare le riserve, peraltro ampie, su marchi,
domini e segni distintivi e a definire le modalità per links al sito.
- Il sito della Regione Lombardia, ancora, ammette per il rilascio dei
contenuti, accanto alla modalità Copyright, la modalità Creative
Commons, salvo poi non presentare alcuna specificazione in relazione a
quest’ultimo modello, di cui non si rinvengono le tipiche icone, né link
esplicativi utili, su alcuna delle - numerose- pagine consultate188.
- Molto più coerente, in questo senso, il sito della Regione Sardegna che
riporta chiaramente la doppia “C” di Creative Commons su tutte le
pagine del sito principale, assieme al Commons Deed del modello di
186 http://www.regione.sicilia.it/ 187 http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ermes/pagine/copyright.htm 188http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=HomeSPRL/RegioneDettaglio&cid=1194454760315&pagename=HMSPRLWrapper: “Tutti i contenuti ( testi, immagini ,filmati,grafiche, marchi, loghi, audiovisivi ecc…) ed informazioni presenti all’interno del sito, sono di proprietà esclusiva di Regione Lombardia e/o di terzi e sono protetti ai sensi della vigente normativa sul diritto d’autore (legge n.633/1941 e s.m.i.)sui brevetti e su quelle relative alla proprietà intellettuale e possono essere rilasciati in modalità Copyright ovvero con diritti riservati o in modalità Creative Commons ovvero con alcuni diritti riservati. La riproduzione, la comunicazione e la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza l’autorizzazione del titolare dei diritti è vietata”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
94
licenza “Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso
modo”189.
- Grandi differenze si riscontrano, altresì, tra le strutture web ministeriali:
il sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(www.miur.it ) si limita infatti ad un’indicazione nel colophon, peraltro
obsoleta190, e priva di collegamenti attivi ad una sezione di note legali.
Analoga la situazione del sito del Ministero per i Beni Culturali e le
Attività Culturali (www.beniculturali.it), che presenta un laconico
simbolo © in calce alla pagine principale e non consente di giungere ad
indicazioni più specifiche neppure attivando la funzione “Cerca nel sito”.
Del tutto irreperibili, sul punto, indicazioni utili sul sito del Ministero
dell’Ambiente (www.minambiente.it), dove risultano inattive anche le
sezioni “Privacy” e “Responsabilità”, normalmente accostate alle
indicazioni sul copyright. Una situazione, questa, condivisa anche dal sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it), che
non fornisce indicazioni in materia neppure attraverso il motore di ricerca
interno.
- Per ciò che riguarda il sito del Senato della Repubblica (www.senato.it),
non compaiono simboli o indicazioni sintetiche sulla pagina principale; si
accede, infatti, all’”Avviso legale” solo attraverso la sezione “Guida al
sito”: “L'utilizzo, la riproduzione, l'estrazione di copia, ovvero la
distribuzione delle informazioni testuali e degli elementi multimediali
disponibili sul sito del Senato è autorizzata esclusivamente nei limiti in
cui la stessa avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico all'informazione,
per finalità non commerciali, garantendo l'integrità degli elementi
riprodotti e mediante indicazione della fonte”. Analoghe disposizioni
sono reperibili sul sito della Camera dei Deputati (www.camera.it), che
189 http://www.regione.sardegna.it/disclaimer.html 190 La laconica indicazione del colophon è: © 2006 Ministero dell’Università e della Ricerca, mentre titolare dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere, nella sua denominazione attuale e precisa, il “Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”. Infatti col Governo Prodi II, nel 2006, venne deciso di scorporare il Ministero e distinguerlo nelle sue vecchie componenti, il Ministero della Pubblica Istruzione, tornato appunto alla dicitura di "pubblica" istruzione, e il Ministero dell'Università e della Ricerca. Infine, in seguito alla Finanziaria 2008, legge n. 244/2007, venne deciso di ritornare alla Riforma Bassanini restituendo l'attuale denominazione del Ministero, attuata dal governo Berlusconi nel 2008.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
95
ribadisce il divieto di modificare informazioni testuali ed elementi
multimediali, subordinando la realizzazione di opere derivate ad
autorizzazione scritta dell’istituzione stessa.
- Alquanto estese, infine, anche le riserve presenti sul sito del
Governo italiano (www.governo.it), se paragonate, ad esempio,
con quelle formulate sugli omologhi siti di Spagna191 e Regno
Unito192. Più che lampante, dunque, la differenza con il sito della
Casa Bianca, che a partire dall’amministrazione Obama ha reso
disponibile ogni contenuto sotto licenza Creative Commons del
tipo Attribution 3.0193.
Ne emerge, insomma, un panorama alquanto frammentato, caratterizzato da un
elevato livello di disomogeneità anche tra enti di struttura analoga (governi
regionali, o ministeri), con la sola eccezione, nella formulazione delle riserve, dei
due rami del Parlamento, che pure non danno identica collocazione, nei propri siti
Internet, alle note in tema di proprietà intellettuale.
Dato il contesto generale, per molti versi scarsamente sensibile e tendenzialmente
immaturo ad una riflessione di più ampio respiro circa la valorizzazione
dell’informazione pubblica, sembrano quindi da salutare con grande favore
iniziative, isolate ma estremamente lungimiranti, quali quella della piattaforma
Culturalazio.it194, che recentemente ha reso disponibili tutti i propri contenuti con
licenza Creative Commons, e sedi di dibattito quali il convegno nazionale tenutosi
191 http://www.la-moncloa.es/es_AvisoLegal.htm: “Los contenidos, organización y elección de enlaces de las páginas de la-moncloa.es han sido seleccionados y/o coordinados por la Secretaría de Estado de Comunicación del Ministerio de Presidencia. Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes”. 192 V. http://www.cabinetoffice.gov.uk/copyright.aspx, dove per gli usi di natura diversa da quelli privati si rimanda al sito dell’OPSI, al fine di richiedere una “PSI Click-Use Licence”, rilasciata, come già visto, senza l’applicazione di alcuna tariffa (diversa dai costi di riproduzione e distribuzione). 193 V. http://www.whitehouse.gov/copyright, dove si legge: “Pursuant to federal law, government-produced materials appearing on this site are not copyright protected. The United States Government may receive and hold copyrights transferred to it by assignment, bequest, or otherwise. xcept where otherwise noted, third-party content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License. Visitors to this website agree to grant a non-exclusive, irrevocable, royalty-free license to the rest of the world for their submissions to Whitehouse.gov under the Creative Commons Attribution 3.0 License”. 194 V. www.culturalazio.it; Il ricorso alle licenze CC è, peraltro, esplicitamente annoverato tra gli aspetti caratterizzanti della nuova versione del portale: "Salvo dove diversamente specificato, tutti i contenuti del portale Culturalazio.it sono sotto licenza Creative Commons. Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5".

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
96
a Torino nel luglio 2006, dal titolo “L’informazione pubblica è un bene
comune?”, in cui, già allora, l’associazione “Il secolo della Rete” aveva lanciato
la proposta di dare vita a licenze d’uso di tipo Creative Commons per i dati degli
enti pubblici e di ideare un apposito marchio per le amministrazioni locali che
intendessero adottarle. Di altrettanto rilievo, e qualità, lo spazio dedicato al tema
“L’informazione del settore pubblico e la Rete” nel contesto della conferenza
annuale del “Centro Nexa su Internet e Società” del Politecnico di Torino195:
proprio tale centro di ricerca, infatti, si appresta ad avviare nel 2010 un ambizioso
progetto regionale, di taglio multidisciplinare, volto ad indagare la materia della
PSI e della sua attiva e consapevole valorizzazione, anche nella direzione di una -
auspicabile e necessaria- estensione del dibattito su scala nazionale.
3.2. La compatibilità delle licenze Creative Commons con la
normativa sull’accesso alla PSI
Come anticipato, uno specifico capitolo dello studio della Van Eechoud è dedicato
alla discussione del rapporto di compatibilità tra il sistema di licenze Creative
Commons e il diritto d’accesso all’informazione del settore pubblico. L’analisi si
incentra, in particolare, sul rapporto tra la normativa olandese sul diritto d’autore e
il Wet openbaarheid van bestur (WOB), che è punto cardine della legislazione
olandese in materia di accesso all’informazione pubblica e che contiene le norme
ad implementazione della direttiva 2003/98/CE; le considerazioni che ne derivano,
dunque, sono per lo più focalizzate sul contesto olandese, ma conservano gran
parte della loro validità lungo la cornice normativa dei vari Stati membri.
Preliminare all’analisi della compatibilità delle specifiche licenze Creative
Commons con il WOB è la questione se il diritto d’autore o il diritto sui generis
sulle banche dati dello Stato possa essere invocato per impedire l’accesso
all’informazione amministrativa. Ciò pare doversi escludere, in ragione del fatto
che la normativa sull’accesso si configura come lex generalis, mentre la
195 Per maggiori informazioni circa la struttura e le attività del centro Nexa, si rimanda al sito: http://nexa.polito.it/. Predisposta anche una sezione “Public Sector Information”, di prossima implementazione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
97
legislazione in materia di proprietà intellettuale opera quale lex specialis: nello
specifico, dottrina e giurisprudenza, per il caso in cui il settore pubblico sia
titolare di un diritto d’autore sui propri documenti, concordemente escludono che
tale diritto possa giustificare il diniego dell’accesso sulla base dell’art 10 (2) sub b
del WOB, che ha ad oggetto la tutela degli interessi economici e finanziari dello
Stato, quale limite all’accesso196.
La situazione appare differente qualora il diritto d’autore sia detenuto da terzi (in
particolare, se l’accesso comporta un danno sproporzionato per il titolare dei
diritti): in ogni caso, però, i diritti di proprietà intellettuale dei terzi rimangono
fuori dall’ambito di applicabilità delle licenze Creative Commons, che
presuppongono, come detto, l’effettiva titolarità dei diritti o l’ottenimento di
un’autorizzazione specifica dal titolare degli stessi.
Dunque, chiarito che l’amministrazione non potrà negare l’accesso ai propri
documenti sulla base dei diritti di proprietà intellettuale che essa possa vantare
sugli stessi197, potrà essa, ciò nondimeno, condizionare l’accesso o esercitare un
196 Il Wob contiene un elenco tassativo di motivi, assoluti e relativi, di diniego dell’accesso. L’art.10 (2) sub b, in particolare, illustra sette motivi relativi di diniego; due risultano particolarmente rilevanti rispetto all’analisi in corso: - il pregiudizio agli interessi economici e finanziari dello Stato, o di altro ente pubblico; - la necessità di prevenire un vantaggio o uno svantaggio sproporzionato alle persone fisiche o giuridiche coinvolte o a terzi. Come segnalato nell’approfondito lavoro di revisione del Wob condotto dall’università di Tilburg, le ragioni di diniego ora menzionate ricorrono entrambe con una certa frequenza; ma né la giurisprudenza, né la dottrina (e un riferimento quale il Libro Bianco del 2000 sull’ottimizzazione della disponibilità dell’informazione governativa) supportano l’idea che i diritti di proprietà intellettuale configurino un interesse finanziario dello Stato tale da giustificare il diniego all’accesso. Ivi, p. 49. 197 Come sottolinea la Van Eechoud, un’importante questione preliminare è data dall’interrogativo se consentire l’accesso a documenti pubblici tutelati dal copyright (o dal diritto sui generis) comporti un atto in violazione delle citate forme di tutela. L’attiva disseminazione di informazione pubblica nei termini definiti dal Wob costituisce un atto sia di riproduzione sia di comunicazione al pubblico secondo la legge sul copyright; per contro, la disseminazione passiva (o su richiesta) non comporterebbe comunicazione al pubblico e non coinvolgerebbe, pertanto, la questione della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Anche in questo secondo caso, però, bisogna tenere conto del fatto che la diffusione in forma passiva, pur non comportando comunicazione al pubblico, vede, di norma, la produzione di una o più copie, il che salvo le eccezioni previste per le copie private - richiama nuovamente il problema della tutela del copyright. È opportuno osservare, inoltre, che la diffusione delle tecnologie dell’informazione ha reso labile in maniera crescente il confine tra disseminazione attiva e passiva: risulta evidente, infatti, che quanto più un’amministrazione rende pubblici meta-dati (dunque, registri) in cui sono indicizzati i documenti di cui essa è titolare, e che sono accessibili ai cittadini, tanto più la distinzione tra diffusione attiva e passiva dell’informazione pubblica perde di pregnanza e tanto più, ancora, è probabile che vi sia “messa a disposizione” nei termini dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE (“Sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”). Detto art. 3 riconosce agli autori “il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico […]delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”. D’altra parte, l’art. 9 della medesima direttiva fa salva l’applicazione delle disposizioni

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
98
controllo sul successivo uso dell’informazione, in virtù dei menzionati diritti?
Evidentemente, l’amministrazione potrà imporre condizioni all’uso
dell’informazione resa accessibile, ma tali restrizioni devono rimanere coerenti
con lo spirito della normativa sull’accesso; ciò che si traduce, in primo luogo, nel
divieto di imporre condizioni discriminatorie. In sostanza, i termini su cui l’ente
acconsente all’accesso devono essere identici per la totalità dei cittadini: ciò
deriva, secondo quanto osserva lo studio dell’IViR, da una consolidata
giurisprudenza che ha qualificato come illegittima la pratica di subordinare
l’accesso alla titolarità di un interesse qualificato198 (“The adagio is ‘access for
one is access for all’”199).
Considerati, quindi, gli obiettivi di fondo che animano il Wob, e verificato che
non sussiste alcuna delle limitazioni all’accesso di cui agli art. 10 e 11,
l’informazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale atto dovrebbe, a
concernenti l’accesso alla documentazione pubblica: sulla base di ciò, si potrebbe argomentare che l’amministrazione pubblica non necessita del permesso dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale per garantire l’accesso alla PSI sulla base dei principi della “freedom of information”. Ma, come osservato dallo studio dell’IViR, è altamente improbabile che l’art. 9 della direttiva sulla Società dell’Informazione miri ad obbligare gli enti pubblici a conferire ai principi dell’accesso una priorità assoluta e sistematica sulla tutela del copyright di cui sono titolari terze parti. Ivi, p. 51. 198 Già si è discusso, nel primo capitolo, che laddove il diritto d’accesso si configura come soggettivamente limitato, in ragione dell’interesse che è necessario far valere -come nel caso del nostro ordinamento- l’integrazione della disciplina sul riutilizzo risulta più problematica, perché le filosofie sottese ai due istituti non solo non convergono, ma appaiono animate da principi, e da esiti concreti, quasi antitetici. Da un lato, infatti, il diritto d’accesso richiede la puntuale dimostrazione di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”; dall’altro, il riutilizzo presuppone la messa a disposizione, da parte dell’amministrazione titolare, di intere categorie di documenti e di dati senza alcuna relazione con la situazione giuridica del richiedente, che non sia l’interesse stesso al riutilizzo. Secondo Ponti, i due istituti si muovono su piani distinti, ma possono astrattamente convivere, a condizione che l’interesse al riutilizzo non arrivi a consolidarsi in una situazione giuridica soggettiva sufficientemente tutelata, perché in questo caso il diritto di accesso - per lo meno, nella sua attuale e limitata configurazione- finirebbe per risultare del tutto svuotato. Ciò spiega l’estrema laconicità del legislatore italiano nel disciplinare la materia, e anche l’ambiguità di fondo della tutela giuridica, non pienamente assicurata, all’interesse ad ottenere i documenti ai fini di riutilizzo. In questo senso, trova spazio la congettura per cui, a fronte di una significativa tutela giuridica dell’interesse al riutilizzo, quest’ultimo finirebbe per essere utilizzato in luogo del diritto di accesso, dal momento che consentirebbe di ottenere più facilmente un numero di informazioni ben maggiore di quello assicurato dal diritto d’accesso (benché, naturalmente, a costi più elevati). V. B. PONTI, Il patrimonio informative pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 1006. Contra, ovvero nel senso del riutilizzo quale estensione del diritto d’accesso, cfr. S. GIACCHETTI, Una nuova frontiera del diritto d’accesso: il “riutilizzo dell’informazione del settore pubblico” (Direttiva 2003/98/CE), in COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI PUBBLICI, L’accesso ai documenti amministrativi, vol. IX, pp. 1245 ss. 199 M. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 53.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
99
rigore, essere disponibile senza restrizioni: in questo senso, la “Public Domain
Dedication” di Creative Commons appare il modello di licenza più compatibile
con i principi di trasparenza amministrativa e libertà dell’informazione, poiché
opera nel senso di sottrarre i cittadini all’incertezza circa le possibilità di utilizzo
dell’informazione, esplicitando, anzi, le più variegate opportunità d’utilizzo della
stessa.
La Van Eechoud procede dunque ad analizzare nel dettaglio come i termini
specifici del modello Creative Commons si rapportino con gli obiettivi e le
previsioni della normativa sull’accesso, distinguendo tre diversi piani: quello delle
clausole pienamente compatibili o che addirittura rafforzano i principi della
“Freedom of Information” (Fully compatible terms or FOIA enhancing), quello
delle clausole discretamente compatibili o neutre (Fairly compatible or FOIA
neutral) e infine quello dei termini scarsamente compatibili o che annullano i
risultati della normativa sull’accesso (Poorly compatible or FOIA impairing).
Secondo le osservazioni fin qui sviluppate, pare potersi affermare che il WOB
olandese trova una soddisfacente livello di aderenza nella natura non
discriminatoria delle licenze standardizzate Creative Commons, dal momento che
le stesse sono disponibili a chiunque desideri diffondere contenuti in Creative
Commons e che i termini di utilizzo sono i medesimi.
In secondo luogo, l’assenza di royalties per l’utilizzo dei contenuti è compatibile
con il principio per cui l’informazione pubblica dovrebbe essere disponibile
gratuitamente o al costo massimo di riproduzione e diffusione. Infine, le clausole
che escludono la prestazione, da parte del licenziante, di garanzie e dichiarazioni
riguardo ai materiali e le clausole di limitazione di responsabilità non paiono
contrastare con il regime di accesso all’informazione pubblica.
Alcune delle clausole generali sembrano però sollevare questioni di compatibilità
(c.d. “Fairly compatible terms”) . Una prima disposizione è quella che prevede
che le opere licenziate in Creative Commons non possano essere sottoposte a
Technical Protection Measures, che necessariamente finirebbero per sottrarre ai
destinatari “a valle” i privilegi che l’autore desidera riservare loro200. Si tratta di
una clausola pensata per mantenere libera l’informazione, ed in questo senso,

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
100
sicuramente, essa è coerente con l’idea di generale accessibilità che informa il
WOB. D’altra parte, tale clausola pare al contempo limitare, in qualche misura, la
libertà dell’utente, facendo sorgere la questione se effettivamente le
amministrazioni intendano interferire con la libertà del cittadino in questi termini.
Un analogo argomento può essere sollevato rispetto alla clausola che impone al
licenziatario di mantenere intatti i riferimenti ai termini della licenza e di includere
un link alla licenza dalle copie dell’opera (indicando, nel caso di copie non
digitali, come poter risalire al testo della licenza). Ciò naturalmente impone un
onere sull’utente che non compare nella normativa tradizionale sul copyright, ma
che, si osserva, è complessivamente piuttosto modesto se comparato alla
situazione ordinaria, dove il destinatario dell’informazione deve in primo luogo
procedere all’identificazione del titolare del copyright e dunque ottenerne il
permesso per gli atti di riproduzione e distribuzione.
Una terza disposizione che può sollevare qualche perplessità quanto alla
compatibilità con il regime di accesso è la clausola di attribuzione. Infatti, nel
distribuire i contenuti offerti in licenza, il licenziante dovrà mantenere
l’indicazione di diritto d’autore intatta su tutte le copie dei materiali in oggetto, in
modo tale che sia sempre chiaramente individuabile chi è il detentore dei diritti e
qual è il tipo di licenza che questi abbia scelto. Oltre agli argomenti già esposti, si
potrebbe osservare che i cittadini dovrebbero essere liberi nella scelta di
accreditare o meno l’amministrazione. Nella pratica, però, gli utenti avranno
tipicamente interesse a indicare l’ente amministrativo come fonte
dell’informazione, poiché ciò sarà un elemento di forte credibilità nel contesto del
dibattito pubblico oppure nella gestione dei rapporti con l’amministrazione.
Infine, vi sono tre clausole nel corpo di licenze Creative Commons che non
appaiono sufficientemente compatibili con i principi dell’accesso all’informazione
del settore pubblico (c.d. Poorly compatible terms).
La prima di esse è la clausola “Non commerciale” (NC), che non consente alcun
uso dei contenuti in senso commerciale. Osserva lo studio dell’IViR che i media,
ma anche altri gruppi economici, non sarebbero in grado di accedere alla PSI sotto
licenza “NC”, se non limitandosi alla lettura o attuando gli altri usi consentiti
200L’applicazione di meccanismi di protezione non consentirebbe, ad esempio, ad un utente / destinatario dell’opera di includere copie della stessa in una raccolta di altri dati e opere, e di

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
101
secondo le norme che regolano il copyright. Ma è evidente che, dato in particolare
il loro ruolo di “public watchdogs” e la loro funzione di supporto alla cittadinanza
nell’ambito dei processi decisionali, questi soggetti non possano discriminati sul
piano dell’accesso all’informazione.
La seconda clausola problematica è la clausola “Condividi allo stesso modo”
(“SA”), che è, in linea di principio, coerente con i principi sottesi alla normativa
sull’accesso, la quale configura l’insieme di dati e documenti conservati presso le
amministrazioni come un patrimonio comune. Cosa diversa, però, è imporre ai
cittadini il dovere di condividere come contropartita rispetto al diritto d’accesso: i
principi dell’accesso, infatti, impongono innanzitutto doveri al governo nei
confronti dei cittadini, ma non fissano un insieme di doveri nei rapporti orizzontali
tra cittadini. Nell’opinione dell’IViR, dunque, la clausola “SA” non trova
sufficiente fondamento, a dispetto dell’apparente compatibilità con la normativa
sulla libertà dell’informazione.
Una terza clausola che solleva perplessità analoghe è la “Non opere derivate”
(ND): se, infatti, la funzione della legislazione sull’accesso è quella di proteggere i
cittadini da comportamenti arbitrari del governo, potenziando i diritti degli stessi,
ne deriva che l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle
amministrazioni non dovrebbe minare i principi dell’accesso all’informazione, i
quali, certamente, legittimano il cittadino ad estrarre copia del documento e a
distribuirlo ad altri cittadini, eventualmente anche pubblicando in parte o per
intero il documento attraverso i media a disposizione. La clausola “ND”
consentirebbe gli usi fin qui menzionati, ma non potrebbe autorizzare l’utente a
rielaborare i dati integrandoli con quelli provenienti da altre fonti, né a distribuire
le traduzioni del documento in un’altra lingua, mentre, evidentemente, simili
utilizzi realizzano ancora più pienamente lo spirito delle norme sull’accesso201.
distribuire quindi liberamente detta raccolta. 201 M. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 57: “We have established first, that there is no explicit hierarchy of norms. The Wob does not trump intellectual property laws per se. Nor does the Copyright Act necessarily take precedence over the Wob. Copyright prerogatives, especially those of the public sector, cannot be used to prevent access to government information. Nor does the fact the right to access imply that recipients of public sector information can ignore the fact that such information may be subject to exclusive rights, i.e. the use may be conditioned. However, we argue that the rationale of the Government Information Act implies that recipients of information must enjoy considerable freedom of use, certainly where the public sector owns the copyright. Recipients should be able to copy, distribute and rework it so as to be able to share

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
102
3.3. La compatibilità delle licenze Creative Commons con la
normativa sul riutilizzo della PSI
Dal confronto critico tra il regime di riutilizzo tracciato dalla direttiva 2003/98/CE
e il modello Creative Commons, risultano individuabili, in tale modello, numerosi
elementi non soltanto di compatibilità, ma piuttosto di convergenza con i principi
ispiratori della normativa sul riutilizzo: innanzitutto, la non discriminatorietà e
non esclusività delle licenze Creative Commons, assieme al loro carattere
standardizzato, quindi la promozione di pratiche di licenza on-line e la
facilitazione della ricerca di contenuti disponibili per il riutilizzo. Prima di
muovere all’esame della compatibilità degli specifici termini delle licenze
Creative Commons con la direttiva sul riutilizzo occorre, dunque, dedicare
qualche considerazione agli aspetti appena citati.
Quanto all’aspetto dell’identificazione e della ricerca di contenuti, la direttiva PSI
prescrive, all’art. 9, che gli Stati membri garantiscano “modalità pratiche per
facilitare la ricerca di documenti disponibili per il riutilizzo, come elenchi di
contenuti, di preferenza accessibili per via elettronica, dei documenti più
importanti e dei portali collegati a elenchi di contenuti decentralizzati”. Il
modello Creative Commons suggerisce una via alternativa: abilita i licenzianti a
taggare i propri contenuti e fornisce i mezzi affinché i motori di ricerca
individuino tali contenuti, combinando, di fatto, le tre fasi che la direttiva articola
separatamente, ossia l’identificazione di contenuti disponibili, la determinazione
delle condizioni di licenza e la fornitura dell’informazione stessa202. Tale modello,
infatti, può essere variamente utilizzato in combinazione con elenchi on-line: un
utente identifica, grazie a detti indici, l’informazione che intende utilizzare, inoltra
una richiesta di riutilizzo e il contenuto, quindi, è reso disponibile con la licenza
their views and report their findings. The idea that access enables citizen’s participation and influence in the decision- and policy-making process, and the idea that the citizen in his or her role as subject of authority should be empowered, are only truly meaningful if the citizen can actively engage with government information”. 202 Si rimanda, sul punto, a quanto osservato nella nota 10. Anche la Van Eechoud sottolinea come sia Google sia Yahoo abbiano già predisposto motori di ricerca finalizzati a tracciare la presenza di contenuti rilasciati in Creative Commons. Ivi, p. 42.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
103
Creative Commons più appropriata; gli elenchi on-line, inoltre, possono non
soltanto specificare quali contenuti siano disponibili in Creative Commons, ma
anche fornire un collegamento alla pagina dove il contenuto è reso attivamente
disponibile.
Particolarmente significativo della convergenza tra le modalità operative prescritte
dalla direttiva PSI e il modello Creative Commons appare, altresì, l’art. 8, c. 2
della direttiva, che prevede che negli Stati membri in cui si fa uso della licenza,
questi provvedano “affinché le licenze standard per il riutilizzo di documenti del
settore pubblico, che possono essere adattate per soddisfare particolari richieste
di licenza, siano disponibili in formato digitale e possano essere elaborate
elettronicamente”, e che così conclude: “Gli Stati membri incoraggiano tutti gli
enti pubblici a ricorrere alle licenze standard”.
Quanto al carattere non discriminatorio delle licenze Creative Commons, è
evidente che, operando secondo tale modello, un ente pubblico non potrà
licenziare un’opera consentendo e, allo stesso tempo, impedendo un utilizzo
commerciale della medesima opera differenziando il trattamento a seconda della
tipologia di licenziatari; d’altra parte ciò è consentito dalla direttiva PSI all’art. 10,
c. 1, che afferma che “le condizioni poste per il riutilizzo di documenti non
comportano discriminazioni per categorie analoghe di riutilizzo”.
Per l’informazione rispetto alla quale è suggeribile adottare licenze differenziate,
l’uso delle licenze Creative Commons può avere vantaggi limitati: se un ente,
infatti, licenzia l’opera secondo il modello di licenza “CC-BY-NC”, necessiterà
poi, comunque, dell’adozione di una propria licenza standard per autorizzare gli
utilizzi commerciali. Al contempo, però, si intravedono scarse ragioni per non
adottare l’infrastruttura Creative Commons laddove gran parte dell’informazione
pubblica si adatta a tale modello: come suggerito dal già citato studio condotto
dallo stato del Queensland, infatti, le licenze Creative Commons potrebbero
agevolmente essere applicate al nucleo più consistente della PSI e, quindi,
affiancate da un numero limitato di licenze standard, elaborate dalle
amministrazioni e applicabili all’informazione non compatibile con detto modello
(per ragioni inerenti la tutela dei dati personali, la natura confidenziale
dell’informazione o, ancora, il suo particolare valore commerciale)203.
203 Ivi, p. 72.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
104
Per ciò che riguarda invece l’elemento della non esclusività, occorre ricordare che
il principio guida della direttiva è che le licenze non dovrebbero essere accordate
su base esclusiva, a meno che il diritto esclusivo risponda alla necessità di un
servizio di interesse pubblico204. Anche in questo caso è possibile utilizzare le
licenze Creative Commons in combinazione con un accordo esclusivo, optando
per una licenza che non interferisca con l’accordo esclusivo, quale, per esempio,
la “BY-NC” o la “BY-NC-ND”.
I meccanismi di tariffazione delineati dalla direttiva non paiono incompatibili con
lo schema delle licenze Creative Commons, dal momento che la stessa esprime
una preferenza per la gratuità nella fornitura dell’informazione e
nell’autorizzazione al riutilizzo o per tariffe orientate al limite del costo marginale
di diffusione. Nella sostanza, l’imposizione di eventuali tariffe non sarebbe da
relazionarsi all’utilizzo dei contenuti (ma piuttosto, come osservato, ai costi di
raccolta e disseminazione) e proprio in questo senso l’art. 6 della direttiva
(“Principi di tariffazione”) sembra compatibile con l’impostazione delle licenze
CC, che non contemplano l’applicazione di royalties205.
Infine, un potenziale inconveniente potrebbe essere rappresentato dall’obbligo,
previsto in capo alle amministrazioni, di indicare in ogni decisione negativa un
riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente per impugnare la
decisione che nega il riutilizzo o che lo consente su termini non reputati
soddisfacenti206. Ebbene, specialmente in quest’ultimo caso, l’ente pubblico
204 Il riferimento è all’art. 11 della direttiva 2003/98/CE, rubricato “Divieto di accordi di esclusiva”, che così dispone ai commi 1 e 2: “I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più soggetti stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi. Tuttavia, se per l’erogazione di un servizio d’interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l’attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. […]”. 205 Come osservato dallo studio dell’IViR, nella pratica i contenuti sotto licenza Creative Commons sono per lo più distribuiti gratuitamente in Internet, ciò che rende superflua la distinzione tra l’applicazione di tariffe a fronte di utilizzo (royalty) e l’applicazione di tariffe corrispondenti ai costi di diffusione dell’informazione. V. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 72. 206 In realtà, a fronte di quanto richiesto dalla direttiva, che ha prescritto l’obbligo di indicare – in caso di decisione negativa sulle richieste di riutilizzo- sia le motivazioni alla base del rifiuto, sia i mezzi di ricorso a disposizione del richiedente per impugnare la decisione, la disciplina italiana, contenuta nel d. lgs. 36/2006, tace del tutto sul punto. Complessivamente, quindi, l’interesse al riutilizzo appare piuttosto “disarmato” di fronte ai comportamenti che le amministrazioni dovessero assumere di volta in volta in materia. Cfr. B. PONTI, Il patrimonio informative

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
105
potrebbe essere spinto a riconsiderare il tipo di licenza scelta nel passato. Bisogna
però tenere conto che l’ente pubblico, pur potendo in ogni momento cessare di
offrire i contenuti sotto licenza Creative Commons, non potrà impedire a qualcuno
che abbia ottenuto i contenuti in Creative Commons di usare l’opera secondo i
termini di detta licenza. Il problema non si porrà, naturalmente, laddove il
licenziante voglia passare da una licenza più restrittiva ad un’altra più liberale, ma
piuttosto nel caso, opposto, in cui intenda successivamente limitare i termini di
utilizzo (per esempio, da “BY” a “BY-ND”)207; in quest’ultimo caso, come
osservato, non sarebbero coinvolti i precedenti licenziatari, ma ciò potrebbe
implicare un’azione di responsabilità nei confronti dell’ente pubblico
licenziante208.
È possibile ora procedere all’esame degli specifici termini di licenza Creative
Commons con le finalità e le previsioni della direttiva 2003/98/CE, adoperando la
classificazione, già adottata a proposito del regime di accesso all’informazione,
che distingue tra termini pienamente compatibili o che potenziano gli obiettivi del
regime di riutilizzo, termini discretamente compatibili o neutrali e infine termini
incompatibili o che addirittura frustrano le finalità della normativa sul riutilizzo.
Come in precedenza osservato, il set di licenze CC appare pienamente compatibile
con la cornice normativa sul riutilizzo della PSI in una molteplicità di elementi:
innanzitutto, il carattere standardizzato delle licenze e l’adozione di meccanismi
operativi di ricerca ed individuazione dell’informazione pubblica disponibile per il
riuso, ma anche la non discriminatorietà delle licenze e l’assenza di royalties. In
particolare, il carattere non discriminatorio delle licenze CC rimane compatibile
con il regime di riutilizzo, sebbene trattamenti differenziati, ammessi dalla
direttiva 2003/98/CE, non siano invece consentiti entro lo schema di licenze CC.
A questo proposito, è utile osservare che laddove si renda necessario un
trattamento differenziato a seconda della tipologia di riutilizzo, le licenze più
restrittive - in particolare la BY-NC-ND – potrebbero essere combinate con
pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, cit., p. 1002. 207 Ciò potrebbe accadere, ad esempio, in questioni inerenti la concorrenza. Cfr, sul punto, il caso del National Road Dataset (NWB), descritto in V. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 64. 208 Se il riutilizzo è consentito sulla base della “Public Domain Dedication”, nessun cambio di politica appare possibile, dunque la scelta dell’attribuzione in pubblico dominio andrebbe compiuta con la massima cautela. Ivi, p. 73.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
106
modelli di licenze che consentano usi commerciali e che vengano elaborate dalle
specifiche amministrazioni.
Altrettanto coerenti con le necessità di trasparenza cui la direttiva mira a
rispondere sono alcune delle clausole comuni a tutte le licenze Creative
Commons, quali, in particolare: l’attribuzione automatica “a cascata” delle licenze
dal licenziatario iniziale a quelli successivi, la non limitazione, geografica e
temporale, della validità delle licenze, il mantenimento dell’indicazione di diritto
d’autore intatta su tutte le copie dell’opera (in modo tale che sia sempre
chiaramente individuabile il detentore dei diritti e il tipo di licenza per cui questi
abbia optato), e l’inclusione di un link alla licenza nelle copie dell’opera (o
l’indicazione, in caso di copie non digitali, delle modalità per risalire al testo della
licenza).
Passando in rassegna, poi, i termini caratteristici delle licenze Creative Commons
che appaiono solo mediamente compatibili con gli obiettivi della direttiva PSI,
viene in rilievo, in primo luogo, la clausola “Share Alike”. Sebbene essa ponga
meno problematiche nel contesto normativo del riutilizzo che non in quello
dell’accesso all’informazione, analizzato al paragrafo precedente, ciò nondimeno
l’adozione della stessa segue a sollevare perplessità e ad apparire sconsigliabile,
poiché finirebbe per imporre severe limitazioni sui modelli di business che le
imprese abbiano interesse ad attuare rispetto ai prodotti e servizi a valore aggiunto
da esse sviluppati a partire dall’informazione pubblica.
Altro termine delle licenze Creative Commons che desta qualche perplessità è la
proibizione di applicare Digital Rights Management (DRM) che limitino l’uso del
contenuto licenziato. La lettera della direttiva PSI, infatti, non esclude l’adozione
di DRM, ma se si tiene presente l’obiettivo della stessa, che è quello di stimolare
lo sviluppo di un solido mercato dell’informazione a partire da materiali
informativi pubblici, ne deriva che simili misure di protezione potrebbero in certa
misura frenare i modelli di business fondati sul riutilizzo.
Ancora, per i casi di enti pubblici che continuino ad applicare tariffe basate su
politiche di recupero dei costi, le licenze Creative Commons non paiono adatte
come modello primario di licenza, ma possono svolgere, comunque, un efficace
ruolo complementare: ed è il caso, in particolare, delle licenze “BY-NC” o “BY-
NC-ND”. Si osservi, infine, che alcune amministrazioni, specie quelle che sono

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
107
titolari dei registri pubblici, potrebbero trovare problematica l’applicazione delle
licenze CC quanto alle clausole che escludono la responsabilità per danni
derivanti dall’uso dei contenuti licenziati, e che non offrono alcuna garanzia:
specie per i casi in cui detti enti siano l’unica fonte di determinati dati, o abbiano
lo specifico dovere di assicurare un certo standard di qualità o affidabilità dei dati,
essi potrebbero non voler escludere ogni responsabilità e rifiutare ogni garanzia.
In conclusione, quanto ai termini delle licenze CC scarsamente compatibili in una
prospettiva di stimolo al riutilizzo, torna in rilievo in primo luogo la clausola NC,
che, oltre a restringere considerevolmente le possibilità di riutilizzo, esclude
altresì dalle opportunità di riuso tutti i soggetti che siano portatori di un interesse
commerciale209.
Analoghe riflessioni valgono per la clausola “ND”, che non consente
l’elaborazione di opere derivate ma riconosce al licenziatario soltanto il diritto di
riprodurre e distribuire i contenuti (compreso il diritto di apportare agli stessi le
modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l’esercizio di detti diritti
tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati): tali attività, infatti,
consentite secondo i termini della clausola “ND”, innegabilmente risponderebbero
a schemi di “riconfezionamento” e rivendita dell’informazione, piuttosto che
all’autentica attribuzione di valore aggiunto, quale finalità ispiratrice della
direttiva sul riutilizzo della PSI.
A conclusione di questa riflessione, sembra infine utile riproporre un’efficace
schema elaborato dall’IViR con il proposito di esprimere, in sintesi grafica, i
principali rilievi dell’indagine circa la compatibilità del modello di licenze
Creative Commons con i principi della “Freedom of Information” e della
normativa sul riutilizzo210:
209 Si ribadisce, a questo proposito, il ruolo complementare giocato dalla licenze CC per la circostanza in cui l’ente debba mantenere (essenzialmente per ragioni finanziarie, legate alla scelta di un modello di cost recovery) schemi di licenza che distinguono tra tipologie di utilizzi e categorie di utilizzatori. 210 V. VAN EECHOUD, B. VAN DER WAL, Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, cit., p. 83.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
108

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
109
Capitolo quarto
Riutilizzo della PSI e diritti fondamentali: riflessioni sul diritto alla privacy
4.1. Premessa
Una delle sfide di maggiore interesse in materia di riutilizzo della PSI è data dalla
necessità di contemperamento, esplicitata dalla lettera della stessa direttiva
2003/98/CE, tra gli obiettivi di crescita economica, associati allo sviluppo del
mercato europeo dell’informazione, e i principi relativi alla tutela dei dati
personali, quali delineati, innanzitutto, nella direttiva 46/95/CE, “relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati”211.
L’art. 1, c. 4 della direttiva 2003/98/CE ribadisce quanto già anticipato al
considerando 21, là dove recita che la normativa comunitaria “non pregiudica in
alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario e nazionale e
non modifica, in particolare, i diritti e gli obblighi previsti dalla direttiva
95/46/CE”212.
211 Un’interessante panoramica sulla relazione tra tutela della privacy e freedom of information, e approfondimenti critici sull’idea di privacy come limite all’accesso all’informazione pubblica (quale contenuta, in particolare, nei registri pubblici, di cui sono menzionati numerosi esempi) si trova in C. D. RAAB, Privacy Issues as Limits to Access, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age. Between Markets, Public Management and Citizen’s Rights, Edward Elgar Publishing, Celtenham, 2004, pp. 23-47. Si rimanda, altresì, a L. FLORIDI, Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione, Digitalica, Giappichelli, Torino, 2009. 212 La direttiva del 2003 accoglie l’impostazione che si afferma con il Libro Verde sull’Informazione del Settore Pubblico nella Società dell’Informazione del 1998 e che ritornerà nella Comunicazione della Commissione europea del 21 0ttobre 2001 (“eEurope 2002: Creating a EU Framework for the Exploitation of Public Sector Information), impostazione che deriva dalla reazione affermativa ad una delle principali questioni poste dal Libro Verde: “Do privacy considerations deserve specific attention in relation to the exploitation of Public Sector Information?” (par. 114, question 7). Il percorso storico del dibattito che ha portato a fare salvi senza esitazioni, nella direttiva sul riutilizzo della PSI, i principi della normativa europea in materia di privacy, si trova efficacemente tracciato in: C. D. RAAB, Privacy Issues as Limits to Access, in G. AICHHOLZER, H. BURKERT (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, cit., pp. 31-41.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
110
Le ragioni per cui, a mio avviso, l’integrazione dei due complessi normativi è
destinata ad essere piuttosto complessa e articolata sono raggruppabili attorno a
due punti.
Il primo appare necessariamente legato alla natura della privacy come diritto
fondamentale nel diritto comunitario213, che per molti versi si oppone al modello
statunitense, dove tende invece a prevalere un’impostazione di tipo proprietario214.
In secondo luogo, la questione dell’integrazione tra regime di tutela dei dati
personali e normativa sul riutilizzo della PSI rappresenta un campo parzialmente
inedito nell’ambito delle iniziative e dei principi relativi alla tutela della privacy.
Come sottolineato da diversi commentatori (e, in primis, dai centri di ricerca cui la
Commissione europea ha affidato, in anni recenti, studi comparativi circa gli
effetti dell’implementazione della normativa sulla PSI), la direttiva 2003/98/CE è
ben lungi, infatti, dall’avere dispiegato tutte le proprie potenzialità in ambito
europeo: prova ne sia il fatto che nei confronti di diversi stati membri sono state
213 Tra i diritti fondamentali dell’Unione europea ritroviamo, all’art. 7 della Carta di Nizza (Carta alla quale l’art. 6 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, riconosce “lo stesso valore giuridico dei trattati”) , il rispetto per la vita privata e familiare delle persone che, almeno in parte, riprende quanto già affermato dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: “Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza” (comma 1); “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui” (comma 2). La specifica novità della Carta di Nizza rispetto alla Convenzione rinvia alla circostanza che, oltre al rispetto della vita privata come diritto fondamentale della persona, l’art. 8 tutela separatamente il diritto alla privacy, inteso come protezione dei dati personali. In questo senso, si trova dunque messa a frutto l’esperienza lungamente maturata dai singoli ordinamenti di alcuni stati membri, quali, in particolare, la Svezia o la Germania. Per un’articolata riflessione sul modello europeo della privacy, attraverso l’esame dei testi costituzionali, della legislazione ordinaria e dei case studies della giurisprudenza, si rimanda a: U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa. Modelli giuridici a confronto, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 109-155. 214 Particolarmente interessanti, nella raffigurazione della sensibilità americana in materia di privacy e nella descrizione dei caratteri e delle ragioni di un’impostazione tendenzialmente proprietaria, i contributi di L. LESSIG, Privacy as property, in Social Research, 2002, 69, p. 247-269; J. LITMAN, Information Privacy/ Information Property, in Stanford Law Review, vol. 52(5), 2000, pp. 1283-1313; P. SAMUELSON, Privacy as Intellectual Property, in Stanford Law Review, vol. 52, 2000, pp. 1125-73; C. PRINS, Property and Privacy: European Perspectives and the Commodification of our Identity, in L. GUIBAULT, P. B. HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, The Hague, Kluwer Law International, 2006, p. 223-257. In particolare, per un esauriente quadro comparativo in tema di privacy, tra sistema federale statunitense e disciplina comunitaria, dove l’indagine sui due modelli muove dal confronto critico tra l’approccio settoriale americano e la vocazione generale europea, si rimanda, ancora, a: U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., pp. 61-107.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
111
avviate procedure d’infrazione per inesatta o mancata attuazione della direttiva215,
e che la maggioranza di tali stati abbia ritenuto il progetto di consultazione
pubblica finalizzato alla revisione della direttiva, avviato nel 2008 e conclusosi
nella primavera del 2009, troppo prematuro, propendendo per l’idea di concedere
maggiore spazio alla fase di prima implementazione e sperimentazione.
In particolare, oggetto di scrutinio nel processo di revisione della direttiva sono
stati i settori dell’informazione geografica, meteorologica e legale, ossia campi nei
quali - per la natura stessa delle materie - un’interferenza con la disciplina dei dati
personali è, allo stato, poco probabile216. Piuttosto, è altamente possibile (oltre
che, in certa misura, auspicabile) che la progressiva implementazione della
direttiva sul riutilizzo della PSI nei vari ordinamenti nazionali finirà per stimolare
il dibattito sulle questioni connesse alla tutela della privacy dei cittadini,
sollevando nuove diatribe: si tratterà, in primis, di questioni relative alla necessità
di promuovere le iniziative economiche legate al riuso della PSI senza che da ciò
derivi detrimento alcuno alla tutela dei dati personali, sia attraverso strumenti
giuridici, quali le licenze di riutilizzo, sia mediante supporti tecnologici, quali
software capaci di rilasciare porzioni di PSI riutilizzabile una volta filtrati, e
sottratti alla diffusione, i dati personali oggetto di tutela.
215 Tutti gli Stati membri hanno attuato la direttiva, ma solo quattro hanno rispettato il termine del 1° luglio 2005. La Commissione ha avviato 18 procedimenti di infrazione nei confronti di vari Stati membri: nello specifico, la mancata notifica dell'attuazione ha riguardato inizialmente Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Ungheria, mentre la non conformità delle misure nazionali di attuazione con la direttiva riguarda attualmente Italia, Polonia e Svezia. Inoltre la Corte di giustizia europea ha emesso 4 sentenze per mancata attuazione, nei confronti di Austria, Belgio, Spagna e Lussemburgo. V. COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Riutilizzo dell’Informazione del Settore pubblico, Riesame della Direttiva 2003/98/CE, Bruxelles, 7 maggio 2009, COM (2009) 212 definitivo. 216 Le conclusioni del documento che ha ad oggetto il riesame della direttiva poggiano, a loro volta, sulle risultanze dello studio Micus, pubblicato nell’anno 2009, cui si è fatto riferimento in apertura del primo capitolo. V. MICUS Management Consulting GmbH, Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information Sectors, 2009. In ogni caso, l’idea che il riutilizzo della PSI non ponga questioni di diretto rilievo rispetto alla normativa sulla privacy, avendo ad oggetto dati che - specie nelle categorie di PSI la cui rielaborazione sia più remunerativa (in primis, dati geografici e meteorologici) - tendenzialmente non contengono informazioni personali, è un’idea presente sin dalle prime iniziative promosse in ambito europeo con l’obiettivo di valorizzare la PSI. Si rimanda al report operativo del terzo studio Publaw (1995), che conclude con la seguente osservazione: “The question of personal data protection does not seem to pose major problems with regard to marketing of public data, as the marketable information is not generally personal”; v. PSI (Policy Studies Institute) and CRID (Centre de Recherches Informatique et Droit), Final Report, London, 1995.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
112
Nonostante la questione del bilanciamento tra privacy e riutilizzo - commerciale o
non commerciale - della PSI rappresenti un ambito relativamente nuovo, ciò
nondimeno sono individuabili alcuni progetti condotti in ambito europeo che
spiccano per la sensibilità dedicata al tema: si distingue, tra questi, il progetto
Aporta217, promosso dal Governo spagnolo, che si avvale di una piattaforma
multimediale tra più ricche di quelle cui ha dato ispirazione la direttiva
2003/98/CE e che è giunto, nel maggio 2009, alla pubblicazione di una completa
guida interattiva al riutilizzo dell’informazione pubblica.
In particolare, la Guía Aporta contiene un’apposita sezione (Información excluida
por intereses de terceros: Información que contenga datos de carácter personal)
in cui si trovano riportate le raccomandazioni avanzate nel 2008 dalle Agenzie per
la protezione dei dati personali della Comunità di Madrid218 e della Catalunya219
(che saranno più avanti oggetto d’esame, attraverso un’analisi in parallelo con le
corrispondenti disposizioni del Codice italiano della privacy) relativamente al
trattamento di dati personali mediante strumenti informatici, nel contesto di
iniziative di riutilizzo della PSI220.
217 La piattaforma informativa del progetto è accessibile all’indirizzo: www.aporta.es. 218 http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=APDCM/Page/homeAPDCM 219 http://www.apdcat.net/ 220 In un passo della menzionata sezione si legge: “El acceso a la información que contenga datos personales se limita, en general, a sus titulares que podrán además ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la legislación de protección de datos personales. […] Más allá de la regulación general, existen algunas normas que regulan el acceso a determinado tipo de información: 1. Información que contenga datos personales referentes a la intimidad. El acceso a la información que contengan datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado a éstas, existiendo la posibilidad de ejercer un control sobre la misma y pudiendo exigir su rectificación en caso de que los datos sean inexactos o estén incompletos. 2. Información de carácter nominativo. […] A este tipo de información pueden acceder no sólo los afectados, sino quienes acrediten un interés legítimo y directo, siempre que no se trate de procedimientos sancionadores o disciplinarios o que prevalezcan otros intereses de más digna protección. 3. Información que contengan otros datos personales. Diferentes normas establecen regímenes específicos respecto al acceso a datos personales. […]“Entre otros se pueden traer a colación: - Datos sanitarios: se establece la remisión a las disposiciones específicas que regulan el acceso a la información y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes que limitan el acceso a la información a ellos; -Datos electorales: para los archivos regulados por la legislación del régimen electoral se establece un régimen de prohibición de acceso a datos personales contenidos en el censo electoral, a excepción de los solicitados por vía sudicia; - Archivos estadísticos: se refiere a aquellos archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública que están protegidos por el secreto estadístico y cuya difusión regula la legislación sobre la función pública estadística”. V. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Guía Aporta sobre reutilización de la información del sector público, Madrid, Mayo 2009, www.aporta.es.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
113
E’ evidente che muovendo dal principio di inderogabilità della normativa sulla
privacy, ribadita dalla direttiva 2003/98/CE, l’analisi della relazione tra riutilizzo
della PSI e tutela delle informazioni a carattere personale dovrà prendere in
considerazione tanto le esigenze e gli interessi delle amministrazioni che
detengono i dati oggetto di riutilizzo, quanto i corrispettivi interessi dei cittadini,
soprattutto quando si abbia a che fare con dati c.d. sensibili.
Nella strutturazione della menzionata analisi, dunque, si è ritenuto opportuno far
precedere, all’esame del rapporto tra interesse al riutilizzo della PSI e diritto alla
tutela dei dati personali, una breve riflessione di ordine filosofico circa la natura
dell’istituto della privacy, volta a cogliere la molteplicità di elementi che ne
caratterizzano l’essenza e, dunque, a tracciarne il rapporto dialettico con altri
fondamentali istituti degli ordinamenti democratici. Tale panoramica è seguita da
una sintetica illustrazione della questione del bilanciamento tra diritto d’accesso
all’informazione pubblica e diritto alla privacy, la cui relazione si arricchisce di
significato ulteriore - nella prospettiva della materia in oggetto - qualora si
consideri che proprio la dimensione dell’accessibilità della PSI costituisce il filtro
primo rispetto ad ogni ipotesi di riutilizzo della stessa221.
Dette considerazioni introducono, quindi, il tema della tutela della privacy nelle
iniziative di riutilizzo della PSI, tema che sarà affrontato, in primo luogo,
attraverso l’esame dei pareri di alcune autorità garanti europee (supportato dal
riferimento alle disposizioni fondamentali del Codice della privacy) e, infine,
mediante la disamina di tre significativi casi di riutilizzo commerciale di dati
personali contenuti in registri pubblici, tratti, il primo, dall’esperienza italiana, e
gli ultimi due dal contesto, rispettivamente, statunitense e britannico.
221 Pare non potersi prescindere, ancora una volta, dalla duplice prospettiva dell’accesso all’informazione pubblica e del riutilizzo della stessa, così come delineato dalla direttiva 2003/98/CE, la quale - lo si è ricordato in più occasioni – si basa, senza recare loro pregiudizio, sui regimi domestici di accesso esistenti nei vari Stati membri. Cfr. art. 1, c. 3 della direttiva sul riutilizzo, che dopo aver fatto salve le normative nazionali in materia d’accesso, specifica: “La presente direttiva non si applica nei casi in cui i cittadini o le imprese devono dimostrare, in virtù del regime di accesso, di avere un particolare interesse all'ottenimento dell'accesso ai documenti”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
114
4.2. Le filosofie della privacy
Si è fatto poc’anzi riferimento all’idea che il riutilizzo della Public Sector
Information non ponga questioni di diretto rilievo rispetto alla normativa sulla
privacy - avendo il più delle volte ad oggetto dati che tendenzialmente non
contengono riferimenti personali. Del pari, si è fatto cenno alla tesi che la direttiva
sul riutilizzo della PSI si limiti a rimandare alla normativa sulla protezione dei dati
personali, quale delineata nella direttiva 46/95/CE, senza aggiungere ulteriori
specificazioni sulla nozione di privacy ad essa sottesa. Sicché appare opportuna
una breve riflessione sull’essenza dell’istituto, la cui centralità tende ad essere
ricondotta a radicali motivazione di tipo filosofico222.
Obiettivo della breve panoramica che segue, nella quale lo spettro d’indagine è
centrato sul quadro offerto dal vivace dibattito anglo-americano degli ultimi anni -
a partire dall’analisi effettuata da Ugo Pagallo dello studio di Herman T. Tavani223
- è essenzialmente quello di illustrare alcuni dei caratteri più significativi di una
nozione tanto complessa, e ricca di sfaccettature, quanto quella della privacy,
specie nella configurazione attuale dell’istituto. Benché, infatti, la nozione sia per
lo più ricondotta, al giorno d’oggi, alla tutela dei dati personali (con una certa
tendenza della dottrina, specie italiana, a far coincidere in alcuni casi la
prospettiva della tutela della privacy con quella della sola tutela della riservatezza)
la privacy - come si vedrà – non si identifica con la riservatezza delle persone, ma
appare, all’inizio del secolo XXI, nella pregnanza dei suoi molteplici significati,
come uno dei nuclei del dibattito giuridico, politico e filosofico contemporaneo.
Si muoverà, come accennato, dallo sforzo sinottico di Tavani, che suggerisce
innanzitutto di dividere il panorama filosofico contemporaneo in tema di privacy
in quattro gruppi, riconducibili ad altrettante teorie, le quali, al fine di definire
222 Rodotà definisce la privacy come “un elemento fondamentale della “società dell’eguaglianza” […] una condizione essenziale per essere inclusi nella “società della partecipazione” […] uno strumento necessario per salvaguardare la “società della libertà” […] una componente ineliminabile della “società della dignità”. S. RODOTA’, Intervista su privacy e libertà, Laterza, Roma-Bari, 2005, p. 149. 223 U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., pp. 37-43.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
115
l’”essenza” della privacy, rispettivamente richiamano le nozioni di “non
intrusione”, “esclusione”, “limitazione” e “controllo”224.
In relazione alla prima teoria, Tavani richiama la definizione di Warren e Brandeis
come diritto a non essere disturbati, vale a dire come right to be let alone225.
Questa prima teoria, però, incorrendo nell’equiparazione tra privacy e libertà,
rischia di non cogliere il fatto che la privacy è ciò che rende possibile l’esercizio
di una certa libertà, senza tuttavia coincidere con la libertà medesima o con la
condizione, o contenuto, con cui di volta in volta l’istituto sarà identificato.
La seconda definizione di privacy, invece, ruota attorno alla nozione di esclusione,
ossia all’idea della persona che, “divenuta completamente inaccessibile agli
altri”226, eserciti il proprio diritto di vivere appartata ed in tranquillità. Ma, come
osservato da Pagallo, anche la tesi dell’”esclusione” finisce per imbattersi in una
difficoltà non superabile: ”anche lo“stato di solitudine” al quale si è rifatto a suo
tempo Alan F. Westin, presta il fianco all’obiezione che ci sono in fondo molti
casi in cui disponiamo di privacy, pur non essendo affatto soli”227.
Altri autori, ancora, hanno posto l’accento, anziché sull’elemento della libertà o
della solitudine delle persone, su quello dell’informazione, elaborando una
definizione di privacy tale per cui essa corrisponde all’”area” in cui l’accesso
all’informazione si trova limitato228. Eppure, muovendo dal rilievo che soltanto
chi ha privacy può effettivamente scegliere di condividere con altri una certa
informazione - nello stesso momento in cui, per converso, decide di escluderne
altri - pare potersi rimproverare a questa terza definizione l’ulteriore difetto di
identificare privacy e segretezza, mancando di attribuire adeguato peso
224 Cfr. H. TAVANI, Philosophical Theories of Privacy: Implications for an Adequate Online Privacy Policy, in “Metaphilosophy”, 2007, p. 4, che riconosce comunque la possibilità di suddivisioni ulteriori o differenti. 225 V. S. WARREN, L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, 1890, vol. V, n. 5, p. 50; tale articolo, ormai classico, deve essere considerato come il punto d’inizio della riflessione giuridica moderna sull’istituto. L’idea è stata poi riproposta in un caso del 1972 da un altro giudice della Corte suprema, William Brennan, secondo il quale la privacy consisterebbe “nel diritto dell’individuo di essere libero da intrusioni pubbliche [government] non autorizzate”. 226 R. GAVISON, Privacy and the Limits of the Law, in Yale Law Journal, 1980, 89, p. 428. 227 U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., p. 41. 228 Secondo Allen “La privacy perfetta si avrebbe quando nessuno ha informazioni su un soggetto determinato”. Il riferimento è, in particolare, a A. ALLEN, Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society, Rowman and Littlefield, Totowa, N. J., 1988, p. 269; R. GAVISON, Privacy and the limits of the Law, in Yale Law Journal, 1980, 89, pp. 421-471; W. A. PARENT, Privacy, Morality and the Law, in Philosophy and Public Affairs, 1983, 12, 4, pp. 269-288.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
116
all’elemento del controllo e dunque delle scelte individuali nell’esercizio della
privacy.
Di tali elementi si trovano invece permeate le teorie di Charles Fried, secondo il
quale la privacy “non è la semplice assenza di informazione su di noi da parte di
altri, ma piuttosto è il controllo sull’informazione che abbiamo su noi stessi”229.
Osserva Pagallo che “rimanendo ancora poco chiaro il tipo di informazione che
uno ritiene debba rimanere sotto il proprio controllo e che tipo di controllo uno
spera di poter esercitare, questa (quarta) teoria sembra tuttavia incorrere
nell’errore uguale e contrario dell’idea di privacy come limitazione. Infatti,
confondendo privacy e autonomia, si giunge anche ad affermare, in coerenza con
i propri assunti, che pure a svelare volontariamente ogni singolo bit informativo
della propria vita a tutti, non per questo avremmo perso la nostra privacy”230.
Da analoghi rilievi prende le mosse la teoria “unificata” di Tavani, che ha
proposto di integrare il principio della scelta personale con la teoria della
“limitazione” poc’anzi richiamata. Secondo tale impostazione, la privacy è intesa
come protezione rispetto a una data situazione, per la quale risulta possibile
modulare il controllo attraverso il consenso, la scelta e la revoca dell’interessato.
Tuttavia, nella prospettiva dell’indagine filosofica, anche la teoria “unificata” di
Tavani manca di sciogliere un nodo di primaria importanza: vale a dire se la
privacy abbia un valore puramente strumentale o piuttosto lo status di diritto
autonomo, sia pure riconducibile ad un fascio di diritti di rango costituzionale.
Nell’indagine sviluppata da Pagallo, il punto è oggetto di approfondita analisi
attraverso il quadro offerto dalla filosofia dell’informazione di Luciano Floridi,
che, rispetto ai punti oscuri lasciati in sospeso dalle tesi di Tavani, fornisce un
solido fondamento ontologico alla raffigurazione della privacy come diritto
fondamentale e inalienabile della persona umana. Compatibilmente alla sensibilità
della filosofia digitale, infatti, Floridi muove dall’idea che il mondo debba essere
rappresentato come “informazione”: in questa prospettiva, infine, la privacy
verrebbe a configurarsi “come “immunità” da cambiamenti sconosciuti,
indesiderati o inintenzionali dell’entità personale come entità informativa, in
229 C. FRIED, Privacy: A Rational Context, in M. D. ERMANN, M. B. WILLIAMS, C. GUTIERREZ (a cura di), Computers, Ethics and Society, Oxford University Press, New York, 1990, p. 54. 230 U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., p. 42.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
117
quanto ogni forma di aggressione nei confronti della privacy non è che
un’indebita alterazione della natura informativa delle persone, della loro
dignità”231.
Il significato più autentico della riflessione filosofica fin qui sviluppata, nonché
l’utilità pratica della stessa ai fini di un approccio critico al tema trattato, si
paleseranno in ogni caso nei paragrafi a seguire (in particolare, 4.5.1. e 4.5.2.),
laddove la dialettica tra le molteplici dimensioni (e teorie) della privacy - con
un’attenzione particolare all’elemento del controllo - tornerà ad emergere, forte, in
relazione alle ipotesi di riutilizzo per finalità commerciali (e, in un caso, criminali)
dei dati personali contenuti in registri pubblici.
4.3. Accesso documentale e tutela della privacy: la soluzione
legislativa al potenziale conflitto.
Il Codice della privacy si apre con l’enunciazione di un principio generale,
proclamato in modo icastico e chiaro all’art. 1: “Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano”. Tale disposizione, dunque,
introduce nell’ordinamento uno specifico diritto alla protezione dei dati personali
come diritto della persona fondamentale ed autonomo rispetto al generale diritto
alla riservatezza già richiamato all’art. 1 della legge n. 675/1996232. Il diritto alla
protezione dei dati tiene conto, infatti, delle molteplici prerogative legate al
231 La declinazione del concetto di privacy in chiave informativa propone, a partire dalla riflessione fin qui sviluppata, tre questioni ulteriori. Rispetto ai Four Challenges for a Theory of Informational Privacy di Floridi, appaiono particolarmente significativi l’approccio “negazionista”, che riconduce la privacy ad un principio informativo a carattere ancora più fondamentale; l’idea “relativista”, che contesta l’approccio ontologico della filosofia dell’informazione, in virtù del multiculturalismo contemporaneo; infine la questione della “negoziabilità pratica” della privacy come diritto fondamentale. L’analisi delle prospettive qui menzionate si trova in U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa, cit., p. 44-53. 232 Sull’evoluzione del concetto di privacy nell’ordinamento italiano, cfr. R. PARDOLESI, Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali: una storia di evoluzione e discontinuità, in ID. (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 2003, vol. I. Analoghi argomenti di riflessione appaiono in: A. MANTELERO, Il costo della privacy tra valore della persona e ragione d’impresa, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 7-80.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
118
trattamento dei dati personali, anche al di là dei fenomeni e degli assetti collegati
al riserbo e alla privacy della vita privata233.
In particolare, il diritto esplicitato dall’art. 1 del Codice della privacy acquisisce
un rilievo significativo rispetto ai meccanismi di accesso all’informazione
pubblica e solleva questioni giuridiche in merito al suo bilanciamento col regime
di accesso documentale (quale configurato, in particolare, nella l. 241/90), che -
come più volte ricordato – è fatto salvo per intero dalla normativa sul riutilizzo
della PSI e che individua, nell’informazione generalmente accessibile secondo il
regime ordinario di accesso, l’informazione suscettibile di riutilizzo.
Tra le esigenze che rappresentano un filtro oggettivo all’accessibilità
documentale, la tutela della privacy è, infatti, proprio a causa del potenziale
antagonismo con il diritto di accesso, quella che solleva gli interrogativi più
complessi, a maggior ragione a seguito del rapidissimo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione234.
Situazioni di possibile conflitto tra diritto di accesso ed esigenze di protezione dei
dati personali vengono a configurarsi, in particolare, sul punto della tutela
attribuita dalla legislazione sulla privacy ai dati personali nell’ambito delle
diciassette categorie di trattamento previste (art. 4, comma 1, lett. (a), Codice
privacy), tra cui figurano anche le attività cui il diritto di accesso è tipicamente
finalizzato, quali, innanzitutto, la “consultazione”, la “comunicazione”, nonchè la
“diffusione”.
Il problema, poi, risulta particolarmente complesso rispetto alla categoria dei “dati
sensibili” che, a differenza della categoria generale dei “dati personali” trattati
233 Sulla spinta del diritto comunitario, il d. lgs. 196/2003, enfatizzando il carattere aperto della fattispecie di cui all’art. 2 della Costituzione, ha stabilito il “diritto alla protezione dei dati personali” (art. 1) nell’ambito del trattamento dei medesimi, garantendo che lo stesso si svolga “nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (art. 2). Inoltre l’insieme di regole e principi fissati dal Codice del 2003 ha consentito l’affermazione del diritto alla “autodeterminazione informativa” intesa come governo delle informazioni e del flusso dei dati personali. Così S. RODOTA’, Discorso del 9 febbraio 2005 (presentazione della Relazione 2004 del Garante per la protezione dei dati personali), in www.garanteprivacy.it. Si rimanda a A.A. V.V., (V. ITALIA coordinatore), Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 196/2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative, vol. I, Giuffrè Editore, 2004; cfr anche G. P. CIRILLO, (a cura di), Il codice sulla protezione dei dati personali, Milano, 2004. 234 V. il paragrafo “La morte della privacy e i suoi profeti”, in PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa, cit., pp. 208-210, che riprende la celebre dichiarazione di Scott McNealy, capo della Sun Microsystems, secondo il quale con l’avvento delle nuove tecnologie avremmo semplicemente già perso la nostra privacy: “You have zero privacy now. Get over it!”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
119
dall’amministrazione, costituisce il vero e proprio “nocciolo duro” della
personalità dei singoli235.
La soluzione avanzata dal legislatore del 2003 e del 2005 al potenziale conflitto
tra accesso all’informazione e tutela della privacy è stata individuata
nell’affinamento delle modalità di coordinamento tra i complessi normativi
afferenti all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (legge
241/1990) e alla tutela della privacy (d. lgs. 196/2003) e nell’attribuzione alla p.a.
del delicato ruolo di “giudice preliminare” di tale conflitto236.
Nell’ottica di assicurare un contemperamento tra l’interesse all’accesso del
richiedente e quello alla tutela della riservatezza dei terzi, la scelta del legislatore
si è concentrata sulla tipologia di dati contenuti nel documento di cui si chiede
l’accesso (art. 24, legge 241/90), distinguendo tra:
a) “dati personali” c.d. “comuni”, laddove ha prevalenza l’accesso se la
conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri
interessi giuridici (art. 24, comma 7, c.d. “accesso difensivo”). In questa
ipotesi, la valutazione da parte dell’amministrazione è incentrata
esclusivamente sulla posizione del soggetto che intende accedere e non
235 Per “dato personale” si intende “qualunque informazione relativa a persona fisica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”; per “dati sensibili”, invece, i “dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 4, comma 1, rispettivamente lett. b) e lett. d), d. lgs. 196/2003). Tali ultime due sotto-tipologie di dati hanno un regime giuridico ad hoc e perciò sono altresì definiti, dalla dottrina italiana, “dati super-sensibili”. 236 Il rapporto tra legge 241/90 e normativa a tutela della privacy è stato chiarito dall’art. 59 del Codice della privacy, che ha salvaguardato le regole sull’accesso ai documenti amministrativi ex legge 241/90 e s.m.i., considerando quest’ultima normativa “di rilevante interesse pubblico” ai fini del d.lgs. 196/2003 ed introducendo criteri ulteriori (“pari rango” e “stretta indispensabilità”: art. 24, comma 7, legge 241/1990 e s.m.i.) in caso di richiesta di accesso documentale che coinvolga dati sensibili di terzi. In particolare, la legge 15/2005, preso atto della insufficienza di una soluzione astratta che avrebbe garantito la massimizzazione di uno soltanto dei principi in gioco, con la marginalizzazione dell’interesse risultato soccombente, ha previsto un regime giuridico differenziato a seconda dei dati oggetto dell’istanza di accesso. Occorre, infatti, distinguere preliminarmente tra richiesta di accesso che abbia ad oggetto i dati personali dell’istante, alla quale si applica l’art. 7 del Codice privacy, e richiesta che, invece, riguardi i documenti amministrativi. L’accesso ai dati personali del richiedente si differenzia dall’accesso ai documenti contenenti dati di terzi non solo per l’oggetto della richiesta, ma anche in quanto la motivazione che dia conto della legittimazione all’accesso e degli altri requisiti ex lege è richiesta solo nella seconda ipotesi; inoltre, nel primo caso, il Codice della privacy impone la collaborazione del soggetto detentore dei dati e destinatario della richiesta, il quale risulta obbligato a ricercare i dati e a rielaborare gli stessi, mentre nel secondo caso non è imposto alle amministrazioni alcun obbligo positivo, avendo l’accesso ad oggetto i documenti amministrativi così come materialmente si presentano.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
120
richiede alcuna comparazione tra opposti interessi; di conseguenza, la p.a.
risulta vincolata all’accoglimento o al rigetto della domanda in caso di
presenza o assenza del requisito dell’interesse difensivo predeterminato ex
lege;
b) “dati sensibili e giudiziari”, laddove il diritto d’accesso prevale solo se
risulti “strettamente indispensabile”, ciò che impone di esplicitare nella
motivazione della richiesta le ragioni che sono alla base di tale requisito,
lasciando alla p.a. destinataria della richiesta ampi margini di
discrezionalità nella valutazione della sua integrazione in relazione alle
finalità di tutela (art. 24, comma 7), fermo restando l’obbligo di
motivazione della scelta in capo alla p.a. destinataria della richiesta (art. 3,
legge 241/90);
c) “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” (c.d. dati “super-
sensibili”), laddove l’accesso prevale solo se “strettamente indispensabile”
e ove sia volto a tutelare diritti “di rango almeno pari” rispetto a quello
fondamentale alla riservatezza (art. 24, comma 7, che richiama
espressamente l’art. 60 del Codice privacy);
d) “informazioni di carattere psico-attitudinale nei procedimenti selettivi”,
laddove -unico caso- l’accesso è escluso tout court dal legislatore, che
qualifica tali dati come inaccessibili (art. 24, comma 1, lett. (d) ).
e) Ne deriva che il punto di equilibrio individuato dalla normativa vede la
privacy come limite “relativo” al diritto di accesso237, in quanto non è
sancito un divieto “assoluto” di consentire l’accesso a documenti
contenenti dati personali di terzi, ma “soltanto l’obbligo di comunicare gli
stessi alle condizioni previste da leggi e regolamenti, secondo quanto
previsto dalle regole sul trattamento dei dati personali contenute nel
Codice della privacy”238.
237 La configurazione della privacy come limite esterno in via regolamentare rispetto al diritto di accesso (art. 24, comma 6, lett. d, legge 241/90) appare scarsamente compatibile con la sua natura di diritto fondamentale, la cui tutela -almeno generale- dovrebbe essere assicurata in via legislativa.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
121
4.4. Il riutilizzo della Public Sector Information e la tutela della
privacy
4.4.1. L’implementazione della direttiva 2003/98/CE e la tutela della privacy
Nel provvedimento del 27 ottobre 2005, esaminato per i profili di competenza lo
schema di decreto attuativo della direttiva 2003/98/CE, diramato pochi giorni
prima dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Garante ha constatato con
favore che il decreto intende fare salva la disciplina sulla protezione dei dati
personali contenuti nei documenti pubblici da riutilizzarsi, conformemente a
quanto previsto dal diritto comunitario239.
In tema di riutilizzazione dei dati personali contenuti in ambito pubblico
(intendendosi per “dati pubblici” solo quelli conoscibili da chiunque240) sono
previste, secondo quanto ricorda il Garante, alcune garanzie in via di
specificazione ai sensi dell’art. 61 del Codice in materia di protezione dei dati
personali. Queste garanzie devono tenere conto delle cautele previste dalla
Raccomandazione n. R (91) 10 del Consiglio d’Europa, per quanto riguarda, in
particolare:
a) i casi e le modalità di riutilizzazione dei dati provenienti da soggetti
pubblici, riuso che può avere luogo solo in termini compatibili con gli
scopi per i quali i dati sono stati in precedenza utilizzati, anche quando il
riutilizzatore non persegue una finalità commerciale;
b) l’informazione da fornire ai cittadini sulle possibilità e modalità di tale
riutilizzo;
c) gli accorgimenti specifici relativi ad interrogazioni di massa di banche
dati, interconnessioni ed associazioni di dati provenienti da più archivi;
238 Cfr. G. ARENA e M. BOMBARDELLI, Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, p. 427. 239 Cfr. considerando 21 della direttiva 2003/98/CE: “La presente direttiva dovrebbe essere attuata ed applicata nel pieno rispetto dei principi relativi alla protezione dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 240 Cfr. d.lgs. 36/2006, di attuazione della direttiva 2003/98/CE, art. 2, comma 1, lett. d).

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
122
d) l’eventuale trasferimento all’estero dei dati.
Il provvedimento del Garante ha specificato, inoltre, che la clausola di salvezza
della disciplina sulla protezione dei dati personali, prevista in termini generali,
avrà effetto nei riguardi di tutti i trattamenti di dati personali, sia di quelli
effettuati dalle amministrazioni pubbliche “titolari” dei dati, che permetteranno il
loro riutilizzo, sia di quelli svolti dai terzi che riutilizzeranno i dati medesimi.
Il documento emesso dal Garante ha menzionato espressamente, tra le condizioni
e limitazioni imposte mediante gli schemi di licenze standard per il riuso dei dati,
l’obbligo del riutilizzatore di rispettare la disciplina sulla protezione dei dati
personali, ivi compreso il codice di deontologia e di buona condotta di cui all’art.
61 del Codice. L’art. 8, comma 2, del d. lgs. 36/2006 recita infatti: “Le condizioni
e le limitazioni poste dal titolare del dato negli schemi di licenze standard sono
individuate per categorie di documenti secondo criteri di proporzionalità e nel
rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e non possono
costituire ostacolo alla concorrenza”.
Il Garante, quindi, ha ravvisato la necessità di un’ulteriore precisazione a
proposito della pubblicità dei dati: tra le norme fatte espressamente salve dall’art.
4 del d. lgs. 36/2006241, andrebbero particolarmente tutelate, “con una clausola
generale, le norme speciali che (sebbene in relazione a dati pubblici conoscibili
da chiunque) fissano in ogni caso alcune regole da osservare per la loro concreta
conoscibilità e pubblicità”242.
Infine, premesso quanto fin qui esposto, il Garante ha espresso parere favorevole
circa lo schema di decreto legislativo sul riutilizzo dell’informazione nel settore
241 L’art. 4 del d. lgs. 36/2006 dispone che siano fatte salve: ”a) la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) la disciplina sulla protezione del diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo si applicano compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, del 1886, ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, e l'Accordo TRIPS sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, del 1994, ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747; c) la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) le disposizioni in materia di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecarie, anche con riferimento all'articolo 1, commi da 367 a 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e) le disposizioni in materia di proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; f) la disciplina sul Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' la disposizione sull'accesso ai dati individuali di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 681”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
123
pubblico, in virtù, in particolare, delle ipotesi di integrazione dei menzionati art. 4
e 8 nel medesimo schema.
4.4.2. Il riutilizzo della PSI e i principi generali del trattamento dei dati personali
Come anticipato in apertura del presente capitolo, uno dei più apprezzabili
progetti europei in materia di politiche di sostegno al riutilizzo della PSI è
rappresentato dal Proyecto Aporta - patrocinato dal governo spagnolo e
concretizzatosi in una piattaforma multimediale ricchissima di contenuti - che, nel
giugno del 2009, ha pubblicato una delle più complete guide al riutilizzo
dell’informazione pubblica, rivolta a privati ed imprese, la “Guía Aporta”. Una
delle peculiarità della Guía Aporta, nel suo assetto efficacemente divulgativo, è
rappresentato dall’attenzione riservata allo specifico tema della tutela dei dati
personali nelle iniziative di riutilizzo che coinvolgono l’informazione di fonte
pubblica: la guida contiene infatti un’apposita sezione (Información excluida por
intereses de terceros: Información que contenga datos de carácter personal) in
cui si trovano menzionate le raccomandazioni avanzate dalle Agenzie per la
protezione dei dati personali della Comunità di Madrid243 e della Catalunya244 in
relazione al trattamento di dati personali attraverso strumenti informatici,
raccomandazioni poi ribadite in forma sintetica in calce alla guida nel “Anexo 1:
Recomendaciones sobre protección de datos”. In particolare, l’esame dei
menzionati documenti, in sé interessante ai fini dell’analisi in oggetto, acquista
ulteriore rilievo nell’ottica di un raccordo alle disposizioni del Codice della
privacy (d. lgs. 196/2003), stante il forte coordinamento comunitario in materia di
protezione dei dati personali.
Entrambe le raccomandazioni, infatti, si articolano in una serie di punti, a partire
dai quali sono enucleabili i principi fondamentali della normativa a tutela della
privacy. Tali punti riguardano, in particolare, il principio di riduzione dei dati
personali oggetto di trattamento; i principi generali applicabili a tutti i trattamenti
di dati personali; i diritti dell’interessato; i casi in cui l’interessato può opporsi al
trattamento. Procediamo dunque all’esame in dettaglio dei suddetti elementi:
242 Cfr. art. 24, comma 1, lett. c) del Codice della privacy. 243 http://www.madrid.org/cs/Satellite?pagename=APDCM/Page/homeAPDCM

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
124
- Quanto al principio della riduzione dei dati personali ed identificativi,
attraverso procedure di anonimizzazione, la raccomandazione 2/2008, del
25 aprile, dell’Agenzia madrilena per la protezione dei dati personali,
circa la pubblicazione di dati personali in gazzette e giornali ufficiali in
Internet, su siti web istituzionali e su altri mezzi elettronici e telematici
afferma: “Se disociará la información de carácter personal, de modo que
la información que se obtenga no pueda asociarse a personas
identificadas o identificables”. Una previsione analoga è ribadita nello
schema sintetico in calce alla Guia Aporta dalla Recomendación 1/2008
dell’Agenzia catalana per la protezione dei dati personali, rispetto alle
ipotesi di diffusione di informazioni contenenti dati personali attraverso
Internet: “Evitar difundir datos personales sobre infracciones, sanciones
o resoluciones judiciales sin anonimizar, salvo que una ley prevea lo
contrario”. Il principio espresso dalle raccomandazioni è quello che
troviamo codificato nell’art. 3 del d.lgs. 196/2003, che contiene una
regola generale rivolta alla “riduzione al minimo” dell’utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi (c.d. principio di necessità nel
trattamento dei dati) 245. La regola, anzi, è ancora più recisa, nel senso
che il trattamento dovrebbe essere escluso allorché le finalità possano
essere realizzate senza il trattamento di dati personali e di dati
identificativi, e quindi o mediante dati anonimi o mediante determinate
modalità che consentono di identificare l’interessato soltanto in casi
eccezionali, qui indicati come “casi di necessità”. In sostanza, benché
non venga espressa in questi termini, la regola generale è che per una
compiuta tutela dei dati personali non vi dovrebbe essere trattamento,
poiché ogni trattamento di per sé comporta un’intrusione nella vita
privata, per cui tale trattamento deve essere ridotto al minimo, o escluso
quando sia possibile l’utilizzazione di dati anonimi, ed è, in ogni caso,
244 http://www.apdcat.net/ 245 L’art. 3 del d. lgs. 196/2003 prevede infatti: “I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
125
ammesso soltanto in casi di necessità246. L’art. 3, in conclusione, contiene
una presunzione della violazione della sfera della privacy attraverso ogni
forma di utilizzazione dei dati personali ed identificativi: proprio da ciò
deriva, dunque, il principio di riduzione del trattamento sia dei dati
personali sia dei dati identificativi.
- Per quanto attiene, invece, ai principi generali applicabili a tutti i
trattamenti di dati personali, la Raccomandazione 1/2008 dell’Agenzia
catalana fissa quattro linee guida in rapporto ad altrettanti ambiti:
“Difundir la información que contenga datos personales cuando exista el
consentimiento previo del interesado o bien cuando lo autorice una
norma con rango de ley” (Legitimidad de la publicación); “No difundir
más datos personales que los necesarios para alcanzar la finalidad de la
difusión” (Proporcionalidad de la información); “Velar para que los
datos difundidos sean correctos y actualizados” (Exactitud y
actualización de los datos difundidos); “Ajustar el periodo de difusión al
cumplimiento de la finalidad que la justifica” (Limitación temporal de la
difusión)247. Previsioni di tenore analogo sono rintracciabili nell’art. 11
del Codice della privacy, che, in ordine alle modalità del trattamento e
requisiti dei dati, prescrive che i dati personali oggetto di trattamento
debbano essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi: dunque
il trattamento dei dati deve essere motivato dalla necessità per il
titolare di realizzare finalità chiare, determinate a monte, esplicite e
legittime;
c) utilizzati in altre operazioni del trattamento, cioè collaterali al
trattamento per cui sono raccolti ed utilizzati, in termini compatibili
con tali scopi: ciò significa che eventuali, diverse operazioni di
trattamento connesse che si rivelino necessarie, e per le quali
246 A.A. V.V., (V. ITALIA coordinatore), Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 196/2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative, cit., pp. 123-133. 247 La raccomandazione 2/2008 dell’agenzia madrilena contiene previsioni analoghe: “Los documentos con datos personales especialmente protegídos, como los relativos a la salud, a la comisión de infracciones penales o administrativas, etc., contendrán los datos mínimos e indispensables para cumplir con la finalidad perseguida”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
126
l’interessato potrebbe non essere stato informato, dovranno comunque
basarsi su finalità lecite, esplicite, legittime, correlate e compatibili
con quelle del trattamento principale;
d) esatti, cioè rispondenti all’identità o al profilo dell’interessato e, se
necessario, aggiornati;
e) pertinenti, ossia ci deve essere un chiaro rapporto di causalità tra i dati
raccolti e le finalità del trattamento perseguite; completi, in modo da
non dar luogo ad una eventuale ricostruzione dell’identità o del profilo
dell’interessato che sia imprecisa; non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati. Si parla, rispetto a
quest’ultimo carattere dei dati, di “principio di proporzionalità”: in
virtù di esso i dati raccolti devono essere strettamente necessari e
sufficienti per perseguire le finalità del trattamento, non potendo
eccedere tali finalità, poiché è vietato trattare dati personali superflui
rispetto agli scopi del trattamento;
f) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati: si parla, in
questo senso, di “diritto all’oblio” dell’interessato, il che significa che
una volta che siano state perseguite dal titolare del trattamento le
finalità dello stesso, non c’è più ragione di continuare a conservare o a
trattare i dati raccolti e l’interessato ha, per così dire, diritto “di essere
dimenticato”248.
- Ancora, per ciò che riguarda i diritti dell’interessato, l’Agenzia per la
protezione dei dati personali di Madrid prevede quanto segue: “Se
procederà a la supresión y borrado de los datos personales publicados
cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la
cual hubieran sido publicados. El tratamiento de datos personales se
realizarà de forma que permita el ejercicio por parte de los afectados de
248 P. CECCOLI, Regole per il trattamento dei dati, in A.A. V.V., (V. ITALIA coordinatore), Codice della Privacy, cit., pp. 123-133.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
127
los derechos a los que se refieren los artículos 15 y siguientes de la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal”249.
- Sul punto “Ejercicio de los derechos de habeas data”, l’Agenzia catalana
dispone brevemente nell’appendice alla Guía Aporta: “Adoptar las
medidas adecuadas para dar cumplimiento efectivo al ejercicio de los
derechos de habeas data (acceso, rectificación, cancelación y oposición
de los datos de carácter personal)”. Tali raccomandazioni richiamano
senza dubbio il contenuto dell’art. 7 del Codice della privacy, che
disciplina il “Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti”,
riprendendo pressoché integralmente la disposizione contenuta nell’art.
12 della direttiva 95/46/CE250. Secondo quanto previsto dall’art. 7,
l’interessato ha, in primo luogo, il diritto di ottenere la conferma, da parte
del titolare o del responsabile del trattamento (ove nominato),
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha altresì diritto ad ottenere l’indicazione dell’origine dei
dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica
applicata in caso di trattamento con strumenti elettronici e degli estremi
identificativi del titolare o responsabile del trattamento (art. 7, c. 2). Al di
là dei diritti appena menzionati – la cui finalità è quella di fornire
all’interessato necessarie informazioni sui dati personali che lo
riguardano, l’interessato ha inoltre il diritto di far compiere al titolare
alcune operazioni sui dati in quanto tali, avendo cioè il diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati, cosicché la richiesta di integrazione deve
basarsi su un motivato interesse;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge (che in ogni caso – anche al di là
della richiesta dell’interessato che viene a conoscenza di tali ipotesi –
non potrebbero essere trattati), compresi quelli di cui non è necessaria
249 Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Guía Aporta sobre reutilización de la información del sector público, Madrid, Mayo 2009, p. 20, www.aporta.es.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
128
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati erano stati
raccolti o successivamente trattati (in tale ultima ipotesi l’interessato
esercita il c.d. “diritto all’oblio”, ed in ogni caso è principio generale –
indipendentemente dalla specifica richiesta- che i dati il cui
trattamento abbia raggiunto le finalità previste non possano più
continuare ad essere trattati);
c) l’attestazione che il titolare del trattamento ha portato a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi informazioni circa
l’origine dei dati personali e del loro contenuto e circa le finalità e
modalità del trattamento.
d) Infine, l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte251:
e) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ed anche se in precedenza
abbia manifestato il proprio consenso al trattamento (in tale ipotesi,
anche a fronte di trattamenti corretti e conformi al Codice,
l’interessato può esercitare il suo diritto di opposizione al trattamento,
ma dovrà dimostrare l’esistenza di fondati motivi che prevalgano sul
diritto del titolare a trattare i dati a quel punto legittimamente
acquisiti);
f) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
4.4.3. I limiti del riutilizzo: a tutela dei dati personali oggetto di riutilizzo
La necessità di tutelare i dati personali detenuti e trattati dalle amministrazioni
incide sul regime di riutilizzo secondo due modalità distinte, a seconda della
tipologia di dati personali in oggetto.
Per quanto attiene ai dati personali c.d. sensibili, essi dovrebbero essere del tutto
esclusi dal novero dei dati che risultano cedibili a fini di riutilizzo. Come
sottolineato in diverse occasioni, infatti, i dati assoggettabili a finalità di riutilizzo
250 Cfr. A. DEL NINNO, La tutela dei dati personali, Guida pratica al Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196), Cedam, 2006, pp. 50-51.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
129
sono soltanto i dati pubblici, ovvero i dati “conoscibili da chiunque”, dai quali
restano esclusi per definizione i dati “a conoscibilità limitata”, nel cui ambito
sicuramente vengono a collocarsi i dati sensibili252.
Per ciò che riguarda, invece, i dati “comuni”, essi ricadono nell’insieme dei dati in
linea di principio riutilizzabili, ma anche rispetto a questi dati si pongono esigenze
di tutela. Se, infatti, la cessione di tali dati dall’amministrazione cedente al
soggetto riutilizzatore appare complessivamente compatibile con la disciplina
della privacy253, il problema si sposta sulle attività poste in essere in sede di
riutilizzo di dati di provenienza pubblica. Rispetto alle comuni esigenze relative al
trattamento dei dati, rilevano, in particolare, la circostanza che i dati siano raccolti
senza il consenso dell’interessato e il principio per cui il loro riutilizzo deve
risultare compatibile con gli scopi che ne hanno giustificato la raccolta254. A
questo fine, la licenza di riutilizzo si configura come lo strumento attraverso il
quale l’amministrazione è in grado di imporre al contraente/riutilizzatore limiti e
oneri idonei ad affrontare queste esigenze, in alcuni casi limitando lo spettro delle
possibili attività di riutilizzo (per esempio, escludendo del tutto usi di tipo
commerciale), in altri invece prescrivendo oneri di informazione nei confronti
degli interessati, ovvero regolamentando il riutilizzo incrociato di dati personali
provenienti da una pluralità di fonti informative pubbliche, senza mancare di
251 Ibidem. 252 Come osserva Ponti, questa lettura, fondata sulla “sistematica” dei dati personali, trova puntuale riscontro nel Codice della privacy, che consente il trattamento dei dati sensibili (ivi compresa la cessione a terzi a fini di riutilizzo) solo “se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite” (art. 20, comma 1), condizione non solo non assolta, ma nettamente esclusa dal tenore del d. lgs. 36/2006 di attuazione della direttiva sul riutilizzo. Anche il Garante si è espresso in questo senso, nel parere sullo schema del d.lgs. (cfr. provvedimento del 27 ottobre 2005 di cui al paragrafo precedente). 253 Questa ipotesi di “trattamento” appare espressamente autorizzata dal Codice della privacy, nella misura in cui, in particolare, la stessa disciplina del riutilizzo ad opera del d.lgs. 36/2006 obbedisce al requisito previsto contemplato dall’art. 19, comma 3 del Codice, che ammette “la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati di dati personali diversi da quelli sensibili” quando essa è prevista da una norma di legge o di regolamento. 254 Si rimanda al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, del 27 ottobre 2005, che in questo senso richiama la necessità di tenere conto delle cautele previste dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. R (91) 10 relativa alla comunicazione a terze persone dei dati a carattere personale detenuti da organismi pubblici. In senso opposto, le considerazioni di V. ZENO-ZENCOVICH, Uso a fini privati di dati personali in mano pubblica, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2/2003, p. 110, che giudica negativamente le opportunità di riutilizzo di dati personali, anche se comuni, detenuti dalle amministrazioni, in ragione della prevalenza assoluta delle esigenze di salvaguardia della riservatezza.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
130
considerare l’opportunità di imporre alcuni requisiti ulteriori quanto alle misure di
sicurezza da applicare al trattamento255.
Come emerge, dunque, lo spazio regolatorio si presenta particolarmente ampio e,
in esso, il ruolo delle licenze d’uso, per quanto non esclusivo256, manifesta una
significativa adattabilità alle diverse categorie e tipologie di dati personali
potenzialmente oggetto di riutilizzo.
4.4.4. (Segue): a tutela della qualità dei dati nella regolazione della privacy
Una seconda finalità rimessa alle clausole contenute nelle licenze sul riutilizzo
attiene all’esigenza che le attività di riutilizzo non determinino un impoverimento
della qualità dei dati di fonte pubblica. Tale questione attiene, indubbiamente,
all’esigenza, sistemica, di salvaguardia della integrità, correttezza ed esattezza dei
dati pubblici, anche una volta che questi siano fuoriusciti dal settore pubblico. Si
tratta di un’esigenza che può trovare soluzione - sul piano convenzionale – anche
nelle clausole volte a distribuire le responsabilità giuridiche per gli eventuali danni
determinati in esito o in concorrenza alle attività di riutilizzo, in capo
all’amministrazione cedente ovvero al riutilizzatore. Particolarmente utili a questo
scopo sono le clausole che, oltre ad imporre il dovere di corretto uso dei
documenti ceduti e di non alterazione delle informazioni, rendono obbligatoria la
citazione della fonte pubblica delle informazioni riutilizzate257.
Una delle discipline più organiche e compiute in materia di dati, rivolta, anche se
solo indirettamente, ad assicurare la qualità degli stessi, è senza dubbio
255 All’ipotesi in cui il riutilizzatore fosse da considerarsi come “incaricato” del trattamento (ai sensi dell’art. 4, comma 1 lett. h) del Codice della privacy), pare, infatti, da preferirsi l’opzione per cui il riutilizzatore costituisce un differente, autonomo titolare del trattamento, rispetto all’amministrazione cedente. In questo secondo caso, tuttavia, non varrebbe l’onere di rispettare le stesse misure di sicurezza predisposte dall’amministrazione cedente, cosicché le licenze potrebbero rappresentare lo strumento per imporre ai riutilizzatori il rispetto di requisiti ed accorgimenti ulteriori rispetto al nucleo minimo imposto dal Codice. 256 Per quanto attiene, infatti, al trattamento da parte di terzi di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti detenuti da soggetti pubblici, il Codice prevede la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta da parte dei soggetti riutilizzatori, al momento allo studio del Garante (cfr. art. 61, comma 1, Codice della privacy). 257 Si vedano le specifiche indicazioni contenute nelle direttiva 2003/98/CE, al considerando (17), che restano però oscurate nella disciplina nazionale, anche per effetto del mancato coordinamento con il Codice dell’amministrazione digitale, che invece dedica specifiche previsioni sia alla

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
131
rappresentata dalla normativa in materia di privacy, frutto - come già più volte
osservato - di una regolazione fortemente coordinata dal livello comunitario258.
La normativa in materia di privacy richiede in primo luogo la correttezza,
l’esattezza e, se necessario, l’aggiornamento dei dati personali oggetto di
trattamento. Altri requisiti rintracciabili nel testo del d. lgs. 196/2003 riguardano,
quindi, le modalità di trattamento: particolarmente significativo risulta, in questo
senso, l’art. 11 del Codice, che - come anticipato - disciplina la liceità, correttezza
ed esattezza del trattamento dei dati.
Nel processo di trattamento dei dati è in sostanza necessario rispettare un insieme
di regole e principi che si legano direttamente alla qualità dei dati, e che sono
talora individuati dallo stesso Garante, per esempio quando si richiede che i dati
siano accurati, pertinenti, non eccedenti e aggiornati in rapporto alle specifiche
finalità, in particolare allorché si tratti di dati sensibili259. Come sottolineato da
Carloni, “più che per i caratteri richiesti ai dati ed al loro trattamento, questa
disciplina si evidenzia particolarmente in virtù del fatto che la sua effettività è
garanzia della qualità dei dati che al tema della responsabilità rispetto alle informazioni diffuse in rete. 258 Si tratta, infatti, di una disciplina fissata in una prima fase dalla legge 675/1996 e quindi ampliata da una serie di provvedimenti correttivi ed integrativi - che ora possiamo rintracciare in maniera compiuta nel Codice in materia di trattamento dei dati personali - cui si aggiungono numerosi interventi dell’Autorità Garante. 259 In taluni documenti, queste caratteristiche sono espressamente qualificate come requisiti di “qualità dei dati”: si v., ad esempio, la risoluzione della ventisettesima Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della Privacy, tenutasi a Montreaux, tra il 14 e il 16 settembre 2005 (Risoluzione sull’uso di dati personali per la comunicazione politica), in http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1170546. Analoghe conclusioni sono rintracciabili nella Risoluzione di Madrid (Propuesta Conjunta para la Redacción de Estándares Internacionales para la protección de la Privacidad, en relación con el Tratamiento de Datos de carácter personal), approvata in esito alla trentunesima Conferenza Internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della Privacy, celebratasi tra il 4 e il 6 novembre scorso nella capitale spagnola. Alla voce “Principio de Calidad” si legge infatti: “La persona responsable deberá asegurar en todo momento que los datos de carácter personal sean exactos, así como que se mantengan tan completos y actualizados como sea necesario para el cumplimiento de las finalidades para las que sean tratados. La persona responsable deberá limitar el periodo de conservación de los datos de carácter personal al mínimo necesario. De este modo, cuando los datos de carácter personal hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades que legitimaron su tratamiento deberán ser cancelados o convertidos en anónimos”. Il documento è disponibile alla pagina web: http://www.privacyconference2009.org/home/Novedades/index-ides-idweb.html, assieme alle altre risorse multimediali e materiali relativi alla conferenza. In altre tipologie di documenti, comunque, le garanzie di qualità dei dati si legano in maniera più diretta a quelle di sicurezza, come nel caso della segnalazione a Governo e Parlamento sulle banche dati di DNA, del 21 settembre 2007, in http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1441899.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
132
assicurata attraverso meccanismi interni ed esterni di garanzia, di tipo
organizzativo e procedurale”260.
Sotto il profilo organizzativo risulta particolarmente significativa la previsione di
specifiche autorità di garanzia. Il riferimento va sia ad un’autorità indipendente
rispetto alle amministrazioni che detengono i dati, e appositamente costituita (il
Garante), sia in capo a specifiche figure individuabili all’interno delle
amministrazioni: tali previsioni organizzative si traducono con meccanismi di
controllo da parte del Garante della privacy, cui sono attribuiti poteri di vigilanza
e sanzionatori.
La normativa in materia di privacy contempla altresì garanzie di tipo procedurale,
attraverso la previsione di poteri di controllo a carattere più “diffuso”: si segnala,
in particolare, il riconoscimento agli interessati del diritto di accesso ai dati e il
diritto di richiedere la correzione del dato se inesatto, od il suo aggiornamento,
nella prospettiva di un complesso di dinamiche volte, tutte, a supportare
un’adeguata qualità dei dati personali detenuti e trattati dalle pubbliche
amministrazioni.
Particolare rilievo meritano, in questo senso, le garanzie di sicurezza nel
trattamento dei dati, specie allorché esso abbia luogo attraverso l’ausilio di
strumenti informatici e i dati siano organizzati in banche dati: tali regole di
sicurezza e le correlate garanzie organizzative e procedurali risultano nel loro
complesso adeguate ai dati delle amministrazioni pubbliche, al punto che gli
standard di sicurezza previsti in materia di privacy e quelli posti a garanzia
dell’efficienza e della trasparenza dell’attività amministrativa vengono a
coincidere, almeno dal punto di vista sostanziale261.
In linea generale, comunque, pare potersi affermare che le regole in materia di
trattamento dei dati, nell’assicurare standard qualitativi riferiti a specifici profili,
se tendenzialmente determinano un innalzamento complessivo della qualità dei
dati trattati, comportano, in alcuni casi, un abbassamento dello standard rispetto ad
ulteriori finalità di trattamento262: si pensi, da questo punto di vista, alle
260 E. CARLONI, La qualità dei dati pubblici, in B. PONTI, Il regime dei dati pubblici, cit., p. 293. 261 Ivi, p. 294. Analoghi standard tecnici di sicurezza garantiscono, in particolare, le banche dati tanto ai fini della sicurezza pubblica che della privacy. 262 Carloni ricorda che la letteratura scientifica ha evidenziato circa 180 requisiti di qualità dei dati, e ha quindi variamente tentato di enucleare le caratteristiche salienti di qualità degli stessi: cfr., sul

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
133
menzionate procedure di anonimizzazione, che, da un lato, contribuiscono al
miglioramento della dimensione qualitativa sotto il profilo dell’accessibilità (una
volta assicurata la tutela della persona), ma che, dall’altro, implicano
inevitabilmente un peggioramento qualitativo nell’ottica dei caratteri di rilevanza,
per esempio ai fini della ricerca scientifica263.
4.5. Registri pubblici e mercato dell’informazione: alcuni significativi
casi di riutilizzo commerciale di informazioni personali
4.5.1. L’utilizzazione per finalità commerciali e di marketing dei dati personali
contenuti nelle liste elettorali, negli atti anagrafici e negli atti dello stato civile.
Un esempio di particolare rilevanza relativo alla raccolta di dati personali per
successivi riutilizzi con finalità, in senso lato, di marketing, è rappresentato
dall’utilizzo che fino all’entrata in vigore del Codice della privacy aveva ad
punto, R. Y. WANG, D. M. STRONG, L. GUARASCIO, An Empirical Investigation of Data Quality Dimensions. A Data Consumer’s Perspective, working paper TDQM-94-01, MIT, Cambridge (Ma), 1984 e il modello semplificato proposto in M. EPPLER, Managing Information Quality. Increasing the Value of Information in knowledge-intensive Products and Processes, second revised and extended edition, Springer, Berlin/New York, 2006. Le categorie di R. Y. Wang e D. Strong sono, al riguardo, quelle più frequentemente richiamate dalla dottrina, e consistono in quattro caratteri a loro volta suscettibili di essere articolati in molteplici dimensioni rilevanti: la accuratezza (credibilità, accuratezza, obiettività, affidabilità), la rilevanza (valore aggiunto, rilevanza, tempestività, completezza, appropriatezza), la rappresentatività (interpretabilità, comprensibilità, consistenza rappresentativa, sinteticità rappresentativa) ed infine l’accessibilità (accessibilità, sicurezza di accesso) dei dati stessi. R. Y. WANG, D. M. STRONG, Beyond Accuracy. What data quality means to data consumers, in Journal of Management Information Systems, 1996, n. 12, pp. 5 ss, e, più recentemente, Y. W. LEE, D. M. STRONG, B. K. KAHN, R. Y. WANG, a Methodology for Information Quality Assessment, in Information and Management, 40, 2002, pp. 133-146. 263 Le procedure di anonimizzazione giocano un ruolo fondamentale, nel momento in cui, garantendo la tutela della privacy, consentono il trattamento degli stessi in ambito, ad esempio, chimico-farmaceutico o giornalistico. Tali ulteriori finalità di trattamento si trovano dunque realizzate sebbene il settore della ricerca scientifica, o dell’informazione, non abbiano a disposizione tutti i dati ai quali astrattamente potrebbero avere accesso. La questione della misura in cui l’anonimizzazione dei dati possa inficiare i risultati della ricerca scientifica e, più in generale, il tema del bilanciamento tra esigenze di tutela della privacy e bisogno di “materia prima” informativa da parte della ricerca, costituiscono, evidentemente, uno dei nuclei dell’attuale dibattito in tema di privacy. Basti menzionare l’articolo pubblicato il 5 gennaio del 2009 dal quotidiano torinese “La Stampa”, che denunciava, tra le più diffuse prassi elusive delle norme poste a presidio della privacy, quella di consentire l’accesso ai dati personali a fronte della mera dichiarazione che detti dati sono necessari a fini di ricerca scientifica.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
134
oggetto i dati contenuti nelle liste elettorali, negli atti anagrafici e negli atti dello
stato civile.
Per dare una risposta alla domanda circa la legittimità ed i limiti di liceità della
comunicazione a terzi dei dati anagrafici, occorre in primo luogo riportare la
disciplina specifica di settore, onde evidenziare le tipologie di dati interessati,
nonché il loro regime di pubblicità, coordinando quest’ultimo con i principi
introdotti sia dal Codice della privacy che dalla legge 241/90, così come
riformulata dalla legge 15/2005.
Il regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con d.p.r. del 30
maggio 1989, n. 223, definisce anagrafe della popolazione residente “la raccolta
sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie
ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle
posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune
il proprio domicilio”264 e precisa che l’anagrafe è costituita da schede individuali,
di famiglia e di convivenza, il cui contenuto è particolarmente rilevante, dal
momento che rientrano in esso, tra l’altro, dati attinenti alla professione, al titolo
di studio o all’insieme delle persone conviventi in un determinato nucleo.
Con riferimento al regime di conoscibilità degli atti sopra menzionati, il d.p.r.
223/1989 prevede, all’art. 33, una disciplina speciale, circoscrivendo i dati
comunicabili e i destinatari dei medesimi: possono infatti essere oggetto di
comunicazione “a chiunque ne faccia richiesta” i soli certificati “concernenti la
residenza e lo stato di famiglia”. L’accesso ad altre informazioni richiede invece
una preliminare valutazione circa l’esistenza di “gravi o particolari esigenze di
pubblico interesse” che rendano inopportuna la comunicazione, ad eccezione delle
informazioni relative alla “professione, arte o mestiere, la condizione non
professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede
individuali sia stato autorizzato ai sensi dell’art. 20, c. 2”, alle quali non possono
invece avere accesso i terzi265.
264 D.p.r. 30 maggio 1989, n, 223, art. 1. 265 La comunicazione può avere ad oggetto, oltre che i certificati, anche gli elenchi, ma solo nei confronti delle amministrazioni che ne facciano motivata richiesta, per uso esclusivo di pubblica utilità. Nei confronti degli altri soggetti si ammette solo la comunicazione di “dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati”, e soltanto per finalità statistiche e di ricerca, ex art. 35. Il d.p.r. 233/1989, non limitandosi a disciplinare il rilascio di certificati ed elenchi anagrafici, prevede poi all’art. 37 regole specifiche anche per la semplice consultazione, la quale è consentita ai soli componenti dell’Ufficio anagrafe, essendo vietato agli estranei l’accesso all’Ufficio (sono escluse da tale

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
135
Se quella fin qui illustrata è la disciplina in materia, occorre ora analizzare il
coordinamento di tali norme con quelle della l. 241/90 e del Codice della privacy.
Con riferimento al diritto di accesso, il principio generale della conoscibilità degli
atti amministrativi non sembra trovare deroghe nella disciplina sopra riportata, in
quanto, di norma, gli atti anagrafici non contengono dati che “riguardino la vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e
associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto
titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi
soggetti cui si riferiscono”, vale a dire dati per i quali la stessa l. 241/90, all’art.
24, c. 6, lett. d) contempla la possibilità di escludere l’accesso.
Al contrario, il d.p.r. 223/1989, laddove disciplina la conoscibilità di determinati
atti, circoscrivendone altresì i limiti, integra una fonte idonea ai sensi di quanto
prevede l’art. 19, c. 3 del Codice della privacy266, al fine di effettuare
legittimamente la comunicazione di dati da parte di un ente pubblico anche a
soggetti privati.
Il Garante si è pronunciato sul punto in un parere reso il 23 maggio 2000,
affermando che: “secondo la normativa sugli atti anagrafici, l’ufficiale
d’anagrafe deve rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni
di legge, soltanto i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia degli
iscritti all’anagrafe, ex art. 33 del d.p.r. del 30 maggio 1989, n. 223, e può
comunicare i dati anagrafici, resi anonimi e aggregati, per fini statistici e di
ricerca. E’ possibile poi rilasciare elenchi solo alle amministrazioni pubbliche
che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità (d.p.r. 30
maggio 1989, n.. 223, art. 34, c. 1 e 2). Al di fuori di queste ipotesi, e fatta salva
la particolare disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, la cui
perdurante applicabilità non è pregiudicata dalle disposizioni contenute nella
normativa sulla tutela dei dati personali, non è quindi possibile comunicare o
diffondere a privati i dati personali provenienti dagli archivi anagrafici”.
divieto le persone appositamente incaricate dall’autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell’ordine ed al Corpo della Guardia di Finanza, ai quali è consentita la consultazione previa osservanza di alcune formalità). 266 L’art. 19, c. 3 del Codice della privacy dispone infatti quanto segue: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
136
Ma sarà solo con l’entrata in vigore del Codice della privacy, nel 2003, che
l’utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali, negli atti anagrafici e
negli atti dello stato civile verrà ricondotto in un ambito di maggiore garanzia per
gli interessati: l’art. 177 del Codice, infatti, prevede che il comune possa rilasciare
gli elenchi degli iscritti nell’anagrafe della popolazione residente e i dati
anagrafici per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
In relazione al rilascio dei dati contenuti nelle liste elettorali, l’art. 177 del Codice
prevede inoltre – attraverso una modifica dell’art. 51, c. 5 del d.p.r. 223/1967- che
le liste elettorali possano essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della
disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica,
scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso267.
Dal quadro normativo fin qui ricostruito268, appare evidente che la prassi invalsa
in passato di utilizzare dati personali contenuti nelle liste elettorali, negli atti
anagrafici e negli atti dello stato civile ad esempio attraverso la fornitura delle
informazioni, da parte delle amministrazioni comunali, a società di ricerche di
mercato, risulta in contrasto con precise prescrizioni normative che il Codice della
privacy ha introdotto.
Considerazioni analoghe paiono applicabili anche all’utilizzo per finalità di
marketing, in senso lato, dei dati personali tratti da albi professionali. L’art. 61, c.
2 del Codice del privacy, infatti, dispone che i dati personali, diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi solo quando tali attività siano previste da una norma di
legge o di regolamento o - in mancanza di tale norma- in base a provvedimento
del Garante. La comunicazione o la diffusione, che non possono riguardare dati
sensibili o giudiziari, nei termini e alle condizioni sopra illustrate, può avvenire
soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento”. 267 Inoltre all’art. 5, c. 1, del d.p.r. 223/1967 sono soppresse le lettere d) ed e). Ciò significa che non possono più comparire nelle liste elettorali il titolo di studio e la professione o il mestiere del soggetto iscritto. 268 Tale cornice normativa di riferimento è stata riconfermata dal Garante anche nel provvedimento del 6 ottobre 2005 intitolato “Il caso Laziomatica. Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi”.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
137
anche mediante reti di comunicazione elettronica e può altresì essere menzionata
l’esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull’esercizio della professione.
L’ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell’albo
che vi abbia interesse, integrare i dati con ulteriori informazioni pertinenti e non
eccedenti in relazione all’attività professionale.
Infine, a richiesta dell’interessato, l’ordine o collegio professionale può altresì
fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali
qualificazioni professionali non menzionate nell’albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico
inerente anche a convegni o seminari269.
4.5.2. I casi Kehoe (US) e Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA (UK)
Uno delle esperienze di ricerca più approfondite e recenti in tema di rapporto tra
commercializzazione della PSI e tutela della privacy è, indubbiamente, quella
svolta da Mark Burdon, ricercatore della Queensland University of Technology, la
cui indagine, sebbene focalizzata su contesti ed esempi extraeuropei, dà
criticamente conto delle iniziative e dei nuovi indirizzi in materia di politiche
dell’informazione inaugurati con la direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo
dell’informazione pubblica270.
Burdon analizza un significativo caso statunitense del 2005, il caso Kehoe v.
Fidelity Federal Bank & Trust271, che aveva visto l’esercizio di una class action
nei confronti della Fidelity Bank a fronte dell’acquisto, da parte di questa, di
565.600 nominativi ed indirizzi dal Department of Motor Vehicles (DMV) dello
stato americano della Florida. Acquistate le informazioni, infatti, la banca aveva
269 Per approfondimenti sul tema del trattamento dei dati personali rispetto alle ipotesi di invio di materiale pubblicitario, per il compimento di ricerche di mercato o per finalità di comunicazione commerciale, si rimanda al capitolo XV del volume ad opera di A. DEL NINNO, La tutela dei dati personali. Guida pratica al Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), cit., pp. 722-762. 270 Si rimanda, in particolare, a M. BURDON, Commercializing Public Sector Information: Privacy and Security concerns, in IEEE Technology and Society Magazine, 28(1), p. 34-40. Particolarmente interessante, su temi analoghi, anche: M. BURDON, Profiting from personal information: Power, information, privacy and evidence based policy, in Proceedings from the Third Workshop on Social Implications of National Security, Canberra, 2008, pp. 136-145; D. J. SOMOGY, Information Brokers and Privacy ,in I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, 1 (2/3), 2006, pp. 901-925.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
138
utilizzato i dati dei residenti in Florida per l’invio massiccio di e-mail pubblicitarie
aventi ad oggetto prestiti per l’acquisto di automobili. Un simile atto si poneva
però in assoluto contrasto con il Drivers Privacy Protection Act (DPPA)272
federale, che richiede ai governi statali di proteggere la privacy dei cittadini i cui
dati personali siano inseriti in un registro automobilistico.
Il DPPA era entrato in vigore nel 1993 per impedire a possibili stalkers di entrare
in possesso dei dati delle loro vittime attraverso registri automobilistici
pubblicamente accessibili. Un successivo emendamento del 1999, quindi, aveva
imposto ad ogni DMV statale di ottenere il consenso dei soggetti registrati in
ordine alla cessione dei dati per riutilizzi degli stessi a fini di marketing.
Nello specifico, nel caso Kehoe, risulta che il consenso degli automobilisti
effettivamente fosse stato richiesto prima che il DVM procedesse a riutilizzare e
vendere i loro dati alla banca. In ogni caso, l’emendamento del 1999 cui si è fatto
riferimento, approvato in Florida nel 2000, non venne mai effettivamente integrato
nella legislazione della Florida a causa di un errore materiale. In virtù di tale
omissione, le informazioni personali relative agli automobilisti continuarono ad
essere utilizzate per ragioni commerciali indipendentemente dall’ottenimento di
un permesso da parte degli interessati.
La Corte distrettuale del Sud della Florida emise, in prima istanza, una decisione
favorevole alla banca, poiché gli attori non erano in grado di provare l’esistenza di
un danno attuale derivante dalla violazione del DPPA. Ma la Corte d’appello,
successivamente, rovesciò la decisione condannando la Fidelity Bank a pagare 50
milioni di dollari per aver utilizzato l’informazione degli automobilisti per finalità
commerciali senza tenere conto dei dinieghi al riutilizzo.
Sempre nel 2005, anche la britannica Driver and Vehicle Licensing Agency
(DVLA) andò incontro a vicende giudiziarie per aver venduto dati relativi alla
documentazione degli automobilisti. La DVLA, responsabile della raccolta dei
dati di coloro che sono in possesso di una patente britannica o di un veicolo
registrato entro i confini del Regno Unito, aveva infatti sistematicamente venduto
le informazioni personali degli automobilisti a determinati soggetti operanti nel
settore delle strutture di sosta, quali amministratori di parcheggi o imprese che, in
271 Kehoe v. Fidelity Federal Bank & Trust, 4 S.Ct. 1612 (Mem.), 21 F. 3d 1209 126, 2005. 272 Drivers Privacy Protection Act (18 U.S.C. § 2721), 1993.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
139
presenza di determinate contravvenzioni, si occupano di apporre dispositivi di
bloccaggio agli autoveicoli.
A fronte del pagamento di una somma forfettaria di circa £ 3000, la DVLA aveva
autorizzato l’accesso diretto al proprio sistema di banche dati, cosa che consentiva
agli acquirenti dei dati di inserire un codice di autenticazione e scaricare le
informazioni personali circa i proprietari delle auto registrate. Chiamata a
giustificare la propria condotta, la DVLA si difese sostenendo di dover procedere
alla vendita della PSI in suo possesso, in virtù di un vincolo legale a cedere tali
informazioni a chiunque potesse vantare “una ragionevole motivazione”273.
A dispetto del menzionato requisito, che avrebbe dovuto assoggettare le ipotesi di
accesso al database DVLA a parametri di ragionevolezza, l’agenzia aveva
consentito l’accesso ai dati anche ad una delle maggiori compagnie europee di
carte di credito, nota per l’impiego di strategie commerciali di massa, là dove la
giustificazione era il mero fatto che la suddetta multinazionale era titolare di un
parcheggio privato presso la propria sede centrale. Emerse, ancora, che la DVLA
aveva venduto i propri dati anche ad un’impresa privata, la cui attività aveva ad
oggetto l’apposizione di ganasce alle automobili, per cui i direttori dell’impresa si
erano trovati in grado di ricattare ignari automobilisti, attraverso l’invio di lettere
minatorie che facevano riferimento ai dettagli della loro registrazione e
contenevano la contestazione di una falsa sosta vietata274.
In seguito, grazie in particolare ad un’intensa pressione mediatica circa le attività
commerciali della DVLA, il Ministero dei Trasporti, cui la DVLA fa riferimento,
fu persuaso a rispondere con un procedimento di revisione e di consultazione
pubblica275.
Dai casi Kehoe e DVLA emergono diversi spunti di riflessione. Innanzitutto, è
innegabile che l’impostazione del DPPA sia inusuale rispetto alla normativa
273 L. PURVES, “Licensed to sell your identity”, Times, 29 November 2005, accessibile al sito http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/libby_purves/article597642.ece. 274 M. DELGADO, R. LUDGATE, M. NICHOL, “DVLA sells your details to criminals”, in Mail on Sunday, 2005, disponibile all’indirizzo: http://www.dailymail.co.uk/news/article-369838/DVLA-sells-details-criminals.html. 275 A. McCUE, “Government considers DVLA datasale restrictions”, 2006, disponibile all’indirizzo: http://www.silicon.com/management/public-sector/2006/06/16/government-considers-dvla-data-sale-restrictions-39159622/. Il processo di revisione si tradusse in 14 nuove misure che comprendono indicazioni dettagliate su cosa integri la fattispecie della ragionevole motivazione, requisiti per le organizzazioni ad essere membri di un’associazione commerciale accreditata e l’avvio di una nuova procedura di contestazione.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
140
europea in tema di protezione dei dati personali: tale documento, che era stato
pensato per impedire le molestie degli stalkers, vincolava gli
acquirenti/riutilizzatori dei dati, anziché i soggetti che si occupano della raccolta
degli stessi, ad agire entro determinati confini; proprio per tale ragione, nel caso
Kehoe, l’azione fu proposta nei confronti della Fidelity Bank, e non nei riguardi
del DVM della Florida.
I due casi forniscono esempio dell’impiego di metodologie diverse per ciò che
attiene all’ottenimento del consenso276, ma in entrambi fallisce del tutto il
proposito di fornire effettivi mezzi di tutela della privacy quanto al riutilizzo
commerciale della PSI contenente dati personali.
La sezione 2721 del DPPA, per esempio, indica le finalità per le quali i registri
automobilistici possono essere utilizzati; in essa è inclusa una previsione relativa
all’invio massivo di materiale pubblicitario via mail nel caso in cui l’information
provider abbia ottenuto il consenso espresso dai soggetti inseriti nella mailing list.
Ne deriva, dunque, che nel caso in cui un automobilista non avesse prestato il
consenso al rilascio dei propri dati personali per finalità commerciali, il DPPA
sarebbe dovuto intervenire proibendo ogni utilizzo dei dati diretto a tale scopo277.
Nel caso Kehoe, però, come già osservato, alle norme relative al consenso (quale
presupposto del riutilizzo) non venne data alcuna attuazione nello stato della
Florida e il DMV poté continuare a vendere l’informazione in proprio possesso
senza alcuna restrizione.
276 Sulla nozione di consenso, nel modello americano di privacy, si rimanda al paragrafo “I paradossi del consenso” in U. PAGALLO, La tutela della privacy negli Stati Uniti e in Europa, cit., pp. 99-101: “Rimane poco chiaro negli Usa se la privacy è un diritto e, anzi, un diritto fondamentale, o se è piuttosto un interesse che, nel rapporto tra privati, non riveste valore di per sé ma deve essere fondato o giustificato con qualcos’altro. […] Uno dei problemi più delicati posti dalla tutela della privacy negli Usa riguarda il consenso degli individui, non di rado disposti a consegnare alla controparte una gran mole di dati personali in cambio di crediti, prestiti o vendite dilazionate”. Cfr, nel medesimo testo, pp. 128-129: alla luce del problematico concetto di consenso emerso in rapporto al modello americano, particolarmente interessante appare una riflessione sul “principio comunitario del consenso”, rintracciabile, innanzitutto, nell’art. 7 della direttiva 95/46/CE. L’art. 7 prevede infatti, come prima ipotesi di legittimità per il trattamento dei dati personali, il consenso inequivocabile della persona interessata, elencando, tuttavia, cinque ulteriori casi in cui, al di là del consenso, i dati possono essere trattati. In altri termini, dunque, si potrebbe affermare che mentre negli Usa la regola generale rispetto alle ipotesi di inserimento dei dati personali in un database (e correlato trattamento) è nel senso di un sistema di opt-out, nell’ambito comunitario, da questo punto di vista più garantista, prevale la regola dell’opt-in, che subordina al consenso dell’interessato sia l’inserimento dell’informazione personale in una banca dati, sia l’estrazione ed utilizzo della stessa.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
141
Nel caso DVLA si ha, invece, che soltanto determinati soggetti, dotati di un
legittimo interesse, avrebbero dovuto ottenere accesso ai dati personali degli
automobilisti. Ma, come poc’anzi illustrato, la nozione di “motivazione
ragionevole” risultava così ampia da consentire un accesso – illegittimo - ai dati
personali anche alle imprese che potessero vantare un interesse solo vagamente
correlato ai dati; inoltre, la situazione generale era tale per cui, una volta resa
accessibile l’informazione, di fatto mancava qualsiasi restrizione pratica
all’utilizzo di quei dati, sulla base dell’assunto che gli automobilisti avessero
implicitamente acconsentito a qualsiasi tipologia di riutilizzo dei propri dati
personali.
In sintesi, entrambi i casi raffigurano, oltre che - specie nel caso britannico -un
esempio di trattamento dei dati personali in assoluta malafede da parte delle
agenzie governative, un clamoroso fallimento delle medesime agenzie
nell’osservare il principio del consenso in ordine a finalità commerciali
secondarie278, il che evidenzia un allarmante mancanza di consapevolezza circa i
potenziali effetti negativi sulla privacy dei cittadini derivanti dalla
commercializzazione, posta in atto dal settore pubblico, della PSI contenente dati
personali e riporta un quadro alquanto inquietante circa i margini di rischio legati
alle ipotesi di riutilizzo illecito di dati personali.
4.5.3. (Segue): lo sfruttamento commerciale dei dati personali tra tutela della
privacy e sicurezza nazionale
I casi Kehoe e DVLA pongono in rilievo profili di rischio per la privacy ad un
livello, innanzitutto, individuale, ma è innegabile che la commercializzazione
della PSI da parte delle amministrazioni sollevi, altresì, questioni di ordine
pubblico a livello governativo e sociale.
Colpisce, in entrambi i casi, il carattere di estrema esiguità del pagamento
effettuato per ottenere l’accesso ai dati personali. Nel caso Kehoe, la Fidelity
277 Electronic Privacy Information Center, “The Drivers Privacy Protection Act (DPPA) and the privacy of your state motor vehicle record”, 2005, reperibile all’indirizzo: http://epic.org/privacy/drivers/. 278 In questo senso, una delle questioni di più stringente attualità è rappresentata dal problema del riutilizzo di dati personali sistematicamente operato dagli sviluppatori di applicazioni per i social network, primo fra tutti Facebook.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
142
Bank pagò appena 5656 di dollari per i dati personali di più di mezzo milione di
residenti della Florida, il che corrisponde a circa un centesimo di dollaro per ogni
nominativo ed indirizzo acquisito. Ancora, la DVLA vendette dati personali per
soli £ 2.5 per registro, incassando dal riutilizzo commerciale dei dati personali in
proprio possesso, soltanto nel 2005, circa 6.3 milioni di sterline, cifra che dà l’idea
della frequenza con cui la maggioranza dei registri veniva sistematicamente
riutilizzata e venduta279. Fu inoltre reso pubblico che i DMV di tipo statale non
erano affatto immuni a situazioni di frode, corruzione e ad una prassi di scarsa
sicurezza280.
I casi analizzati, dunque, mostrano in maniera eloquente l’entità che può assumere
il valore commerciale delle informazioni personali degli automobilisti:
naturalmente, se nei casi di vendita “legittima” da parte del DMV e della DVLA,
il valore commerciale era legato alle operazioni di marketing diretto effettuabili da
terzi, nel caso di azioni fraudolente, invece, tale valore risiedeva nella cessione di
dati personali finalizzata a fornire false identità (c.d. identity theft)281.
Relativamente a quest’ultima fattispecie osserva Burdon: “ In fact, it is
astonishing at a time when identity theft is fast becoming a major crime concern
in most first world countries, that both agencies were selling personal information
at basement store prices, and more worringly, paid scant regard to whom they
were providing it. It would appear from the two examples highlighted , that
commercial reasons, whether directly or indirectly, outweighted the potential
279 A. McCUE, “DVLA nets £6m from sale of motorist details”, 2006; maggiori dettagli sulla vicenda sono reperibili alla pagina web: http://www.silicon.com/management/public-sector/2006/06/14/dvla-nets-6m-from-sale-of-motorist-details-39159537/. 280 Nel dicembre 2003, per esempio, un ex impiegato del DMV del Nevada si dichiarò colpevole di aver ricevuto tangenti per oltre $ 300,000 per fornire illegittimi documenti di identificazione agli immigrati. Nel giugno del 2002, trentasei persone, incluso lo staff DMV, vennero indagate nell’ambito di una complessa operazione criminale che riguardava il rilascio illegale di patenti di guida nello stato del New Jersey. Pare addirittura che il livello delle operazioni criminali fosse così sofisticato, e la domanda così alta, che diversi brokers si facevano concorrenza per offrire la più ampia scelta di servizi illegali al prezzo più competitivo. Maggiori dettagli sulla vicenda sono reperibili sul portale web della “Division of Criminal Justice” dello stato del New Jersey, all’indirizzo: www.njdcj.org. 281 La patologia dell’uso di informazioni pubbliche a contenuto personale (c.d. “PSI misuse”), dà luogo, da un lato, ad illeciti tradizionali, quali frode, corruzione, ecc.; dall’altro, vede emergere fattispecie nuove, cui si fa generalmente riferimento con la definizione di computer crimes. Rientrano in quest’ultima categoria, oltre alla citata fattispecie del furto d’identità, anche reati quali lo spamming, l’attentato informatico e il sabotaggio di sistema. Si rimanda, sull’argomento, a I.J. LLOYD, Information Technology Law, Oxford University Press, New York, 2009, pp. 207-238, dove sono approfonditamente analizzate non soltanto le fattispecie qualificabili come

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
143
threats of national security arising from the misuse of personal information for
identity theft crimes..[…]While government have recognized the security issues
arising from the identification purposes of drivers’ licenses, they have not been as
quick to recognize the concerns that may arise through the commercialization of
driving license information”282.
I casi Kehoe e DVLA, quindi, rendono l’idea del volume di PSI che può essere
commercialmente riutilizzata dai governi al fine di incamerare introiti, sollevando
riflessioni nella prospettiva di una società dell’informazione idealmente aperta,
trasparente e sicura, ma anche sensibile delle diverse priorità nell’ambito delle
politiche governative e dei loro effetti sui cittadini.
Da un lato, infatti, è presente il forte interesse della società rispetto all’accesso alla
documentazione pubblica, sia nella forma dell’accesso libero e gratuito in
obbedienza a principi democratici, sia nella forma del riutilizzo commerciale volto
a favorire l’economia dell’informazione. Dall’altro lato, invece, è marcato
l’interesse sociale alla tutela dei dati personali, che poggia - oltre che sul rapporto
fiduciario che intercorre tra i cittadini e relativi governi - soprattutto sulla nozione
di privacy dell’informazione, in tutte le sue molteplici caratterizzazioni283.
Evidentemente, dall’interesse delle amministrazioni allo sfruttamento
commerciale dell’informazione da esse detenuta e al restringimento della libera
distribuzione della stessa (spesso con finalità di autofinanziamento della propria
attività) sorgono rischi per il diritto dei cittadini a esercitare forme d’accesso e di
effettivo controllo rispetto ai propri dati personali e alle attività di utilizzo e
riutilizzo che coinvolgono i medesimi. È innegabile, poi, che la già ardua
riconciliazione di questi interessi diviene ulteriormente complessa quando
questioni di sicurezza nazionale entrano in gioco284.
“computer related crimes”, ma anche le ultime iniziative legislative - soprattutto sul piano europeo – finalizzate ad arginare e reprimere tali reati. 282 M. BURDON, Commercializing Public Sector Information, cit., p. 39. 283 Si rimanda, in questo senso, alle considerazioni di tipo filosofico e alle correlate teorie esposte a proposito della nozione di privacy nel par. 2. 284 “A balance will not be found by simply examining and updating PSI, information privacy and national security legislation. Current laws do not adequately reflect the conceptual complexity and the democratic importance of maintaining a balance between open access to government information, governmental income generation through the commercial re-use of PSI, the information privacy of citizens, and the national security requirements of governments”. V. M. BURDON, Commercializing Public Sector Information, cit., pp. 39-40.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
144
Il preoccupante quadro d’insieme fin qui delineato, in sintesi, suggerisce di
ricordare i principi fondamentali che sono alla base dell’odierno ius conditum, il
quale impone alle agenzie pubbliche di ottemperare alle disposizioni vigenti in
materia di privacy, nell’ambito delle scelte di politica governativa che riguardano
la commercializzazione della PSI. Sia il caso Kehoe sia il caso DVLA pongono in
rilievo, infatti, le problematiche e i rischi che possono emergere qualora le agenzie
governative agiscano secondo criteri marcatamente - se non esclusivamente -
rivolti al profitto. In particolare, l’avvento su larga scala di crimini connessi ai
furti d’identità impone alle agenzie di ponderare attentamente l’adozione di nuove
strategie di commercializzazione della PSI e, altresì, il rinnovo di prassi
commerciali già in uso: è infatti innegabile che se a tale valutazione non è
riservato l’adeguato spazio, politiche commerciali applicate in maniera massiva e
non affiancate da strumenti di effettivo controllo quasi certamente riserveranno
effetti deleteri sia sulla privacy individuale sia sulla sicurezza nazionale.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
145
CONCLUSIONI
La direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ha
armonizzato le condizioni di base alle quali l'informazione del settore pubblico è
messa a disposizione di imprese e cittadini, nell'intento di promuovere prodotti e
servizi basati sull’informazione pubblica europea ed evitare le distorsioni della
concorrenza. La suddetta direttiva ha stabilito norme in materia di non
discriminazione, tariffazione, accordi di esclusiva, trasparenza, licenze e strumenti
tecnici che facilitino la ricerca e il riutilizzo dei documenti pubblici, fissando il
termine finale del 31 dicembre 2008 per gli accordi di esclusiva preesistenti; ha
ammesso, inoltre, per gli Stati membri, di fissare norme più rigorose di quelle
minime stabilite dalla direttiva285.
Nello studio Micus (2009), che valuta l'impatto della direttiva nei tre ambiti
principali dell'informazione del settore pubblico - geografico, meteorologico e
giuridico/amministrativo - i vari indicatori che misurano il riutilizzo di tale
informazione hanno evidenziato la crescita del mercato e l'aumento del riutilizzo
in tutti e tre i settori negli ultimi anni286.
Per quanto concerne il settore geografico, la quantità di informazioni del settore
pubblico scaricate nel 2007 è cresciuta di circa il 350% rispetto al 2002 e nella
sola Germania il mercato è stato stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, con un
aumento del 50% rispetto al 2000. I servizi meteorologici nazionali, invece, hanno
indicato che la quantità di dati scaricati tra il 2002 e il 2007 è aumentata del 70%,
tanto che il mercato dell’informazione meteorologica dell'UE si aggirava nel 2006
intorno a 530 milioni di euro, registrando un aumento del 60% rispetto al 1998.
Anche nel settore giuridico e amministrativo, la maggior parte dei detentori di
contenuti ha notevolmente rinnovato, negli ultimi anni, la propria politica in
285 La Commissione applica i principi della direttiva anche ai propri documenti, mediante una politica di riutilizzo delle informazioni. La decisione 2006/291/CE, Euratom della Commissione (GU L 107 del 20 aprile 2006, p. 38) va oltre le prescrizioni della direttiva, fissando tariffe basate (al massimo) sui costi marginali e autorizzando il riutilizzo di tutti i documenti. È una politica che si applica, ad esempio, ai dati statistici di Eurostat, alle memorie di traduzione della Commissione, alla banca dati Eur-Lex del diritto comunitario e agli studi. Spesso disponibili in 22 o 23 lingue, le informazioni della Commissione hanno un valore unico, in particolare per i sistemi di traduzione automatica. 286 Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information sectors, MICUS, 2009.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
146
materia di dati, offrendo una quantità crescente di informazioni in modo gratuito
su internet e segnalando così un aumento del 40% del mercato dal 2002287.
A dispetto degli indici menzionati, indubbiamente incoraggianti, permangono
tuttavia alcuni significativi ostacoli al pieno sviluppo del mercato europeo
dell’informazione: i riutilizzatori di informazioni geografiche e meteorologiche,
ad esempio, lamentano tariffe eccessive, condizioni restrittive di licenza e fattori
discriminatori. Nel settore meteorologico in particolare, i riutilizzatori che hanno
difficoltà ad ottenere informazioni del settore pubblico europeo si rivolgono
altrove (USA o fonti private di dati) o rinunciano del tutto a sviluppare servizi
specifici. Gli utenti dell’informazione legale, ancora, denunciano la frequente
scarsità di elenchi e repertori delle categorie di informazione riutilizzabile
(elementi, questi, indispensabili al fine di favorire l’accesso, l’interscambio e la
fruibilità dei dati, accentuandone le possibilità di effettivo utilizzo e
valorizzazione, altrimenti soltanto teoriche).
La direttiva sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, insomma, ha
introdotto le condizioni di base che favoriscono tale pratica nell'Unione europea;
tuttavia i progressi effettuati in attuazione della direttiva sono difformi nei vari
Stati membri, sussistendo ancora grandi ostacoli alla sua piena implementazione.
Tra questi, soprattutto, la tendenza degli enti pubblici a recuperare il più possibile
i costi anziché guardare ai vantaggi dell’economia nel suo complesso, attraverso
l’applicazione di politiche tariffarie limitate ai costi marginali; barriere di natura
tecnologica, che si traducono nella difficoltà a rendere informazioni e dati
pubblici effettivamente disponibili in formato elettronico e a indicizzare tali
informazioni in elenchi completi e facilmente consultabili; ostacoli di tipo
giuridico, legati ad una situazione di scarsa chiarezza ed estrema disomogeneità
sia rispetto ai diritti di proprietà intellettuale di cui gli enti pubblici siano titolari
sia relativamente agli usi consentiti della PSI gravata dagli stessi.
In particolare, le difficoltà giuridiche in materia di proprietà intellettuale appaiono
legate alla lettera della direttiva, che, da un lato, “lascia impregiudicate
l’esistenza o la titolarità di diritti di proprietà intellettuale da parte degli enti
pubblici e non limita in alcun modo l’esercizio dei diritti al di là di quanto da
287 In Francia il settore dell'informazione giuridica è uno dei più dinamici nel mercato dell'informazione digitale professionale, mercato che registra una forte crescita, pari al 17% nel

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
147
essa stabilito”, ma che, dall’altro, conclude in modo alquanto contraddittorio
affermando che “gli enti pubblici dovrebbero comunque esercitare il proprio
diritto d’autore in maniera tale da agevolare il riutilizzo”288.
Questa situazione di scarsa chiarezza circa lo status della PSI sotto il profilo dei
diritti di proprietà intellettuale - che inevitabilmente finisce per frustrare la
capacità dei cittadini di valutare quali usi dell’informazione pubblica siano
consentiti e zavorra pesantemente quella produzione di valore aggiunto che la
direttiva 2003/98/CE intende incoraggiare – si trova condivisa dalla pressoché
totalità degli Stati membri e appare particolarmente marcata nel contesto
nazionale: evidenza di ciò emerge dalla ricerca che si è pensato di condurre su
alcuni siti web istituzionali italiani (v. par. 2.1 cap. II), la quale segnala una
tendenza degli enti pubblici a formulare riserve molto estese e secondo modalità
variabili (che, spesso, impongono agli utenti un’attività di ricerca non agevole né
immediata).
Se parte della dottrina denuncia il carattere insoddisfacente della direttiva, poiché
con essa - frutto del compromesso tra Stati membri fautori dell’open access e
altri, invece, più ancorati a logiche di tipo proprietario – l’Europa avrebbe perduto
l’opportunità di sottrarre l’informazione pubblica, una volta per tutte, ai diritti di
esclusiva, altri studiosi, per converso, enfatizzano la possibilità di rifondare, sugli
stessi diritti di proprietà intellettuale, paradigmi alternativi di gestione
dell’informazione pubblica.
E’ proprio all’insegna di tale seconda impostazione che, in anni recenti, diversi
governi hanno manifestato un interesse crescente rispetto all’opportunità di
adottare modelli informativi più “aperti”, in grado di semplificare le modalità di
accesso e riutilizzo dei contenuti digitali resi disponibili dalle amministrazioni. In
particolare, l’attenzione degli enti pubblici di diversi paesi si è concentrata sulle
potenzialità offerte, in questa direzione, dall’insieme di licenze Creative
Commons e dal modello “alcuni diritti riservati” ad esso sotteso.
Dal confronto critico tra il regime di riutilizzo tracciato dalla direttiva 2003/98/CE
e il modello Creative Commons, risultano individuabili, in tale modello, numerosi
elementi non soltanto di compatibilità, ma piuttosto di convergenza con i principi
2007, dovuta all'elevato valore aggiunto. Serda GFII, comunicato stampa del 27 gennaio 2009.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
148
ispiratori della normativa sul riutilizzo: innanzitutto, la non discriminatorietà e
non esclusività delle licenze Creative Commons, assieme al loro carattere
standardizzato, quindi la promozione di pratiche di licenza on-line e la
facilitazione della ricerca di contenuti disponibili per il riutilizzo.
In particolare, le risultanze di una ricerca del 2006 finanziata dallo stato
australiano del Queensland, che ha determinato in una percentuale prossima
all’85% la porzione di informazione pubblica licenziabile secondo detto
schema289, sono corroborate dalle conclusioni dello studio pubblicato nel gennaio
2008 dall’Instituut voor Informatierecht (IViR) dell’Università di Amsterdam in
collaborazione con CC Nederland290, centrato sull’analisi comparativa degli
elementi di compatibilità tra il set di licenze Creative Commons - e i principi cui
le stesse si richiamano - e l’ambito dell’informazione pubblica, sotto il duplice
aspetto dell’accesso alla PSI e del riutilizzo della stessa, quale regolamentato dalle
disposizioni della direttiva 2003/98/CE.
Sebbene alcune licenze Creative Commons (in particolare, la Non-Commercial e
Non-Derivative) manifestino una scarsa compatibilità con gli obiettivi del
riutilizzo, risulta che tale modello potrebbe agevolmente essere applicato al
nucleo più consistente della PSI e, quindi, affiancato da un numero limitato di
licenze standard, elaborate dalle amministrazioni e applicabili all’informazione
non compatibile con detto schema (per ragioni inerenti alla tutela dei dati
personali, alla natura confidenziale dell’informazione o, ancora, al suo particolare
valore commerciale).
Per ciò che riguarda l’altra principale questione giuridica in esame, ossia quella
relativa alle necessità di contemperamento tra gli obiettivi di crescita economica
associati al riutilizzo e i principi relativi alla tutela dei dati personali - quali
288 Cfr. il testo del considerando 22 della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. 289 Queensland Spatial Information Office, Office of Economic and Statistic Research, Queensland Treasury, Government Information and Open Content Licensing: An Access and Use Strategy. Government Information Licensing Framework Project Stage 2 Report, October 2006, pp. 87, disponibile al sito www.qsic.qld.gov.au. Si rimanda, altresì, alle conclusioni di INTRALLECT Ltd, AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, University of Edinburgh, The Common Information Environment and Creative Commons. Final Report to the Common Information Environment Members of a study on the applicability of Creative Commons Licenses, October 2005. 290 VAN EECHOUD M., VAN DER WAL B., Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, Institute for Information Law, University of Amsterdam, 2008.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
149
delineati, innanzitutto, nella direttiva 46/95/CE - risultano ribaditi i principi
fondamentali del trattamento dei dati personali, quali, in primo luogo, il consenso
dell’interessato e la compatibilità del riutilizzo dei dati personali con gli scopi che
ne hanno giustificato la raccolta. In questo senso, la licenza di riutilizzo si
configura come lo strumento attraverso il quale l’amministrazione impone al
contraente/riutilizzatore limiti ed oneri idonei ad affrontare queste esigenze, in
alcuni casi limitando lo spettro delle attività di riutilizzo (ad esempio, escludendo
del tutto riusi commerciali), in altri imponendo oneri di informazione nei
confronti degli interessati, ovvero regolamentando il riutilizzo incrociato di dati
personali provenienti da una pluralità di fonti informative pubbliche, anche con
l’esigenza di evitare un impoverimento della qualità dei dati.
In esito all’indagine in oggetto, dunque, pare potersi affermare, in consonanza con
le conclusioni del documento di riesame pubblicato nel maggio 2009, che la
direttiva 2003/98/CE ha avuto effetti complessivamente positivi nel predisporre
una situazione di stimolo al riutilizzo, benché tanto gli enti pubblici quanto le
imprese private non siano del tutto consapevoli delle proprie responsabilità e
diritti e delle opportunità che si offrono loro291. Come rimarcato in più occasioni,
comunque, i limiti della normativa sul riutilizzo si annidano non soltanto nelle
responsabilità delle amministrazioni, ma anche, ed in misura determinante, nel
carattere compromissorio della direttiva del 2003, che rinuncia a tracciare un
quadro normativo autenticamente omogeneo in materia di riutilizzo nel momento
in cui fa salvi i regimi nazionali d’accesso, che si pongono, nella loro diversità, a
discrimine delle opportunità di riutilizzo.
Appare necessario, dunque, che entro la prossima procedura di riesame della
direttiva, programmata dalla Commissione per il 2012 (e che contempla la
possibilità di estendere l’ambito d’applicazione della stessa, tenendo presenti i
progressi nel frattempo compiuti), gli Stati membri si impegnino a fondo per dare
291 I riutilizzatori propongono di modificare la direttiva per renderla più rigorosa. Tra i suggerimenti si propone di ampliare il campo d'applicazione, obbligare gli enti pubblici ad autorizzare il riutilizzo, imporre una tariffazione basata sui costi marginali, chiedere l'istituzione di autorità di regolamentazione e/o meccanismi di risoluzione delle controversie, chiarire i compiti di servizio pubblico, redigere elenchi/repertori delle informazioni nazionali ed obbligare gli Stati membri a presentare alla Commissione relazioni annuali. Chiedono infine precisazioni su alcuni termini utilizzati nella direttiva ritenuti ambigui, come la definizione di documenti, compiti di servizio pubblico, tariffazione basata sui costi marginali e congruo utile sugli investimenti.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
150
piena e corretta attuazione alla normativa, adottando schemi di licenza e di
tariffazione volti a favorire la disponibilità e il riutilizzo della PSI, garantendo la
parità di condizioni tra enti pubblici ed altri soggetti nelle attività di riutilizzo,
nonché promuovendo meccanismi di risoluzione delle controversie rapidi e poco
costosi.
Muovendo dal riconoscimento del ruolo insostituibile che il settore pubblico gioca
nella promozione dell’accessibilità e dell’attribuzione di valore aggiunto
all’informazione pubblica, si auspica, in conclusione, che il presente lavoro di
ricerca abbia offerto un modesto contributo al dibattito nascente in tema di riuso
della PSI, quale elemento di trasparenza democratica, da un lato, e competitività
economica (sul piano nazionale e locale, prima ancora che europeo), dall’altro:
obiettivi, entrambi, imprescindibilmente legati alla percezione, e dunque alla
valorizzazione, del patrimonio informativo pubblico come autentico common292.
292 Sulla nozione di commons, relazionata al concetto e alla filosofia del pubblico dominio, v. J. BOYLE, The Second Enclosure Movement and the construction of Public Domain, in Law & Contemporary Problems, vol. 63, 2003, p. 33 ss e D. BOLLIER in Silent Theft. The Private Plunder of our Common Wealth , Routledge, 2003, p. 15-55, ma anche le analisi condotte da E. M. SALZBERGER, Economic Analysis of the Public Domain e da P. SAMUELSON, Challenges in Mapping the Public Domain in GUIBAULT, HUGENHOLTZ (a cura di), The Future of the Public Domain, cit., rispettivamente pp. 27-57 e 7-21. Un’analisi illuminante del ruolo dei commons è quella svolta dall’economista premio Nobel 2009 Elinor Ostrom, in E. OSTROM, Reformulating the Commons, Swiss Political Science Review, 6(1), 2000, p. 29-52.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
151
BIBLIOGRAFIA A.A. V.V., (V. ITALIA coordinatore), Codice della Privacy, Commento al Decreto Legislativo 196/2003, n. 196 aggiornato con le più recenti modifiche legislative, vol. I, Giuffrè Editore, 2004; ALIPRANDI S., Copyleft & Opencontent. L’altra faccia del copyright, PrimaOra, Lodi, 2005; ALIPRANDI S., Creative Commons: manuale operativo. Guida all’uso delle licenze e degli altri strumenti, Stampa Alternativa, Milano, 2008; ALLEN A., Uneasy Access: Privacy for Women in a Free Society, Rowman and Littlefield, Totowa, N. J., 1988; ARENA G., BOMBARDELLI M., Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in V. CERULLI IRELLI (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 2006, pp. 420-435; AUTERI P., FLORIDIA G., MANGINI V., OLIVIERI G., RICOLFI M., SPADA P., Diritto Industriale. Proprietà Intellettuale e Concorrenza, III ed., Giappichelli Editore, Torino, 2009; BANISAR D., Freedom of Information Around the World 2006: A Global Survey of Access to Government Records Laws, disponibile al sito: www.freedominfo.org/documents/global_survey2006.pdf; BEERS M.C., Public Access to Government Information towards the 21st Century, in KORTHALS ALTES W.F., DOMMERING E.J., HUGENHOLTZ P.B., KABEL J.J.C. (a cura di), Information Law Towards the 21st century, Kluwer Law International, L’Aja, 1992, pp. 177-195; BENTLY L., SHERMAN B., Intellectual Property Law, Oxford University Press, 2009; BIRKINSHAW P., Freedom of Information: the Law, the Practice and the Ideal, II ed., Butterworths, London, 1996; BIRKINSHAW P., HICKS A., The Law and Public Information on UK. Quality, Access and Re-use, Diritto Pubblico, n. 3, 2007, pp. 959-990; BOLLIER D., in Silent Theft. The Private Plunder of our Common Wealth , Routledge, 2003;
BOYLE J., The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind, Yale University

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
152
Press, 2008; BOYLE J., The Second Enclosure Movement and the construction of Public Domain, in Law & Contemporary Problems, vol. 63, 2003; BURDON M., Commercializing Public Sector Information: Privacy and Security Concerns, IEEE Technology and Society Magazine, 28 (1), 2009, pp. 34-40; BURDON M., Profiting from personal information: Power, information, privacy and evidence based policy, in Proceedings from the Third Workshop on Social Implications of National Security, Canberra, 2008; BURKERT H., The Mechanics of Public Sector Information, in AICHHOLZER G., BURKERT H. (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age. Between Markets, Public Management and Citizen’s Rights, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2004, pp. 3-19; CARDARELLI F., Le banche dati pubbliche: una definizione, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, Giuffrè, 2/2002, pp. 320-335; CASCIONE C. M., Il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 1/2005, pp. 1-26; CAWS-ELWITT H., Copyright, Competition and Reselling of Government Information: Impact on Dissemination, Katharine Sharp Law Review, n. 7, 1998, pp. 1-10; CERRILLO I MARTINEZ A., GALAN GALAN A., La reutilización de la información del sector público, Comares, Granada, 2006; CERRILLO MARTINEZ A., Reseña de la Jornada sobre la Reutilización de la Información del Sector Público, Revista de Internet, Derecho y Politica, UOC, 2006; CHIMIENTI L., Banche dati e diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 1999; COLE D., DEMPSEY J.X., Terrorism and the Constitution: Sacrificing Civil Liberties in the Name of National Security, Norton, New York, 2002; COX N., Copyright in Statutes, Regulations and Judicial Decisions in Common Law Jurisdictions: Public Ownership or Commercial Enterprise?, Statute Law Review, 27(3), 2006, pp. 185-208; CURTIN D.M., Citizen’s fundamental right of access to EU information: an evolving digital passepartout?, in Common Market Law Review, 2000, pp. 7-41; CURTIN D.M., DEKKER I., Good Governance: The Concept and its Application by the European Union, in CURTIN D.M., WESSEL R.A., Good Governance and the European Union. Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia, 2005, pp. 3-19.

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
153
DAVIES R., (MDR Partners), Economic and Social Impact of the Public Domain: EU Cultural Institution and PSI Directive, 5 maggio 2009, in: http://www.epsiplatform.eu/psi_library/reports/economic_and_social_impact_of_the_public_domain_eu_cultural_institutions_and_the_psi_directive_may_2009; DAVIS R. W., Public Access to Community Documents: a Fundamental Human Right?, European Integration online Papers, vol. 3, nr. 8, 1999, disponibile al sito http://eiop.or.at/eiop/texte/1999-008.htm; DAVISON M., Database Protection: The Commodification of Information, in GUIBAULT L., HUGENHOLTZ P.B. (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, Kluwer Law International, L’Aja, 2006; DAVISON M.J., HUGENHOLTZ P.B., Football fixtures, horse races and spin-offs: the ECJ domesticates the database right, European Intellectual Property Review, n. 3, 2005, pp. 113-118; D’ELIA I., La diffusione e il riutilizzo dei dati pubblici. Quadro normativo comunitario e nazionale: problemi e prospettive, Informatica e diritto, 1/2006, pp. 7-46; DE VRIES, M., Summaries of the Italian Cases on Directive 2003/98/EC, in http://www.epsiplus.net/cases/italy_legal_issues_and_cases_psi_re_use_cadastral_and_mortgage_data ; DEL NINNO A., La tutela dei dati personali, Guida pratica al Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196), Cedam, 2006; DERCLAYE E., Case Comment. Of Maps, Crown Copyright, Research and the Environment, European Intellectual Property Law Review, 30(4) 2008, pp. 162-164; DERCLAYE E., Does the Directive on the Re-use of Public Sector Information affect the State’s database sui-generis right ?, in Gaster J., Schweighofer E. & Sint P., Knowledge Rights – Legal, societal and related technological aspects, Austrian Computer Society, 2008, pp. 137- 169; DERCLAYE E., The Legal Protection of Databases: A Comparative Analysis, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2008; ELKIN-KOREN N., Exploring Creative Commons: A Skeptical View of a Worthy Pursuit, in GUIBAULT L., HUGENHOLTZ P.B. (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, Kluwer Law International, L’Aja, 2006, pp. 325-345; EPPLER M., Managing Information Quality. Increasing the Value of Information in knowledge-intensive Products and Processes, second revised and extended edition, Springer, Berlin/New York, 2006;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
154
FANTIGROSSI U., I dati pubblici tra Stato e mercato, in Amministrare, Il Mulino, 1/2007, pp. 277-294; FITZGERALD B., Access to PSI: Policy, Law and Technology, 5th Communia Workshop, Accessing, Using, Re-using Public Sector Content and Data, London, 26-27 March 2009; FLORIDI L., Infosfera. Etica e filosofia nell’età dell’informazione, Digitalica, Giappichelli, Torino, 2009; FRIED C., Privacy: A Rational Context, in M. D. ERMANN, M. B. WILLIAMS, C. GUTIERREZ (a cura di), Computers, Ethics and Society, Oxford University Press, New York, 1990; GAVISON R., Privacy and the Limits of the Law, in Yale Law Journal, 1980, 89, pp. 421-471; GELLMAN R., Public Records -Access, Privacy and Public Policy, Government Information Quarterly, vol. 12(4) 1995, pp. 391-426; GELLMAN R., The Foundations of United States Government Information Policy, in AICHHOLZER G., BURKERT H. (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, Cheltenham-Northampton, 2004, pp. 123-136; GELLMAN R., Twin Evils: Government Copyright and Copyright-Like Controls over Government Information, Syracuse Law Review, (45)1995, pp. 999-1072; HARDIN G., The Tragedy of the Commons, in Science, vol. 162, pp. 1243-1248, 1968; HELLER M.A., The Tragedy of the Anticommons, in Harvard Law Review, 111 (3), January 1998, pp. 622-688; HELM (UK), ZENC (NL), Mepsir Study (Measuring European Public Sector Information Resources), Final Report of Study on Exploitation of Public Sector Information - benchmarking of EU framework conditions, 2006; HINS A.W., VOORHOOF D., Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights, European Constitutional Law Review, 1-2007, pp. 114-126; HUGENHOLTZ B.P., Owning Science. IPR's as Impediments to Knowledge Sharing, 2nd Communia Conference, Global Science & Economics of Knowledge-Sharing Institutions, Torino, 29 giugno 2009, disponibile su http://www.communia-project.eu; INTRALLECT LTD., AHRC Research Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, University of Edinburgh, The Common Information Environment and Creative Commons. Final Report to the Common Information Environment Members of a study on the applicability of Creative Commons Licenses, October 2005;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
155
JANSSEN K., INSPIRE and the PSI Directive: public task versus commercial activities?, Proceedings of the 11th EC GI & GIS Workshop, Alghero, Sardinia, 29th june 2005; JANSSEN K., DUMORTIER J., Towards a European Framework for the Re-Use of Public Sector Information: A Long and Winding Road, International Journal of Law & Information Technology, vol. 11, n. 2, 2003, pp. 184-201; JUDGE E.F., Crown Copyright and Copyright Reform in Canada, in M. GEIST (ed), In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law, Irwin Law, September 2005, pp. 550-594; KRANENBORG H.R., STOLK P.J., TUNOVIC A., VOERMANS W.J.M. (a cura di), Transparency in Europe II, Ministry of the Interior and Kingdom Relations Constitutional Affairs and Legislation Department, The Hague, 2005; LAVARCH L., CUNNINGHAM S., Government and Creative Commons, in FITZGERALD B., Open Content Licensing: Cultivating the Creative Commons, Sidney University Press, 2008; LEE W.Y., D.M. STRONG, KAHN B.K., WANG R.Y., a Methodology for Information Quality Assessment, in Information and Management, 40, 2002, p. 133-146; LEITH P., MCCULLAGH K., Developing European Legal Information Market based on Government Information, International Journal of Law & Information Technology, vol. 12, n.3, 2004, pp. 247-281; LESSIG L., Il futuro delle idee, Feltrinelli, Milano, 2006; LESSIG L., Privacy as property, in Social Research, 2002, 69, p. 247-269; LESSIG L., Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni), Etas, 2009; LITMAN J., Information Privacy/ Information Property, Stanford Law Review, vol. 52(5), 2000, pp. 1283-1313; LLOYD, I.J., Information Technology Law, Oxford University Press, New York, 2008; LONGHORN R., BLAKEMORE M., Re-visiting the Valuing and Pricing of Public Sector Information, Journal of Digital Information, vol. 3, n. 2, 2003, pp. 1-27; MC DONAGH M., European Access Legislation: Consistence or Divergence?, in AICHHOLZER G., BURKERT H., Public Sector Information in the Digital Age. Between Markets, Public Management and Citizen’s Right, Edward Elgar Publishing, Celtenham, 2004, pp. 108-122.
MANTELERO A., Il costo della privacy tra valore della persona e ragione

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
156
d’impresa, Milano, Giuffrè, 2007; MENDEL T., Freedom of Information: A Comparative Legal Survey, Unesco Publishing, 2008; MEZZACAPO S., The Right of Access to Public Bodies’ Records in Italy and UK: “Actio ad Exhibendum” and Freedom of Information. Risks and Opportunities for Private Companies, European Business Law Review, 2006, pp. 959-979; MEZZETTI C.E., Dati pubblici ed abuso di posizione dominante, nota a commento delle ordd. Trib. App. di Milano, 2 maggio e 5 luglio 2005, in Giur. It., III, 2006, 549 ss; MICUS Management Consulting GmbH, Assessment of the Re-use of Public Sector Information (PSI) in the Geographical Information, Meteorological Information and Legal Information Sectors, 2009; MOWBRAY A., The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, Oxford, 2004; MURACA A. (CSI Piemonte), Progetti di Riutilizzo dei Dati Regionali in Piemonte, ePSIplus Meeting Italia, Roma, 13 febbraio 2009; OPSI (Office of Public Sector Information), The United Kingdom Report on the Re-use of Public Sector Information. Unlocking PSI Potential, 2009, consultabile al sito: http://www.opsi.gov.uk/advice/psi-regulations/uk-report-reuse-psi-2009.pdf; OSTROM E., Reformulating the Commons, Swiss Political Science Review, 6(1), 2000, p. 29-52; OXERA Consulting Ltd., Public Information, Private Profit: How Should Government Agencies Compete?, 2005; PAGALLO U., La Tutela della Privacy negli Stati Uniti d’America e in Europa. Modelli giuridici a confronto, Giuffrè, Milano,2008; PAPAPAVLOU G., Public Sector Information Initiatives in the European Union, UNESCO Infoethics, 2000; PARENT W.A., Privacy, Morality and the Law, in Philosophy and Public Affairs, 1983, 12, 4, p. 269-288; PAS J., DE VUYST B., Re-Establishing the Balance Between the Public and the Private Sector: Regulating Public Sector Information Commercialization in Europe, The Journal of Information, Law and Technology, (2)2004; PAS J., DE VUYST B., The Use and Re-use of Government Information from an EU Perspective, Proceedings of the 37th Hawaii International Conference on System

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
157
Sciences, 2004; PAS J., RECHTEN L., The commercialization of Government Information and the Proposal for a Directive (2002) 207 by the European Commission, Murdoch University Electronic Journal of Law, vol.9, n. 4, 2002; PERRY, Acts of Parliament: Privatisation, Promulgation, Crown Copyright — is there a need for a Royal Royalty?, New Zealand Law Review, 1998, p. 493-529; PETTIFER R.E.W., Towards a Stronger European Market in Applied Meteorology, Meteorological Applications, 15, 2008, pp. 305-312; PIRA INTERNATIONAL, Commercial Exploitation of Public Sector Information, Final Report for the European Commission, Directorate General for the Information Society, 2000; PONTI B. (a cura di), Il patrimonio informative pubblico come risorsa. I limiti del regime italiano di riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, Diritto Pubblico, n.3/2007, pp. 991-1014; PONTI, B. (a cura di), Il Regime dei Dati Pubblici. Esperienze europee e ordinamento nazionale, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2008; QUEENSLAND SPATIAL INFORMATION COUNCIL, Government Information and Open Content Licensing: An Access and Use Strategy, reperibile in www.qsic.qld.gov.au, 2006; QUINTON C. G., Access to European Public Sector Information: Reconciling the Access Needs of Administrative Transparency and the Information Market, Cardozo Electronic Law Bulletin, vol.3 (18)1997; RAAB C.D., Privacy Issues as Limits to Access, in AICHHOLZER G., BURKERT H. (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2004, pp. 23-46; REDOLFI D. , VEUTRO F., La tutela giuridica delle banche dati della pubblica amministrazione, Milano, 1999, in http://www.interlex.it/copyright/redolfi2.htm; RENNA M., Voce Beni Pubblici, in CASSESE S., Dizionario di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, Vol. I, p. 714-725; RENNA M., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Giuffrè, Milano, 2004; RICCI S., Note in tema di “Riutilizzo dell’Informazione Pubblica” e Diritto alla Privacy, rivista telematica www.federalismi.it, n. 15/2005; RICOLFI M., Individual and collective management of copyright in a digital environment, in TORREMANS P. (a cura di), Copyright law. A Handbook of

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
158
Contemporary Research, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2008, pp. 282-314; RODOTA’ S., Intervista su privacy e libertà, Laterza, Roma-Bari, 2005; SALZBERGER E.M., Economic Analysis of the Public Domain, in GUIBAULT L., HUGENHOLTZ P.B. (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, Kluwer Law International, L’Aja, 2006, pp. 27-57; SAMUELSON P., Challenges in Mapping the Public Domain, in GUIBAULT L., HUGENHOLTZ P.B. (a cura di), The Future of the Public Domain. Identifying the Commons in Information Law, Kluwer Law International, L’Aja, 2006, pp. 7-25; SAMUELSON P., Mapping the Digital Public Domain: Threats and Opportunities, Law and Contemporary Problems, 66, 2003, pp. 147-171; SAMUELSON P., Privacy as Intellectual Property, Stanford Law Review, (52)2000, pp. 1125-73; SAXBY S., Crown Copyright Regulation in the UK – Is the Debate Still Alive?, International Journal of Law & Information Technology, vol.13, n.3, 2005, pp. 299-335; SAXBY S., Information Access Policy and Crown Copyright Regulation in the Electronic Age – Which way forward?, International Journal of Law & Information Technology, vol. 6, n.1, 1998, pp. 1-33; SAXBY S., The Development of UK Government Policy Towards the Commercialization of Official Information, International Journal of Law & Information Technology, vol. 4, n.3, 1996, pp. 199-233; SCHRAM F., Executive transparency in Belgium, in Freedom of Information Review, 2001, p. 34-41; SECRETARIA DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES, Guía Aporta sobre reutilización de la información del sector público, Madrid, Mayo 2009, www.aporta.es; SOMOGY D.J., Information Brokers and Privacy ,in I/S: A Journal of Law and Policy for the Information Society, 1 (2/3), 2006, p. 901-925; SUSSKIND R., The Public Domain and Public Sector Information, in C. WAELDE, H. MACQUEEN (a cura di), Intellectual Property. The Many Faces of the Public Domain, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2007, p. 150-182; TAVANI H., Philosophical Theories of Privacy: Implications for an Adequate Online Privacy Policy, in “Metaphilosophy”, 2007; TORREMANS P., Intellectual Property and Human Rights: Enhanced Edition of Copyright and Human Rights, Kluwer Law International, L’Aja, 2008;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
159
UHLIR P. (Rapporteur), The socioeconomic Effect of Public Sector Information on Digital Networks. Toward a Better Understanding of Different Access and Reuse Policies. Workshop Summary, The National Academy Press, Washington, 2009; VAN DER BOOMEN M., SCHAEFER M.T., Will the Revolution be open-sourced? How open source travels through society, in WYNANTS M., CORNELIS J. (a cura di), How open is the future? Economic, Social & Cultural Scenarios inspired by Free & Open-Source Software, VUB Brussel University Press / Cross Talk, Bruxelles, 2005; VAN EECHOUD M., Does the Public Sector Information Directive Deliver , 5th Communia Workshop, “Accessing, Using, Re-using Public Sector Content and Data”, London, 26-27 March 2009; VAN EECHOUD M., The commercialization of Public Sector Information: Delineating the Issues, in GUIBAULT L, HUGENHOLTZ P.B., (a cura di), The future of the public domain: identifying the commons in information law, Kluwer Law International, L’Aja, 2006, pp. 279-300; VAN EECHOUD M., VAN DER WAL B., Creative Commons licensing for Public Sector Information: Opportunities and Pitfalls, Institute for Information Law, University of Amsterdam, 2008, pp. 99; VICTORIA, (Parliament of), Economic Development and Infrastructure Committee Inquiry into Improving Access to Victorian Public Sector Information and Data Discussion Paper, 2008; VISSER D.J.G., The Database Right and the spin-off theory, in SNIJDERS, WEATHERILL (a cura di), E-commerce Law, Kluwer Law International, L’Aja, 2003, pp. 105-110; VOLMAN V.Y., Expoitation of Public Sector Information in the Context of the eEurope Action Plan, in AICHHOLZER G., BURKERT H. (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2004, pp. 93-107; WANG R.Y., D. M. STRONG, Beyond Accuracy. What data quality means to data consumers, in Journal of Management Information Systems, 1996; WANG R. Y., STRONG D. M., GUARASCIO L., An Empirical Investigation of Data Quality Dimensions. A Data Consumer’s Perspective, working paper TDQM-94-01, MIT, Cambridge (Ma), 1984; WARREN S., L. BRANDEIS, The Right to Privacy, in Harvard Law Review, 1890, 14, pp. 193-220; WEISS P.N., Conflicting PSI Policy and their Economic Impacts, in AICHHOLZER G., BURKERT H. (a cura di), Public Sector Information in the Digital Age, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton, 2004, pp. 137-160;

Il riutilizzo della PSI tra diritti di proprietà intellettuale e privacy
160
ZENO ZENCOVICH V., Uso a fini privati di dati personali in mano pubblica, Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, 2/2003, pp. 197-218;