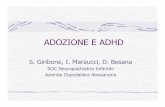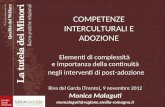Un’eredità del progetto di adozione sociale a Napoli: la ... ACP Campania Su questa rivista...
Transcript of Un’eredità del progetto di adozione sociale a Napoli: la ... ACP Campania Su questa rivista...
241
elementare, di madri adolescenti e di madriche sfuggono ai controlli di prevenzione ingravidanza. Pochissimi bambini sono sot-toposti alla vaccinazione antimorbillo-paro-tite-rosolia, come scrive Giuseppe Cirilloin Salute e Territorio (2002;133:202).Le origini contadine del quartiere si sonoperse con l’urbanizzazione, accelerata dalterremoto del 1980, in seguito al qualemolte famiglie di senza-tetto furono siste-mate a Secondigliano in una specie di ghet-to, il Rione dei Fiori, ribattezzato dagli abi-tanti stessi “Terzo Mondo”, per l’alta con-centrazione di soggetti marginali e per lacarenza di servizi essenziali. L’attuale so-vraffollamento, l’invivibilità dello spaziourbano, la carenza di opportunità di lavoroe di aggregazione, la povertà, sono allabase del diffuso comportamento asociale eaggressivo e anche del rifiuto di ogni nor-ma, che caratterizza soprattutto i giovani.Ne è prova, tra tante, la frequente vandaliz-zazione degli istituti scolastici. La scuolanon riesce a far raggiungere ai più disagia-ti l’obiettivo di base di imparare a leggere,scrivere e far di conto. Per i bambini nonesistono opportunità diverse dalla strada edalla televisione ed è difficile dire qualeprospettiva sia più nociva al loro sviluppo.
L’azione del ComuneIn questo scenario da 7-8 anni si vannoinserendo i progetti comunali finalizzati apromuovere azioni di contrasto all’abuso,al maltrattamento, all’emarginazione e nel-lo stesso tempo a dare a centinaia di ragaz-zi opportunità di gioco e di conoscenza inambienti sani e protetti. Napoli, primo Co-mune in Italia, ha varato il Piano Territo-riale d’intervento per l’infanzia e l’adole-scenza, finanziato dalla legge 285/97 e rea-lizzato da una rete collaborativa tra le A-genzie delle Istituzioni (Assessorati, Prov-veditorato agli Studi, ASL Napoli 1, CentroGiustizia Minorile, ecc.) e quelle del TerzoSettore, che in Campania sostengono circal’80% degli interventi in favore dell’infan-zia. Il Piano è stato progettato con una spe-cifica attenzione ai gruppi socialmentesvantaggiati che vivono nelle periferie,
Per corrispondenza:Roberta Arsierie-mail: [email protected]
AbstractAn heritage from the social adoption project in Naples: Secondigliano’s (Naples) toy libraryStarting from the social adoption project realized in Naples in the 1990’s many expe-riences regarding socially disadvantaged children were born. Among these a toylibrary in Secondigliano (Naples) in order to support mothers and all children livingin the area. The toy library’s activities are basically three: the “Nati per Leggere” pro-ject for children from 6 months to 6 years of age, “Storie in gioco” for older children(6-12 years) and “Leggere per…” for adolescents and adults. Quaderni acp 2005; 13(6): 242-243Key words Social risk. Social assistance. Mother-child health
Dal progetto di adozione sociale realizzato a Napoli negli anni Novanta sono natemolte esperienze nel campo dell’assistenza ai bambini a rischio sociale. Viene illu-strata l’esperienza della ludoteca di Secondigliano, sede di un intervento di sostegnoalle madri e ai bambini dedicato alle madri, ai bambini e ai giovani del quartiere.L’attività della ludoteca si fonda su tre ambiti: “Nati per Leggere”, dedicato alla fa-scia di età 6 mesi-6 anni; “Storie in gioco”, per i ragazzi di 6-12 anni; “Leggereper…”, per ragazzi, giovani e adulti.Parole chiave Rischio sociale. Assistenza sociale. Salute materno-infantile
Quaderni acp 2006; 13(6): 241-242
Un’eredità del progetto di adozione sociale a Napoli: la ludoteca di SecondiglianoRoberta ArsieriPediatra, ACP Campania
Su questa rivista (Quaderni acp 2003;3:10)è stato illustrato il progetto di adozionesociale realizzato a Napoli. Si era annun-ciato che da quel progetto erano nate moltealtre esperienze sul campo. Questa cheviene presentata ha mosso i primi passi inquegli anni in cui il Comune di Napoli rap-presentava un vero e proprio laboratorio dinuove idee, ed era un punto di riferimentoprezioso per tanti operatori.
Il contestoSecondigliano, abitato nel Medioevo dacontadini, vassalli di nobili feudatari primae della curia arcivescovile dopo, era un vil-laggio quasi inaccessibile fino al 1500. Inepoca aragonese fu sottoposto a bonificadelle paludi e furono realizzati tracciatiurbanistici più geometrici e meno casualiche portarono alla configurazione del“casale”, un insieme di masserie, circonda-te da campi. In ogni masseria le case eranoarticolate intorno a una corte dove si svol-gevano tutte le attività di lavorazione deiprodotti della terra e si macellavano lecarni. In ogni casa c’era un telaio: i fittuarilavoravano il lino, la canapa e la seta daloro stessi coltivati. La vendita di vino,pane, salumi, formaggi, tessuti, frutta e
verdure nel mercato locale o in quelli diNapoli garantiva la sussistenza e serviva apagare le tasse. Benché vivesse in schiavitùeconomica, la popolazione aveva la terrada coltivare, le attrezzature e una casa. Allafine del XIX secolo gli abitanti erano circa8000 e Secondigliano rimase comune su-burbano, con relativa autonomia ammini-strativa, fino al 1929, quando entrò a farparte del Comune di Napoli.Oggi Secondigliano è il risultato di un pro-cesso di crescita edilizia all’interno dellenumerose masserie, copre una superficie di2,94 km2, vi risiedono 51.000 abitanti,17.392 per km2. È un quartiere di giovani:il tasso di natalità è 12,3‰, il 38% degliabitanti ha meno di 25 anni, i ragazzi da 5a 14 anni sono circa 6000 e l’indice di vec-chiaia è al 62%; è tra i più bassi dellaCampania.A questi dati positivi fanno riscontro unalto tasso di disoccupazione giovanile e unbasso livello medio di scolarizzazionedegli abitanti. Il tasso di disagio scolasticoriguarda l’11‰ degli scolari del primociclo e il 146‰ di quelli del secondo ciclo.Nel quartiere si registrano le più alte per-centuali della città di madri con livello diistruzione uguale o inferiore alla quinta
senza escludere la necessaria integrazionecon altri bambini che, pur godendo didiscrete condizioni socio-economiche,vivono in contiguità con il rischio sociale e,per questo, rischiano di essere segregatidavanti alla TV o di uscire, tenuti permano, come detenuti in libertà vigilata.Pian piano, mediante una rete collaborativatra istituzioni e terzo settore, si sono molti-plicate iniziative che hanno coinvolto unelevato numero di ragazzi, ma si è ancoramolto lontani dall’obiettivo di raggiungeretutti i potenziali utenti.
La collaborazione tra ACPe Terzo SettoreNel 1995, in risposta alla sollecitazione delSindaco, che chiedeva alla società civile diassumere un ruolo di cittadinanza attiva epropositiva, è nata l’Associazione “Labo-ratorio Città Nuova” (LCN), che ha indivi-duato come ambiti di intervento la riduzio-ne del disagio sociale e la riqualificazionedelle periferie urbane. In questi 8 anni ilLCN ha realizzato numerose iniziative, trale quali le più significative sono la biblio-teca di quartiere “G. Mazzacurati” di Ba-gnoli, dotata di circa 10.000 volumi, e laludoteca di Secondigliano. Il LCN annove-ra tra i suoi soci anche alcuni pediatri chenel 1995 hanno collaborato con l’ACP auno studio pilota sul Progetto di adozionedel bambino a rischio sociale (RS) nelDistretto 50, al quale appartiene Se-condigliano. Il Progetto di adozione socia-le è stato esteso, successivamente, a tuttal’utenza metropolitana. Nel LCN ci si è posti, quindi, l’interrogati-vo: e dopo? Anche se usufruisce di un sup-porto alla famiglia nei primi anni di vita,quali opportunità avrà un bambino a RSche cresce in uno dei quartieri più degrada-ti della periferia napoletana? È stato, quin-di, progettato un intervento di sostegno allemadri e ai bambini a RS che si collegasseall’adozione e con questo obiettivo è ini-ziata un’attività, che continua tuttora, dedi-cata alle madri, ai bambini e ai giovani delquartiere.Nel 1996, accolte in uno spazio antistantel’ambulatorio della pediatra del Consul-torio del Rione dei Fiori, Lina Di Maio,volontarie del LCN hanno aperto uno“sportello informativo per le madri” su per-corsi amministrativi, scolastici e sanitari, euno “spazio ludico” per l’intrattenimentodei bambini durante l’attesa della visitapediatrica. I colloqui con le madri sonostati l’occasione per parlare dei loro figli,
ma anche per discutere dei problemi legatialla vivibilità del quartiere, con l’intento difar crescere lo spirito di solidarietà e ildesiderio di cambiamento tra persone chevivono nelle stesse difficili condizioni. Levolontarie offrivano tempo alle madri,sostituendole nella cura dei bambini duran-te brevi assenze. Successivamente lo spa-zio ludico ha funzionato anche come ludo-teca per ragazzi a RS di 6-12 anni, segnala-ti dalla pediatra. Dal 1998 lo sportello e la ludoteca, allaquale i bambini hanno dato il nome “vu-limmo pazzià”, sono stati trasferiti in loca-li della Biblioteca Comunale “G. Dorso”,messi a disposizione dall’Assessorato allaDignità del Comune di Napoli. La ludoteca opera in rete con i ProgettiComunali (“La città in gioco”, “Ragazzi inCittà”, “Educativa Territoriale”) ed è aper-ta ogni pomeriggio per tre ore. Finora èstata frequentata da centinaia di ragazzi di6-12 anni, segnalati dalla pediatra, dai ser-vizi sociali, dalle scuole o venuti libera-mente. I ragazzi sono liberi di giocare o dipartecipare ai laboratori (colore, manipola-zione, preparazione di dolci, teatro, letturaanimata, ecc.); nei mesi estivi sono accom-pagnati in piscina, al mare o presso la strut-tura comunale di Marechiaro per soggiornieducativi e di svago. Nel rapporto con i ragazzi si cerca di porreattenzione alle loro modalità di comunica-zione, più gestuali che verbali, di interpre-tare l’aggressività o il silenzio, ambeduepossibili segnali di disagio, di migliorarnel’autostima e l’autonomia. Si privilegial’apprezzamento del percorso, piuttostoche la valutazione o la correzione del risul-tato ottenuto nello svolgimento di qualun-que attività. Gli operatori parlano in italia-no, ma usano il dialetto nel momento in cuioccorre stabilire la relazione.Eventuali problemi di salute fisici, (il piùfrequente è la pediculosi) o psichici sonodiscussi e affrontati con i genitori, la pedia-tra del Consultorio e la psicologa del Di-stretto Sanitario.Tutto ciò è stato ed è possibile per il con-tributo di giovani del quartiere, la maggio-ranza ragazze, che sono stati formati daesperti del LCN sui temi del disagio socia-le e sulle tecniche del gioco guidato e deilaboratori creativo-espressivi per bambini.La formazione permanente si realizza attra-verso l’esperienza sul campo, la partecipa-zione a workshop teorico-pratici e a stagesa Napoli e in altre realtà, come ReggioEmilia, Bologna, Salerno, Gafsa. Il gemel-
laggio e lo scambio di visite tra operatoridella ludoteca di Secondigliano e quellidelle scuole della Regione di Gafsa inTunisia sono stati un’occasione per amplia-re i loro orizzonti mediante il confrontocon realtà più povere, ma meno degradatedi Secondigliano.L’ultimo seminario, in ordine di tempo, èstato quello realizzato il 27 gennaio 2003in occasione dell’incontro con il prof. JackZipes, che ha presentato il suo ultimo libro,“Oltre il giardino: l’inquietante successodella letteratura per l’infanzia da Pinocchioa Harry Potter”, ed. Mondadori, 2002.All’incontro è stata data la massima pub-blicizzazione, non solo per l’indubbiavalenza culturale, ma anche per l’impattosociale che può avere la sua realizzazione aSecondigliano, piuttosto che in una sedeprivilegiata del centro città. Si è volutodare un messaggio, soprattutto agli abitantidel quartiere, che, se si vuole, nelle perife-rie non ci sono solo gli eventi riportati incronaca nera, ma anche quelli che meritanola pagina della cultura sul quotidiano piùdiffuso in città.La collaborazione con l’ACP continuatutt’oggi fruttuosamente nella promozionedei Progetti di promozione alla lettura, chehanno trovato interlocutori sensibili nel-l’Amministrazione Comunale. Il Comune,infatti, sostiene a Secondigliano in collabo-razione con l’ACP, il LCN, il Centro Salutedel Bambino e il Provveditorato agli Studitre progetti: “Nati per Leggere”, dedicatoalla fascia di età 6 mesi-6 anni; “Storie ingioco”, per i ragazzi di 6-12 anni; “Leggereper…”, per ragazzi, giovani e adulti.
ConclusioniSappiamo che l’azione del Comune e delleAssociazioni che offrono la loro collabora-zione, in assenza di interventi strutturalicentrali, finalizzati a risolvere il problemadella disoccupazione (soprattutto femmini-le, vero fattore di protezione per i figli) equello della casa, non saranno efficaci acambiare un destino che, per molti ragazzia RS, appare irrimediabilmente segnato.Siamo anche consapevoli dei limiti di que-sto nostro ruolo e dobbiamo accontentarcise quello che facciamo serve, almeno, adare a molti ragazzi momenti di gioia e aun gruppo di giovani donne del quartiere laspinta per crescere e per diventare un puntodi riferimento e un elemento di speranzaper tante/tanti loro coetanei. �
242
nati per leggere Quaderni acp 2006; 13(6)