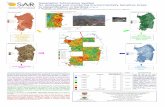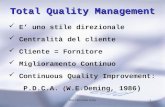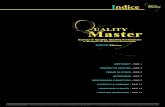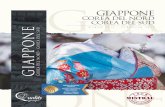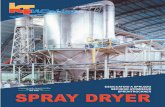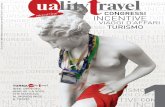Tomato cultivation and quality
-
Upload
domenico-cappello -
Category
Documents
-
view
53 -
download
2
description
Transcript of Tomato cultivation and quality

Introduzione

Secondo gli accordi internazionali stipulati a Montreal nel settembre del 1997,
a cui ha aderito l’Italia, dal 01/01/2005 è stato proibito l’impiego del bromuro di
metile, che attualmente è molto utilizzato per la sterilizzazione dei terreni in serra.
L’agricoltura italiana risentirà in modo particolare di tale vincolo, in quanto
l’Italia è il primo Paese utilizzatore di bromuro di metile nell’Unione Europea ed è al
secondo posto, dopo gli USA, nella graduatoria mondiale.
Tra le alternative all’impiego del bromuro di metile, le colture senza suolo
assumono un’importanza rilevante.
In Italia la diffusione del senza suolo è ancora molto limitata, rispetto a Paesi
come Olanda e Spagna, soprattutto a causa dei costi d’impianto elevati e della
mancanza di assistenza tecnica qualificata.
La tendenza delle coltivazioni in colture protette va verso sistemi che
consentano: l’automazione dei principali processi produttivi; la riduzione dei consumi
di acqua, concimi e fitofarmaci; l’aumento dell’efficienza d’uso dell’ambiente; il
rispetto dell’ambiente e il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni.
L’adozione di sistemi di coltivazione senza suolo potrebbe rispondere a queste
esigenze.
Al fine di verificare alcune delle potenzialità offerte dalle colture senza suolo e
più in particolare la qualità del pomodoro è stato impostata una prova sperimentale in
camera di crescita con i seguenti obiettivi:
1.Valutare la qualità del pomodoro cv. Naomi tipo "Cherry" allevato con il
sistema idroponico NGS in camera di crescita.
Inquadramento botanico del pomodoro

Il pomodoro appartiene alle dicotiledoni, ordine solanales, famiglia solanaceae,
genere Lycopersicon.
La tassonomia di questa specie ha fatto registrare nel tempo notevoli
variazioni.
La prima classificazione su basi scientifiche del pomodoro si deve al Linneo il quale
lo incluse nel genere Solanum e lo denominò Solanum lycopersicum (lycopersicum
deriva dal latino e significa pesca del lupo).Philip Miller nel 1768, sulla base delle
sostanziali differenze delle strutture riproduttive del pomodoro rispetto alle altre
specie del genere Solanum, quali patata e melazana, - stami uniti a formare un
piccolo cono e deiscenza del polline attraverso le fenditure longitudinali delle antere
nel caso del pomodoro, stami distinti e deiscenza del polline attraverso pori disposti
alla sommità delle antere nel caso delle specie del genere Solanum ( Fig. 1.1 )-
propopose la costituzione del nuovo genere Lycopersicon. Egli incluse in questo
genere 7 specie tra le quali il pomodoro, denominato Lycopersicon esculentum ( dal
latino = commestibile ). Questa denominazione fu largamente accettata dalla
comunità scientifica sebbene le regole di nomenclatura vegetale prevedano che se si
stabilisce per una specie l'appartenenza ad un nuovo genere, il nome della specie (in
questo caso lycopersicum ) non deve essere modificato. In rapporto a quanto sopra è
stata successivamente proposta per il pomodoro la denominazione di lycopersicon
lycopersicum ma essa, sebbene formalmente più corretta, non ha trovato in pratica
diffusione, per cui è generalmente adottata quella proposta dal Miller .

Attualmente il genere Lycopersicon comprende 9 specie che sono state
suddivise da Muller (1940 ) in due gruppi sulla base della colorazione della polpa del
frutto a maturità, rossa o giallo-arancio in Eulycopersicon, verde o biancastra in
Eriopersicon. Il gruppo Eulycopersicon, comprende 3 specie ed in particolare
L.esculentum Mill., L.pimpinellifolium (jusl.) Mill., L.cheesmanii Riley; il gruppo
Eriopersicon comprende 6 specie e cioè L. pennelli (Corr.) D'arcy, L.hirsutum Humb.
e bonpl., L. parviflorum Rick, Kesicki, Fobes e Holle, L. chimielewskii Rick,
Kesicki, Fobes e Holle, L. chilense Dun., L. peruvianum Mill. (fig. 1.2 ) Le suddette
specie inoltre differiscono tra lo loro per il fatto che i frutti di L. esculentum e di L.
pimpinellifolium sono commestibili mentre non lo sono, per la presenza di alcaloidi
tossici, quelli delle restanti specie .
Fig 1.2- Frutti maturi di specie diverse di Lycopersicon
Tutte le specie appartenenti al genere Lycopersicon sono diploidi e caratterizzate da
un numero base di cromosomi pari a 12. La capacità di ibridazione naturale con L.
esculentum è molto elevata per L. pimpinellifolium; è inoltre possibile ottenere ibridi
interspecifici attraverso l'incrocio con L.cheesmanii, L. pennellii, L.hirsutum, L.
parviflorum e L.chimielewskii, mentre soltanto per l.chilense e L.peruvianum ciò non
è possibile, se non ricorrendo a tecniche specifiche, in particolare alla coltura in vitro
degli embrioni immaturi.
In rapporto a quanto sopra recentemente Rick (1976) ha suddiviso le diverse
specie del genere Lycopersicon sulla base della loro capacità di incrociarsi
naturalmente con il pomodoro coltivato (" complesso esculentum") o della incapacità
di incrociarsi con esso ("complesso peruvianum") . Al "complesso esculentum" sono

pertanto riconducibili L. esculentum, L. pimpinellifolium, L. cheesmanii, L.pennellii,
L. hirsutum, L. parviflorum e L.chimielewskii, mentre per il "complesso
peruvianum" vanno ascritti L.chilense e L.peruvianum.
Questa classificazione assume notevole interesse anche pratico se si considera
il ruolo non trascurabile che alcune delle specie di cui sopra hanno avuto e potranno
avere nel futuro nel processo di miglioramento genetico del pomodoro, sia al fine di
aumentare la variabilità genetica, ridottasi notevolmente per effetto della pressione
selettiva esercitata nel corso della domesticazione prima, a seguito dell'introduzione
in Europa poi, sia per il reperimento ed il trasferimento ai tipi coltivati di fattori di
resistenza agli stress biotici e abiotici .
Il genere Solanum resta comunque quello più strettamente imparentato e
verosimilmente ancestrale del Lycopersicon, come dimostrano anche i risultati
conseguiti con le moderne tecniche di biologia molecolare rivolti a definire i rapporti
filogenetici tra le varie specie .
Nell'ambito di L.esculetum, in rapporto alla forma e dimensioni del frutto, alle
caratteristiche delle foglie ed al portamento della pianta si distinguono le seguenti
varietà botaniche :
- var. cerasiforme, con foglie di dimensioni minori rispetto alla var. comune,
frutti molto piccoli (diametro intorno a 1 cm, di forma tondeggiante, a ciliegia,
biloculari e portati da infiorescenze molto ramificate ;
- var. comune, con frutti di notevoli dimensioni, globosi, multiloculari;
- var. pyriforme, con frutti di dimensioni medie, piriforme, bi-triloculare;
- var. grandiflorum, con foglie larghe, a margine intero (foglie di patata);
-var. validum, con stelo breve, robusto, eretto e cespuglioso.
Origine e diffusione
Gli studiosi concordano nel ritenere quale centro di origine del genere
Lycopersicon la striscia che, tra la costa del pacifico e la cordigliera delle Ande, si

estende dall'Ecuador al Perù e al Cile settentrionale, ivi comprese anche le isole
Galapagos ( Fig.1.3) nelle quali si è evoluto, separatamente rispetto alle restanti
specie presenti nella terraferma grazie al suo isolamento spaziale, L.cheesmanii .
Fig.1.3-Aree di origine e di domesticazione del pomodoro
La domesticazione del pomodoro, a partire dalla sua forma ancestrale ( che
molti ritengono sia L. esulentum var. cerasiforme ) sembra sia avvenuta nel Messico
meridionale ; in questa regione, infatti, quando giunsero i conquistadores la specie era
già coltivata dagli Aztechi insieme ad altre specie solanacee soprattutto del genere
physalis, mentre nell'areale peruviano ed ecuadoriano erano solamente oggetto di
consumo occasionale i frutti raccolti delle piante presenti allo stato spontaneo .
L'origine di L. esculentum sarebbe avvenuta attraverso incroci della suddetta
forma ancestrale con L.pimpinellifolium secondo alcuni A.A, a seguito di un
progressivo accumulo di mutazioni geniche a carico della forma selvatica secondo
altri A.A. In ogni caso il processo di domesticazione del pomodoro, allorchè gli
spagnoli giunsero nel Nuovo mondo era già molto avanzato ed erano utilizzati a
scopo alimentare tipi contrassegnati da forma, dimensione e colore delle bacche

molto diverse .Esse, infatti, al pari di quelle di altre specie del genere Physalis e in
particolare a P. phyladelfica che tra tutti sembrano siano stati i frutti maggiormente
apprezzati, macinate e mescolate con peperoncio, formavano una salsa molto
gradevole, che migliorava il sapore delle pietanze e stimolava l'appetito .
L'introduzione del pomodoro in Europa è avvenuta a seguito dell'invasione da
parte dei conquistadores nella prima metà del XVI secolo .Esso giunse in Spagna
dove suscitò interesse e curiosità, soprattutto presso i giardinieri, a
causa delle bacche colorate di giallo. Dalla Spagna la solanacea è stata quindi
introdotta in Portogallo e in Italia.
Gia' alla fine della prima metà del '500 alcune piante di pomodoro erano
presenti nell'orto botanico dell'università di Padova e il Mattioli, nel capitolo dedicato
alla Mandragora, ne descrive le caratteristiche, anche dei frutti : "appiattiti e costoluti,
che da verdi divengono giallo oro e che alcuni consumano fritti nell'olio con sale e
pepe, come le melanzane e i funghi ". Al Mattioli si deve la denominazione comune
"pomo d'oro " (dal latino mala aura ), da cui l'attuale termine italiano pomodoro, che
sta ad indicare che le prime forme diffuse, almeno in Italia, producevano frutti di
colore giallo-oro .
Il temine "tomate" con cui il pomodoro è indicato in diverse lingue europee
deriva invece dal vocabolo "tomatl" che nella lingua nàhuatl indica genericamente
una pianta con frutti globosi, con polpa ricca di acqua e provvisti di numerosi semi; i
Conquistadores spagnoli hanno erroneamente attribuito questo nome specificamente
al pomodoro e lo hanno diffuso in tutto il mondo .
Dai paesi mediterranei il pomodoro è stato quindi introdotto in quelli del nord
Europa, dove i pregiudizi circa il consumo del frutto sono stati tuttavia rilevanti e
assai radicati fino a quasi tutto il XVII secolo, come dimostrano le denominazioni
"Pomme d'amour " e "love apple" con cui esso era chiamato in francese ed in inglese,
con chiara allusione all'effetto eccitante ed afrodisiaco attribuito ai frutti di questa
solanacea. Per lungo tempo, infatti,la coltivazione del pomodoro ha avuto finalità non
alimentari, ma quasi esclusivamente ornamentali, e il consumo del frutto è stato
sconsigliato dai dotti dell'epoca che lo definivano malsano, ritenendo che potesse
causare effetti analoghi a quelli di altre solanancee presenti in Europa, come la

belladonna o l mandragora; solo al succo della pianta si attribuivano poteri
rinfrescanti. Castore Durante, al quale si deve una delle prime rappresentazioni
grafiche al mondo del Pomodoro (1585), nella sua descrizione del pomodoro così si
esprime : "Mangiansi nel medesimo modo che le melanzane con pepe, sale e olio, ma
danno poco e cattivo nutrimento "(Fig. 1.4 ) .
E' in questo quadro che probabilmente ha avuto inizio in Europa il
miglioramento genetico volto ad aumentare le dimensioni delle bacche, attraverso la
selezione delle piante che presentavano frutti molto voluminosi, ritenuti di maggiore
valore ornamentale .Malgrado le forti controindicazioni, il consumo dei frutti di
pomodoro, bolliti o crudi, conditi con sale e pepe, già alla fine del '500 aveva
cominciato a diffondersi in Italia ( in particolare nel napoletanno ), in Spagna e in
genere nei paesi mediterranei, soprattutto tra la gente di campagna meno informata
dell'opinione dei dotti.
L'utilizzazione a fini alimentari del pomodoro sia pure assai lentamente si andò
quindi estendendo verso i paesi del nord Europa, ma soltanto a partire dall'inizio del
XIX secolo assume una diffusione ampia e generalizzata. E' significativo che ancora
nel 1760 il catalogo Andrieux e Vilmorin, il primo a commercializzare sementi di
pomodoro, le propone nella sezione dedicata alle piante ornamentali e soltanto nella
edizione del 1778 del suddetto Catalogo esse sono commercializzate nella sezione
relativa alle ortive. Parimenti nell'America del Nord la coltivazione del pomodoro,
che era stata introdotta dai coloni europei, fino agli inizi del XIX secolo incontra
grandi difficoltà per le prevenzioni che ne accompagnano l'utilizzo dei frutti; soltanto
allorchè tale Gibbon Johnson nel 1820 provocatoriamente li consuma senza accusare
alcun danno, sui gradini del palazzo di giustizia di Salem davanti ad una folla
attonita, essa si diffonde rapidamente .
In ogni caso il pomodoro va perdendo progressivamente la caratteristica di
pianta ornamentale ed acquista sempre più quella di pianta da orto. Il suo sugo,
ricavato bollendo in acqua bacche mature che vengono poi passate al setaccio per
eliminare bucce e semi, entra come ingrediente base nella cucina europea.
Il successivo sviluppo delle tecniche di trasformazione e conservazione delle
bacche determinerà il passaggio della coltivazione da familiare ad industriale,

promuovendo la progressiva espansione del pomodoro fino a raggiungere una
posizione di assoluto predominio nell'ambito dell'orticoltura mondiale .
Importanza economica e agraria
Il pomodoro è, dopo la patata, la più importante specie orticola coltivata nel
mondo e la sua diffusione assume considerevoli dimensioni in tutti i continenti. La
superficie destinata al pomodoro nel 2000 è stata infatti stimata di poco inferiore a 4
M di ha e la produzione superiore a 108 M di t (tab. 1.1 ).
Sebbene come già rivelato il pomodoro riveste ovunque grande importanza, il
continente asiatico è certamente quello che, sia in termini di superficie che di
produzione, assicura il maggior contributo a livello mondiale.
Tab 1.1-Superficie (ha) e produzione (000 t) nel mondo anno 2000. Dati FAO
Superficie (000 ha) Produzione (M t)
AfricaAmerica settentrionaleAmerica centraleAmerica meridionaleAsia Europa Oceania
676,1 174,9 145,2 149,5 2.101,2 720,2 9,6
13,4 12,3 3,3 6,0 51,4 21,6 0,5
Totale 3.976,7 108,5
La superficie a pomodoro, in Asia, infatti nell'anno 2000 si è aggirata intorno
a 2,1 milioni di ettari mentre la relativa produzione è stata di oltre 52 milioni di t .
Notevolmente minori i valori delle superfici e delle produzioni di pomodoro in
Europa ( nell'ordine 720 mila ha e 21,6 milioni di t ) e in Africa (nell'ordine 676 mila
ha e 13,4 milioni di t ).Apprezabile infine la superficie occupata dal pomodoro nel

continente americano, in particolare in America settentrionale, che peraltro si
distingue anche per la produzione (tab.1.1 ).
In ogni caso la coltivazione del pomodoro ha fatto registrare a livello mondiale,
negli ultimi trenta anni, incrementi notevoli: la superficie infatti si è più che
raddoppiata ove si consideri che nel 1970 era stimata poco più di 1,8 milioni di ha,
mentre la produzione si è più che triplicata, passando da meno di 36 milioni di t del
1970 agli oltre 108 milioni di t del 2000 (fig.1.5); le rese unitarie nel periodo
considerato sono aumentate di oltre il 40 %.Passando da 19,3 t/ha del 1970 a 27,3
t/ha del 2000 .
Il paese in cui la coltivazione del pomodoro raggiunge la massima estensione è
la Cina, con oltre 850 mila ha ; seguono l'India con circa 460 mila ha, la Turchia con
225 mila ha e poi, via via, l'Egitto, gli USA e l'Italia con superfici comprese tra poco
meno di 200 ha e poco più di 135 mila ha (fig. 1.6 ).
Per quanto concerne la produzione al primo posto si colloca sempre la Cina
con oltre 22 M di t, mentre passando al secondo posto gli USA, con oltre 11 M di t,
dal quinto occupato in termini di superficie, grazie alle assai rese unitarie, di poco
inferiore alle 70 t/ha .
Seguono quindi in ordine di importanza, Turchia, Italia, India ed Egitto, con
produzioni comprese tra 8,9 e 6,8 M di t e infine, a notevole distanza, Spagna, Iran,
Brasile e Messico (Fig.1.7 ). Nel complesso pertanto si riscontra una scarsa
concordanza tra la graduatoria relativa alle superfici e quella delle produzioni, in
conseguenza delle notevoli differenze tra i Paesi per quanto concerne le rese unitarie,
variando queste ultime dalle circa 7 t/ha della Nigeria alle quasi 70 t/ha degli USA .
Nella UE il pomodoro nel 2000 ha interessato, nel complesso dei 15 paesi
costituenti, una superficie superiore ai 270 mila ha, mentre la produzione
complessivamente ottenuta in quell'anno è stata di oltre 16 M t ( Fig.1.8 ).
La dinamica temporale delle superfici e delle produzioni ha fatto registrare nel
periodo 1970-2000 notevoli variazioni .
In particolare le superfici, cresciute fino alla metà degli anni '80, sia pure in
misura modesta, hanno accusato una sensibile riduzione nel corso degli anni '90,
arrestatasi solamente nel 2000; le produzioni di contro si sono notevolmente

accresciute pressoché costantemente (fig. 1.8).Di fatto rispetto agli inizi degli anni
'70, la superficie a pomodoro nel 2000 è risultata pressoché immutata ( di poco
superiore ai 280 e ai 270 mila ha nel 1970 e nel 2000 rispettivamente ) mentre la
produzione nel suddetto periodo si è raddoppiata, passando da 8 a 16 M di t circa .
Il risultato di cui sopra è stato com'è ovvio reso possibile dall'aumento delle
rese unitarie, raddoppiatesi anche esse e passate da 30 t/ha del 1970 a 60 t/ha del
2000.
In ogni caso il pomodoro riveste una importanza assai diversa nei paesi della
UE; l'Italia, con una superficie di quasi 140 mila ha e una produzione di oltre 7,5 M
di t occupa saldamente il primo posto.
Seguono la Spagna e la Grecia, con una superficie nell'ordine di 62 mila e 44
mila ha e una produzione di 3,7 e 2,1 M di t rispettivamente ( tab. 1.2).
Nel complesso il contributo dei suddetti tre Paesi è stato del 90 % circa in
termini di superficie e superiore all'80% con riferimento alla produzione complessiva
comunitaria. Ove si consideri inoltre che al di fuori dei suddetti tre paesi, nell'ambito
della UE, superfici e produzioni significative si riscontrano solamente in Portogallo e
Francia, emerge chiaramente la localizzazione mediterranea della coltura, in sintonia
con la sua origine tropicale. In Italia il pomodoro da diversi decenni rappresenta
l'ortiva più largamente diffusa anche se le superfici e le produzioni hanno fatto
registrare negli ultimi trenta anni ora incrementi rilevanti ora decrementi ( fig.1.9),
legati alle alterne vicende delle coltivazioni per l'industria, in alcuni periodi
incoraggiate dagli interventi comunitari (inizi degli anni '80 ), in altri periodi
ostacolate (fine degli '80, inizi degli anni '90 ).
La superficie occupata nel 2000 dal pomodoro ha riguardato per quasi il 25% il
mercato fresco e per la restante parte l'industria di trasformazione; per la produzione
la destinazione è stata per il 20 % e per l'80 % nell'ordine il fresco e il trasformato
(tabb. 1.3, 1.4 ).Con riferimento al pomodoro da mensa è da rilevare inoltre che il 23
% della relativa superficie cioè quasi 7.700 ha, è coperta da serre e che da detta
superficie si ottiene, in periodo extrastagionale, oltre il 35 % del prodotto fresco
complessivo (tab. 1.3).

Le regioni maggiormente interessate alla coltivazione di questa solanacea sono
in genere quelle meridionali .Per il pomodoro da mensa in testa è la Sicilia, seguita da
Calabria, Campania, Puglia, Lazio, Sardegna e Lombardia; in molte di dette regioni è
anche assai importante la produzione fuori stagione, quasi il 70 % di quella
complessiva nel caso della Sicilia, intorno al 50 % per Campania, Lazio e
Sardegna.Con riferimento al pomodoro da industria al primo posto si colloca la
Puglia, la quale contribuisce nell'ordine per oltre il 35 % e il 40 % alla superficie e
produzione nazionale, seguita dall'Emila-Romagna e quindi, a notevole distanza dalla
Campania, dove la coltura, destinata principalmente alla produzione di pelati, aveva
in passato una importanza assai maggiore rispetto a quella attuale, essendosi, in
confronto agli inizi degli anni '80, la superficie ridotta a meno di un terzo e la
produzione pressoché dimezzata.
Gli scambi commerciali sono piuttosto modesti per il pomodoro da mensa,
mentre assumono grande importanza per il pomodoro trasformato. Con riferimento al
primo, le esportazioni e in minor misura le importazioni, sono cresciute in misura
significativa solamente a partire dalla seconda metà degli anni '90 e il saldo è positivo
sia in termini di quantità che di valore; nella misura di 70 mila t e 100 M di euro
nell'ordine (fig.1.10). I principali partner commerciali sono i paesi dell'UE :
Germania e Austria tra gli importatori, Paesi Bassi e Spagna tra gli esportatori ( Tab.
1.5).
Per quanto concerne il pomodoro trasformato il trend delle esportazioni è stato
pressoché costantemente in crescita sia per le quantità che per il relativo valore
(fig.1.11).Nel 2002 in particolare è stato esportato prodotto per circa 1,6 M di t e si è
realizzato un saldo in attivo per oltre 1,4 M di t ; in termini di valore le esportazioni
di conserve di pomodoro hanno superato i 970 M di euro e il saldo. positivo, ha
raggiunto gli 880 M di euro, per cui esse oggi costituiscono la voce più significativa
della bilancia commerciale del comparto orticolo.
Il pomodoro trasformato italiano è destinato in larga misura ai paesi della UE
(Germania, Regno Unito e Francia in primo luogo )ma una quota rilevante è
indirizzata verso i paesi extracomunitari, USA soprattutto (tab.1.6).Le importazioni
più significative da parte del nostro paese provengono dalla Cina, paese che di

recente ha cominciato a competere, grazie ai bassi costi di produzione, sui mercati
internazionali.
Caratteri morfologici
Il pomodoro è una pianta erbacea dicotiledone. La radice è fittonante con
numerose ramificazioni secondarie, ricche di peli; essa può spingersi ad elevate
profondità, anche oltre un metro, ma in prevalenza si localizza in superficie, entro i
primi 30 cm .In ogni caso, al pari delle altre solanacee, l'apparato radicale tende ad
essere fascicolato quando per l'impianto della coltura si ricorre al trapianto radici
avventizie inoltre possono facilmente svilupparsi a partire dalle numerosissime
gemme presenti nella parte basale del fusto. Quest'ultimo pubescente si presenta
eretto nelle fasi giovanili, poi diviene decombente; il portamento della pianta tuttavia,
per effetto degli interventi di miglioramento genetico, nelle cv. oggi diffuse in coltura
è molto variabile e in alcuni casi permane eretto anche in fase avanzata di sviluppo.
L'accrescimento è simpodiale e si caratterizza per la formazione in successione di due
-tre foglie seguite da una infiorescenza. Lo stelo è provvisto di numerose
ramificazioni, dicotome, ascendenti, che si originano all'ascella delle foglie e il cui
accrescimento si realizza con modalità analoghe a quelle del fusto per cui la pianta
adulta tende ad assumere un aspetto cespuglioso.
Fig 1. -Pianta ad accrescimento determinato (a sinistra ) e indeterminato (a destra).

La lunghezza dello stelo è variabile, in rapporto, soprattutto alla modalità di
accrescimento, il quale può essere indeterminato o determinato.
Il primo, teoricamente, indefinito tende a perpetuarsi fino a che le condizioni
climatiche lo consentono; le infiorescenze si formano scalarmente e sono inserite
solamente sugli internodi in posizione laterale mentre il fusto, se si eliminano le
ramificazioni ascellari, può raggiungere in un anno una lunghezza anche di 10 m. Nel
caso dell'accrescimento determinato, viceversa, l'apice vegetativo del fusto e quelli
delle ramificazioni dopo aver prodotto un certo numero di foglie e di infiorescenze,
cessano di svilupparsi differenziando una infiorescenza terminale (fig. 1.12).
Le foglie si dipartono dai nodi; sono di grandi dimensioni, fino ad oltre 30 cm
di lunghezza, alterne, picciolate, imparipennate, composte da 7-9, ma in qualche caso
anche 11 foglioline (fig.1.13 ), ricoperte al pari del fusto e delle ramificazioni da peli
ghiandolari che secernono una sostanza dell'aroma caratteristico. Esse presentano
sulla pagina inferiore numerosi stomi che assicurano intensi scambi gassosi con
l'esterno, mentre sulla pagina superiore il loro numero è modesto. Si possono
distinguere due forme di foglie e cioè quella normale e quella a "patata" .Nel primo
caso il numero di foglioline semplici è più elevato, il lembo è piuttosto sottile mentre
il bordo è in genere situato o dentato. La foglia a " patata" invece si caratterizza per le
maggiori dimensioni della lamina che presenta inoltre il bordo generalmente intero.
Le infiorescenze, inserite nell'internodo, sono a grappolo o a cima semplice o
composte; esse possono portare da uno a oltre cento fiori (fig. 1.).
Fig 1. - Infiorescenza di pomodoro tipo “cherry”.

I singoli fiori sono provvisti di un peduncolo che oltre ad avere una funzione di
sostegno, ospita i fasci vasali che alimentano lo stesso fiore e in seguito il frutto.Il
peduncolo di norma presenta, a metà circa della sua lunghezza, un nodo, in
corrispondenza del quale si forma uno strato di cellule suberose che a maturità
promuovono la rottura del peduncolo stesso, favorendo il distacco del frutto con il
calice.
Fig.1. - Fiore di pomodoro con sei sepali e altrettanti tepali
Nella forma mutata denominata "jointless", viceversa, manca il nodo sul
peduncolo, per cui il frutto si stacca privo del calice avvenendo la rottura in
corrispondenza del punto di inserzione di quest'ultimo (fig.1.15). I fiori, ermafroditi,
hanno calice gamosepalo con 5 lobi persistenti e corolla anch'essa gamotepala, con 5
petali di colore giallo; il numero di petali e di sepali, tuttavia, può essere più elevato
in alcune cv. (fig. 1.16).Gli stami, essi pure cinque o più, sono brevi hanno antere
biloculari, connati all'apice e formanti un tubo cilindrico-conico attorno al pistillo.
Quest'ultimo è costituito da un ovario supero, pluriovulare, con due o più carpelli. Lo
stilo ha anch'esso lunghezza variabile e termina con uno stimma a capocchia che può
fuoriuscire o meno dalla colonna staminale.
Il frutto è una bacca le cui dimensioni possono essere assai diverse: da 2-3 cm
di diametro a quasi 20 cm (fig. 1.17); il peso parimenti, può essere compreso tra
pochi grammi ed oltre 500 grammi .Molto variabile è anche la forma della bacca, che
fondamentalmente è riconducibile a due tipologie: tonda e allungata, ciascuna delle
quali, tuttavia, presenta notevoli diversificazioni.

Fig.1. -Principali forme della bacca di pomodoro
Nella fig. 1.18 sono rappresentate schematicamente le forme che più
frequentemente possono essere riscontrate. Detta forma può essere regolare o più o
meno irregolare in rapporto dello sviluppo dei carpelli; un disforme accrescimento di
quest'ultimo determina infatti le così dette "costolature", ondulazioni della superficie
della bacca causate da depressioni longitudinali che a partire dalla estremità
peduncolare si possono estendere fino a raggiungere l'apice stilare.Sulla base della
presenza o meno delle costolature e della loro estensione i frutti sogliono essere
distinti in lisci, semicostoluti e costoluti (fig. 1.19).La dimensione della bacca è una
caratteristica varietale, ma può essere molto influenzata da condizioni ambientali e
dalla tecnica colturale. In genere, l'aumento del peso della bacca è inversamente
correlato al numero di bacche per pianta. Anche il numero di semi per bacca può
influenzare la dimensione, dato che i semi agiscono come centri di produzione di
auxine e di regolazione del metabolismo del frutto.
Il miglioramento genetico del pomodoro è stato perseguito sia attraverso
selezione che attraverso l'incrocio, utilizzando anche quello interspecifico per
ottenere una maggiore resistenza alle malattie. I trattamenti per indurre mutagenesi
artificiale sono stati applicati al pomodoro con risultati promettenti. Grande interesse
commerciale ha suscitato la costituzione di ibridi F1, che consentono di ottenere una
produzione ed una precocità superiore ai genitori, un maggiore adattamento
ambientale ed uniformità delle bacche.

Le dimensioni della cicatrice peduncolare costituiscono altro elemento di
differenziazione dei frutti di pomodoro ; esse possono essere infatti molto variabili,
anche se in genere vi è una positiva correlazione tra le dimensioni dei frutti e quelle
della cicatrice peduncolare stessa (fig. 1.20 ).
Il colore del frutto maturo è molto variabile, dal bianco o giallo (soprattutto
nelle vecchie cv.) al rosso intenso ed è determinato dai pigmenti presenti : clorofilla,
beta carotene e licopene .La clorofilla conferisce la colorazione verde, tipica delle
bacche immature, che tende a scomparire gradualmente a mano a mano che i
pigmenti clorofilliani vengono eliminati e sostituiti con licopene e/o beta carotene.
Questi ultimi se presenti entrambi determinano, in rapporto alla proporzione tra loro,
le differenti tonalità di colore rosso del frutto; se viceversa è presente solo il beta
carotene la bacca sarà di colore giallo. Mancando il beta carotene si ha una
colorazione rosa-violacea (Pink) del frutto (fig.1.21).Il colore dei frutti immaturi è
dato dalla presenza di clorofilla e le sua intensità dipende da fattori genetici: “U”
(uniform), pigmentazione uniforme indipendentemente dall’intensità; “UG” (uniform
gray green), variante del precedente a colore verde grigiastro; “GS” (green
shoulders), con spalla verde determinata da pigmentazione più intensa in
corrispondenza della zona peduncolare della bacca che rimane più a lungo rispetto al
resto del frutto, caratterizzando in modo esclusivo le cultivar del mercato fresco; “gs”
(green stripes), con striature verdi più intense che possono permanere o meno a
maturazione. La pigmentazione del frutto maturo è condizionata dalla quantità totale
di carotenoidi e dal rapporto fra i due principali pigmenti: licopene (rosso) e -β
carotene (giallo).
La bacca è fondamentalmente costituita da un pericarpo, da un tessuto
placentare e dai semi. Il pericarpo a sua volta è formato da un epicarpo o buccia, da
un mesocarpo esterno, mediano ed interno e da un endocarpo (fig. 1.22).
L'epicarpo si presenta come una pellicola lucente, liscia e sottile, più o meno
resistente. Esso è formato da uno strato epidermico esterno privo di stomi e da due a
quattro strati sottostanti di cellule con parete robusta; lo strato epidermico è inoltre
ricoperta da una cuticola il cui spessore aumenta progressivamente a mano a mano
che il frutto si accresce. Le caratteristiche della buccia determinano la sua resistenza

alla spacco; altro aspetto che assume notevole importanza, soprattutto nel caso della
produzione dei pelati, è la facilità con cui essa si distacca dal sottostante mesocarpo,
cioè la "pelabilità".
Il mesocarpo, polposo e ricco di sugo, ha sapore dolce acido e può raggiungere
uno sviluppo più o meno rilevante, superiore in peso anche ai 2/3 di quello
complessivo della bacca; occupa la porzione del frutto immediatamente sottostante la
buccia, la parte mediana della bacca, formando i setti che delimitano i carpelli o
logge e la parte più interna della bacca stessa.
Esso è costituito principalmente da cellule parenchimatiche, provviste di un
ampio vacuolo centrale e di una elevata quantità di pigmenti; la porzione più interna
del mesocarpo talora è meno pigmentata delle restanti parti e può includere ampi
spazi occupati da aria per cui assume una colorazione bianchiccia. Il mesocarpo è
percorso inoltre da una fitta rete di fasci fibrovascolari, formata principalmente da
vasi che attraversano il mesocarpo esterno e da vasi che attraversano i setti divisori e
la porzione più interna, raggiungendo radialmente i semi.
L'endocaropo è formato da uno strato unicellulare che circonda i carpelli e i
loculi.Questi ultimi possono essere in numero variabile, da un minimo di due nelle
cv. a frutto piccolo e di forma regolare a oltre 10 in quelle a frutto di dimensioni
elevate e costoluto (fig.1.23); le bacche infatti presentano forma tanto più irregolare
quanto più elevato è il numero di logge . All'interno dei carpelli sono contenuti il
tessuto placentare, mucillaginoso e i semi, immersi nel suddetto tessuto e il cui
numero in genere è compreso tra 50 e 200. In alcuni casi, tuttavia , i semi sono
assenti e i frutti si sviluppano partenocarpicamente.
Questi frutti partenocarpici si caratterizzano per le dimensioni in genere assai
ridotte e per la mancanza del tessuto placentare.
I semi di forma discoidale, appiattiti e di colore giallognolo; sono costituiti da
un embrione ricurvo, formato da una radichetta, un ipocotile e due cotiledoni che
racchiudono l'apice caulinare, da un poco di endosperma che circonda l'embrione e
svolge la funzione di materiale di riserva per la germinazione e da un tegumento
esterno membranaceo, provvisto di numerosi peli, il quale svolge una funzione di
protezione (fig. 1.24).I peli sono i resti di ispessimenti filiformi prodottisi sulle pareti

laterali delle cellule esterne del tegumento ovulare e hanno la funzione di trattenere
l'umidità per favorire il processo di germinazione. I semi in commercio, molto spesso,
sono stati privati dei peli superficiali ("rasatura") e ciò sia per consentire la semina di
precisione che per rendere meno agevole la trasmissione di agenti patogeni attraverso
il seme. (fig. 1.25). Le dimensioni del seme possono oscillare tra i 3 e i 5 mm di
lunghezza e i 2- 4 mm di larghezza; il peso di 1000 semi si aggira intorno a 3 g .
Biologia
Il pomodoro ha un ciclo biologico perennante negli ambienti di origine, che è
reso annuale al di fuori delle zone tropicali e subtropicali dalle condizioni
fototermiche svavorevoli che si verificano durante parte dell'anno.
Il processo di germinazione si realizza in un tempo più o meno lungo, da 6 a 12
giorni ed oltre in dipendenza, oltre che dai fattori pedoclimatici, temperatura in primo
luogo, dal vigore del seme. La somma termica per la germinazione è di 160 gradi
giorno (zero di germinazione 9 °C).
La germinazione è epigea; i cotiledoni dopo essere liberati dei tegumenti
seminali si accrescono in lunghezza e larghezza, dando inizio alla vita autotrofa della
piante. La durata della fase cotiledonare si protrae da 7 ad oltre 15 giorni (fig.1.26 ).
La crescita della radice, inizialmente non particolarmente rapida, assume un
ritmo assai elevato a partire dalla emissione della quinta foglia vera e tale permane
fino all'allegazione dei primi frutti, per rallentare successivamente ed arrestarsi del
tutto in corrispondenza della maturazione dei frutti stessi.
La pianta differenzia in successione da 6 a 12 foglie prima che la gemma
principale si trasformi in infiorescenza (fig.1.27).L'accrescimento successivamente è
di tipo simpodiale ; dalla gemma ascellare inserita sull'ultima foglia prende origine
una ramificazione,che si sviluppa come un prolungamento del fusto, spostando
lateralmente l'infiorescenza stessa (fig.1.28).Questa struttura assiale, a sua volta, dopo
aver formato 2-3 foglie differenzia all'apice una nuova infiorescenza, mentre la
gemma ascellare presente sull'ultima foglia dà origine a una nuova ramificazione e

quindi ad una nuova porzione del fusto. Il processo di cui sopra, sia con riferimento al
fusto che alle ramificazioni laterali, si perpetua continuativamente fino a che le
condizioni ambientali lo consentono nelle piante delle cv. ad accrescimento
indeterminato, per cui esse assumono l'aspetto descritto in precedenza. Nel caso delle
cv. ad accrescimento definito, il numero di foglie che precede la formazione
dell'informazione non è costante ma si riduce progressivamente a mano a mano che il
fusto e le ramificazioni laterali si sviluppano, fino a che si ha la formazione di
un'ultima infiorescenza che segna la fine dell'allungamento dello stelo.
E' evidente che a quest'ultima modalità di accrescimento fa riscontro una
differenziazione delle strutture riproduttive più ravvicinata sia fisicamente che nel
tempo, e quindi una maggiore contemporaneità di maturazione dei frutti.
La scalarità di fioritura riguarda, oltre che le infiorescenze, anche i fiori
presenti su queste ultime; infatti procedendo dall'inserzione verso l'apice si possono
notare frutticini di differenti dimensioni, fiori in antesi e fiori chiusi.
La fecondazione è autogama e la frequenza di incrocio è in genere assai bassa,
inferiore all'1%, per effetto della deiscenza dalla parte interna verso lo stigma (fig.
1.29), che spesso non fuoriesce dal cono staminale, e della simultanea maturazione
degli organi sessuali maschili e femminili. Nelle cv.longistilo, tuttavia gli incroci
possono raggiungere anche il 10 %.
A fecondazione avvenuta ha inizio l'aumento del peso del frutto, processo che
ha un andamento sigmoidale (fig. 1.30).Nel corso del primo periodo, della durata di
2-3 settimane, la bacca raggiunge solamente un peso inferiore al 10 % di quello
finale, soprattutto attraverso un aumento del numero di cellule e assai meno per
effetto dell'aumento delle dimensioni delle stesse. Il secondo periodo, che si potrae
per 3-5 settimane, è caratterizzato da una velocità di crescita molto rapida e dal
raggiungimento di un peso assai prossimo a quello finale; questo risultato è
determinato da un aumento delle dimensioni delle cellule formatesi in precedenza,
all'interno delle quali ha inizio l'accumulo delle sostanze di riserva.
L'ultimo periodo dura 1-2 settimane e fa registrare un incremento del peso della
bacca assai modesto, ma modificazioni metaboliche molto rilevanti che
contrassegnano l'inizio della maturazione. In particolare si verificano alcune

variazioni nel contenuto dei principali pigmenti presenti nelle bacche: la clorofilla A
e B presente nei frutti immaturi scompare e si formano licopene e beta carotene (fig.1
31) ; tutto ciò fa riscontro il viraggio del colore dal verde a quello definitivo.
Modificazioni nel corso della maturazione avvengono anche con riferimento agli
zuccheri riduttori, agli acidi organici, alle proteine e alla vitamina C; in particolare si
riscontra un graduale aumento degli zuccheri e dell'acidità, un lieve abbassamento del
pH, un rilevante incremento, soprattutto in corrispondenza della piena maturazione,
del contenuto in vitamina C
Una decina di giorni dopo l'inizio del viraggio di colore ha inoltre temine il
trasferimento di assimilati nel frutto da parte della pianta, in conseguenza della della
formazione tra il calice e il frutto di uno strato di abscissione
Il tempo necessario affinché, si giunga alla maturità fisiologica delle prime
bacche è piuttosto variabile in rapporto soprattutto alle condizioni ambientali, oltre
che ovviamente ai fattori genetici. Nel caso di coltivazioni realizzate in condizioni
ambientali favorevoli sono necessari in genere, da 7 a 9 settimane dalla fecondazione
del fiore, mentre, a partire dalla germinazione, circa 90 giorni, per un totale di gradi
giorno compreso tra 2000 e 3000.
La piena maturazione della bacca segna l'inizio della senescenza della stessa ad
opera degli enzimi pectolitici ( pectinestererasi e poligalatturonasi) che si trovano
principalmente nel mesocarpo e che causano la degradazione della parete cellulare
costituita da cellulosa, emicellulosa e da sostanze di natura pectica, provocando di
conseguenza il rammollimento dei tessuti.Tale processo di degradazione risulta
comunque più o meno veloce a seconda delle caratteristiche della cv.; nelle cosidette
"long shelf life " esso è assai lento per effetto della ridotta o pressoché nulla attività
dell'enzima poligatturonasi.
Ogni pianta produce mediamente dai dieci ai quindici mila semi.
Nei confronti del clima

L'origine tropicale del pomodoro determina la sua predilezione per climi
temperato-caldi e la sua elevata sensibilità nei confronti delle basse temperature. Le
temperature ottimali per la germinazione si collocano tra 20 e 26 °C, quelle minime e
quelle massime sono nell'ordine 12 e 35 °C circa; si conoscono comunque anche cv.
in grado di germinare a temperature molto basse (tra 8,5 e 12 °C ) e molto elevate
( tra 35 e 37 °C )
L'accrescimento delle radici trova condizioni ottimali entro valori della
temperatura del terreno che, in rapporto alle cv. risultano compresi tra 15-19 °C e 25-
29 °C; al di sotto o al di sopra di tali valori si ha una riduzione della superficie
assorbente. In genere l'assorbimento radicale aumenta passando da 5 a 20-25 °C,
mentre decresce più o meno rapidamente quando si superano questi ultimi valori; in
ogni caso temperature del substrato inferiori a 12-13 °C assicurano un rifornimento
idrico e minerale modesto, ciò che limita significativamente l'accrescimento della
parte aerea e ha riflessi negativi sulla fioritura e la fruttificazione.
La temperatura minima letale dell'aria è 0-2 °, mentre la minima biologica è di
8-10 °C. I valori termici ottimali per l'accrescimento in genere si aggirano intorno a
22-26 °C durante il giorno e 13-16 °C di notte; essi tuttavia, oltre che in rapporto alle
cv., variano considerevolmente per effetto delle condizioni di disponibilità di luce:
risultano più idonei, in presenza di un modesto irraggiamento, valori della
temperatura notturna e diurna di 12-15 °C e 16-18 °C, in condizioni di elevata
radianza valori di 16-18 °C e di 22-25 °C nell'ordine. Livelli termici prossimi o di
poco inferiori a 10 °C nelle fasi che seguono il dispiegamento dei cotiledoni, per una
durata di 2 settimane circa, rispetto a quelli contrassegnati da valori intorno a 20 °C,
inducono una anticipazione della differenziazione dei primi grappoli fiorali ed una
inserzione degli stessi più vicini al colletto; essi tuttavia rallentano l'accrescimento
della pianta e lo sviluppo delle infiorescenze. L'allegagione dei frutti necessita di
temperature minime intorno a 10-13 °C; valori inferiori non consentono infatti la
formazione dei granuli pollinici, la germinazione del polline, l'accrescimento del
tubetto pollinico e la fecondazione degli ovuli. La temperatura minima per la fioritura
è 21 °C, mentre quella di maturazione delle bacche è 23°C.Temperature sopra i 32°C
causano scarsa allegagione, decolorazioni ed ustioni alle bacche.

Composizione chimica delle bacche
Nel frutto del pomodoro la parte commestibile è superiore al 96%; solo buccia,
semi e la parte fibroso-legnosa non sono assimilabili. In 100 grammi di prodotto
fresco abbiamo: 95% acqua, 3% di zuccheri semplici (glucosio e fruttosio); 0.2% di
grassi; 1% di proteine e 1.8% di fibre.
Grassi e proteine sono concentrate soprattutto nel seme. Il sapore così unico ed
apprezzato del pomodoro è dovuto al particolare rapporto tra il contenuto in zuccheri
e gli acidi organici. L’apporto energetico è valutabile in 20 Kcal circa per 100 g di
prodotto fresco.
Il pomodoro riveste un ruolo importante nell’alimentazione umana, non tanto
come apporto nutrizionale, quanto come fattore di equilibrio e diversificazione nel
contesto evolutivo delle abitudini alimentari. Rappresenta una fonte interessante di
vitamine (nonostante siano presenti in misura contenuta) e sali minerali, soprattutto
per classi di popolazione di età particolare (giovani e anziani).
Occorre ricordare anche la presenza di -carotene e del licopene. Il primoβ
funge da provitamina A, la cui forma aldeidica è importante ai fini della funzione
visiva, il secondo è un potente antiossidante che previene la formazione di tumori
soprattutto quello del pancreas e della prostata.
Nel frutto e nella pianta c’è però anche un alcaloide (tomatina) che pare avere
effetti antiallergici, antinfiammatori, cardiotonici e il cui livello di assunzione non ha
mai determinato sintomi di tossicità.

. Sali minerali e oligominerali
Nella componente acquosa del pomodoro sono disciolti decine di sali minerali
e di oligoelementi. Tra i primi predomina il potassio (297 mg ogni 100 g), che aiuta
l’organismo a ritrovare l’equilibrio idrico e quindi combatte la ritenzione dei liquidi e
l’ipertensione. Ma sono ben rappresentati anche il calcio (9 mg), fondamentale per la
salute di ossa e denti, e il fosforo (25 mg), che aiuta a sentirsi tonici e in forma,
perché é una componente essenziale di molti processi enzimatici e riveste un ruolo
fondamentale nella contrazione muscolare.
Tra gli oligoelementi i più presenti sono ferro (in 100 grammi di pomodoro se
ne trovano 0,3 mg), imprescindibile nella lotta all’anemia, lo zinco (0,11 mg) e il
selenio (2,3 mcg) che favoriscono la riparazione delle cellule e, per questo, aiutano a
combattere i segni dell’invecchiamento cutaneo. Il pomodoro rappresenta un vero e
proprio elisir di salute anche per la presenza di fibre e di acidi organici. Le fibre (2%)
sono soprattutto cellulosa ed emicellulosa, e sono concentrare nella buccia e nei
semini.
Acidi Organici
Nella polpa si trovano gli acidi organici, soprattutto acido citrico e acido
malico, che ne determinano il suo sapore caratteristico. Ma facilitano anche la
digestione, aumentano la salivazione, stimolano l'appetito e rigenerano i tessuti.
Inoltre, combinandosi con i minerali, determinano le proprietà alcalinizzanti del
pomodoro. Infatti, a dispetto del suo sapore acido, quest’ortaggio ha un buon
equilibrio acido-basico, e per questo favorisce l’alcalinizzazione dell’organismo.Ma
non solo: grazie al suo sapore acidulo, il pomodoro stimola le secrezioni
dell’apparato digerente e prepara la buona assimilazione di quel che si è mangiato.
Vitamine

A completare il profilo del pomodoro mancano solo le vitamine. Anche su
questo fronte il pomodoro ha molti atout. Il primo: apporta tutte le vitamine
idrosolubili. Il secondo: è un’ottima fonte di vitamina C (25 mg). Basta un bel
pomodoro per coprire il 40% degli 80 mg che un adulto dovrebbe assumere ogni
giorno di questa vitamina, che facilita l'assorbimento del ferro e contribuisce alla
produzione dell'emoglobina e dei globuli rossi nel midollo osseo. Terzo plus: la
presenza di vitamina A sotto forma di –carotene, uno dei componenti che apportanoβ
al pomodoro il suo bel colore (610 mcg ogni 100 g). Basta un pomodoro da 100 g per
coprire il 15% della quantità di –carotene che andrebbe assunta ogni giorno. Infine,β
non bisogna dimenticare le vitamine del gruppo B che sono, in quantità diverse, tutte
presenti nel pomodoro e che sono in grado di favorire il ricambio e l’ossigenazione
delle cellule.
Tabella 1. Valori indicativi su 100 grammi di prodotto fresco edibile, dei principali componenti del pomodoro
maturo.Composizione
Parte edibile % 96 Glucidi:
Acqua g. 94 - disponibili g. 3,5
Proteine g. 1 - amido g. 0
Lipidi g. 0,2 - solubili g. 3,5
Acidi organici - Glucosio g. 1,24
Acido Citrico mg 0.44 - Fruttosio g. 1,54
Acido Malico mg 37.00 - fibra g. 2
Acido ossalacetico mg 24.00 Amminoacidi
Acido Acetico mg 8.00 Acido lutammico 337.00
Acido Lattico mg 6.00 Acido Aspartico 121.00
Leucina mg 30.00Energia: Kcal 19 Lisina mg 29.00Vitamine Kj 79 Serina mg 28.00
Alanina mg 26.00
Tiamina - vit.B1 mg 0,02 Elementi minerali
Riboflavina vit.B2 mg 0,03 Sodio mg 6
VitaminaB5 mg 0,31 Potassio mg 297

Vitamina B6 mg 0,10 Ferro mg 0,3
Vitamina A mg 0,82 Calcio mg 9
Vitamina A(Retin.eq.) mg 620Magnesio mg
20
Niacina ( - vit.PP) mg 0,8 Fosforo mg 25
Vitamina C mg 25 Nitrati mg 5Licopene mg 16
Fonte: Istituto Nazionale della Nutrizione “Tabelle di composizione degli
alimenti
Le tipologie di pomodoro presenti in Italia
Gli ibridi commerciali ottenuti attraverso il miglioramento genetico degli
ultimi quarant’anni attualmente coprono il 90% del mercato ma in Italia, come del
resto in tutti quei Paesi dove viene coltivato il pomodoro, con il tempo c’è stata anche
una capillare opera di selezione, soprattutto per quanto riguarda il pomodoro da
consumo fresco, che ha comportato una grande variabilità di cultivar locali.
Alcune tipologie locali sono però diffuse anche su tutto il territorio nazionale
perché molto apprezzate. Queste cultivar sono piante a sviluppo indeterminato, con
forme (tondo, costoluto, ecc..), pezzature (da 20 fino a 200 g) e pigmentazioni (verde,
arancione e rosse) più diverse che spesso non possiedono alcuna forma di resistenza
alle malattie, tanto da necessitare l’innesto su cultivar resistenti. Purtroppo una
frammentazione variegale va a scapito dello sviluppo commerciale e della
concentrazione dell’offerta, arrivando a penalizzare produzioni di successo.
Il pomodoro da consumo fresco viene prodotto prevalentemente in serra, per
cui la disponibilità si protrae per tutto l’anno, oppure in pieno campo ma solo
limitatamente ad alcune aree di produzione del Centro (Toscana, Lazio, Abruzzo e
Marche) e del Sud.
Insalatari

I pomodori definiti “insalatari”sono quelli che raggruppano il maggior numero
di tipologie.
Prima della diffusione del pomodoro rosso a grappolo, i pomodori “insalatari”
occupavano il posto prevalente nel panorama commerciale italiano. Per il loro
declino è risultata determinante: la scarsa consistenza dei frutti che ne condizionava il
trasporto e raccolta (a frutto singolo) che implicava un notevole impegno di
manodopera. Il verde nella zona del colletto e la colorazione rosata più o meno
intensa della restante parte del frutto è stato l’elemento che veniva più apprezzato dai
consumatori, ma anche uno dei suoi punti deboli: troppa la presenza dell’alcaloide
tomatina nella parte verde del frutto.
I pomodori “insalatari” vengono distinti in tre tipologie prevalenti in funzione
della pezzatura dei frutti: medio grossi, medio piccoli e ovali.
Medio grandi
I frutti hanno un peso medio di 160-250 g, sono di forma tonda schiacciata con
superficie liscia o semi costoluta; internamente si presentano pluriloculari. La
colorazione della bacca è verde scura. Nell’ambito del grappolo esiste una forte
competizione fra i frutti per cui è in genere necessario un intervento di cimatura del
grappolo fiorale, con la riduzione del numero di fiori a 4-6, se si vuole evitare
l’eccessiva diminuzione della pezzatura. L’eliminazione di un certo numero di fiori
consente: pezzatura più uniforme dei frutti, maturazione contemporanea dei frutti
presenti nel grappolo, conseguente riduzione dei costi di manodopera in fase di
lavorazione. I frutti vengono raccolti allo stadio invaiatura.
Medio piccoli
Il peso medio dei frutti è di 130-180 g; la forma è tonda e l’epidermide liscia
colorata di verde chiaro, talora leggermente più accentuata nella zona del colletto;
internamente presentano 3-4 loculi di dimensioni relativamente ridotte che

contengono i semi. La pianta si presenta in genere vigorosa ed equilibrata, con un
numero di frutti per grappolo geneticamente uniforme (5-6) per cui non sono richiesti
interventi di cimatura.
Molti ibridi soprattutto fra la pezzatura medio piccola sono detti “a duplice
attitudine:” possono essere raccolti allo stadio di invaiatura oppure a completa
maturazione.
Ovali
Gli “insalatari” di forma ovale hanno una pigmentazione intensa con una spalla
verde. Attualmente la commercializzazione di questi frutti risulta ancora circoscritta a
nicchie di mercato. I pochi ibridi presenti in commercio (Colonna e DRK 2063) sono
caratterizzati da piante vigorose e frutti raggruppati in grappoli di 6-8.
Tipologia allungata
Il pomodoro certamente più famoso appartenente a questa tipologia è il
pomodoro San Marzano. L’origine del San Marzano trova discordi molti genetisti,
alcuni dei quali l’attribuiscono ad un incrocio spontaneo fra popolazioni locali
presenti nel territorio di Pagani e Nocera e in quello di Angri e Scafati, mentre altri la
riducono a popolazioni locali di pomodori dell’agro nocerino-sarnese e del nolano-
acerrano.
Al San Marzano va riconosciuto il merito di aver fatto conoscere il pomodoro
italiano in tutto il mondo, soprattutto come prodotto trasformato in pelati, di cui è
diventato sinonimo. La pianta del San Marzano si presenta:
particolarmente vigorosa e indeterminata, per cui richiede numerosi interventi▪
discacchiatura
fusto eretto e grosso che tuttavia necessita di tutori, poco ramificato alla base.▪

ottima copertura fogliare, che consente una maggiore superficie fotosintetizzante in▪
grado di determinare una più intensa produzione ed un maggior accumulo di solidi
(acidi e zuccheri) nei frutti.
I frutti del San Marzano per il consumo fresco hanno un peso medio che varia
da 100 a 200 g; sono riuniti in grappoli di 6-10, hanno la tipica forma allungata (da
10 a 15 cm), cilindro parallelepipeda con lati di 2-4 cm. Mentre internamente si
presentano biloculari con carpelli molto allungati, esternamente sono caratterizzati da
due leggere depressioni longitudinali che solcano l’epicarpo liscio e da un apice
rettangolare ed arrotondato.
Le principali differenze che contraddistinguono le diverse popolazioni di San
Marzano sono rappresentate: dalla presenza più o meno marcata della spalla verde,
del marciume apicale, della conformazione interna del frutto che può essere ricco di
polpa oppure scatolato e vuoto con diverse condizioni intermedie. La raccolta del San
Marzano, coltivato prevalentemente in pieno campo, è scalare ed interressa, per il
mercato fresco, i frutti quando sono ancora allo stadio di invaiatura, che inizia con
una colorazione arancione nella zona apicale del frutto per cui, a prescindere dalla
sua forma, la tipologia risulta ascrivibile agli insalatari. La drastica riduzione delle
coltivazioni va imputata a problemi: fitosanitari (totale assenza di resistenze), ed
economici (scarsa produzione e notevole impegno di manodopera).
La ricerca genetica si è data molto da fare per costituire degli ibridi con frutti
simili a quelli del San Marzano in grado di soddisfare le esigenze del consumatore. I
più noti sono: Oskar (peso medio frutti 130-150 g), Sanoras e Greco (peso medio di
100-120 g) che possono essere raccolti sia allo stadio rosso maturo che invaiato. Nel
vasto panorama degli ibridi ricordiamo anche Italdor che è tipico delle coltivazioni in
serra, con frutti di 140-160 g.
Tipologie ovali per raccolta a grappolo rosso

Dopo una iniziale generalizzata diffusione la tipologia di frutti ovali, raccolti a
grappolo quando sono completamente maturi, caratterizzate da piante indeterminate,
risulta attualmente circoscritta prevalentemente alla Sardegna e marginalmente alla
Campania ed alla Puglia. I frutti, in gran parte biloculari e consistenti, hanno la
caratteristica forma ovale del pomodoro da industria coltivato in pieno campo;
singolarmente pesano da 100 a 130 g e quando sono immaturi presentano una
pigmentazione verde uniforme.
Gli ibridi maggiormente commercializzati vengono coltivati in serra; offrono
una produzione generalmente abbondante, ma le caratteristiche organolettiche non
sono sempre eccezionali. Manifestano inoltre grande sensibilità nei confronti di
alcune fisiopatie, in particolare marciume apicale, mentre ottima risulta la resistenza
alle principali patologie: Verticillum, Fusarium, nematodi, Cladosporium e TMV.
POMODORINO DI CORBARA
Tra i numerosi ecotipi locali, il pomodoro di Corbara o Corbarino, fresco o
trasformato, è quello che più si contraddistingue per caratteristiche organolettiche e
qualitative tipiche. Trattasi di un pomodoro caratterizzato da piante ad accrescimento
indeterminato e da bacche piccole di forma prevalentemente “allungata a pera”, dallo
spiccato sapore agro dolce.
Alla tipologia Corbarino sono assimilati diversi biotipi, la cui selezione è stata
curata nel corso degli anni, dagli stessi agricoltori. Essi, con molta probabilità,
derivano da vecchie varietà da conserva, coltivate in zona. L’area di origine del
Corbarino è quella delle pendici dei monti Lattari, sia sul versante costiero (Costiera
amalfitana, Penisola sorrentina) sia sul versante interno (confine sud della valle del
Sarno), dove si trova il comune di Corbara e sulle cui colline è stato sempre
tradizionalmente coltivato.
Fino a poco tempo fa, il Corbarino era coltivato quasi esclusivamente in zone
collinari, senza alcun sussidio irriguo; le produzioni erano destinate prevalentemente
ai mercati locali per il consumo fresco o per la produzione artigianale di conserve o
come pomodori da serbo, conservati a grappolo per il consumo invernale. L’aumento

della domanda, anche al di fuori dell’ambito locale o regionale, e un notevole
interesse da parte di trasformatori locali, hanno determinato uno sviluppo della
coltivazione anche in aree di pianura, dove si ottengono produzioni più elevate, anche
se con caratteristiche qualitative inferiori.
Tipologia “ciliegino”
Questi pomodori sono comparsi sul mercato, in tempi relativamente recenti,
sono adatti alla coltivazione in serra, caratterizzati da pianta indeterminata e da frutti
riuniti in grappoli, si presentano perfettamente rotondi, con diametro da 15 a 25 mm e
peso medio da 10 a 30 g. I grappoli possono essere singoli oppure biforcati; nel primo
caso il numero dei frutti viene ridotto generalmente a 10-25 e si presentano con
un’elegante disposizione a “spina di pesce”; nel secondo caso il grappolo può essere
diviso, oppure mantenuto tal quale, presentando comunque un aumento di
produttività. I frutti, di colore rosso intenso, vengono raccolti a completa maturazione
e così commercializzati.
Gli ibridi di questa tipologia di pomodoro hanno avuto, dopo un periodo
iniziale di incertezza, riconducibile all’aspetto innovativo della coltura, alla
diffidenza nei confronti del “nuovo” da parte dei produttori e dei consumatori, un
enorme successo.
Un successo che dipende:
dalla gradevolezza accertata presso il consumatore per le notevoli▪
caratteristiche organolettiche che li contraddistinguono;
dalla ridotta fluttuazione del prezzo del prodotto che è in grado di consentire▪
una sicurezza economica del produttore;
dalla possibilità di coltivarli ovunque durante tutto l’anno per la facilità con▪
cui gli ibridi maggiormente commercializzati si adattano a condizioni pedo-
climatiche differenti ed estreme;
dalla continuità della loro presenza sul mercato che gratifica i commercianti.▪

Il successo della tipologia ha motivato una intensa attività di miglioramento genetico:
piante contenute, che consentono maggiori investimenti (aumento del numero delle
piante per unità di superficie); foglie con lamina più corta, che creano condizioni di
migliore arieggiamento delle piante e pertanto prevengono l’insorgere di malattie
fungine; corredati di resistenze genetiche, che ne rendono possibile la coltivazione in
areali in cui altrimenti sarebbe impossibile.
Alcuni esempi di pomodori ciliegino resistenti alle malattie: il Conchita
resistente a Fusarium oxysporum f. sp. Radicis lycopersici, il Cherelino resistente a
TMV, il Corallino particolarmente resistente ai nematodi per cui ne è possibile la
coltivazione senza dover sensibilizzare il terreno con bromuro di metile. Inoltre il
Corallino viene particolarmente apprezzato nell’areale di Pachino, dove le
coltivazioni si sviluppano in particolari condizioni di stress (per l’elevata salinità),
che contribuiscono a far assumere all’ibrido caratteri organolettici insuperabili.
Nell’ambito della tipologia dei Ciliegini, è oggetto di particolare attenzione e
curiosità una tipologia di recente costituzione (Cherry ovali), che prevede frutti del
peso medio di 10-40 g e che presentano grande variabilità di forma: a uovo, ovale, ad
oliva oppure che ricorda in piccolo il San Marzano, ecc. Per il momento i Cherry
ovali rappresentano una nicchia di produzione da cui si approvvigionano i degustatori
di pomodoro più esigenti, alla ricerca di caratteri qualitativi particolarmente esaltanti
come ad esempio l’elevato contenuto in vitamina C, l’elevato grado zuccherino e un
aroma particolare.
Tutte queste particolarità fanno in modo che il costo di un seme di un
pomodoro Cherry ovale costa circa 10 volte di più di un normale ciliegino.
Tipologia tondo-liscia per la raccolta a grappolo
Questi ibridi, di origine israeliana, raccolti a grappolo e commercializzati
quando sono intensamente pigmentati di rosso, hanno fatto la loro comparsa sul
mercato italiano negli anni ’80.

Questa tipologia ha in parte soppiantato le cultivar che non possedevano
particolari caratteristiche di consistenza a maturazione per cui i frutti venivano
raccolti ad uno stadio di maturazione incompleta.
Il successo del pomodoro tondo liscio raccolto a grappolo è dipeso dalle
caratteristiche del primo ibrido commercializzato (Rita), che presentava una
consistenza dei frutti superiore a quella delle altre cultivar in commercio, sia per il
particolare spessore della buccia sia perché in esso era stato inserito, per la prima
volta, il carattere genetico della lunga conservazione (long shelf-life), che consente di
mantenere inalterate le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del frutto in post
raccolta per 2-3 settimane.
Molti altri ibridi sono comparsi sul mercato: Inbal, Monika, Bravo, Mirò,
Rovente. Fra questi, Rovente rappresenta l’ibrido che attualmente presenta il più
esteso panorama di resistenze genetiche: TSWV, nematodi e Fusarium oxysporum f.sp.
radicis lycopersici. I frutti della tipologia di pomodoro rosso a grappolo devono
comunque possedere i seguenti requisiti: ottima consistenza, peso medio della bacca
da 80 a 160 g, resistenza allo stacco e maturazione contemporanea nell’ambito del
grappolo, disposizione dei frutti a spina di pesce, che devono anche presentare
pezzatura uniforme.
Aspetti nutrizionali e salutari
Il pomodoro contiene un numerose sostanze nutritive come il betacarotene (che
viene trasformato in vitamina A dal nostro corpo), un potente antiossidante che
combatte i radicali liberi, e quindi l’invecchiamento, rafforzando il sistema
immunitario, facendo produrre più linfociti utili nel combattere i tumori e le
infezioni; inoltre, è un elemento necessario per la crescita ossea, per la salute dei
denti e delle mucose e per la nostra pelle.
Il pomodoro è una buona riserva di vitamina C, che elimina l’acido urico ed è
quindi indicato nelle persone affette da reumatismi, artrite e patologie
cardiovascolari; sali minerali, in particolare il potassio, quindi è considerato un

ottimo diuretico; acido lattico, arabico e malico, che facilitano la digestione e sono
ottimi disintossicanti per il corpo. Infine, la presenza di altri gruppi di vitamine, quali
la B, la K, la E, lo rendono un perfetto prodotto per la salute e la bellezza.
Il pomodoro è un alimento che apporta al nostro organismo enormi benefici
senza alcun effetto collaterale. E’ un efficace antitumorale grazie ad una sostanza, il
licopene, che si trova nella sua buccia rossa e che è incredibilmente valido nella lotta
ai radicali liberi. È stato dimostrato, e la ricerca è stata pubblicata sul Journal of the
National Cancer Institute, che chi mangia pomodori ha una maggiore protezione
contro vari tipi di tumore (al polmone, allo stomaco, al colon e al retto, al pancreas,
alla prostata, al seno e all’utero).
Il pomodoro è un ottimo antiaggregante, grazie all’ azione preventiva
esercitata dalla sostanza gelatinosa che circonda i semi. In condizioni normali, Il
consumo di pomodoro impedirebbe l’ aggregazione delle piastrine, rendendo più
fluido il sangue ed imitando così la funzione dell’aspirina (vitamina C), senza effetti
collaterali. Le piastrine infatti si aggregano in occasione di ferite con fuoriuscita di
sangue per bloccare l’emorragia; in alcune persone, invece, le piastrine si aggregano
in casi in cui non è necessari.
Il succo, sorbito lentamente soprattutto al mattino, è moderatamente lassativo,
allevia i disturbi renali legati a calcolosi, è un eccellente ricostituente, aiuta a
combattere reumatismi e gotta, protegge e rigenera il tessuto epiteliale, previene
l’insorgenza di patologie cardiovascolari e neoplasie. Costituito in media per il 94%
di acqua, il pomodoro è ricco di vitamine (A, C, B1, B2, PP); sali minerali (potassio e
sodio), oligoelementi (ferro, calcio, fosforo) e fibre; il licopene, carotenoide che ne
determina la colorazione rossa ed il cui assorbimento è facilitato dalla cottura,
possiede effetti antitumorali accertati.
Le erbe aromatiche, l’aglio e la cipolla ne rafforzano le qualità protettrici;
l’olio extravergine di oliva e il vino rosso ne potenziano l’attività anti-ossidante.
Essiccato, si conserva soprattutto sottolio assumendo un sapore molto particolare e
divenendo, in assoluto, l’alimento più ricco di provitamina A.
Gustato come aperitivo aumenta la salivazione, stimola l'appetito, facilita la
digestione attivando la mobilità gastrica. Crudo è il protagonista di stuzzicanti

antipasti e fantasiose insalate: contorno ideale per formaggi e uova, accompagna
egregiamente anche carni e pesci, soprattutto arrosto o grigliati. Squisito in graticola
o alla brace, il pomodoro rappresenta, in tutte le stagioni, un ingrediente essenziale in
cucina, soprattutto nell'area mediterranea e, in particolar modo, in quella partenopea.
Autentico jolly per l’arte culinaria vegetariana e creativa, è indispensabile per
preparare invitanti zuppe, minestre, minestroni, innumerevoli salse, sughi,
concentrati, conserve abbinabili a diversi tipi di pasta, riso, cereali, legumi e a
secondi vari. Alcune ricette a base di pomodoro, vanto della tradizione gastronomica
italiana, costituiscono eccellenti piatti unici: la deliziosa panzanella, la croccante
bruschetta, i ricchi pomodori ripieni (con riso, carne o tonno), la squisita caprese, la
mitica pizza.
In cosmesi, la polpa viene impiegata come componente di maschere tonificanti,
rassodanti e nutrienti per la pelle. Il Museo del Pomodoro, presso la Corte di Giarola,
vasto complesso curtense che si erge nella campagna a ridosso dell'alveo del fiume
Taro in provincia di Parma, è un riconoscente omaggio tributato al prezioso ”oro
rosso”, valido paladino della salute.
Le colture protette
Nel sistema agroindustriale italiano le colture protette rivestono una notevole
importanza economica sia per la loro ragguardevole estensione, oltre 40.000 ha
secondo fonti ISTAT, sia per la produzione di prodotti freschi a largo consumo e di
prodotti floricoli da esportazione.
In questi ultimi anni, ed in misura sempre più crescente, essa é oggetto di un
complesso processo evolutivo che, attraverso l’ammodernamento tecnologico dei
fattori di natura produttiva, strutturale e organizzativa, tende a privilegiare la qualità
della produzione e la commercializzazione di prodotti garantiti.
Infatti questo nuovo modello produttivo, fortemente competitivo con alcuni
paesi del nord Europa tradizionalmente più avanzati nel settore, se da un lato trova

nelle aree mediterranee favorevoli condizioni climatiche dall'altro deve risolvere
problemi di ordine energetico, ambientale ed economico.
L'ENEA, nell'ambito delle sue attività di sviluppo e promozione di tecnologie
avanzate in agricoltura, é da tempo impegnato nel settore delle colture protette con
programmi di ricerca ed applicazione fortemente innovativi che riguardano
principalmente l'aspetto della climatizzazione, dell'impiego degli agrochimici, del
monitoraggio e del controllo dei parametri produttivi. In questo lavoro viene
schematicamente illustrata l'attività che si sta svolgendo al fine di stimolare
collaborazioni scientifiche con le istituzioni pubbliche e aziende di settore.
Fra le colture protette importanza commerciale di grande rilievo spicca la
produzione del pomodoro"ciliegino" una tipologia di prodotto caratterizzato dalle
ridotte dimensioni delle bacche che oggi è offerta da numerose varietà quali panarea,
rubino top, tyty, naomi, camelia, shiren. Al fine di assecondare l'esigenza dei mercati
che richiedono il prodotto per tutto l'arco dell'anno il "ciliegino" viene coltivato sotto
serra. La coltura ha subito una forte espansione territoriale nella Sicilia sud-orientale
a partire dagli anni '80 dello scorso secolo e fino ai giorni nostri. Oggi si stima che
circa il 25-30% della superficie serricola situata nella così detta "fascia trasformata",
che si estende tra la città di Gela e quella di Pachino, sia destinata alla coltura stessa.
Le serre presenti nella zona del "Vittoriese" presentano infatti caratteristiche
costruttive molto diverse tra le varie aziende visitate anche se tutte, sotto il profilo
della climatizzazione, possono essere classificate come serre fredde. La tipologia
costruttiva più rappresentativa è quella della serra fredda costruita con pali in
cemento precompresso e collegamenti in legno avente una struttura portante
longitudinale che rappresenta l'80% circa delle strutture serricole. Questa tipologia
prevede una struttura portante longitudinale, che consta di palificazioni collegate
longitudinalmente e trasversalmente da tavole dette arcarecci che costituiscono
l'ossatura principale .
La distanza tra i pilastri di cemento precompresso è di 2 metri in senso
longitudinale e di 2,75-3,00 metri in senso trasversale, l'altezza alla gronda varia dai
2,00 ai 2,20 metri mentre l'altezza al colmo tra i 2,50-2,70 metri nelle strutture così
dette a "capannina" dove la distanza tra la gronda e il colmo è di 2 metri. Nelle serre

così dette a "capannoni" la distanza tra la gronda e il colmo è i doppio cioè 4 metri,
l'altezza alla gronda è di 2,20-2,60 metri e quella al colmo di 3,20-3,60 metri.
La superficie unitaria di queste serre si aggira sui 1000-2000 mq.
L'altra tipologia costruttiva si è andata diffondendosi negli ultimi 5-10 anni e
oggi rappresenta il 20 % circa della superficie serricola vittoriese e limitrofa .Questa
nuova tipologia è caratterizzata dalla struttura portante trasversale costituita da
pilastri e capriate in acciaio galvanizzate con bagni in zinco metallico e collegati con
bulloni e viti anch'esse galvanizzate. Sia i pilastri che le capriate sono costituiti da
profilati tubolari rotondi sagomati a freddo, posti alla distanza longitudinale di 2,50-
3,00 metri circa. Sono delle serre multiple, cioè a più navate, con una superficie
unitaria variabile da 2000 mq a 5000-10000 mq .
L'altezza alla gronda è di 3,00-3,50 metri, quella al colmo di 4,00-4,50 metri e
la navata presenta una larghezza di 8 metri.I materiali di copertura utilizzati sono dei
film flessibili prodotti con vari materiali plastici quali il polietilene (PE)e
l'etilenvinilacetato (EVA) tutti utilizzabili nelle diverse tipologie costruttive ed aventi
quasi sempre uno spessore di 0,15 mm.Il più delle volte questi film plastici sono
antigoccia (anti-fog).
Ultimamente cominciano ad impiegarsi film fotoselettivi di color rosa-violetto
in grado di assorbire le radiazioni ultraviolette evitando la loro trasmittanza e creando
all'interno della serra una situazione di mancata visibilità e quindi disorientamento
per l'insetto vettore responsabile della trasmissione del virus dell'accatocciamento
fogliare giallo del pomodoro (TYLCV) quale è la Bemisia tabaci .
La tecnica di messa in opera del film sulle strutture si è evoluta negli ultimi
anni passando dal metodo di fissare il film plastico alle strutture in legno con dei
listelli in faesite, ancora oggi utilizzato nelle serre dette a "capannina", a quello messo
in atto oggi nelle serre a "capannoni" o meglio ancora in quelle moderne con
inteliatura metallica dove il film viene applicato facilmente tramite profili a pressione
detti comunemente "rulli" che vengono pressati a baionetta.

L’acqua
Con il progresso dell’umanità il fabbisogno di acqua è andato aumentando.
L’acqua è una risorsa fondamentale per lo sviluppo degli insediamenti civili, di quelli
industriali e di quelli agricoli. E’ noto che nelle aree a carenza idrica si ha la tendenza
a privilegiare, nell’assegnazione dell’acqua, i settori ad alta priorità sociale, come
quello civile, o economico, come il turismo, a scapito ovviamente del settore
agricolo. Oggi in seguito alla crescita della popolazione mondiale,
all’industrializzazione di molti Paesi e alla necessità di una agricoltura intensiva che
fosse in grado di sfamare un maggior numero di persone con una disponibilità minore
di territorio, si è reso necessario un più oculato utilizzo della risorsa acqua.
L’uso che si è fatto dell’acqua soprattutto nel secolo scorso, ha favorito la
scarsità, lo spreco, l’inquinamento e la salinizzazione di questa risorsa. Inoltre,
sembra ormai accertato che, i cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra abbiano
incrementato la distribuzione disomogenea delle precipitazioni caratterizzata da brevi
periodi di forte intensità, anche in zone geografiche precedentemente non interessate
da questo fenomeno.
In materia di gestione delle risorse idriche, l’Unione Europea ha recentemente
dato il via allo sviluppo di una politica ispirata al principio del “cost recovery”
(Commissione Europea 2000). Secondo questo principio, ogni utilizzatore dovrà
sostenere i costi legati alle risorse idriche consumate e comprensivi dei costi
finanziari ed ambientali dei servizi idrici. In questo scenario, c’è da aspettarsi che in
molte zone si diffondano colture intensive molto remunerative (cash crops) e ad
elevata efficienza d’uso dell’acqua (WUE), come sono le colture di serra.
Nel comparto ortoflorovivaistico importante appare lo sviluppo delle tecniche
idroponiche o fuori suolo. In effetti, il risparmio idrico è uno dei maggiori vantaggi
delle colture idroponiche, insieme all’efficienza d’uso dei fertilizzanti permessa dai
sistemi con soluzione ricircolante (ciclo chiuso) ed al fatto di non dover sterilizzare il
terreno. Inoltre, l’idroponica consente di sfruttare anche un certo tipo di acque saline,

cosa non possibile per le colture a terra, perchè con le colture a terra si avrebbero, con
il passare del tempo, problemi di fertilità del terreno.
Nel settore orticolo il fenomeno della salinità viene risolto anche utilizzando
nuove varietà commerciali più tolleranti, ma attualmente per molte piante
ornamentali questa strategia non dà ancora risultati soddisfacenti. Gli imprenditori si
vedono dunque costretti a cambiare totalmente la soluzione nutritiva (mediamente
una volta ogni quindici giorni), quando, nonostante i continui aggiustamenti, la
conducibilità elettrica assume dei valori critici.
Il pomodoro è tra le specie orticole una di quelle che meglio tollera l’uso di
acque con alta conducibilità elettrica, infatti, se opportunamente adattato, può
resistere a una E.C. di 1500-2000 dell’acqua di d irrigazione possono essere
riprodotte e sfruttate nel caso delle colture “fuori suolo”, dove l’utilizzo di soluzioni
nutritive ad elevata conducibilità può costituire un efficace mezzo per migliorare le
caratteristiche qualitative della produzione.
Poiché oggigiorno su scala commerciale, si coltivano molti ibridi caratterizzati
dall’elevata consistenza e vita post-raccolta delle bacche, caratteristiche queste legate
alla presenza dei geni rin o nor, appare certo interessante studiare l’influenza
dell’irrigazione con acqua salina sulla produzione e sulla qualità dei frutti in genotipi
di pomodoro diversificati per geni coinvolti nel controllo della maturazione.
La pratica colturale in campo
Il pomodoro in generale richiede terreni freschi, ben aerati, fertili, dotati di
sostanza organica cui si provvede con apporti abbondanti di concimi organici durante

la preparazione estivo - autunnale del terreno. L’adattabilità della specie a terreni
diversi, oppure pesanti, purché ben drenati, è grande.
Nell’individuazione dei terreni più idonei alla coltura ci si avvale dell’analisi
chimico-fisica, prestando attenzione alle seguenti caratteristiche. Il pH, che per un
terreno di coltura del pomodoro dovrebbe essere compreso tra 5.8 e 7.0 da cui si
desume la tendenziale attività chimica delle soluzioni circolanti, la disponibilità
chimica di alcuni elementi nutritivi, il tipo prevalente di attività microbica.
La capacità di scambio cationico (C.S.C.) viene espressa in meq/100 g, ed
indica la capacità del terreno di assorbire e scambiare cationi: più il suolo è ricco di
sostanza organica, maggiore risulterà la C.S.C. La salinità viene espressa in mS/cm, e
fornisce indicazioni sulla quantità di sali presenti nelle soluzioni.
La sostanza organica rappresenta la fertilità del terreno. Il rapporto tra
carbonio organico ed azoto (C/N) il cui valore in terreni con umificazione e
mineralizzazione equilibrata si colloca attorno a 8-10; valori inferiori sono indice di
rapida mineralizzazione, superiori di mineralizzazione carente.
Le esigenze nutritive del pomodoro variano in relazione al tipo di coltura. È
considerata una specie potassofila, ma l’assorbimento del potassio varia con
l’intensità della coltura, il ciclo colturale e la disponibilità dell’elemento nel terreno.
Le asportazioni per unità di prodotto sono quindi variabili: in serra, con
produzioni di 120 t/ha, si possono registrare asportazioni per tonnellata prodotta di
2.70 kg di N, 1.02 kg di P2O5 e 4.60 kg di K2O; in pien’aria invece con rese di 60
t/ha si sono registrate asportazioni di 3.88 kg di N, 7.6 kg di P2O5 e 4.42 kg di K2O
per tonnellata prodotta.
Il potassio ha una azione importante sulla qualità dei frutti migliorandone il
contenuto in zuccheri, il residuo secco e il colore.
L’azoto normalmente stimola l’attività vegetativa delle piante; se però il
contenuto nel terreno è eccessivo si può avere un eccessivo rigoglio della vegetazione
e un ritardo e una riduzione della fruttificazione, oltre ad un generale peggioramento
delle caratteristiche qualitative delle bacche.
Il fosforo influenza l’equilibrio tra fase vegetativa e riproduttiva, favorisce la
formazioni di tessuti più resistenti e la produzione e consistenza dei frutti. Anche il

calcio pare avere un ruolo nella consistenza delle bacche ed inoltre la sua carenza
pare che accentui l’insorgenza di marciume apicale.
Esigenze ed adattamento ambientale
La pianta del pomodoro non resiste alle basse temperature essendo assai
sensibile al gelo; per questo motivo la coltivazione, nei climi temperato-caldi, viene
effettuata nel periodo primaverile – estivo.
Nelle regioni del sud la coltivazione può essere anticipata di un mese o due in
relazione alle condizioni climatiche. Può essere coltivata anche in serra o in tunnel
(coltura forzata), ed in questo caso si può coltivare tutto l'anno. Limiti tecnici per la
coltura sono: 0-2 °C minima letale, 8-10 °C minima biologica (zero di vegetazione),
ottimale notturna 13-16 °C, ottimale diurna 22-26 °C.
La temperatura superiore ai 30-35 °C può influire negativamente sulla
formazione del licopene e quindi sulla colorazione delle bacche, specialmente nel
caso di scarsa protezione dai raggi solari ustioni, ma anche causare difetti
d'allegagione e consistenza dei frutti. La temperatura minima per la germinazione del
pomodoro è 12 °C, per la fioritura 21 °C e per la maturazione 23 °C. L'induzione alla
fioritura sembra essere legata ad un termostadio di 10-15 °C della durata di circa due
settimane dopo la formazione dei cotiledoni.
Il fotoperiodo può intervenire su alcune caratteristiche morfologiche della
pianta. L'intensità e la qualità della luce possono influenzare l'epoche dell'iniziazione
della fioritura, la percentuale di fiori allegati e la colorazione delle bacche.
L'allegagione dei frutti di pomodoro in serra, in periodi con bassa intensità
luminosa e freddi, è piuttosto scarsa, per cui è necessario intervenire con
l'impollinazione artificiale. Anche l'umidità dell'aria, la piovosità e la ventosità
possono interferire sulle caratteristiche delle bacche e sulla produzione.
Ambienti umidi non si confanno alla crescita del pomodoro in quanto
favoriscono le malattie ed i marciumi; migliori sono quelli a clima piuttosto secco,
con terreni a grande capacità di ritenzione idrica o possibilità d'irrigazione. Dato che

la disponibilità idrica è l'altro fattore d'ottimizzazione della produttività del
pomodoro, in condizioni di clima caldo-arido l'intervento irriguo è una pratica
indispensabile; sempre più limitata la coltura asciutta, praticata con varietà locali,
nell'Italia meridionale.
Il pomodoro s’adatta a diversi tipi di suolo purché ben drenati; sistemati per
favorire lo sgrondo delle acque ed evitare l'asfissia idrica delle radici e di buona
struttura; le condizioni estreme, da molto sabbioso a molto compatto, sono
sconsigliabili. Sono preferibili i terreni a medio impasto con tendenza alla scioltezza
tipici delle località rivierasche, profondi e freschi.
La reazione ha limiti che oscillano tra pH 5,5-7,9; l'ottimale sarebbe sub-acida
o neutra, pH non inferiore a 6. Il pomodoro è una specie moderatamente sensibile alla
salinità. L'assorbimento dei principali elementi nutritivi avviene dall'inizio della
vegetazione al termine della fioritura.
Il potassio ha una maggiore influenza sulla qualità delle bacche, in particolare
sul contenuto di zuccheri, sul residuo secco ed il colore
L'azoto esalta il vigore vegetativo, è quindi un elemento importante per
l'ottenimento di rese elevate. L'eccesso d'azoto, però, può esaltare eccessivamente il
rigoglio vegetativo a discapito della fruttificazione determinando ritardo della
maturazione, maggiore sensibilità alle malattie, peggioramento delle caratteristiche
qualitative delle bacche per: eccessiva acquosità, scarsa consistenza della polpa,
tendenza allo "scatolatura" nelle varietà da pelati, riduzione degli zuccheri, aumento
dell'azoto ed acidità totale, scarsa resistenza ai trasporti ed alla sosta pre-lavorazione.
Il fosforo sebbene assorbito in quantità più modeste ha un'influenza sensibile
su uno sviluppo equilibrato della vegetazione, favorendo la formazione di tessuti
robusti ed aumentando la consistenza delle bacche.
L'abbondanza di calcio non ha effetti negativi sulla vegetazione ma favorisce
una buona fruttificazione evitando, insieme ad una buona dotazione idrica del terreno,
l'accentuarsi di fenomeni di marciume apicale. Per quanto riguarda i microelementi
particolare attenzione meritano il boro ed il cloro. Valori elevati di cloro e bassi di
boro possono creare problemi alla coltura; per gli altri la normale dotazione del
terreno è generalmente sufficiente alle esigenze della pianta.

Operazioni colturali nella coltivazione protetta del pomodoro su suolo
Come prima operazione è prevista una lavorazione del terreno più o meno
profonda, a seconda della sua natura, che va dai 0,4-0,5 metri fino ad una profondità
di 0,6-0,7 metri. I terreni che presentano delle zolle di grosse dimensioni vengono
quindi sottoposti a fresatura. Molte volte prime della fresatura viene praticata la
concimazione pre-impianto, in quanto quest'ultima può essere effettuata, a seconda
delle tecniche di disinfestione del terreno e del tipo di concime utilizzato, prima o
dopo il trattamento disinfestante. Viene praticata prima quando si somministrano
letami non sterilizzati e quindi portatori di patogeni, quando il terreno viene
disinfestato con bromuro di metile o quando si effettua la solarizzazione, in quanto
con queste ultime due tecniche non conviene lavorare successivamente il terreno.
La concimazione pre-impianto viene praticata dopo la disinfestione,
utilizzando naturalemente concimi sterilizzati, quando il terreno viene fumigato con
meta-sodium o metan-potassio e 1,3 dicloropropene .Con la concimazione pre-
impianto si somministra oltre alla sostanza organica che è rappresentata dal letame o
altro concime organico anche una certa quantità di macroelementi primari sotto forma
di azoto ammoniacale, anidride fosforica, ossido di potassio e di altri elementi quali
lo zolfo, il magnesio, il calcio e il ferro.La distribuzione del concime può essere
effettuata in due modi: o a spaglio o localizzata sulle file : nel primo caso occorre una
quantità di letame quasi il doppio per una stessa superficie rispetto al metodo di
somministrazione sulle file.
I prodotti e le dosi utilizzati per la concimazione pre-impianto a spaglio per
1000 mq sono i seguenti :
20 q/li di concime organico
150 kg di fertil ( 9-14-13 )
100 kg di zolfo
100 kg di solfato di ferro
50 kg di geomag (microelementi )

Dopo l'eventuale concimazione e la fresatura l'operazione seguente è quella
della disinfestione o della solarizzazione.
La prima tecnica consiste nell'utilizzo di prodotti fumiganti contro nematodi,
microrganismi patogeni ( Pythium sp.,
Rhizoctonia sp. Fusarium sp, Verticillum sp.,ecc ), insetti (elateridi, grillotalpa)
erbe infestanti e orobanche; tra i principi attivi più efficaci va ricordato il bromuro di
metile, il quale dal 2006 è stato bandito dal commercio, l'1,3 dicloropropene (nome
commerciale DD-SOIL), il metan-sodium e metan-potassio (nome commerciale
VAPAM) rispettivamente utilizzati per terreni poco salini e terreni molto salini.Prima
di qualsiasi trattamento di disinfestione il terreno deve essere adeguatamente irrigato
in modo da favorire la risalita dei nematodi nello strato più superficiale (10-20 cm )
in modo da rendere più efficace l'azione del trattamento.La tecnica di distribuzione
del prodotto varia in rapporto alla sua natura:
Per il trattamento con bromuro di metile, nella serra dovranno essere
posizionati dei tubi in film plastico provvisti di fori distanti 30 cm, utili per distribuire
uniformemente il gas; successivamente bisogna coprire il terreno con film plastico in
polietilene di color nero dello spessore di 0,02 mm o di color nero da un lato e bianco
dall'altro dello spessore di 0,03 mm oppure un film di nuova concenzione chiamato
film "barriera" di color nero e spessore di 0,05 mm in grado di dimezzare le perdite
per evaporazione attraverso il film del bromuro di metile.
La dose da somministrare di bromuro è di 40-50 gr/mq e può scendere anche a
30 gr/mq utilizzando il film "barriera", il film plastico viene rimosso da operatori
specializzati dopo 8-10 giorni dal trattamento.
L'elevata fitotossicità del metan-sodium o metan-k e del 1,3-dicloropropene
consiglia di somministrare i primi due prodotti 20 giorni e il terzo almeno quattro
settimane prima del trapianto.Sia il metan-sodium e potassio che l'1,3 dicloropropene
vengono distribuiti da un'apposita macchina fumigatrice portata da una trattrice e
dotata di un serbatoio, pali iniettori e una ruota per regolare la quantità di fumigante
da distribuire.

I prodotti vengono iniettati uniformemente nel terreno ad una profondità di 10-
15 cm, dopo il trattamento occorre irrigare al fine di evitare una rapida dispersione
del prodotto e garantire la discesa dei gas fino a 30 cm di profondità .
Le dosi consigliate sono di 950 l/ha di VApam e 100-150 l/ha di DD-Soil.
Se si utilizza la cloropicrina dopo aver lavorato, sminuzzato, livellato e
inumidito il terreno, si procede alla somministrazione del prodotto che viene eseguita
in due modi : per iniezione diretta nel suolo mediante macchina fumigatrice o per
diluizione tarata con acqua e immissione nelle tubature del sistema di irrigazione a
goccia, prevedendo un numero di almeno 5-6 gocciolatori per metro quadrato, al fine
dell'ottenimento di una distribuzione uniforme del fumigante.In ambedue i modi di
somministrazione il terreno deve essere coperto da teli di plastica impermeabili ai
gas, per trattenere nel suolo i vapori del fumigante man mano che si sprigionano.
La rimozione di questi teli non deve avvenire prima di 8-10 gg dal
trattamento.Le dosi consigliate sono di 20-40 gr /mq.
Qualunque sia stato il metodo di disinfestione adottato, tranne che per la
solarizzazione, prima della messa a coltura bisogna praticare una lavorazione
superficiale del terreno in modo da garantire il suo arieggiamento allo scopo di
disperdere eventuali vapori residui.
La solarizzazione è una tecnica che si è diffusa negli ultimi anni, come
alternativa al bromuro di metile, per combattere i patogeni fungini, specialmente
quelli sensibili alle alte temperature come il fasarium oxysporum radicis-lycopersici,
verticillum dahliae e alboatrum, Pyrenochaeta lycopersici che molte volte non sono
inattivati dai vari fumiganti .
Questa tecnica consiste nel coprire il terreno, ben inumidito e preventivamente
concimato, con film plastico trasparente dello spessore di 0,03 mm ben aderente al
suolo, oppure con un altro tipo di film plastico, un film coestruso, di color verde,
formato da due film uniti tra loro in grado di indurre nel terreno temperature più
elevate, anche questo spesso 0,03 mm.Per quanto concerne la natura dei film, è noto
che quelli in EVA sono più efficienti di quelli in PE. Si ottengono migliori risultati
effettuando la solarizzazione in serre "chiuse", cioè con film plastico messo in opera
sulle strutture e lasciando coperto il terreno per circa 40-50 giorni.Dopo la

solarizzazione non viene praticata nessuna lavorazione al terreno ma si effettua
direttamente la messa a coltura lasciando il film plastico anche per la pacciamatura.
Concluse le operazioni di concimazione, di fresatura e di disinfestione o
solarizzazione la serra può essere preparata per la messa a coltura. Se non è coperta
con film plastico, si procede alla messa in opera del telo utilizzandone come abbiamo
già accennato vari tipi dello spessore di 0,15 mm circa.
Nelle aperture laterali si posizionano delle reti antiinsetto in modo da evitare
l'ingresso nella serra di insetti portatori di virus come la già citata Bemisia tabaci .
Queste reti hanno una struttura a maglia molto fine presentando per ogni
centimetro quadrato 20 fili orizzontali e 10 fili verticali o, in quelle di ultima
concezione, 22 fili orizzontali e 12 verticali.
Oltre alle reti antiafidi vengono messe anche quelle a maglie più grosse con 3
fili orizzontali e 2 fili verticali per ogni cm quadrato utilizzate quando quelle antiafidi
sono alzate, ad esempio verso le ultime fasi del ciclo colturale, per evitare sia
l'ingresso all'interno della struttura di uccelli che potrebbero nutrirsi del frutto delle
piante e sia la fuoriuscita degli insetti impollinatori.
Un'altra operazione è quella dell'applicazione della doppia copertura del tetto,
che può essere effettuata pre-impianto o durante il ciclo : viene effettuata pre-
impianto quando il trapianto è previsto per il periodo compreso tra i mesi di ottobre e
marzo, durante il ciclo, nel mese di novembre, se la coltura era stata trapiantata ad
agosto-settebre. Il film plastico utilizzato è in PE, avente uno spessore di 0,015-0,020
mm, che viene applicato all'interno della struttura sotto il telo di copertura ad una
distanza di 15-30 cm con l'ausilio di fili di ferro zincati nelle serre con strutture in
acciaio e utilizzando listelli in legno nelle serre in cemento e legno.Negli ultimi anni
la doppia copertura comincia ad essere utilizzata anche per le pareti laterali delle
serre, in modo da ottenere una migliore coibentazione dell'apprestamento
dimimuendo le perdite di calore durante la notte .
Si procede quindi alla sistemazione superficiale del terreno, la cui modalità
dipende dalla tecnica di irrigazione che dovrà essere utilizzata durante l'intero ciclo
colturale:

- se si irriga con il metodo tradizionale quale è quello per infiltrazione laterale da
solchi, adottato oggi solo per il 2- 3 % dell'intera superficie serricola,oltre al
livellamento del terreno si procede alla ripartizione della superficie in tante striscie
larghe circa 2 metri, distanza che c'è tra le file delle colonne in cemento
precompresso in senso longitudinale. E' proprio in prossimità delle file di queste
colonne che vengono praticati dei cumuli di sabbia in quali avranno la funzione di
non far passare l'acqua di irrigazione da una striscia all'altra.
-se si utilizza l'irrigazione localizzata cioè quella a goccia, dopo aver livellato con
cura il terreno, si procede alla sistemazione lungo uno dei due due lati longitudinali
alla serra del tubo di mandata in PE, del diametro 63 mm, nel quale verranno
collegate tramite apposite pipette le manichette o il tubicino rigido.
Le manichette utilizzate differiscono tra di loro per la distanza che c'è tra un foro e
l'altro e per la quantità di acqua erogata in un'ora da ognuno di essi.
Due sono quelle utilizzate :
--Acqua 10 : con fori distanti 10 cm l'uno dall'altro e che erogano ognuno 1,7 litri di
acqua/ora
--Acqua 15 : con fori distanti 15 cm l'uno dall'altro e capaci di erogare ognuno 2 litri
di acqua /ora
I tubicini rigidi sono anch'essi in PE e ce ne sono di due tipi :
--- con Diametro di 16 mm, distanza fori di 10 cm e che erogano per ogni foro 4 litri
di acqua /ora

Dopo aver sistemato l'impianto di irrigazione si procede alla pacciamatura che può
essere integrale utilizzando il film plastico impiegato per la sterilizzazione con
bromuro di metile o la solarizzazione o limitata al terreno più interessato dalla fila di
piante mediante l'impiego di una striscia in film plastico bicolore, cioè bianca da un
lato e nera dall'altra, larga 40-50-60 cm a seconda della natura del terreno e
dell'epoca di impianto, avente uno spessore di 0,10 mm. La pacciamatura integrale
viene preferita durante l'inverno perchè in grado di mantenere più elevata la
temperatura del terreo e di limitare l'evaporazione di acqua con gli ovvi riflessi
sull'umidità relativa dell'aria e quindi sui problemi di natura fitopatologica. La striscia
in film plastico bicolore viene maggiormente utilizzata nei mesi estivi in quanto, pur
limitando l'evaporazione dell'acqua dal terreno evita un eccessivo innalzamento della
sua temperatura. Viene posta infatti con la parte bianca rivolta verso l'alto in maniera
da riflettere i raggi solari con maggior efficienza.Questa striscia è disponibile già
preforata, con buchi del diametro di 10 cm e distanti tra loro 25-30-35-40-45-50-60
cm.
Dopo la pacciamatura, totale o parziale, viene generalmente effettuato un trattamento
aereo per eliminare eventuali fitofagi.
Dopo un giorno da questo trattamento il terreno, preventivamente irrigato, viene
predisposto per il trapianto mediante la realizzazione di fossette nelle quali verranno
interrate le piantine con l'ausilio di un attrezzo avente una punta a cono ed un corpo
cilindrico lungo circa 15 cm che viene interrato fino alla profondità desiserata.
All'interno della serra prima del trapianto possono essere applicati dei pannelli,
spalmati di colla, di colore giallo o blu. Generalmente vengono posti lungo il
perimetro della serra, appesi con dello spago ed hanno la funzione di attirare e
catturare quegli insetti che riescono ad entrare accidentalmente all'interno della serra.
Per 1000 mq vengono distribuiti circa 30 pannelli aventi forma rettangolare, 30 cm
per 40 cm, di colore giallo per catturare specialmente la bemisia tabaci e quelli di
colore blu per attirare e catturare la Frankliniella occidentalis e la Thrips tabaci.
Terminate tutte queste operazioni preliminari viene effettuato il trapianto.
Le piantine di pomodoro "ciliegino" provenienti dai vivai e, a seconda della richiesta
dell'agricoltore, possono presentare o una o due branche .

Nel secondo caso, oltre che alle ordinarie cure colturali tipiche dell'attività vivaistica,
le piantine, dopo aver raggiunto circa 3-5 cm di altezza, vengono sottoposte ad una
potatura verde la quale prevede l' asportazione dell'apice vegetativo favorendo così la
formazione all'ascella delle due foglioline cotiledonari di germogli i quali daranno
vita alle due nuove branche della piantina.
Nell'interfila, larga 2 metri, sono presenti due manichette di irrigazione e quindi due
filari di piantine distanti 120 cm all'interno dell'interfilare con una distanza di 80 cm
tra due filari adiacenti .
La distanza sulla fila varia molto e dipende :
-dall'epoca del trapianto : in estate la distanza sulla fila è minore perché c'è più
luminosità e quindi meno competizione tra le piante
-dal tipo di allevamento : nell'allevamento ad una branca la distanza sulla fila è
minore di quella utilizzata per l'allevamento a due branche
In rapporto a questi due fattori vengono assegnate le seguenti distanze fra le piantine
sulla fila :
1. ESTATE 1 BRANCA : 25 cm
2.ESTATE 2 BRANCHE : 35-40 cm
3.INVERNO 1 BRANCA : 30 cm
4. INVERNO 2 BRANCHE : 45-50 cm
In alcuni casi l'allevamento a 2 branche può essere trasformato in quello a 4 branche,
lasciando al momento della scacchiatura delle due branche principali due nuovi
germogli laterali che daranno origine alle altre 2 nuove branche.
Quando le piantine arrivano in azienda, prima di trapiantarle possono essere
sottoposte al così detto "bagno" che consiste nell'immergere il contenitore, per tutto
lo spessore dei cubetti di torba con l'apparato radicale delle piantine, in una vasca

dove sono stati preventivamente miscelati in 100 litri di acqua le seguenti quantità di
fitofarmaci:
CONFIDOR gr 180
PREVICUR gr 120
RADIFARM gr 120
LINFOR gr 150
Questa soluzione è sufficiente per effettuare la bagnatura di circa 150 contenitori.
Il trapianto viene attuato generalmente nelle ore meno calde della giornata
posizionando una piantina per ogni fossetta ed interrandola con della sabbia alla
giusta profondità. Subito dopo il trapianto viene effettuata un'irrigazione della durata
di 20-40 minuti, utile a minimizzare lo stress post-trapianto e garantendo una
disponibilità di acqua adeguata ai fini dell'attecchimento.
Nel caso di irrigazione localizzata nei successivi 5-7 giorni al trapianto vengono
somministrati 20-30-40 minuti giornalieri di acqua a seconda della natura del terreno,
delle condizioni atmosferiche e del volume di acqua erogato dalla manichetta.
Nel caso di irrigazioni per infiltrazione laterale da solchi si irriga 3-4 giorni in estate
oppure anche 7-10 giorni se la stagione è piovosa e fredda prima del trapianto .
Circa 7 giorni dopo il trapianto viene generalmente somministrata la prima
concimazione, in copertura, impiegando concimi contenenti macroelementi e
microelementi prontamente utilizzabili dalle piante. La quantità di concime minerale
( titolo 1:3:2,5 ) somministrata in questa fase è di circa 4-5 kg per ogni 1000 mq.
Per una superficie di 1000 mq vengono utilizzati i seguenti prodotti alle dosi indicate
:
Urea fosfato kg 1,5
Fosfato mono potassio kg 0,5
Solfato di potassio kg 1,0
Solfato di magnesio kg 0,5
Amminoacidi kg 1,0

Chelati gr 250
Dopo una settimana dal trapianto viene effettuato anche il primo trattamento
antiparassitario, utilizzando insetticidi sia ad azione adulticida che ovicida, fungicidi
e prodotti ricchi in amminoacidi utili per veicolare i nutrienti o i prodotti
antiparassitari somministrati. La dose dei prodotti utilizzati per 100 litri di acqua è la
seguente :
Insetticidi adulticidi gr 40
Insetticida ovicida gr 50
Amminoacidi gr 200
Zolfo Bagnabile gr 200
Tra le avversità biotiche più diffuse in coltura protetta ricordo le "farfalline bianche"
(Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci ), le minatrici fogliari (Lyriomyza
trifolii e Lyriomiza huidobrensis ), le nottue (Spodoptera littoralis, Chrysodeixys
chalcites, Heliocoverpa armigera e Autographa gamma ) ed infine gli acari
(Tetranychus sp.) e Aculops lycopersici (Acaro rugginoso ).
Tra le patologie fungine più frequenti e più dannose sono l'oidio o mal bianco, la
peronospera o mal nero, la muffa grigia o botrite, la fusariosi e la cladosporiosi.
La seconda concimazione viene efettuata dopo 1 settimana circa dalla prima
utilizzando gli stessi concimi somministrati nella precedente concimazione ed
aggiungendo prodotti utili sia per la germinazione del polline (boro 17 ), che per la
formazioni di nuove radici (nitrato di calcio ).
Per il trattamento antiparassitario, se non insorgono problemi evidenti, si
somministrano gli stessi prodotti del primo trattamento con le stesse dosi .
Se la temperatura è elevata e la pianta tende a filare, possono essere somministrati
prodotti ad effetto brachizzante come ad esempio il tridan combi (triadimenol al 2,5
% )che viene aggiunto all'acqua di irrigazione alla dose di gr. 100 per 1000 mq e che

oltre all'azione brachizzante, esplica anche un' azione anticrittogamica di prevenione,
dovuta alla presenza di zolfo nella combinazione.
A circa 10-15 giorni dal trapianto si inizia a distinguere il primo palco che si presenta
come un'infiorescenza a racemo formata da 8-20 fiori, inserita all'ascella delle foglie.
I fiori si aprono scalarmente partendo da quelli prossimali e procedendo verso
l'estremità dell'infioresenza.
La fecondazione può essere autogama ma per facilitarla vengono utilizzate varie
tecniche :
--utilizzo di bombi: viene posta un arnia ogni 1000-1500 mq circa a seconda del
numero di fiori e della quantità di polline. L'arnia viene posizionata nella serra
quando ci sono almeno 3-4 fiori in antesi per ogni primo palco.Questa tecnica viene
adoperata quando non fa troppo caldo (tardo autunno, inverno ed inizio primavera ),
in quanto con temperature troppo elevate all'interno della serra i bombi non escono
dall'arnia e quindi non effettuano l'impollinazione.Nel periodo favorevole il ricorso ai
bombi è pressoché generalizzato in quanto oltre a consentire un notevole risparmio
all'impiego di manodopera si dimostra altamente efficiente .
--utilizzo dei soffiatori : attrezzi che soffiano l'aria verso le piante facendole muovere
e facilitando così la mobilità del polline .
-- trattamento ai fiori con una soluzione contenente prodotti auxinici: la soluzione
viene preparata diluendo in 10 litri di acqua 20 gr di prodotto allegante (sedlene ) se è
estate o 30 gr se è inverno .Alla soluzione vengono aggiunti prodotti stimolanti e
anticrittogamici. I fiori vengono bagnati spruzzando la soluzione con delle pompette
poste a 10-15 cm dall'infiorescenza, il primo trattamento viene praticato quando ci
sono almeno 3-4 fiori in antesi per ogni infiorescenza e i successivi si ripetono ogni
3-4 giorni in estate oppure ogni 4-5 giorni in inverno .
A circa 15-20 giorni dal trapianto si effettua la prima potatura verde, la scacchiatura,
che consiste nell'asportare tutti quei germogli laterali che si formano all'ascella di

ogni foglia e che entrano in competizione con l'apice vegetativo, in modo da regolare
l'accrescimento della pianta, lo sviluppo dei frutti e di agevolare le esecuzioni delle
operazioni colturali.
Dopo questa operazione, che prevede anche l'asportazione delle foglioline più
prossime al suolo scarsamente fotosintetizzanti, si procede all'applicazione di
sostegni tramite l'utilizzo di spaghi preventivamente tagliati, lunghi 2,50-3,00 m a
seconda dell'altezza della serra .Fino a pochi anni fa' si usava legare lo spago
direttamente al fusticino della pianta a circa 10 cm da terra, negli ultimi anni si è
largamente diffuso l'utilizzo di gancetti in plastica di forma circolare, con un diametro
di 3-4 cm aventi un sistema di apertura chiusura da un lato e una sorta di incastro
dall'altro. Nella parte ad incastro viene messo lo spago che così non può scorrere e
l'altra parte serve per aprire il gancetto metterlo attorno al fusticino e richiuderlo.In
entrambi i casi lo spago viene fatto girare più volte attorno al fusticino e fissato ad un
filo di ferro e posto ad un'altezza variabile col variare dell'altezza della serra .
A 3 settimana dal trapianto può essere eseguita una terza concimazione in copertura,
prevedendo una quantità di concime minerale un pò superiore a quella somministrata
precedentemente e pari a circa 6 kg ogni 1000 mq, contenente oltre che ai 3
macroelementi pricipali anche zolfo magnesio, stimolanti e sostanze in grado di
favorire la formazione di anticorpi (fitolisine ).
Per quanto riguarda i trattamenti parassitari successivi, somministrati a cadenza
settimanale, bisogna considerare i limiti imposti dalla presenza di impollinatori alla
scelta dei pricipi attivi .
A tal riguardo i fitofarmaci utilizzati vengono suddivisi in :
--prima categoria : da non usare assieme ai bombi
--seconda categoria : togliere le arnie prima del trattamento
--terza categoria : possono essere utilizzati insieme con i bombi
Anche le concimazioni in copertura vengono somministrate a ritmo settimanale alla
stessa dose complessiva utilizzata per la terza concimazione ( 6 kg di prodotti per
1000 mq ), ma variando però il titolo della miscela minerale nel corso del

ciclo.Mentre nella prima fase di crescita delle piantine e formazione dei fiori viene
somministrato un concime con una bassa quantità di azoto e medio-alta di fosforo e
potassio, nella fase centrale del ciclo colturale si aumenta la quantità di azoto totale
utile per l'ingrossamento dei frutti ed infine nella fase finale del ciclo si abbassa la
quantità di fosforo e si aumenta quella del potassio al fine di migliorare alcune
caratteristiche qualitative dei frutti: colore, sapore, consistenza.
La scacchiatura viene ripetuta più volte, a distanza di 1-2 settimane a seconda sia
della stagione che dalla vigoria della pianta. Conteporaneamente alla scacchiatura si
provvede a girare attorno allo spago di sostegno la pianta stessa al fine di evitare una
sua inclinazione con successivi problemi di filatura e rottura del fusto .
Tra le operazioni di potatura verde viene effettuata anche la sfogliatura, asportando
quelle foglie che si trovano in corrispondenza dei primi 2 palchi, cioè le prime 5-6
foglie che oltre a presentare per i processi di senescenza una bassa efficienza
fotosintetica, causano ombreggiamento ai frutti ritardandone la maturazione. Questa
operazione deve essere eseguita con molta attenzione, cercando di minimizzare le
ferite inferte alla pianta che potrebbero favorire la penetrazione all'interno della stessa
di funghi patogeni, come ad esempio la Botrytis cinerea.
Un'altra operazione di potatura è la cimatura che consiste nella soppressione
dell'apice vegetativo di ogni pianta.
Questa operazione viene effettuata quando la pianta raggiunge un'altezza di 2,00-
2,50-3,00 m a seconda dell'altezza della struttura e garantisce oltre che l'arresto della
crescita in altezza della pianta anche una maggiore affluenza di nutrienti nei frutti già
presenti .
A cimatura ultimata le piante presentano un numero di grappoli variabile da 8 a 14
ognuna a seconda l'altezza alla quale la pianta è stata cimata .
Il momento della raccolta coincide con la maturazione ottimale, per i diversi mercati,
del 1°palco; il grado di maturazione del pomodoro tipo cherry per la raccolta infatti
non è standard, ma varia in relazione alla domanda e al mercato cui è destinata la
merce :

--se la domanda è molto attiva viene richiesto ed apprezzato anche il ciliegino con
una media maturazione chiamato comunemente rosato
-- se la domanda scarseggia, viene richiesto solo quello che abbia tutti i migliori
requisiti: maturazione ottimale, lucentezza, durezza della polpa.
-- per quanto concerne al mercato, ci sono mercati sia nazionali che esteri richiedenti
una maturazione ottimale ed altri che lo preferiscono rosato .
La raccolta viene effettuata recidendo con delle forbici l'intero grappolo a circa 2-3
cm dal fusto della pianta.
I giorni che intercorrono tra una raccolta e quella successiva variano in funzione della
stagione si raccoglie ogni settimana durante la tarda stagione primaverile e tutta
quella estiva mentre si allunga il periodo tra una raccolta e l'altra durante la stagione
autunno-vernina .
In media la fase di raccolta ha una durata variabile da 60 e 100 giorni, con rese di 5-6
t ogni 1000 mq .
LE TECNICHE IDROPONICHE CON E SENZA SUBSTRATO
Colture senza substrato
Coltura in mezzo liquido statico (Deep water culture)
Questa rappresenta il primo sistema idroponico applicato commercialmente,
costituito da una vasca contenente una soluzione nutritiva, sulla quale è disposta una
rete a maglia fine con sopra un tessuto che sostiene uno strato di sabbia, con spessore

di un centimetro, in cui vengono trapiantate le piantine. Il sistema non è più
utilizzato, poichè presentava dei problemi per ipossia radicale dovuti al fatto che
veniva a crearsi una limitata superficie di scambio aria-acqua tale per cui si abbassava
eccessivamente il grado di diffusione dell’ossigeno nella soluzione.
Coltura in mezzo liquido ricircolante (Deep recirculating water culture)
La tecnica, molto diffusa in Giappone, è simile alla precedente ha il vantaggio,
però di avere un sistema per aerare (riciclo continuo) la soluzione per evitare i rischi
di ipossia radicale.
Idroponica galleggiante (Floating system)
Questa tecnica può essere realizzata su bancali impermeabilizzati con bordo di
15-20 cm e con una pendenza dello 0,5% per consentire il recupero della soluzione.
Quest’ultima viene recuperata per caduta in una vasca di deposito posta sotto il
bancale in modo da realizzare un movimento che garantisca l’ossigenazione.
Recentemente sono state realizzate anche vasche di ampie dimensioni (200-400
m2) appoggiate direttamente sul terreno spianato e sagomato, per limitare il costo
dell’impianto. Sopra la superficie dell’acqua, che ha una profondità di 20-25 cm,
viene fatto galleggiare un pannello di polistirolo con numerosi fori in cui vengono
seminate le diverse colture. La gestione della soluzione nutritiva è realizzata con
sensori di pH e E.C. posti nelle vasche di coltura, che inviano i risultati ad una
centralina la quale gestisce l’invio di nuova soluzione attraverso pompe volumetriche.
I problemi derivanti dal riciclo della soluzione nutritiva riguardando la variazione di
composizione e la diffusione di patogeni, da prevenire con adeguati filtri o con la
disinfezione della soluzione.
Oggi l’idroponica galleggiante è molto impiegata sia per la semplicità di
realizzazione che per la facilità di gestione, in particolare consentita da elevati volumi
di soluzione nutritiva (150-200 l/m2) che assicurano un alto potere tampone al

sistema, una riduzione delle escursioni termiche all’apparato radicale e inoltre un
risparmio di soluzione tale per cui essa può essere utilizzata per più cicli colturali.
In Italia questo sistema viene utilizzato per colture di ortaggi da foglia:
basilico, rucola, valerianella, spinacio, lattuga e cicoria da taglio.
Film di soluzione nutritiva (nutrient film technique) NFT
Il sistema NFT è stato ideato da Cooper in Inghilterra a partire dal 1970, si è
poi diffuso nei Paesi del Centro-Nord Europa. Negli impianti NFT la soluzione
nutritiva circola direttamente a livello radicale senza la presenza di substrato, scorre
in canalette opportunamente inclinate e raccordate con un deposito centralizzato da
cui, attraverso una pompa, avviene la distribuzione. Si possono utilizzare diverse
tipologie di canalette in base ai materiali impiegati ed alle dimensioni adottate,
semplici (a tenda od a busta) oppure multiple.
Le canalette debbono essere sufficientemente rigide, con una pendenza (1.5-
2.5%), tale da permettere il deflusso della soluzione che vi scorre in strato sottile (2-3
mm) e che scende per gravità al deposito, posizionato al di sotto del piano di
coltivazione, in cui sono inseriti i sensori per il controllo della soluzione. I materiali
impiegati per le canalette possono essere manufatti metallici come l’alluminio,
l’acciaio inox o le lamiere zincate se rivestite con un film di polietilene per evitare
problemi di tossicità. La lunghezza delle canalette varia da 10 a 40 m (generalmente
20-25 m), la larghezza da 15 a 25 cm, la profondità da 5 a 10 cm.
Il dimensionamento del deposito dipende dalle canalette, ma comunque si
cerca di avere dei volumi grandi per riuscire meglio a compensare le variazioni di pH
e di E.C. Le piantine, allevate precedentemente in substrato inerte di perlite o lana di
roccia, sono poste nelle canalette ricoperte da film plastico nero o bianco
impermeabile alla luce. Le radici che si adagiano sul fondo della canaletta sono
bagnate da un velo di soluzione in scorrimento.
L’ossigenazione della soluzione si realizza per caduta al momento del ritorno
nel deposito. La distribuzione della soluzione può essere continua o intermittente (15

m ogni 15-45 m di sosta), in questo ultimo caso si economizza energia elettrica e si
realizza una maggiore aerazione dell’apparato radicale, ma si possono determinare
maggiori temperature e concentrazioni della soluzione nutritiva a livello radicale. E '
stata adottata per le colture orticole ( soprattutto pomodoro).
In seguito al diffondersi della coltivazione su lastre di lana di roccia con
soluzione a perdere, più vicina alla tradizionale coltivazione a terra e con minori
problemi di gestione. ha subito un rallentamento. Le problematiche suscitate negli
ultimi anni dalla necessità di ridurre l’impatto ambientale della coltivazione fuori
suolo e l'evoluzione dei sistemi di gestione e controllo della soluzione nutritiva hanno
determinato nuovo interesse verso questa tecnica.
Il sistema consente di eliminare il substrato di coltivazione, che è utilizzato in
piccola quantità e solo per la fase di semina; infatti l'apparato radicale si sviluppa
all'interno di canalette, nelle quali scorre, in continuo o ad intermittenza, un sottile
film di soluzione nutritiva da cui attinge direttamente acqua e nutrienti, e in cui
rilascia escreti radicali.
L'assenza del substrato di coltura consente però un controllo più immediato
della nutrizione della pianta: con interventi mirati a variare la composizione azotata
della soluzione nelle fasi terminali del ciclo colturale prima della raccolta il contenuto
di nitrati negli ortaggi da foglia può essere controllato in NFT, migliorando le
caratteristiche qualitative della produzione. (Van der Boon J. et al., 1990). La
coltivazione in NFT viene comunemente ritenuta non adatta per coltivazioni a ciclo
molto lungo quali ad esempio pomodoro o gerbera, in quanto caratterizzate da un
elevato sviluppo dell’apparato radicale al quale fa seguito un precoce invecchiamento
riduzione di funzionalità delle radici con conseguente aumento dell’incidenza di
malattie radicali.
Sistema New grovig system (NGS)

IL sistema di coltivazione NGS rappresenta una nuova forma idroponica
sperimentata interamente in Almerita dall’impresa NEW GROWING System S.L. A
partire dalla sua nascita nel 1991 NGS ha subito nuove tecnologie permettendo di
adattarlo alle necessità del mercato e alle esigenze dei produttori , ai nuovi sistemi di
produzione integrata, nonché a nuove coltivazioni.
Il sistema si basa nella circolazione di una soluzione nutritiva all’interno di
sacche comunicanti in polietilene sistemate una dentro l’altra. La disposizione delle
sacche è tale che la soluzione nutritiva scorre su un tratto più o meno esteso della
sacca secondo i diversi modelli, passando a quella inferiore attraverso dei fori che
mettono in comunicazione le diverse sacche.
La soluzione nutritiva uscita dal gocciolatore percorre un lungo tratto bagnando
un ampia superficie mettendo a disposizione alle radici acqua, ossigeno e nutrienti .
Nello stesso tempo la soluzione nutritiva ritira dalla rizosfera gli ioni non assimilati e
i composti escreti dalle radici e contribuisce a rinnovare i gas che partecipano alla
respirazione radicale (ossigeno e anidride carbonica). Si utilizza una soluzione
nutritiva riscaldata(inverno) o raffreddata (estate) la soluzione nutritiva facilita lo
scambio di calore del sistema radicale.
Fig.1. - Sacca NGS con vasca di raccolta
Le radici nel trapianto si trovano a contatto con la prima sacca quella superiore,
spinti dal movimento dell’acqua che scorre per una leggera pendenza della sacca,
passano attraverso il foro scendendo nella sacca inferiore. Questo movimento si
ripete tante volte quante sono le sacche che costituiscono la borsa, cosi che il sistema
si adatta a numerose coltivazioni.

Cosi, oggi l’NGS permette di coltivare numerose specie orticole nonché floricole.
Modalità di installazione NGS
Il sistema NGS può essere istallato in aziende con superfici differenti, sia in
coltura protetta che in pieno campo. Negli ultimi anni ha permesso di ottenere buone
coltivazioni di pomodoro, peperone, melone fragole e non si scarta la possibilità di
coltivare rose viti e agrumi.
Borsa di istallazione NGS
La borsa è l’elemento fondamentale del sistema NGS ,e si presenta in diverse
forme specifiche per le diverse coltivazioni . La sezione trasversale della borsa
formata da 5 strati di polietilene Blanemer.
Lo strato esteriore ha uno spessore di 150 micron, esteriormente è di colore
bianco per aumentare la radiazione solare nel periodo invernale mentre interiormente
è di colore nero. I rimanenti strati hanno uno spessore di 75 micron e sono di colore
nero per evitare la dispersione della luce all’interno della borsa e lo sviluppo di alghe.
La posizione che occupano gli strati interni della borsa dipendono dal tipo di
coltivazione a cui è destinata la borsa e sono forate con fori equidistanti di differente
forma. La forma e la posizione di questi fori permettono di ottimizzare lo sviluppo
delle radici e l’assorbimento di acqua e nutrienti senza compromettere l’aerazione.
Il sistema NGS si basa su ricircolo di una soluzione nutritiva la cui
composizione è formulata per sostenere le necessità nutritive delle piante coltivate.
Le necessità in elementi minerali delle colture dipendono dalla specie coltivata e in
alcuni casi dalla varietà,per esempio il pomodoro , la fragola,e la lattuga richiedono
quantità di elementi ben diversi.
- dallo stadio fenologico della coltura, per esempio nel caso del pomodoro il
rapporto N/K è maggiore nella fase vegetativa che nella fase riproduttiva.

-dalla stagione di coltivazione, in particolare dalla radiazione solare e dal
fotoperiodo.
-dal momento del giorno, in quanto durante la fase diurna le necessità di acqua
delle coltivazioni aumentano, come conseguenza della maggiore traspirazione che si
ha con gli stomi aperti.
- dalla qualità dell’acqua d’irrigazione e dalla loro frequenza.
- dalla possibilità di indurre stress idrici al fine di conseguire determinati scopi
nella coltivazione (induzione fiorai nella fragola,aumento della qualità nel
pomodoro).
Il sistema NGS permette in qualsiasi momento il cambiamento rapido della
soluzione nutritiva secondo le necessità della coltura e del produttore avvantaggiando
il sistema rispetto ad altri sistemi di coltivazione.
Aeroponica
Questa tecnica è stata ideata per ridurre al minimo la soluzione nutritiva, che
viene riciclata e spruzzata sulle radici confinate in un intercapedine priva di luce. Si
compone di una struttura di sostegno in profilato metallico zincato che assume una
forma triangolare con angoli alla base di circa 50º, per meglio sfruttare lo spazio
culturale. Sui lati della struttura vengono posti dei pannelli di polistirolo sulla cui
superficie sono ricavati dei fori di 1.5 cm, in cui vengono inserite le piantine da
coltivare.
L’aeroponica è stata messa a punto in Italia negli anni ’70, ma ha trovato
scarse adesioni al di fuori degli ambienti di ricerca (Massantini 1985) per le difficoltà
di realizzazione (richiede tecnologie avanzate, con notevoli rischi nella gestione
idrica in caso di interruzione di corrente poiché non esiste alcun volano idrico a
livello radicale). Inoltre questa tecnica si adatta solo a colture di piccola taglia:
lattuga, fragola (Pisanu, 2000). La produzione per unità di superficie aumenta grazie
alla disposizione inclinata dei pannelli, ma purtroppo questo comporta che le piante

che si trovano nelle file più basse presentino uno sviluppo inferiore rispetto a quello
delle file poste più in alto per la minore illuminazione che ricevano (Repetto et al.,
1994).
Coltivazione in aeroponica ad elevata densità (HDAS)
Nei sistemi di coltivazione aeroponica le piante sono sorrette da semplici
strutture di sostegno e gli apparati radicali si sviluppano al di fuori di qualsiasi
substrato liquido o solido, sono infatti sospesi e ricevono la soluzione nutritiva in
forma nebulizzata attraverso gli appositi erogatori.
Questo sistema è stato utilizzato con successo in prove sperimentali di
coltivazione di pomodoro, sedano e lattuga e consente di realizzare un notevole
incremento della produttività per m2 di serra.
Per verificare se anche le specie da fiore,in particolare quelle da mazzetteria,
possano trarre vantaggio dall’applicazione di questa di innovazione applicativa è
stato finanziato dal MiPAF un progetto di ricerca che si proponeva di verificare
l’adattabilità di fresia e anemone alla coltivazione con questa tecnica.
Le strutture che sorreggono le piante, tubi in PVC o più frequentemente
pannelli in polistirolo espanso, possono avere disposizione verticale,orizzontale o su
un piano inclinato, in questo caso consentono di adottare densità di impianto più
elevate. Le nebulizzazione della soluzione nutritiva sulle radici può avvenire ad
intermittenza o in ciclo continuo, la soluzione eccedente ricade alla base della
struttura di sostegno e viene ricircolata (Leoni S. et al. 1994).
Le prove condotte presso il C.R.A.S. prevedono l’utilizzo di una struttura di
supporto a sezione triangolare in tondino di ferro zincato del diametro di 8 mm, con i
due lati inclinati di 50° su cui poggiano pannelli in polistirolo ad alta densità (25
Kg/m3). Sui pannelli sono praticati dei fori dove trovano sistemazione le piantine
preparate su cubetti di lana di roccia,oppure nel caso della coltivazione di anemone e
fresia ,direttamente i bulbi.

All’interno della struttura di sostegno sono state montate le condotte per la
distribuzione della soluzione nutritiva,dapprima con una disposizione a due ali e
successivamente a tre, sospese a diversa distanza dalla base, dotate di ugelli
spruzzatori tipo “dan-fog”, con portata di 35 l/ora. I tempi di erogazione della
soluzione nutritiva sono stati, in relazione alle condizioni ambientali, di 3-5 minuti,
quelli di pausa di 15-20 minuti; durante la notte, invece gli interventi venivano
sospesi del tutto. La semina avviene nei vasetti o nelle scanalature direttamente sui
pannelli che prima, prima di essere essi sulle vasche possono stazionare fino
all’emergenza in ciclo breve quali ortaggi da foglia come rucola o basilico.
L’apparato radicale della pianta si sviluppa all’interno della vasca risultando
completamente o parzialmente immerso nella soluzione nutritiva. Gli impianti
specializzati esistenti sono tutti dotati di doppio sistema di riscaldamento acqua aria
in modo da garantire condizioni termoigrometriche in grado di prevenire attacchi di
botritis. La brevità del ciclo colturale non rende necessario reintegrare gli elementi
nutritivi nella soluzione, solo tra un ciclo e l’altro vengono corretti il pH e la
conducibilità elettrica con aggiunta di acqua e soluzione concentrata. Essendo il ciclo
chiuso si rende anche in questo caso necessaria la filtrazione della soluzione nutritiva
per evitare lo sviluppo di patogeni.
Nella rivista colture Protette (Luglio 2000,pagine 57-61) un interessante
articolo riferisce che in Olanda un sistema idroponico di questo tipo si sta
diffondendo presso i coltivatori di tulipano,giacinto e iris da fiore reciso.
Presso il C.R.A.S. è in fase di allestimento un impianto idroponico galleggiante
per la coltivazione di iris. Le vasche di coltivazione (1,45 m x 5,15 m) con pareti in
alluminio ed il fondo in polistirolo ad elevata densità, sono state impermeabilizzate
con un film di polietilene di spessore 0,2 mm e saranno riempite con la soluzione
nutritiva per uno spessore di 6-8 cm. Sulla superficie saranno adagiati dei plateaux
alveolari in polistirolo, con gli alveoli di dimensioni adeguate a contenere bulbi di
calibro 9-10 e 10+, realizzando una densità di impianto di 219 bulbi/m2 di bancale.
E’ previsto il ricircolo della soluzione nutritiva, con cicli di lavoro della durata
di 15 minuti alternati a 15 minuti di pausa. La prova si propone di verificare due
tecniche di immissione nella vasca:

1) da un solo punto di ingresso con una portata di 6 litri al minuto.
2) Tramite 52 spruzzatori da 7 litri/h disposti a distanze regolari su due ali a pochi
centimetri dalla superficie dell’acqua, allo scopo di ottenere sia una maggiore
ossigenazione che una distribuzione uniforme dell’ossigeno nella soluzione,
garantendo come nella tesi 1 una portata di 6 litri al minuto
Se saranno confermati gli incoraggiamenti risultati ottenuti dai coltivatori
olandesi, si potrà intravedere anche presso i nostri coltivatori, una espansione su larga
scala di questa tecnica per la coltivazione di iris e altre bulbose da fiore reciso come
narcisi giacinti e tulipani , infatti l’idrocoltura non richiede tecnologie molto
sofisticate e consente di ridurre notevolmente i costi di produzione.
Coltivazione NGS
Un nuovo sistema spagnolo "New Growing System". Le linee di coltivazione
del NGS sono costituite da tubolari in polietilene formati da due o tre fogli di diverso
diametro disposti, uno interno all'altro, a formare due o tre strati . Sulla parte
basale dei tubolari più interni sono stati praticati dei fori, uno ogni 45 cm, alternati
negli strati intermedi in modo che non siano mai sovrapposti. Questi fori consentono
alla soluzione nutritiva e all'apparato radicale di raggiungere gli strati sottostanti. Le
linee di coltivazione sono sospese a 40÷50 cm altezza dal terreno, sostenute da una
struttura portante in cavetto di acciaio (tipo vitifil da 0,8 mm) tesa tra i cavalletti
normalmente utilizzati per sostenere le reti di tutoraggio degli steli, ben ancorata in
testata per sostenere il peso della coltura e garantire una adeguata pendenza, per
favorire il recupero della soluzione nutritiva. Questa viene erogata dall'alto, sul bulbo
adagiato direttamente sulla superficie del primo tubolare e sulla parte basale dello
stelo che rimane all'interno dello stesso, mediante nebulizzatori tipo Dan Fog da 7
litri/ora disposti accoppiati e rivolti in direzione opposta a circa 21 cm di distanza
(una coppia ogni 3 bulbi).
Per la preparazione della soluzione nutritiva é stata utilizzata acqua di origine
meteorica raccolta in apposite vasche. Le caratteristiche chimiche dell'acqua hanno

consentito di adottare una gestione in ciclo chiuso, pertanto la soluzione è stata
giornalmente reintegrata con soluzione a composizione costante e non è stata
necessaria alcuna correzione. I tecnici che promuovono la commercializzazione di
questo nuovo sistema di coltivazione, utilizzato prevalentemente per la coltivazione
di specie ortive, consigliano un'erogazione continua della soluzione nutritiva ed il
funzionamento dell'impianto anche nelle ore notturne.
Si è ritenuto opportuno proseguire la sperimentazione sulla gestione della
soluzione nutritiva con questo sistema allo scopo di verificare se le difficoltà
riscontrate siano da imputare alla gestione della distribuzione della soluzione
nutritiva e superabili con l'erogazione continua effettuata anche nelle ore notturne.
Gestione del rifornimento minerale
La distribuzione degli elementi nutritivi nel settore ortoflorovivaistico viene
anche eseguita attraverso la fertirrigazione. Si tratta di una tecnica che permette di
gestire contemporaneamente due operazioni: l’irrigazione e la concimazione.
Fondamentali risultano la conoscenza delle caratteristiche dell’acqua da
impiegare, le esigenze nutrizionali ed idriche della coltura e le tecniche per la
preparazione della soluzione nutritiva. I vantaggi che ne derivano sono
essenzialmente:
una distribuzione uniforme degli elementi nutritivi nelle vicinanze
dell’apparato radicale;
la possibilità d’intervenire in maniera tempestiva e mirata alle esigenze della
coltura;
la possibilità di automatizzare la gestione e distribuzione della soluzione
nutritiva
ridurre i consumi dei concimi e dell’acqua d’irrigazione nonché ridurre
l’impatto ambientale in particolare nei sistemi a ciclo chiuso.

Dell’acqua che verrà utilizzata per effettuare la fertirrigazione vengono osservati
il pH, il contenuto dei carbonati, la salinità e gli elementi nutritivi in forma ionica.
Con questi dati è possibile capire quali saranno i quantitativi di sali e sostanze acide
da apportare per formulare la soluzione nutritiva più appropriata alla coltura.
Non è detto però che ogni specie abbia bisogno di una soluzione nutritiva
specifica; è stato dimostrato sperimentalmente che le specie nelle quali il tasso di
crescita è limitato la particolarità nella composizione della soluzione nutritiva è poco
importante (ad esempio coltura di fragola e piante ornamentali).
Le specie appartenenti alla famiglia delle solanacee e cucurbitacee,
contraddistinte da elevati tassi di crescita, richiedono soluzioni nutritive più
concentrate. Più importante è un altro aspetto ossia le condizioni climatiche e
colturali nelle quali le piante si vengono a trovare; le stagioni più favorevoli alla
crescita contraddistinte per temperatura e radiazione solare maggiore inducono le
piante a richiedere quantitativi superiori di acqua ed elementi nutritivi. Un altro
aspetto che può diventare limitante nello sviluppo di una specie è la salinità della
soluzione nutritiva, sia per la matrice di partenza (acqua irrigua) sia nell’uso, in
particolare nei cicli chiusi, della soluzione nutritiva. La miscelazione dell’acqua con
le soluzioni nutritive concentrate (soluzioni madri) avviene attraverso dei miscelatori
(fertirrigatori) che provvedono inoltre al controllo del pH e della E.C.
Come è stato descritto precedentemente la soluzione nutritiva, che viene
erogata alle piante, è stata preparata miscelando acqua più soluzioni stock. Queste
vengono preparate in forme concentrate di 100-200 volte fondamentalmente per
motivi pratici, di spazio e gestione, dei quantitativi di sali ed acidi da usare. La
tendenza di alcune sostanze a dare delle reazioni indesiderate costringe a comporre
due o più soluzioni stock. Si possono verificare di fatto precipitazioni di sali a base di
calcio e degradazioni di sostanze organiche (come i chelati del ferro e dei
microelementi) quando con esse vengono addizionate delle sostanze acide.
Importante è anche il materiale che compone il contenitore che ospita la soluzione, il
quale non deve essere reattivo. Le soluzioni concentrate che vengono composte
spesso sono tre, nominate soluzione A, soluzione B e soluzione ACIDA.

Nella soluzione A possono essere contenuti i sali di calcio, sostanze chelate e
sali contenenti cloruri. In soluzione B si possono mettere sali a base di solfati, fosfati
ed alcuni di nitrato. Durante la preparazione della soluzione madre i sali debbono
essere sciolti con acqua tiepida per impedire fenomeni di precipitazione.
Le tecniche idroponiche con substrato
Le colture idroponiche si sono inizialmente diffuse nei paesi del Centro Europa
(Olanda,Belgio, Francia, Inghilterra, Germania, Danimarca) ed attualmente, con
l’impiego di tecnologie semplificate, si stanno sviluppando anche nell’area
mediterranea (Spagna ed Italia).
Le prospettive di sviluppo sono tuttavia legate alla complessa situazione
tecnica (formazione di personale per la gestione della soluzione nutritiva), economica
(attività ad elevati investimenti di capitale) ed alle diverse realtà ambientali (dalla
Sicilia al Trentino Alto Adige) che richiedono adattamenti tecnologici e d’indirizzo
colturale molto validi. Le colture “fuori suolo” siamo soliti dividerle in due gruppi: le
colture fuori suolo caratterizzate dalla presenza del substrato e quelle caratterizzate
dall'assenza del substrato (coltivazione in mezzo liquido).
Gli impianti senza substrato sono caratterizzati dal ciclo chiuso, cioè da un
sistema in cui la soluzione nutritiva viene riciclata in maniera continua od
intermittente. Invece gli impianti con substrato possono essere condotti a ciclo aperto
con dispersione della soluzione drenata oppure a ciclo chiuso con depositi e pompe
supplementari che ne permettono il riciclo.
Tutte queste tecniche si differenziano per il tipo di substrato e per il tipo di
contenitore, tuttavia la struttura dell’impianto e la distribuzione della soluzione
nutritiva sono molto simili a quelle degli impianti precedenti anche se, in questo caso,
può essere praticato il ciclo aperto,che riduce i problemi riguardanti la gestione della
soluzione nutritiva, ma che non rappresenta certo il migliore tipo di impianto per

riuscire a contenere i consumi idrici ed il fabbisogno in sali, aspetti da non trascurare
per i risvolti di tipo economico ed ambientale.
Coltivazione in bancali con sabbia (sand culture)
I bancali sono fatti in cemento prefabbricato, sono alzati da terra da un minimo
di 20 cm fino ad 1 m, con larghezza tra i 90 e i 120 cm. Vengono riempiti con
substrati inerti di vario tipo (pomice, pozzolana, perlite) talvolta con aggiunta di torba
per aumentare la capacità di ritenuta idrica e sono alimentati con soluzioni nutritive.
Occorrono notevoli quantitativi di substrato in quanto sono profondi da 20 a 30 cm.
La distribuzione della soluzione avviene per mezzo di una o due linee di
irrigazione localizzata, appoggiate sopra il bancale, e provviste di ugelli che
distribuiscono l’acqua per dispersione oppure a goccia. La gestione della soluzione
nutritiva non prevede alcun riciclo.
Successivamente alle strutture in cemento, nelle serre, sono apparse le canalette
di materiale plastico, che comportano un minor costo d’impianto e di manodopera.
Comunque la coltivazione in bancali o in canaletta sta scomparendo per la notevole
quantità di substrato che occorre.
Coltivazione in sacco
Questo tipo di coltivazione si è sviluppato a partire dal 1960 in Olanda, Belgio,
Danimarca, Regno Unito con sacchi di torba con sistemi di irrigazione a goccia.
Successivamente il metodo di coltivazione è stato perfezionato con l’impiego di
substrati inerti (lana di roccia, perlite, poliuretano, pomice, ecc) che risultano più
facili da gestire per la loro non interferenza con la soluzione nutritiva.
La movimentazione dei sacchi è facilitata dalla leggerezza dei substrati
impiegati e non richiede particolari interventi strutturali in serra. Gli unici interventi

da effettuare sono il livellamento e la pacciamatura del terreno con la predisposizione
di canalette per lo scarico o la raccolta della soluzione drenata.
Nel caso della lana di roccia e del poliuretano il materiale è sagomato in sacchi
5.0-7.5 cm di altezza, di 15-30 cm di larghezza e di lunghezza 90-100 cm rivestiti di
P.E. bianco impermeabile alla luce e forati alla base per favorire il drenaggio. Altri
materiali inerti, come la perlite e la pomice, hanno minore capacità di ritenuta idrica e
quindi richiedono sacchi di volume maggiore: 20-25 litri per moduli di un metro,
rispetto ai 10-13 litri della lana di roccia e della torba.
La perlite e la pomice pongono minori problemi di smaltimento al termine
della loro utilizzazione rispetto alla lana di roccia,ma debbono essere sbriciolate per
aumentare la loro aerazione. La soluzione nutritiva, la cui composizione varia con le
specie nella maggioranza dei casi è distribuita a ciclo aperto con 4-12 interventi al
giorno, mediante impianto di irrigazione a goccia, in modo da compensare i
fabbisogni idrici della coltura e le perdite che avvengono per drenaggio.
Nel caso del Ciclo aperto, pertanto, i volumi irrigui corrispondono all’acqua
evapotraspirata dalla pianta, a cui si deve aggiungere un 10-20%, in modo da
consentire un minimo di drenaggio per evitare aumenti di salinità all’interno del
sacco. In condizioni ottimali il surplus di soluzione distribuita e perduta per
drenaggio può risultare contenuto entro il 2-6% (Bohme, 1993).
La coltura in sacco a ciclo aperto limita la diffusione di eventuali malattie, a
livello delle radici e del colletto, all’interno del singolo modulo che ospita poche
piante. In alcuni Paesi ad elevata densità serricola come l’Olanda il ciclo aperto non è
più ammesso ed è stato sostituito dal ciclo chiuso che permette di raccogliere la
soluzione drenata per riutilizzarla una volta trattata e disinfettata.
4.14 Coltivazione in vaso
Differentemente dalla coltura in sacchi dove ci sono 2 o 3 piante per ogni
sacco, nella coltura in vaso c’è una sola pianta per ogni vaso. Tutto questo comporta

maggiori costi e quindi la coltura in vaso viene usata principalmente per le colture
floricole essendo esse più remunerative di quelle orticole.
Le colture in vaso si possono a sua volta dividere per tipo di irrigazione
adottato: irrigazione capillare, irrigazione a goccia, canalette a scorrimento, bancali a
flusso e riflusso, idrocoltura.
4.15 Irrigazione capillare
L’irrigazione capillare viene realizzata su bancale od a terra su piani livellati,
in entrambi i casi con pendenza dello 0.5-1% per consentire il recupero della
soluzione in un deposito da cui poi viene rinviata mediante una pompa. Sul bancale
viene steso un film di PE, per ottenere la impermeabilizzazione della base, ed un
tappetino in lana di roccia che viene costantemente umido per consentire la risalita
capillare dell’acqua nei vasi che vi vengono appoggiati.
Con questo metodo si realizza un regime idrico ad umidità elevata e costante,
adatta solo a certi tipi di colture (felci, Saintpaulia, bromeliacee, piante da fogliame
decorativo). Importante è soprattutto la granulometria del substrato che deve essere
abbastanza sottile per garantire la risalita capillare, ma tale da permettere la
circolazione dell’aria ed evitare eccessiva ritenuta idrica.
Normalmente si impiegano miscele a base di torba e perlite (85% torba, 15%
perlite). Elevata densità di investimento 10-12 piante/m2. Questo metodo può
comportare alcuni inconvenienti: formazione di alghe sul tappetino (si può rimediare
stendendo un film di PE nero sul piano del bancale), fuoriuscita delle radici dal vaso,
possibilità che non tutti i vasi abbiano la continuità capillare.
Questi svantaggi fanno sì che il sistema venga applicato solo in colture di breve
ciclo o nella fase iniziale del ciclo stesso.
4.16 Irrigazione a goccia

Si impiegano gocciolatori singoli o multipli a seconda della grandezza del
vaso da 1-2 l/h, ma è richiesta una elevata precisione nel gocciolamento con buona
uniformità di distribuzione nelle varie posizioni della serra, infatti l’impiego di
singoli gocciolatori in singoli contenitori può determinare risultati di crescita assai
differenziati a seconda dei quantitativi di acqua distribuita. Servono delle cabalette a
scorrimento per raccogliere l’acqua di drenaggio.
Le canalette utilizzate per questo metodo sono costruite in metallo o plastica
della lunghezza di 8-12 m, vengono appoggiate su sostegni alti un metro, e sono
inclinate con pendenze di 1% per recuperare la soluzione nutritiva. La larghezza
oscilla tra i 15 e i 20 cm in modo da accogliere vasi da 13 a 18 cm di diametro. Le
canalette sono riunite in gruppi di 6-8 alternati a passaggi di 50 cm.
La distribuzione è variabile per durata (15-30 min per volta) e frequenza (1-4
volte al giorno) a seconda della grandezza del vaso, del tipo di substrato e del
fabbisogno della pianta. L’acqua viene assorbita per capillarità della base del vaso e
quindi richiede un substrato adatto, tuttavia a differenza del metodo dell’irrigazione
capillare il regime idrico del vaso non è costante, ma variabile in quanto il contenuto
in umidità varia tra una distribuzione e l’altra.
Un eventuale eccesso di salinità migra verso la parte alta del vaso ove non si
sviluppano radici, con effetti trascurabili sulla crescita.
Questo sistema garantisce una buona aerazione del substrato, ma non si evitano
le trasmissioni delle malattie, pertanto occorre allestire un sistema di filtraggio o
disinfezione della soluzione recuperata.
4.16 Bancali a flusso e riflusso
I bancali impermeabilizzati sono collegati ad una vasca sottostante in cui viene
raccolta la soluzione nutritiva con un sistema di valvole e di pompe idonee.

La soluzione nutritiva viene pompata nel bancale con frequenza variabile
(ogni 1-3 giorni) a seconda della necessità delle piante, raggiunge un’altezza di 2-4
cm a seconda dell’altezza dei vasi, e vi permane per 15-20 minuti in modo da
consentire all’acqua di essere assorbita dai vasi attraverso i fori di drenaggio. Anche
con questo metodo occorre disinfettare la soluzione nutritiva riciclata.
Le condizioni di umidità a livello della coltura rimangono sempre molto
elevate, pertanto occorre controllare le condizioni ambientali in maniera rigorosa e
non eccedere nella densità colturale.
4.17 Idrocoltura
Questa tecnica viene utilizzata soltanto per la produzione di piante ornamentali
da appartamento. L’idrocoltura viene fatta su di un substrato inerte (argilla espansa)
in un vaso di plastica forato sulle pareti; questo vaso è posto dentro un portavaso
dotato di un indicatore di livello del volume della soluzione nutritiva. La soluzione
nutritiva arriva alle radici per capillarità e non necessità di aerazione essendo limitata
a 4-5 cm di altezza (circa ¼ dell’altezza del vaso).
La soluzione iniziale, ottenuta con aggiunta di sali idrosolubili (2-3 g/l), viene
mantenuta a livello mediante aggiunta di sola acqua nel caso delle resine e di
soluzione nell’altro caso; pH e conducibilità della soluzione sono controllati e corretti
ogni 15 giorni; la sostituzione completa della soluzione avviene ogni 2-3 mesi. I
principali vantaggi delle piante allevate con questo sistema sono: maggiore durata in
appartamento, minore sviluppo radicale che permette di eliminare i rinvasi, assenza di
substrati organici che sporcano e ospitano parassiti.
4.17 L’impiego delle acque saline in idroponica

Le caratteristiche delle acque di irrigazione influenzano considerevolmente lo
sviluppo delle piante. I difetti delle acque possono riguardare la temperatura o la
composizione chimica.
Acque con temperatura molto bassa rispetto a quella dell’aria e del suolo
provocano sempre problemi di crescita per le piante. Le temperature ottimali
oscillano da 16 a 21 º C. Da un punto di vista chimico si deve considerare il
contenuto in sali solubili e la qualità dei sali disciolti. La determinazione della
quantità dei sali solubili, espressa come estratto secco (mg/l o ppm), oppure come
conduttività elettrica (µS/cm a 25º C) ci può dare una prima indicazione sulla qualità
dell’acqua. Nella Tabella 1 sono riportati i valori delle qualità dell’acque utilizzate
nelle colture protette.
Le acque “molto buone” sono adatte a qualunque coltura ed a qualsiasi
substrato. Le acque descritte come “buone” sono tollerate da quasi tutte le specie e
non determinano problemi di accumulo nei substrati. Le acque definite “mediocri” si
possono utilizzare solo su substrati ben drenati e con specie tolleranti la salinità.
Nell’ultimo caso solo con il controllo continuo della salinità del substrato, con
frequenti dilavamenti e con colture molto tolleranti alla salinità si può sperare di
coltivare.
Tabella 2 Caratteristiche chimiche dell’acqua irrigua ed idoneità all’uso irriguo.
Qualità dell’acqua
E.C. (µS/cm 25º)
Sali totali ppm (mg/l)
Sodio % dei sali totali
Durezza (ºdH)
Molto buona < 250 < 175 < 20 < 8
Buona 250-750 175-225 20-40 8-12

Mediocre 750-2000 525-1400 40-60 12-20
Non adatta > 2000 > 1400 > 60 > 25
Nella tabella sottostante è riportata la tolleranza di alcune specie più coltivate.
Tabella 3 Sensibilità di alcune specie orticole o floricole alla salinità.
Categoria
Livelli tollerati (µS/cm 100-2800)
Ortaggi Fiori e Piante ornamentali
Specie sensibili (100-1400) Fragola, lattuga, fagiolo, pisello; Tulipano, camelia,
azalea, orchidea;
S. mediamente tolleranti (1400-2100) Melone, pomodoro, peperone, cetriolo; Petunia,
poinsettia, rosa, zinnia;
Specie tolleranti (2100-2800) Asparago, zucchino, cavolo, spinacio; Ortensia,
geranio, crisantemo, garofano.
Tuttavia va ricordato che la sensibilità delle piante alla salinità dipende oltre
dalla specie e dalla cultivar anche dallo stadio di crescita, infatti le giovani piantine
sono più sensibili alla salinità rispetto alle piante adulte.
I sali più frequenti nelle acque di irrigazione sono i solfati di calcio, magnesio e
sodio; i carbonati ed i bicarbonati di calcio e di sodio ed infine, il cloruro di sodio che
è anche quello più importante poiché porta rapidamente all’aumento della salinità, ma
soprattutto quando il drenaggio è insufficiente.
Quando il rapporto tra ioni sodio (Na+) e la somma dei cationi di calcio (Ca2+) e
magnesio (Mg2+) nell’acqua di irrigazione e nella soluzione circolante superano un
certo limite, nel substrato al problema della salinità si aggiunge anche quello della
alcalinizzazione. La presenza del radicale carbonico (HCO3 -) aggrava la situazione in
quanto determina l’insolubilizzazione del calcio come CaCO3 e quindi nella

soluzione circolante gli ioni del sodio tendono a prevalere su quelli del calcio. Il
ricercatore Eaton ha valutato anche la differenza tra la somma degli ioni espressi in
meq [(CO32-, HCO3
-) (Ca2+ + Mg2+)] ed ha stabilito che per valori tra 0 e 1.25 l’acqua è
utilizzabile senza nessuna preoccupazione, per valori tra 1.25 e 2.50 l’acqua può
essere impiegata con precauzione, sopra 2.50 l’acqua non può essere utilizzata.
Per quanto riguarda il boro, i valori tollerati nelle acque dipendono dalla specie
coltivata: le specie più sensibili sono nell’ordine il peperone, il pomodoro, la carota,
la lattuga, mentre tra le più tolleranti ci sono la bietola e l’asparago.
La presenza nelle acque di elevati contenuti di nitrati e di fosfati o di residui
organici, deve essere attentamente considerata nel caso di marcata eutroficazione,
cioè di sviluppo di microrganismi ed in particolare di alghe che portano rapidamente
ad una deossigenazione dell’acqua. In caso di acque inadatte all’irrigazione si può
intervenire per la loro correzione con impianti di deionizzazione (acque saline) o di
addolcimento (acque dure), ma a causa degli elevati costi del trattamento può essere
conveniente ricorrere all’utilizzazione delle acque piovane raccolti in laghetti
artificiali.
4.18 Gestione dell’irrigazione in idroponica
Per le aziende ortoflorovivaistiche l’acqua rappresenta uno dei fattori principali
per la produzione; tuttavia sino ad oggi essa non è stata considerata un elemento di
valore per il fatto che fosse ritenuta un bene inesauribile. Da qualche anno però, in
seguito ai cambiamenti climatici, alla crescita del settore industriale, alle dispersioni
nelle reti di distribuzione ecc. è sorta l’esigenza anche nel settore agricolo di
razionalizzare l’erogazione idrica.
La quantità d’acqua da somministrare alla coltura varia in funzione della
specie, dell’età della pianta, del tipo di substrato e nel caso che essa sia coltivata in
vaso anche dalle dimensioni di esso. Dovendo ottimizzare l’irrigazione o la

fertirrigazione è importante valutare l’efficienza di questa, che varia a seconda della
tecnica irrigua adottata.
L’efficienza irrigua è la quantità di acqua o di soluzione nutritiva totale che
viene utilizzata dalla pianta in maniera vantaggiosa. Fra le varie tecniche irrigue le
più efficienti risultano quella a goccia e a subirrigazione (0.90-0.98).
Per valutare i consumi idrici giornalieri delle piante esistono diversi metodi, fra
cui la stima dell’evapotraspirazione (ETE) oppure la misurazione dell’umidità nel
substrato (Bacci e Checcacci, 2004).
Per la gestione della irrigazione si possono utilizzare dei temporizzatori. Sono
questi i sistemi più diffusi nelle aziende agricole, per il fatto che sono facili da
gestire, poco costosi e applicabili a qualsiasi tecnica irrigua (a pioggia,
nebulizzazione a goccia ecc.). Ne esistono diversi tipi: per i programmi che
contengono e per i settori che possono controllare. Ai temporizzatori possono essere
collegati dei sensori in grado di inibire o attivare, se necessario, prima degli orari
stabiliti le irrigazioni. Sono sensori di pioggia e di temperatura.
Altro sensore applicabile è l’integratore solare costituito da un contatore che
s’incrementa a seconda della luminosità. Quindi raggiunto il valore prestabilito
dall’operatore si attiva l’irrigazione.
Un’alternativa ai temporizzatori sono i sensori di umidità del terreno. In
commercio sono presenti diversi rilevatori di umidità nel suolo che utilizzano principi
differenti. Quelli più pratici sono i tensiometri, che si prestano ad essere utilizzati
anche all’interno dei vasi date le dimensioni. Funzionano misurando il potenziale
idrico del suolo (tensione) e quindi in grado di rivelare la capacità delle piante di
assorbire l’acqua dal terreno. Si compongono di un tubo di vetro in cui, ad una
estremità, vi è un setto poroso in porcellana e all’estremità opposta un sensore di
pressione. Tutte le parti contengono acqua distillata.
Il passaggio dell’acqua è determinata dall’umidità del substrato; dunque, poca
umidità nel terreno richiama l’acqua dal tensiometro creando una depressione che
può essere letta sul manometro.
Viceversa quando il terreno si bagna l’acqua passa all’interno del tensiometro
richiamata dalla depressione. Di rilevante importanza risulta il collocamento del

sensore nel vaso, la migliore risposta si ottiene ponendo il tensiometro ad una
profondità pari a un terzo dello spessore totale del substrato e distanziandolo dal
bordo di qualche centimetro. Per avere dei dati più attendibili è bene disporre più
sensori per ogni settore; dai valori riscontrati sarà possibile trarne quello medio.
Per la gestione dell’irrigazione si può procedere anche alla stima
dell’evapotraspirazione. Con evapotraspirazione s’intende la quantità di acqua persa
dal sistema suolo-pianta in seguito ad evaporazione e a traspirazione; essa viene
misurata in mm. La perdita d’acqua è scaturita dalla temperatura, dall’umidità
dell’aria, dal vento, dalla radiazione solare e dalla superficie fogliare.
Per calcolare l’evapotraspirazione effettiva di una coltura (ETE) in piena aria è
necessario conoscere l’evapotraspirazione potenziale (ETP o ETo) e un coefficiente
colturale (Kc).
ETE = ETP Kc
Il Kc, coefficiente colturale, è specifico della coltura e varia con lo sviluppo
della pianta. Per le colture in vivaio i Kc sono ancora in via di determinazione.
L’ETP è calcolato attraverso modelli micrometereologici oppure con una vasca
evaporimetrica.
Per le colture in serra la stima dell’ETE (in mm) può essere eseguita adottando
questa formula matematica:
ETE = a LAI (Rest Kt) / .
dove Rest è la radiazione globale esterna (MJ/m2), Kt è il coefficiente di
trasmissione esterna della serra (variabile tra 0.55 e 0.65 in funzione del grado di
trasparenza del materiale di copertura della serra), influenzato anche dall’eventuale
ombreggiamento, tinteggiatura e sporcizia, a (variabile tra 0.25 e 0.35) un
coefficiente empirico, . il calore latente di vaporizzazione (2.5 MJ/Kg H2O) e LAI
(Leaf Area Index) l’indice di area fogliare, che varia da 0, per terreni nudi, a 3.5-4.0
per colture mature di serra.

L’ETE può essere anche misurata disponendo dei vasi campione sul piatto di
una bilancia elettronica collegata ad un sistema di raccolta dati. I valori, cumulati,
raggiungeranno il livello di soglia dell’ETE stabilito e attiveranno l’irrigazione. Nei
sistemi a ciclo chiuso, la quantità di soluzione nutritiva o acqua evapotraspirata dalla
coltura può essere calcolata per differenza tra la quantità erogata inizialmente e la
quantità di soluzione raccolta dopo il drenaggio ponendo, sia in avvio che in ritorno,
dei contalitri.
4.19 Gestione dei sistemi aperti o chiusi
Le colture fuori suolo sono contraddistinte dall’essere alimentate con soluzione
nutritiva erogata principalmente attraverso due sistemi, a ciclo aperto e a ciclo chiuso.
Nel ciclo aperto la fertirrigazione viene eseguita sempre con soluzione nutritiva
fresca; la frazione che non viene trattenuta dal substrato, invece di essere recuperata,
viene dispersa nell’ambiente.
Dunque la gestione consiste nel rendere efficace l’irrigazione tale da ridurre la
produzione di soluzione drenata. I cicli chiusi prevedono invece un recupero della
soluzione nutritiva, una reintegrazione e una reimmissione. Per questo essi producono
un minor impatto ambientale.
Nel recupero della soluzione drenata avviene il controllo del pH e della E.C. da
parte delle sonde presenti all’interno dei pozzetti di raccolta. Sulla base dei dati
pervenuti, i fertirrigatori effettuano le reintegrazioni necessarie con le soluzioni stock
o con la soluzione acida. I cicli chiusi sono più difficili da gestire soprattutto dove le
colture hanno un ciclo produttivo lungo; i rischi di attacchi parassitari all’apparato
radicale e del colletto sono alti. Tuttavia possono essere superati praticando quei
metodi di lotta preventiva e dotando l’azienda di apparecchiature atte ad effettuare
una disinfezione della soluzione ricircolante.
4.20 La reintegrazione della soluzione nutritiva

Gestire la reintegrazione della soluzione nei cicli chiusi è complicata, in
particolare laddove si debba utilizzare in partenza un’acqua di scarsa qualità ossia
salina. In questi casi la salinità della soluzione nutritiva impiega poco tempo a
superare valori che possono essere tollerati da una coltura costringendo a praticare
uno smaltimento parziale o totale della soluzione (runoff).
Il motivo per il quale la soluzione tende ad aumentare di E.C. è dovuto alle
colture che non utilizzano gli elementi nutritivi nel rapporto cui gli vengono forniti,
così, alcuni di essi, tendono ad accumularsi nella soluzione ricircolante (Pardossi et
al., 2004).Con la misurazione di E.C. si rileva solo un valore quantitativo della
salinità, per cui è necessario prelevare dei campioni della soluzione di tanto in tanto e
fare delle analisi chimiche.
Principalmente vengono adottati due metodi per reintegrare la soluzione
ricircolante:
ad E.C. costante dove le condizioni sono favorite da un’acqua di
qualità, poiché ha un basso tenore di ioni non essenziali. La
reintegrazione viene eseguita aggiungendo acqua e/o elementi a
diversa concentrazione;
ad E.C. crescente dove la reintegrazione della soluzione ricircolante
avviene con una soluzione nutritiva che mantiene sempre la stessa
concentrazione e con una acqua di La E.C. aumenta in seguito alla
bassa qualità dell’acqua utilizzata e della crescente evapotraspirazione
nella coltura. In questa situazione la E.C. raggiungerà valori che le
colture non riusciranno più a tollerare; diventa importante quindi
puntare ad abbassare la E.C. seguendo una delle due strade:
scarico parziale della soluzione ricircolante reintegrando più soluzione
fresca;
scarico della soluzione drenata ogni qual volta il valore di E.C. superi
un valore

L’ AGROECOSISTEMA
Vista in una dimensione relazionale la produzione agricola della serra é
strettamente legata alle caratteristiche fisico/agronomiche di questo agroecosistema.
Fondamentalmente gli aspetti d'interazione più importanti da porre in evidenza sono:
1. la produzione é legata all'isolamento ambientale della coltura, all'impiego di
energia diretta (climatizzazione) ed indiretta (materiale di copertura, fertilizzanti e
pesticidi) e ad un adeguato controllo dei parametri di produzione;
2. la tendenza alla massimizzazione della produzione (biomassa) genera, quale
conseguenza, una accelerazione del processo entropico (incremento del consumo
di energia termica e chimica, aumento dei cicli produttivi, instabilità del sistema
biologico, aggravamento dei problemi fitosanitari, aumento dei residui tossici);
3. le caratteristiche del sistema serra tende a favorire le infestazioni da fitofagi di
origine tropicale (es. mosche bianche, tripidi) e da patogeni (batteri e funghi), a
facilitare l'attività prolungata e lo svernamento di alcuni insetti (es. Afidi), ad
accelerare il loro ciclo di vita (maggior numero di generazioni e fecondità), ad
ostacolare l'azione dei nemici naturali sia a causa dei trattamenti chimici ripetuti
che dell'isolamento ambientale, a favorire il fenomeno di sviluppo di popolazione
resistenti ai pesticidi;
4. la complessità del sistema richiede un adeguato controllo dei parametri climatici e
agro/biologici della serra ed una razionale gestione del processo produttivo sia a
causa delle caratteristiche proprie della serra che delle strette ed intense interazioni
che si creano tra i diversi fattori coinvolti.
5.1 Energia termica
Circa il 20% delle serre italiane sono dotate di impianti di riscaldamento. Viene
calcolato che per la sola climatizzazione il consumo diretto di energia s'aggira
sullordine di 140.000 TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio), pari a circa il 95%

dell'energia globalmente necessaria alla produzione, con una incidenza sul costo
totale di produzione del 20-30%.
Per i consumi energetici indiretti, relativi ai materiali di struttura e copertura, si
stima che in ogni mq. di plastica e di vetro siano incorporati rispettivamente circa 10-
12.000 Kcal e 80.000 Kcal.
In particolare l'impiego di materiale plastico é in continuo aumento sia per
condizionare l'ambiente che per altri aspetti agronomici. Infatti, per quanto concerne
il primo aspetto, nelle aree dove la temperatura media minima mensile dei mesi più
freddi non scende sotto i 12 °C e si ha una insolazione di almeno 6 ore/giorno nel
trimestre novembre/gennaio, é possibile effettuare la coltivazione di specie
mesotermiche senza ricorrere al riscaldamento.
Si stima comunque che per le colture protette in Italia ogni anno si consumano
circa 80.000 tonnellate di plastica; pertanto notevoli sono i problemi legati al
materiale di scarto di questo tipo, mentre il suo costo, riferito alla copertura di serre
per l'orticoltura, si aggira sui 0,50 euro per metro quadro. Si può osservare comunque
che l'impiego di materiali plastici a lunga durata é poco diffuso a causa del loro costo
elevato. Normalmente gli obiettivi perseguiti per una razionale gestione energetica
della serra sono quelli della massimizzazione dell'apporto di energia e della
limitazione di perdita di energia.
Tuttavia l'interazione dei fattori che condizionano la progettazione e l'utilizzazione
della serra (clima esterno locale, esposizione, pendenza del terreno, altimetria,
ventosità, tipo di serra e materiale strutturale impiegato, specie vegetale coltivata,
ecc.) influenzano enormemente il Bilancio energetico. Pertanto, l'attenzione della
ricerca e della sperimentazione é stata rivolta sia verso una tipologia di serra a
climatizzazione passiva o spontanea, la serra «bio-climatica», che ad una di tipo
industriale che si avvale di sistemi «automatici» per l'ottimizzazione del clima
interno. In questo contesto l'ENEA ha acquisito una discreta competenza sui seguenti
aspetti:
1. serre «bio-climatiche», mediante la realizzazione di un prototipo presso il CRE
della Casaccia (Roma) e la sperimentazione e validazione di modelli matematici
atti a migliorare il rendimento energetico;

2. serre «industriali», con l'installazione di sistemi automatizzati di rilevamento e
regolazione del clima interno, sia per lo studio della affidabilità del sistema che
per la realizzazione di modelli di simulazione;
3. serre a riscaldamento geotermico, con la realizzazione di un impianto pilota
dimostrativo a Canino (Viterbo) al fine di: sviluppare tecnologie impiantistiche
(es. riscaldamento dell'aria con: (a) manichette radianti poste sulla superficie del
terreno, (b) con unità termoventilante, (c) con tubi alettati ventilati sollevati dal
terreno; riscaldamento del suolo con manichette interrate a costituire un «letto
caldo»), definire le tecniche di coltivazione più appropriate e valorizzare questo
tipo di fluido geotermico.
L'ENEA inoltre ha collaborato con la Regione Friuli per sviluppare progetti per
l'utilizzo della geotermia nelle colture protette ed é impegnato in diversi programmi
di ricerca della Unione Europea con vari paesi dell'area del bacino del mediterraneo.
5.2 Agrochimici
La serra, per le sue caratteristiche produttive agro/climatiche, quali temperatura
ed umidità elevate, irrigazioni e fertilizzazioni abbondanti, densità di piante per mq.,
ambiente protetto ed in parte isolato dall'esterno, rappresenta un agroecosistema
molto specifico rispetto al campo aperto.
In particolare questo sistema agricolo é considerato tra quelli a più alto
consumo di fitofarmaci. Infatti per la difesa fitosanitaria di queste colture
mediamente si interviene con circa 10 trattamenti chimici/coltura, con punte che
possono superare i 20 interventi/coltura per certe specie floricole.
Si stima così che nei circa 22.000 ha di serra più rappresentativi, e
relativamente alla sola categoria degli insetticidi ed acaricidi, si consumino circa 300
tonnellate di prodotto per ciclo colturale, pari un giro economico di 5-8 miliardi di
lire. Se riferiti ad un periodo di un anno, questi dati aumentano considerevolmente
per gli avvicendamenti delle coltivazioni che generalmente si effettuano nelle serre.

Orientativamente si calcola che il numero dei trattamenti chimici che si
effettuano per il controllo dei soli parassiti animali (acari ed insetti) può variare dai 4-
12 per il pomodoro (circa 5000 ha di serra), a 2-5 per la fragola (3000 ha), 2-7 per il
peperone (3100 ha), 2-10 per la melanzana (130 ha), 2-6 per il cetriolo e circa 10 per
le specie floricole (oltre 3400 ha).
L'impiego di questi prodotti tossici, che comprendono circa un centinaio di
principi attivi autorizzati per coltura, può creare gravi problemi di ordine
tossicologico/ambientale in considerazione della ragguardevole estensione della
nostra serricoltura, alla classe di tossicità del principio chimico utilizzato, alla
modalità del loro impiego, all'importanza che il sistema serricolo riveste nella
produzione di prodotti freschi a largo consumo.
Una forte riduzione del consumo dei pesticidi potrebbe essere ottenuta
perseguendo una strategia di difesa fitosanitaria basata sulla tecnica di lotta integrata
applicata prima, durante e dopo il processo produttivo; in particolare gli interventi di
controllo di tipo biologico e fisico possono considerare lambiente della serra, il suolo
e la pianta.
L'attività dell'ENEA su questo tema di ricerca persegue diversi obiettivi, tra cui:
1 progettazione e sviluppo di biofabbriche per l'allevamento massivo di organismi
utili da utilizzare in programmi di controllo biologico. In particolare in
collaborazione con la Centrale Ortofrutticola alla produzione di Cesena é stata
realizzata la più importante biofabbrica italiana per la produzione di specie utili
(l'attuale BIOLAB) in grado di operare su oltre 2.000 ha di serra;
2 sviluppo e sperimentazione di tecniche di lotta avanzate, quali quella dell'insetto
sterile, per il controllo delle mosche bianche della serra (Bemisia tabaci e
Trialeuroides vaporariorum). In tal senso é stata avviata con la Società Hithesys di
Aprilia (LT) una collaborazione per mettere a punto nuove tecniche di
irraggiamento massivo degli insetti e per dimostrare in serre commerciali
l'efficacia della tecnica;
3 partecipazione ai progetti dell'Unione Europea riguardanti la lotta biologica in
serricoltura, con il particolare compito di sviluppare e validare modelli matematici

sullinterazione pianta/fitofago/zoofago e di realizzare sistemi esperti a supporto
delle decisioni per programmi di lotta biologica/integrata;
4 ricerche sulla bio/ecologia dei fitofagi e loro interazioni con i fattori ambientali;
5 studio e costituzione di piante geneticamente resistenti ai parassiti mediante
l'individuazione e il trasferimento di fonti di resistenza, successiva selezione e
valutazione agronomica del materiale vegetale ottenuto. Finora l'ENEA ha
ottenuto numerose varietà e linee di Pisello resistenti a Erisiphe polygoni e
Fusarium pisi, di Pomodoro resistenti a Verticillium dahliae, Fusarium
oxysporium f.sp. licopersici, Meloidogyne spp., TMV, di Peperoni resistenti a
Phytophthora capsici, Meloidogyne spp. e a TMV.
5.3 Monitoraggio e controllo
La complessità del sistema serra richiede, come si é detto, la definizione ed il
mantenimento delle condizioni climatiche ottimali che richiedono le diverse specie
vegetali. Inoltre, in considerazione del fatto che i parassiti trovano in questo ambiente
condizioni di sviluppo particolarmente favorevoli, é necessario sorvegliare
accuratamente la loro presenza e dannosità.
Per la regolazione dei principali fattori del microclima, quali temperatura, umidità
dell'aria, ventilazione, intensità della radiazione, esistono diversi sistemi di controllo
basati su sensori e regolatori automatici. Inoltre, sempre più numerosi sono i modelli
matematici realizzati per ottimizzare la coltivazione di determinate specie di piante.
Anche per il monitoraggio dei parassiti sono disponibili metodologie di
riferimento da tempo collaudate nelle diverse regioni italiane. L'attività dell'ENEA su
questo punto riguarda essenzialmente: (a) applicazione di modelli di simulazione che
descrivono i fenomeni energetici, climatici, produttivi e di funzionamento della serra
al fine di prevederne il comportamento; (b) realizzazione di sistemi di rilevamento
dati climatici; (c) assistenza tecnico/scientifica per le problematiche su indicate (es.

realizzazione di data-base sulle colture protette presenti in Abruzzo, mediante un
contratto di collaborazione
con ERSA-Regione (Abruzzo).
5.4 Processo produttivo
Le colture protette interessano prevalentemente le colture orticole, circa 20.000
ha ove prevalgano le Solanacee e le Cucurbitacee, le floricole, oltre 4.000 ha, e le
arboree da frutto. Si osserva inoltre che questo ultimo settore ha registrato l'aumento
più sensibile di superficie negli ultimi anni. L'aspetto della produzione riguarda le
tecniche che si possono utilizzare nelle diverse tipologie serricole; principalmente
esse comprendono la pacciamatura, la modalità di riscaldamento, i substrati di
supporto della coltura (lana di roccia, coltura idroponica, ecc.), le strategie e le
tecniche di controllo.
Per quanto riguarda quest'ultimo punto le tecniche che tendono a proteggere la
parte aerea della pianta possono essere di tipo: (a) fisico che prevengono le
infestazioni, come ad esempio l'isolamento delle colture con reti «ad hoc»,
l'arieggiamento o il riscaldamento dell'ambiente in certi momenti del processo
colturale; (b) biologico mediante la liberazione di organismi utili (zoofagi, batteri e
funghi) per il controllo di diversi fitofagi, la moltiplicazione vegetativa per eliminare
le virosi, la preimmunità basata sull'impiego di patogeni a virulenza attenuata, la
coltivazione di piante geneticamente resistenti; (c) chimico, generalmente basato
sull’impiego di sostanze chimiche ad elevata selettività ecologica.
Per gli interventi che si riferiscono ai parassiti del suolo questi possono essere
di tipo fisico, come la solarizzazione e la sterilizzazione del suolo mediante vapore in
sostituzione dei geodisinfestanti chimici; agronomico, quali la rotazione delle colture,
l'impiego di terreni soppressivi, le tecniche di coltura idroponica; chimico, basato su
svariati prodotti commerciali tossici, la disinfezione delle sementi e bulbi; biologico,

come l'utilizzo di microrganismi utili (funghi e nematodi) per controllare determinati
funghi parassiti o larve di insetti.
In particolare l'attività principale dell'ENEA su questo aspetto riguarda: (a) lo
sviluppo della tecnica di coltivazione mediante l'idrocoltura (collaborazione con
l'Università della Tuscia, Facoltà di Scienze Agrarie in Viterbo); (b) l'impiego di
energia geotermica; (c) la realizzazione di sistemi esperti per la diagnosi dei danni
causati dai parassiti e per la gestione di programmi di controllo; (d) le collaborazioni
con centri dimostrativi locali per la realizzazione di banche dati territoriali relative al
consumo e comportamento dei pesticidi (es. Comune di Trevignano Romano,
Associazione cittadini per l'Ambiente); (e) il trasferimento del proprio know how e la
formazione di personale tecnico mediante corsi specialistici, la preparazione di un
manuale per le serricoltura e di audiovisivi specifici, nonché azioni a supporto per
l'elaborazione di progetti regionali e dell'Unione Europea.
La serra é un sistema agricolo molto complesso non solo per le notevoli
interazioni che si creano tra i diversi fattori del processo produttivo ma anche per la
svariatissima tipologia strutturale e climatica che esso presenta. Inoltre altri fattori di
variabilità sono rappresentati dal grado di preparazione tecnica degli operatori di
settore, dall'organizzazione dell'attività e dal mercato a cui é rivolto il prodotto.
Tralasciando i problemi, pur importanti, dell'impatto della serra sul paesaggio e sul
clima per emissione di gas nell'atmosfera (es. metano, ossido di azoto), si può
osservare che le colture protette causano problemi di contaminazione dell'aria, del
suolo e dellacqua e di presenza di residui tossici nei prodotti.
Sarebbe quindi auspicabile che, nell'affrontare le varie tematiche di questo
agroecosistema, l'approccio perseguito sia di tipo sistemico e multidisciplinare in cui
l'impiego delle diverse tecnologie innovative disponibili sani la conflittualità che
ancora esiste tra processo produttivo da un lato ed esigenze di ordine energetico,
ambientale ed economico dall'altro. In questo contesto, una strategia innovativa per
ridurre l'impatto delle colture protette sull'ambiente é quella che tende a trasformare
la serra da sistema agricolo «aperto» a uno di tipo «chiuso», sostanzialmente basato
sulla riduzione/riutilizzo del materiale di scarto e dei residui tossici,

sull'automatizzazione ed informatizzazione, sul monitoraggio dei parassiti, sulla
coltivazione «senza suolo», sul riciclo della soluzione nutritiva.
Tuttavia l'affermarsi di una serricoltura avanzata, come di altri settori agricoli
in genere, é legato alla capacità di perseguire una politica agricola che sia in grado
non solo di valorizzare la qualità dei prodotti, ma anche di facilitare ed accelerare il
cambiamento tecnologico, di orientare la ricerca e la sperimentazione e di
promuovere un servizio di assistenza tecnica qualificato sul territorio.
L’IMPATTO DELLE COLTURE PROTETTE
Le colture protette rappresentano un comparto produttivo molto attivo e
tecnologicamente avanzato nell’ambito delle produzioni orticole, floricole e
vivaistiche. I principali fattori economici che promuovono lo sviluppo delle colture
protette sono: la possibilità di avere delle colture anticipate e/o posticipate rispetto
alle colture di pieno campo, la possibilità di evitare i danni dovuti alle intemperie
meteorologiche (pioggie, vento, grandine), la possibilità di avere maggiori rese
produttive attraverso la regolazione dei fattori ambientali all’interno delle serre.
Negli anni ci siamo accorti che se da un lato le colture protette incrementavano
il reddito degli imprenditori agricoli dall’altro portavano ad un aumento
dell’inquinamento dovuto al fatto che per condizionare l’ambiente delle serre si
faceva largo uso di riscaldamento (in larga parte con gasolio), di sostanze chimiche
(concimi, anticrittogamici, insetticidi), di acqua (la disponibilità idrica sta
diminuendo e sempre più ne sta peggiorando la qualità), di vario materiale difficile da
smaltire come rifiuto una volta utilizzato (vasi in plastica, teli e tubi in polietilene,
plateau in polistirolo, substrati in lana di roccia, ecc.). La ricerca agraria ha cercato di
fornire delle proposte operative aventi il fine di ridurre i pericoli d’inquinamento,
senza però penalizzare le rese unitarie e la qualità commerciale dei prodotti agricoli.
La coltivazione in serra, che interessa quasi tutti i mesi dell’anno, viene
generalmente effettuata, anche nei periodi climaticamente meno favorevoli. Nel
“sistema colturale serra’’ l’accrescimento e lo sviluppo della pianta risultano

fortemente modificati. In tema di rapporti tra qualità e coltivazione in serra ,le
differenze rispetto alla pien’aria possono essere ricondotte sia alle modificazioni delle
condizioni climatiche che ai metodi e alle tecniche di coltivazione. In riferimento alle
prime ed in funzione di cicli di coltivazione pressocchè continui nel corso di tutto
l’anno, si registrano effetti assai rilevanti su molte caratteristiche qualitative del
prodotto.
Un sistema idroponico svilupperà le piante più velocemente rispetto ad un
sistema tradizionale a base di terra, dando alle piante le stesse caratteristiche
genetiche di quelle maturate in condizioni ambientali.. Le piante, grazie ad una
maggiore attenzione e controllo nell’apporto dei nutrimenti, ad una maggiore
ossigenazione, che consente una respirazione facilitata, impiegano meno tempo per
crescere,anticipando la maturazione di ben due settimane. La rapida crescita ed una
maturazione anticipata, garantiscono un periodo di raccolta più ristretto. Le colture
idroponiche assicurano una più rapida crescita, senza le interruzioni determinate per
un trapianto in terra, che rallentano lo sviluppo per consentire alle radici di fissarsi al
suolo.
La coltura del pomodoro “fuori suolo” richiede serre di buona volumetria,
dotate di efficienti impianti di climatizzazione (aerazione e riscaldamento).
Nel 1999 in Italia si coltivavano circa 8000 ha di pomodoro in serra, di cui il
50% solo in Sicilia, e di questi circa 150 ha in “fuori suolo”. Il pomodoro è una
coltura da serra temperata, in quanto la crescita delle piante si arresta a temperature
minime notturne inferiori ad 8-10 ºC. La temperatura ottimale per la crescita è
compresa fra i 13-16 ºC di notte e 22-26 ºC di giorno. L’allegagione si ottiene a
temperature minime di 13-14 ºC. Al di sopra di 30 ºC la maturazione dei frutti non è
uniforme in quanto si riduce la sintesi dei pigmenti rossi (licopene) a vantaggio di
quelli gialli (carotene). Il riscaldamento basale con tubi ad acqua calda appoggiati
lateralmente ai sacchi di coltura, permette buoni risparmi energetici nelle colture a
ciclo lungo, ma sono poco diffusi in Italia ove prevalgono le colture stagionali a
produzione primaverile od autunnale. Il passaggio alla coltura “fuori suolo”è
motivato dalle difficoltà di disinfezione del terreno in serra e dagli elevati potenziali
di produzione e di qualità.

In Italia la coltivazione del pomodoro “fuori suolo” viene svolta
essenzialmente in sacchi con vari tipi di substrato, mentre l’impiego del sistema NFT
è ancora poco diffuso. Substrati e contenitori
I substrati più diffusi per la coltura del pomodoro “fuori suolo” sono la lana di
roccia ed i miscugli a base di torba, con pomice o perlite. Nel primo caso si usano le
lastre IP 15/75 di m 0.9* 0.15* 0.075 contenute in sacchi di polietilene bianco, con
volume di 10.2 litri, adatto per 2 piante, oppure IP 20/75 con volume di 13.5 litri,
adatto per 3 piante. I substrati a base di torba, con il 30-50% (in vol) di perlite o
pomice sono inseriti in sacchi da 20-22 litri, della lunghezza di un metro.
Recentemente sono stati utilizzati con successo anche sacchi da 15 litri, a base di
torba grossolana e perlite, con i fori di drenaggio già predisposti. Normalmente i
sacchi vengono impiegati per 2-3 colture prima di essere sostituiti.
Anche altri substrati possono fornire buoni risultati colturali, ma la
convenienza economica dipende dalla disponibilità in loco del materiale e dalla
possibilità di meccanizzare il riempimento dei sacchi. Sistemazione in serra .Prima
del posizionamento dei sacchi in serra, la superficie deve essere livellata e battuta per
evitare cedimenti successivi, prevedendo anche i canali di sgrondo ben livellati per il
recupero della soluzione nutritiva. Questi debbono avere una pendenza Max dello
0.3-0.5%, per evitare distribuzione non uniforme ai gocciolatori che altrimenti
dovrebbero essere provvisti di ugelli autocompensanti.
La distanza tra i canali sarà di m 1.4-1.6 in caso di coltivazione a fila doppia o
di fila semplice con allevamento a V. In caso di coltura a fila semplice e di
allevamento normale la distanza sarà di m 1-1.2. I sacchi vengono disposti in file
continue lungo i canali di sgrondo con la base leggermente inclinata (3% Max) verso
il bordo del canale. Il riempimento dei sacchi con la soluzione nutritiva deve essere
effettuato il giorno prima del trapianto attraverso gli ugelli, fino ad ottenere la
saturazione del substrato; prima dell’impianto si verifica il livello d’acqua e se ne
aggiunge in caso di necessità, dopo di che si praticano le fenditure di drenaggio (1-2)
sotto il sacco.
I sistemi idroponici di gran lunga più facili da usare sono lo stoppino e i sistemi
a serbatoio. Questi sono indicati come Metodi Idroponici Passivi, perché non

richiedono alcun sistema di distribuzione dell'acqua su una scala attiva (pompa,
drenaggio, misuratore di flusso e corso). Questi sistemi si basano sul fatto che tu puoi
portare l'acqua nei punti che preferisci se l'ambiente e le condizioni primarie sono
corretti.
Il sistema dello stoppino è più funzionale e più complesso del sistema del
serbatoio, dal momento che gli stoppini devono essere tagliati e sistemati nei vasi,
devono in buchi corretti, ricavandolo spazio per sistemare le piante sopra il serbatoio
dell'acqua. Con questo sistema le piante si sviluppano maggiormente in altezza nella
stanza, occupando solo spazio verticale.
Il sistema del serbatoio ha bisogno solo di un buon ambiente adattato. Le piante
cresciute in questa maniera sono molto robuste perché ricevono molto ossigeno alle
radici. Le piante cresciute con il sistema idroponico a serbatoio si sviluppano con un
ritmo analogo a quello del metodo degli stoppini o di altri metodi idroponici attivi,
con molto meno impegno, dal momento che è di gran lunga il più semplice dei
metodi idroponici. Le piante possono essere annaffiate e nutrite soltanto con una
soluzione che fluisce nel serbatoio ogni pochi giorni. Le vaschette occupano poco
spazio verticale e sono facili da maneggiare e da spostare.
In un metodo idroponico tradizionale, le vaschette sono riempite con una
mistura di lava/vermiculite in un rapporto di 4 a 1, aggiungendo 'Dolite Lime', un
cucchiaio per gallone (circa 4 litri). Questo sistema fermerà e accumulerà acqua,
anche se è dotato di un eccellente drenaggio ed anche della capacità di
immagazzinare aria. La vermiculite si depositerà sul fondo dopo ripetuti
innaffiamenti dall'alto, usando meno soluzione e più spesso acqua, per girare più
ossigeno alle radici nel minor tempo possibile; l’acqua si fermerà alle radici e le
piante avranno tutto il necessario per fiorire.
Un mezzo idroponico è la schiuma floreale Oasi, materiale inerte, ininfluente
sul pH, che consente, grazie alla sua spugnosità, la coltivazione delle piante/cloni,
passando dal blocco di schiuma alla lana di roccia per gli stadi di crescita più
avanzati.
La lana di roccia trattiene l'acqua 10 volte di più della terra, inoltre è
impossibile eliminare l'acqua, perché trattiene sempre un'alta percentuale di aria. Le

piante cresciute idroponicamente non ricavano i nutrimenti dal suolo, ma dalla
soluzione usata per innaffiare le piante. Il nutrimento delle piante deve essere
somministrato con apporti irrigui continui, ciò garantisce un controllo scrupoloso
delle disponibilità di nutrimenti per le piante nei vari stadi della crescita.
Con elevate concentrazioni di umidità nell'ambiente idroponico è probabile la
formazione di alghe all'interno delle vasche, fastidiose e brutte da vedere; non
arrecheranno alcun danno alle piante.
Se si coltiva in vasi o vaschette, coprire con uno strato di ghiaia la cima del
vaso può aiutare a ridurre la formazione di alghe, dal momento che assorbe l'acqua
molto rapidamente. Disponibilità in loco del materiale e dalla possibilità di
meccanizzare il riempimento dei sacchi.
Sistemazione in serra. Prima del posizionamento dei sacchi in serra, la
superficie deve essere livellata e battuta per evitare cedimenti successivi, prevedendo
anche i canali di sgrondo ben livellati per il recupero della soluzione nutritiva. Questi
debbono avere una pendenza max dello 0.3-0.5%, per evitare distribuzione non
uniforme ai gocciolatori che altrimenti dovrebbero essere provvisti di ugelli
autocompensanti. La distanza tra i canali sarà di m 1.4-1.6 in caso di coltivazione a
fila doppia di fila semplice con allevamento a V. In caso di coltura a fila semplice e
di allevamento normale la distanza sarà di m 1-1.2. I sacchi vengono disposti in file
continue lungo i canali di sgrondo con la base leggermente inclinata (3% Max) verso
il bordo del canale. Il riempimento dei sacchi con la soluzione nutritiva deve essere
effettuato il giorno prima del trapianto attraverso gli ugelli, fino ad ottenere la
saturazione del substrato; prima dell’impianto si verifica il livello d’acqua e se ne
aggiunge in caso di necessità, dopo di che si praticano le fenditure di drenaggio (1-2)
sotto il sacco.
I sistemi idroponici di gran lunga più facili da usare sono lo stoppino e i sistemi
a serbatoio. Questi sono indicati come Metodi Idroponici Passivi, perché non
richiedono alcun sistema di distribuzione dell'acqua su una scala attiva (pompa,
drenaggio, misuratore di flusso e corso). Questi sistemi si basano sul fatto che tu puoi
portare l'acqua nei punti che preferisci se l'ambiente e le condizioni primarie sono
corretti.

Il sistema dello stoppino è più funzionale e più complesso del sistema del
serbatoio, dal momento che gli stoppini devono essere tagliati e sistemati nei vasi,
devono in buchi corretti, ricavandolo spazio per sistemare le piante sopra il serbatoio
dell'acqua.
Con questo sistema le piante si sviluppano maggiormente in altezza nella
stanza, occupando solo spazio verticale.
Il sistema del serbatoio ha bisogno solo di un buon ambiente adattato. Le piante
cresciute in questa maniera sono molto robuste perché ricevono molto ossigeno alle
radici. Le piante cresciute con il sistema idroponico a serbatoio si sviluppano con un
ritmo analogo a quello del metodo degli stoppini o di altri metodi idroponici attivi,
con molto meno impegno, dal momento che è di gran lunga il più semplice dei
metodi idroponici. Le piante possono essere annaffiate e nutrite soltanto con una
soluzione che fluisce nel serbatoio ogni pochi giorni. Le vaschette occupano poco
spazio verticale e sono facili da maneggiare e da spostare.
In un metodo idroponico tradizionale, le vaschette sono riempite con una
mistura di lava/vermiculite in un rapporto di 4 a 1, aggiungendo 'Dolite Lime', un
cucchiaio per gallone (circa 4 litri). Questo sistema fermerà e accumulerà acqua,
anche se è dotato di un eccellente drenaggio ed anche della capacità di
immagazzinare aria. La vermiculite si depositerà sul fondo dopo ripetuti
innaffiamenti dall'alto, usando meno soluzione e più spesso acqua, per girare più
ossigeno alle radici nel minor tempo possibile; l’acqua si fermerà alle radici e le
piante avranno tutto il necessario per fiorire.
Un mezzo idroponico è la schiuma floreale Oasi, materiale inerte, ininfluente
sul pH, che consente, grazie alla sua spugnosità, la coltivazione delle piante/cloni,
passando dal blocco di schiuma alla lana di roccia in segui per gli stadi di crescita più
avanzati.
La lana di roccia trattiene l'acqua 10 volte di più della terra, inoltre è
impossibile eliminare l'acqua, perché trattiene sempre un'alta percentuale di aria. Le
piante cresciute idroponicamente non ricavano i nutrimenti dal suolo, ma dalla
soluzione usata per innaffiare le piante. Il nutrimento delle piante deve essere

somministrato con apporti irrigui continui, ciò garantisce un controllo scrupoloso
delle disponibilità di nutrimenti per le piante nei vari stadi della crescita.
Con elevate concentrazioni di umidità nell'ambiente idroponico è probabile la
formazione di alghe all'interno delle vasche, fastidiose e brutte da vedere; non
arrecheranno alcun danno alle piante.
Se si coltiva in vasi o vaschette, coprire con uno strato di ghiaia la cima del vaso
può aiutare a ridurre la formazione di alghe, dal momento che assorbe l'acqua
molto rapidamente.
Secondo gli accordi internazionali stipulati a Montreal nel settembre 1997, accordi
a cui ha aderito l’Italia, dal 01/ 01/ 2005 l’impiego del bromuro di metile, prodotto
impiegato per la sterilizzazione dei terreni delle serre, risulta proibito. La tendenza
delle colture protette dovrà essere pertanto rivista nell’ottica di realizzare sistemi
che consentano: automazione dei processi produttivi; riduzione dei consumi di
acqua, concimi e fitofarmaci; incremento quali-quantitativo delle produzioni nel
rispetto dell’ambiente.
Poiché l’agricoltura italiana risentirà in modo evidente del vincolo dettato dagli
accordi stipulati a Montreal, la realizzazione di colture senza suolo, tecnologia assai
limitata in Italia rispetto a Paesi quali Olanda e Spagna a causa dei costi d’ impianto
elevati, assume oggi importanza rilevante come alternativa all’impiego del bromuro
di metile.
L’adozione di sistemi di coltivazioni senza suolo potrebbe rispondere alle esigenze
economiche ma soprattutto ambientali oggi attenzionati per la salvaguardia della
salute e dell’ecosistema.
L’utilizzo delle colture idroponiche e la messa a punto delle condizioni operative più
idonee per il conseguimento di rese produttive più elevate e qualità uguale e/o
superiori rispetto alle tecniche tradizionali, sono impiegate nel settore florovivaistico.
Al fine di verificare alcune delle potenzialità offerte dalle colture senza suolo e più in
particolare la qualità del pomodoro è stato impostata una prova sperimentale in
camera di crescita con i seguenti obiettivi:

1.Valutare la qualità del pomodoro cv. Naomi tipo "Cherry" allevato con il sistema
idroponico NGS in camera di crescita.
Alla luce di quanto riportato in bibliografia si è voluto realizzare un impianto
di crescita idroponica per il Pomodoro, per valutarne la componente nutrizionale
confrontata con la produzione ottenuta con altre tecniche colturali.
Progettazione e sviluppo dell’impianto idroponico
7.1 L’impianto idroponico NGS
L’impianto idroponico a circuito chiuso NGS è stato istallato utilizzando
seguenti elementi:
- un impianto d’irrigazione centralizzato;
- una rete di bulbi che portano la soluzione nutritiva dalla stazione di pompaggio
centrale alle singole piante e che permette il ritorno fino alla vasca di raccolta;
- vasca con soluzione nutritiva;
- entrata dell’acqua d’irrigazione
- gruppo di pompaggio
- rete di distribuzione
- rete di ritorno (drenaggio)
- tubi per l’apporto di soluzione madre o correttori di pH
- sistema di coltivazione
- sensori di pH e CE
- fertirrigatori
- elettrovalvola
- rete di drenaggio

Fig.1. - Impianto sperimentale idroponico NGS
7.2 Impianto di irrigazione
L’impianto d’irrigazione centralizzato è formato dai seguenti elementi:
7.2.1 Vasca di raccolta:
Situata sotto il gruppo di pompaggio, ha la funzione di ricevere per gravità il
ritorno della soluzione nutritiva, istallata nel punto più basso della coltivazione. Ad
essa confluiscono tutti i tubi di alimentazione (acqua d’irrigazione e fertilizzanti) e di
ritorno (drenaggio).
Il volume della vasca di raccolta è stato calcolato considerando la superficie
coltivata e la possibile espansione della coltivazione.

Fig.1.-vasche di raccolta
7.2.2 Gruppo di pompaggio:
costituito da una elettropompa centrifuga in acciaio inossidabile per evitare la
corrosione, provvista di un filtro e una valvola di ritenzione nel tubo di pesca e una
sonda di livello nel caso il livello dell’acqua si abbassi.
7.2.3 Stazione di filtraggio:
Formata da filtri in sabbia di quarzo.
7.2.4 Riscaldamento basale:
Secondo la temperatura prevista.
7.2.5 Vasche per fertilizzanti :
due vasche equipaggiate con un sistema di mescolamento ad aria che permette
di mantenere disciolti i fertilizzanti e omogeneizzare la soluzione nutritiva prima di
pomparla nell’impianto.
7.2.6 Gruppo di continuità con accensione automatica:
Nei momenti in cui la rete elettrica è in panne, il gruppo di continuità permette
il funzionamento delle pompe elettriche centrifughe e quindi il pompaggio della
soluzione nutritiva.
7.2.7 Fertirrigatore:
Permette di controllare e regolare il pH e la conducibilità della soluzione.

7.2.8 La rete di distribuzione della soluzione nutritiva si compone di:
tubi di mandata:
tubi in polietilene portano la soluzione nutritiva dal centro di pompaggio fino
ai tubi con gocciolatori.
7.2.9 Tubi con gocciolatori autocompensanti:
tubi flessibili in polietilene nei quali si inseriscono i gocciolatori
autocompensanti.
La rete di drenaggio è formata da tubi rigidi in PVC a bassa pressione come
quelli per utilizzi civili. La soluzione nutritiva ritorna alla vasca di raccolta per
gravità senza pressione.
7.3 Coltura
Sono stati messe a dimora piante di pomodoro ciliegino cv “Naomi”nelle
vasche precedentemente allestite. Sono state predisposte 4 vasche per poter realizzare
4 ripetizioni. Le condizioni di crescita sono state monitorate fino alla maturazione
delle bacche.
Tabella 4. Caratteristiche chimico-fisiche delle acqueconsortili impiegate per la sperimentazione
Parametri Risultati mg meq/l
Calcio (Ca++) 123,6 6,17Magnesio(Mg++) 36 2,96Cloruri ( Cl-) 547,7 15,44Sodio (Na+) 474 20,6Potassio ( K+) 0,1 0,003Solfati (SO4
--) 307 6,39
Azoto nitrico (NO3-) 3,2 0,22
Azoto nitroso (NO2-) 0,01

Azoto ammoniacale 0,08 0,006
Bicarbonati (HCO3-) 21,36 0,35

SOLUZIONE IDROPONICA
Coltura E.C. NO3- H2PO4
- SO42- NH4
+ K+ Ca2+ Mg2+
Pomodoro(ciclo aperto) 2,3 13,75 1,25 3,75 1,25 8,75 4,25 2,0
Pomodoro(ciclo chiuso) 1,5
10,75 1,25 1,5 1,0 6,5 2,75 1,0
Coltura Fe Mn B Cu Mo Zn
Pomodoro(ciclo aperto) 15 10 30 0,75 0,5 5
Pomodoro (ciclo chiuso) 15 10 20 0,75 0,5 4
7.4 Campionamento dei frutti
Agli stadi fenologici di “invaiatura” e “maturazione commerciale”, i pomodori
sono stati raccolti e trasferiti presso il laboratorio della sezione Scienze Agrochimiche
del D.A.C.P.A( dipartimento di scienze Agronomiche, Agrochimiche e di Produzioni
Animali ), dove sono stati lavati con acqua distillata, asciugati e successivamente
congelati a -18 °C . Al momento delle determinazioni analitiche sono stati scongelati
a + 4°C.
Parametri RisultatipH 5,58
Conducibilià ms/cm 2,54Durezza F° 45,9
R.S.C. 8,77S.A.R. 9,64
S.A.R. corretto 11,57

Allo scopo di valutare la qualità del prodotto sono stati collezionati altri
pomodori provenienti da differente modalità di produzione. In particolare sono stati
collezionati:
- campioni di pomodorino ciliegino , cv “Naomi”, prelevati all’invaiatura ed a
maturazione ultimata, presso l’azienda Piano Stella, coltivati in pieno campo
(suolo);
- campioni di pomodorino ciliegino , cv “Naomi”, prelevati a maturazione
ultimata presso un’azienda in coltura in serre, alte e ben ventilate, in regime di
fertirrigazione controllata.
Tutte le analisi sono state effettuate in triplo.
Sul prodotto fresco sono stati rilevati i seguenti parametri: peso secco, ceneri,
sostanza organica.
7.5 Determinazione della sostanza secca
La matrice di pomodoro dopo essere stata pesata tramite una bilancia di
precisione a quattro cifre decimali, è stata posta in capsula, tarate, è stata
inizialmente disidratata all’aria e successivamente essiccata a 150°C in stufa
ventilata fino a peso costante.
7.6 Determinazione delle ceneri
Una quantità nota di sostanza secca è stata posta con un crogiolo in muffola a
550°C fino a sbiancamento della matrice, mantenendolo a queste condizioni fino a
peso costante. Dalla differenza fra li peso della sostanza secca di partenza e il peso
finale si ricava il contenuto in ceneri del campione.
Il contenuto di sostanza organica è stato ottenuto per differenza tra il peso
della sostanza secca e le ceneri.

7.7 Mineralizzazione (via umida)
Circa 0,5 g di pomodoro, previamente seccato in stufa a 105°C, è stato
frantumato in un mortaio e posto in un Kijldal nel quale sono stati aggiunti 5 ml di
H2SO4 al 98% concentrato e fatti digerire fino a completa distruzione della sostanza
organica. A freddo sono state aggiunte 5 gocce di HClO4 fino a fare divenire
completamente incolore la soluzione. Il mineralizzatore è stato tarato ad una
temperatura di 330°C. A freddo il mineralizzato è stato portato a volume di 100 ml e
su di esso sono state eseguite le determinazioni di N, P .
7.8 Determinazione Fosforo
Un’ aliquota del campione mineralizzato (2 ml) è stata posta in un matraccio da
100 ml in cui sono stati aggiunti : 4 ml di H2SO4 8/N e acqua distillata fino ad un
volume di 80 ml. Successivamente, sono stati aggiunti 5 ml di molibdato d’ammonio
(1,44% p/v) e 2 ml di acido Ascorbico ( 2,5% p/v) .
I campioni sono stati posti ad incubare ad una temperatura di 90°C per 30
minuti, raffreddati a temperatura ambiente e quindi portati a volume con acqua
distillata.
la lettura dei valori di assorbanza è stata misurata mediante spettrofotometro
UV- Vis alla lunghezza d’onda di 650 nm . Il contenuto di fosforo è stato calcolato
mediante una retta di taratura realizzata utilizzando una soluzione di K2HPO4( 2
mg/l).

7.9 Determinazione Azoto
L’ Azoto totale è stato determinato con il metodo KJeldahl (1883),
mineralizzando su mantello riscaldante fino a soluzione limpida 0,5 g di campione ,
addizionato di H2SO4 concentrato e CuO.
Il liquido è stato posto in un pallone da distillazione in presenza di fenolftaleina
come indicatore .
La soluzione neutralizzata con NaOH (32%) fino al viraggio dell’indicatore da
incolore al rosso è stata sottoposta a distillazione fino a raccolta di tutta l’NH4+ in una
beuta contenente una soluzione fissante (acido borico + fissatore).
La soluzione di raccolta è stata titolata con H2SO4 0,01 N fino al viraggio dal
verde al viola per risalire alla concentrazione di NH4+ fornita dal campione.
7.10 Determinazione dei Cationi
I cationi sono stati determinati sul mineralizzato ottenuto per via secca
incenerendo un’aliquota nota del materiale secco a 105°C. Il materiale è stato ripreso
con 5ml di HCl 1:1 e la soluzione portata a volume finale di 50ml con HCl 0,1N. Sui
mineralizzati cosi ottenuti sono stati determinati i contenuti di Na+ K+, Ca2+ e Mg2+
per via spettrofotometrica di Assorbimento Atomico ( Perkin Elmer 4000 A.A.)

Fig. 5 Spettrofotometro di Assorbimento Atomico
( Perkin Elmer 4000 A.A.)
7.11 Determinazione Proteine
L’estrazione del materiale vegetale è stata effettuata su 0,5 g, omogeneizzando
in mortaio con il tampone di estrazione (K2HPO4/KH2PO4, 50mM, pH 7.5;FAD,
1 M; EDTA 1mM; DDT 1mM; PMSF 1 M; leupeptina 10 M ). μ μ μ
L’omogenizzato, è stato filtrato su garza e centrifugato a 12700 rpm a 4°C per
10 min.
Il contenuto proteico è stato determinato secondo il metodo di Bradford M.M.
(1976), basato sulla reazione calorimetrica di complessazione quantitativa tra la
struttura proteica ed il reagente specifico.
L’assorbanza è stata misurata con uno spettrofotometro UV- visibile, alla
lunghezza d’onda di 595 nm e le quantità di proteine sono state calcolate utilizzando
una retta di taratura costruita con concentrazioni note di albumina (comprese fra 2 e
10 g ) da siero bovino ( BSA ).μ

7.12 Determinazine del pH
Il pH è stato determinato mediante pH-metro Mettler Toledo Mp 220
Previamente tarato con soluzioni tampone a pH 4.00 e 7.00, sulla purea ottenuta
dall’omogenizazione di 3 pomodorini freschi per ogni tesi.
7.13 Determinazione dei Carotenoidi
Estrazione: Per i vari campioni si è proceduto come indicato da De Sio (1999)
in “ Introduzione all’HPLC e Metodi Analitici per Alimenti Vegetali”.
Per i campioni analizzati, il metodo di estrazione è stato modificato: sono stati
posti in agitazione 2 g di campione con 50 ml di miscela estraente
diclorometano/metanolo 2:1 (v/v) contenente 0,1 % di BHT. Dopo 15 minuti la fase
liquida è stata trasferita in un imbuto separatore, a cui sono stati aggiunti altri 50 ml
di miscela estraente posta a riposo per altri 15 minuti.
A questo punto, per favorire la separazione delle fasi, è stata aggiunta acqua
distillata e la frazione inferiore colorata è stata raccolta in un altro imbuto
separatore, in cui l’estratto è stato lavato con acqua per separare nuovamente le due
fasi. L’estratto colorato è stato purificato e deidratato su solfato di sodio anidro,
quindi raccolto in palloncino da evaporatore rotante da 250 ml. Successivamente,
l’estratto è stato portato a secco in Rotovapor, e l’essiccato è stato ripreso con 15 ml
di cloroformio contenente lo 0,1% di BHT e filtrato con filtri in nylon da 0,45
um(sigma) prima dell’iniezione in colonna HPLC.

Fig. 6 Rotavapor (Heidolph Instruments, LABORATA 4000-EFFICENT)
Analisi cromatografia: la separazione e determinazione dei singoli caroteni è
stata effettuata in HPLC Spectra system, modificando il protocollo suggerito da De
Sio(1999). In particolare sono state cambiate le condizioni cromatografiche,
mantenendo invariati i solventi.
Condizioni cromatografiche:
- colonna YMC C-30 per carotenoidi, 250X 4,6 mm,5 um;
- Rivelatore Diode Array con range 320-470 nm. Rivelatore UV 6000 LP 450
nm.
- Volume d’iniezione 20 ul;
- Flusso 0,8 ml/min;
- Fase mobile:
- Eluente A: metanolo/acqua 95/5 v/v allo 0,1% in BHT e 0,005% in
trietilammina (TEA);
- Eluente B:Diclorometano allo 0,1% in BHT e 0,005% in TEA;
- Gradiente d’eluizione:

Tempo(min) A(%) B(%)0 95 52 95 510 30 7015 30 7020 10 9030 10 9040 95 5
Seguono 5 minuti di riequilibrio al 95% dell’eluente A prima della successiva
analisi.
E’ stata usata trietilammina per ridurre le perdite dei carotenoide nella colonna
e per migliorarne l’efficienza.
Gli spettri sono stati registrati tra 320 e 480 nm, mentre i cromatogrammi sono
stati acquisiti alle lunghezze d’onda (lamda) di 480 e 460 per la determinazione,
rispettivamente, del Licopene e del -carotene.β
Tutti i solventi utilizzati per l’estrazione dei carotenoidi sono prodotti “Merck”
per analisi.
I solventi utilizzati per analisi HPLC sono stati diclorometano (labscan) per HPLC e
metanolo (Merck) per cromatografia.
La determinazione di carotenoidi, Licopene e -carotene, è stata effettuata con ilβ
metodo dello standard esterno .
Le rette di taratura sono state costruite usando standard in commercio:
- -carotene (FLUKA bio CHEMIKA)β
- Licopene (Sigma-Aldrich).
Retta di taratura per il -caroteneβ

Standard -caroteneβ y = 812987x - 474221
R2 = 0,9979
02000000400000060000008000000
1000000012000000140000001600000018000000
0 5 10 15 20 25
ppm
Are
a
Retta di taratura del Licopene
retta di taratura licopene y = 2E+06x - 502156
R2 = 0,9881
05000000
1000000015000000200000002500000030000000350000004000000045000000
0 5 10 15 20 25
ppm
area
I contenuti di -carotene e Licopene nei campioni sono stati determinatiβ
tramite l’equazione della retta di calibrazione ottenuta dal relativo standard.
Beta-carotene:
Y = 1* 106X +44
Licopene:
Y = 2*106X-25679
Il valore dell’incognita Y è rappresento dall’ integrazione delle aree relative ai
vari cromatogrammi, rilevate alla lunghezza d’onda pari al massimo assorbimento
(460nm carotene e 480 nm Licopene); l’incognita X è appunto il valore di parti per
milione( ppm) da trovare.

Moltiplicando il valore dei ppm trovati per il fattore di diluizione impiegato (in
questo caso 15), si risale ai mg di carotenoide contenuti in un Kg di prodotto.
Volendo esprimere i risultati riferendoli a 100g di sostanza secca , bisogna
considerare il peso secco (ps) di ogni singolo campione.
7.13 Determinazione Acido Ascorbico ( vit.C)
L’estrazione è stata effettuata su campioni di bacche mantenuti a – 18°C.
L’omogenizzazione dei campioni è stata eseguita a 4°C, in un mortaio, utilizzando
acido tricloroacetico (TCA) al 6%, con un rapporto peso fresco campione / volume
di estraente 1:1.
L’omogenizzato è stata centrifugata a 27000 giri per 15 minuti. Il surnatante è
stato utilizzato per le successive determinazioni.
Le determinazioni delle due forme, acido ascorbico totale (AsA+DHA) e
ridotto (AsA), sono state effettuate secondo il metodo di Kampfenkel et al. (1995),
basato sulla riduzione dello ione ferrico (Fe3+) a ferroso (Fe2+) mediata dall’AsA in
ambiente acido; lo ione ferroso forma con la 2-2 dipiridina un chelato di colore rosso
che assorbe alla lunghezza d’onda di 525 nm.
L’ascorbato totale è stato determinato riducendo il DHA mediante l’aggiunta di
Ditiotreitolo (DTT), il cui eccesso è stato rimosso con N-etilmaleimide (NEM). 0,05
ml di estratto sono stati addizionati di 0,05ml di DTT 10 mM e 0,1 ml di soluzione
tampone potassio-fosfato 0,2 M pH 7,4. Dopo 15 minuti di incubazione a 42°C
venivano aggiunti 0,05 ml di NEM allo 0,5 % (p/v) in acqua, 0,25ml di TCA al 10%
(p/v), 0,2 ml di acido ortofosforico (H3PO4), o,2 ml di 2-2 dipiridina al 4% ( p/v) in
acqua e 0,1 ml di FeCl3 al 3% ( p/v) in acqua fino a raggiungere un volume finale di
1,0 ml. Dopo 15 minuti di incubazione a 42°C veniva eseguita una misura di
assorbanza a 522 nm contro un bianco contenente tutti i reagenti e 0,05 ml di TCA al
6%.
La determinazione dell’ AsA è stata effettuata ripetendo la sequenza sopra
riportata per la determinazione dell’ascorbato totale senza aggiungere DTT e NEM e

portando allo stesso volume finale di 1,0 ml con 0,05 ml di acqua distillata e 0,15 ml
di soluzione tampone potassio-fostato 0,2 mM, pH 7,4.
La misura di assorbanza dell’AsA a 525 nm veniva letta contro un apposito
bianco incubato per lo stesso periodo. La determinazione quantitativa è stata
effettuata contro una curva di taratura, costruita utilizzando quantità note di AsA
comprese nell’intervallo tra 0 e 50 nmoli. I contenuti di DHA sono stati determinata
per differenza tra le quantità di acido ascorbico totale e di AsA.
RISULTATI
I pesi freschi (pf) risultano maggiori nei campioni di pomodori provenienti dalle
serre (Tab. 5), per i quali il pf alla maturazione fa rilevare un incremento del valore
del 12% rispetto al valore registrato all’invaiatura.
Tab. 5 Pesi dei pomodori cv “Naomi (g bacca-1)” relativi alle diverse condizioni Colturali
Campioni Peso Fresco Peso secco Ceneri S. Organica idrop.invaiatura 24,3c 1,1a 0,12a 0,91aidrop.maturaz. 27,4b 1,0a 0,09b 0,98acampo invaiat. 24,2c 1,0a 0,11ab 0,89abcampo maturaz. 26,9bc 1,0a 0,04c 0,96afuori suolo invaiat. 30,4ab 0,8b 0,09b 0,71bfuori suolo maturaz. 34,0a 0,8b 0,08b 0,72b
I campioni relativi alle colture idroponica ed in campo risultano simili,
mostrando il valore minore sempre all’invaiatura.
I pesi secchi (ps) risultano più elevati nei pomodori raccolti in campo e dal
fuori suolo idroponica (Tab. 5), senza evidenziare differenze fra le due raccolte
I valori delle ceneri (CE) e della sostanza organica (SO) mostrano il valore
maggiore nei pomodori coltivati in idroponica (Tab), risultano sempre più elevati
all’invaiatura (CE) ed alla maturazione (SO).

Tab. 6 Umidità relativa (UR), Pesi freschi e secchi (%g-1); Ceneri e Sostanza Organica (% ss-1) relativi alle diverse condizioni colturali
campioni pomodoro UR% Peso secco(%gsf)
CENERI (su ss)
S.ORGANICA (su ss)
idrop.invaiatura 95,3 4,76a 0,52a 4,24aidrop.maturaz. 96,5 3,78b 0,34b 3,44bcampo invaiat. 96,0 4,31ab 0,47ab 3,84abcampo maturaz. 96,3 3,86b 0,39b 3,47bfuori suolo 97,7 2,41c 0,24d 2,17cfuori suolo 97,2 2,70c 0,30c 2,40c
L’UR risulta più elevata nei campioni provenienti dalle serre. I valori dei ps,
su 100g di sf , delle CE e della SO, relativi alla ss, più levati sono risultati nei
campioni di campo e da coltura idroponica sempre in corrispondenza dell’invaiatura (
Tab. 6). Nei campioni da serra i valori maggiori di p.s., CE ed SO sono stati
evidenziati alla maturazione.
Tab. 7 Ceneri e Sostanza Organica in 100g ss relativi alle diverse condizioni colturali
Campioni pomodoro CENERI % ss S.ORGANICA %ss
idrop.invaiatura 8,99 89,07
idrop.maturaz. 10,92 89,95
campo invaiat. 10,90 89,09
campo maturaz. 10,10 89,89
fuori suolo invaiat. 9,96 90,04
fuori suolo maturaz. 11,11 88,89
Riportando i dati rilevati a 100g ss i campioni delle serre mostrano un
contenuto maggiore di ceneri e minore di SO rispetto alle altre due condizioni
colturali. Il contenuto di SO risulta intorno al 90% delle ceneri.

Tab. 8 Contenuto dei cationi( g %g ss) nei pomodori cv “Naomi” relativi alle diverse condizioni colturali
Cationi Ca ++ Mg ++ Na + K+
idrop.invaiatura 0,179d 0,138c 0,07d 2,418c
idrop.maturaz. 0,586a 0,205a 0,242b 4,949a
campo invaiat. 0,345c 0,179b 0,167c 3,205b
campo maturaz. 0,402b 0,195b 0,238b 4,942a
fuori suolo invaiat. 0,346c 0,175b 0,276b 3,067b
fuori suolo maturaz. 0,346c 0,179b 0,331a 4,055a
I contenuti dei cationi risultano sempre maggiori nella fase di maturazione con
i valori più elevati di Ca, Mg e K nelle tesi idroponiche. Nei campioni relativi alla
coltura idroponica e in suolo tra invasatura e maturazione si rilevano incrementi
significativi dei valori. Il contenuto maggiore di Na è stato rilevato nei campioni
provenienti da coltura su suolo.
Tab. 9 pH del succo dei pomodori cv “Naomi” relativi alle diverse
condizioni colturali
campioni pHidrop.invaiatura 4,00cidrop.maturaz. 4,08bcampo invaiat. 3,78dcampo maturaz. 4,04bcfuori suolo invaiat. 4,08bfuori suolo maturaz. 4,22a
La reazione dei succhi di pomodoro risulta acida con il valore più basso nel
pomodoro in fase invaiatura proveniente dalla coltura in campo. I campioni

provenienti dalla coltura in serra alla fase maturazione presentano il pH maggiore
(Tab. 9).
Tab. 10 Contenuto di N e P( g %g ss) nei pomodori cv ”Naomi” relativi alle diverse condizioni colturali
Campioni N Pidrop.invaiatura 2,7c 0,41cidrop.maturaz. 3,0b 0,62acampo invaiat. 3,1b 0,47bcampo maturaz. 3,2ab 0,54abfuori suolo 3,3ab 0,48bfuori suolo 3,5a 0,49b
I contenuti di azoto totale risultano più elevati nelle tesi provenienti da serra.
Tutte le tesi hanno fatto registrare il valore maggiore al prelievo invaiatura . Il
contenuto più elevato di fosforo è stato registrato in coltura idroponica nelle bacche
mature. Anche le altre tesi fanno rilevare in contenuto maggiore a questa fase
fenologica .
Tab. 11 Contenuto Proteico(m g %g sf) e Resa Proteica (RP) nei pomodori cv “Naomi” relativi alle diverse condizioni colturali
Campioni Proteine mg g-1 s.f Resa Proteicaidrop.invaiatura 0,95a 70 idrop.maturaz. 0,98ba 98 campo invaiat. 0,68bc 53,3 campo maturaz. 0,75b 65,2 fuori suolo 0,54c 66,7 fuori suolo 0,91a 73
Il contenuto proteico maggiore è stato rilevato nelle bacche raccolte dal sistema
idroponico, sempre alla fase di maturazione. In queste tesi le RP, calcolate come % di

N-proteico rispetto al contenuto totale di N%ss, raggiungono i valori maggiori
rispetto alle altre tesi in entrambi i prelievi (Tab. 11).
Tab. 12 Contenuti di alcune componenti organiche nei pomodori cv “Naomi “relativi alle diverse condizioni colturali
Campioni -carotene(m g %g sf)β Licopene(m g %g sf) AsA (mol/ g p.f.)
idrop.invaiatura 1,57d 1,98b 0,382e
idrop.maturaz. 1,82c 2,89a 0,401de
campo invaiat. 1,99c 1,13e 0,449d
campo maturaz. 2,03bc 1,39d 0,708c
fuori suolo 2,18b 1,62c 0,831b
fuori suolo 2,73a 2,73a 0,915°
Non è stata rilevata in alcun campione la presenza dell’acido deidroascorbico
DAsA. I contenuti più elevati di B –carotene e di AsA sono stati rilevati nelle bacche
provenienti dalla coltura in serra . In tutte le tesi le bacche mature hanno evidenziato
il valore maggiore (Tab.8). Queste due componenti risaltano le meno presenti nelle
bacche provenienti dalla coltura idroponica , rispetto alla altre tesi (Tab.8). Il
contenuto di licopene risulta maggiore nelle tesi da idroponica in entrambi i prelievi,
rispetto alle altre condizioni esaminate .
La tecnica della coltura idroponica ha consentito di realizzare un prodotto con
caratteristiche nutrizionali paragonabili a quelle delle tecniche tradizionali
ampiamente adottate. Infatti hanno mostrato a parità di pf e ps una maggiore capacità
di organicare gli assimilati, producendo quantità maggiori di SO (Tab.3,4 dei
risultati).
Questa migliore capacità di utilizzare gli elementi assimilati è confermata dai
contenuti proteici maggiori ritrovati in queste tesi rispetto alle altre prese in
considerazione, tesi nelle quali è stato rilevato un contenuto maggiore di azoto totale.
Le RP calcolate per le bacche ottenute in idroponica (90%), indicano infatti un

maggiore induzione della sintesi proteica, che in queste tesi ha consentito di
utilizzare al meglio l’azoto assimilato.
Sebbene queste tesi abbiano fatto registrare contenuti minori di -carotene edβ
acido ascorbico, tuttavia in queste bacche è stato riscontrato il maggior contenuto di
licopene, componente organica notoriamente ad azione antiossidante, indice indubbio
di qualità per un prodotto fondamentale nella dieta umana.

BIBLIOGRAFIA

1 Abushia A . A; Hbshi E. A., Daood H. G, Biacs P. A. ( 1997). Determination of antioxidand
vitamins in tomatoes. Food Chemistry, 60, 207-212.
2 Bacci L. Checcacci E. (2004). Il pilotaggio dell’irrigazione nelle colture florovivaistiche.
Quaderno Arsia 5/2004, 13: 147-155.
2 Baille A. (2001). Water management in soillness system in relation to inside and outside
climatic conditions and type of substrate. Italus Hortus 8 (6): 16-22.
3 Battistel P. Enzo M (1999). Pomodoro da mensa in colture fuori suolo. L’Infrmatore Agrario
n. 6,41-51
4 Bohme M. (1993). Effects of hydroponics on the development of cucumber growing in
ecologically suitable substrates. Acta Horticulturae, 361: 133-140.
5 Cariglia A., Stanghellini C. (2001). Un ambiente umido limita il danno di irrigazione salina
nel pomodoro fuori suolo. Supplemento a Colture Protette 2001 (11): 77-84.
6 Chillemi G., Lazzarin R., Pampini F., Gianquinto G., Sambo P., Lunari G. (1999).
Pomodoro in NFT: salinità della soluzione nutritiva, produzione e qualità intrinseca delle
bacche. Supplemento a Colture Protette 1999 (8): 4-16.
7 Cough C., Hobson G. E. (1990). A comparison of the productivity, quality, shelflife
characteristics and consumer reaction to the crop from cherry tomato plants grown at different
levels of salinity. J. Horticultural Science 65 (49): 431-439.
8 Giovannucci E. (1999). Tomatoes, tomato-based products, lycopene and cancer Review of the
epidemiologic literature,Journal of the National Cancer Institute,91, 317-331.
9 Graifenberg A., Giustiniani L., Barsanti L., Bottini. L. (2000). Effetti della salinità sulla
qualità dei frutti nel pomodoro da mensa. Colture protette XXIX (6): 71-79.
10 Guigoni A. (2005). Il pomodoro: dalle mense azteche ai piatti mediterranei, Pagine del tempo,
(sito internet http:\\ www.fortepiano.it\ Pagine del tempo\ index.htm).

11 Guastella M. (1968). Le conserve di pomodoro, Supplemento, Industria Conserve, febbraio
(II).
12 Leonardi C., Ambrosino P., Esposito F., Fogliano V.(2000). Antioxidative activity and
carotenoid and tomatine contents in different typologies of fresh consumption tomatoes.
Journal of Agricultural and Food Chemistry 48: 47234727.
13 Lejeune J.P. (1992). La coltura del pomodoro senza suolo. L’Informatore Agrario XLV (25):
27-29.
14 Massantini F., (1968). Le colture idroponiche. L’Italia Agricola, Numero speciale Colture
Protette, 11-12: 1137-1172.
15 Massantini F. (1985). The light and dark sides of aeroponics. Soilless culture, (1):85-96.
16 Pardossi A., Tognoni F., Serra G. (1989). Esperienze sulla coltivazione senza
suolo del pomodoro in serra. Colture protette, XVIII (5): 81-84.
17 Pardossi A., Incrocci L., Carmassi G., (2004). I sistemi chiusi per le produzioni nutritiva
ricircolante. Atti del Simposio: La coltura senza suolo in Italia” Lodi:
18 Pisanu A.B. (2000). Nuovi sistemi per la coltivazione fuori suolo di specie orticole e floricole.
Convegno: “Colture floricole fuori suolo: strategie per la riduzione dell’impatto ambientale”,
Ercolano (Na): 25/XI.
19 Repetto A., Cadinu M., Leoni S., (1994). The effect of plant position on root development and
vegetative growth in aeroponic lattuce. Acta Horticulturae, n. 361: 603-611.
20 Sandei L., Siviero P., Zanotti G., Cabassi A. (2002). valutazione di licopene nel pomodoro,
L’Informatore agrario,3, 59-63.
21 Setti G. (2001). Il pomodoro da mensa in Italia Edagricole Bologna 1-39, 127176.

22 Siviero P., Motton M. S. (1995). La coltivazione del pomodoro da mensa
Edizioni l’Informatore Agrario 1-69.