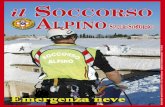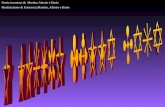Tesi Specialistica - Alessio Coppi
-
Upload
franco-bontempi-org-didattica -
Category
Engineering
-
view
1.014 -
download
20
Transcript of Tesi Specialistica - Alessio Coppi

Università degli studi di Roma
“La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile
Indirizzo Strutture
Tesi di Laurea:
Analisi non lineare
per lo studio delle prestazioni
di una struttura ospedaliera soggetta a sisma
Relatore: Laureando:
Prof. Ing. F. Bontempi Alessio Coppi
Correlatore: Matricola:
Ing. F. Petrini 799139
ANNO ACCADEMICO 2010 - 2011

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INTRODUZIONE 1
INTRODUZIONE
Tra gli edifici pubblici, gli ospedali rivestono un ruolo strategico in caso di calamità, in
quanto sono chiamati a svolgere un’importantissima funzione di soccorso alla popolazione,
garantendo l’efficace continuazione delle prime operazioni di pronto intervento sanitario
avviate sul campo.
All’ospedale, sede tra le più esposte e sensibili in quanto affollata da migliaia di persone
aventi capacità reattive diversissime, viene quindi richiesto non solo di resistere senza danni
eccessivi alla forza d’urto del sisma, ma anche di continuare a offrire sufficienti livelli di
assistenza sanitaria. Ciò significa che si deve porre una particolare attenzione non solo agli
elementi portanti, ma anche a quelli non strutturali e impiantistici, oltre che alla
distribuzione delle funzioni e ai flussi. In Italia, per quello che risulta da un’indagine
effettuata sulla base di dati del Ministero della Salute, molti Comuni sono stati classificati
sismici dopo la costruzione o l’ampliamento degli ospedali, che non sono quindi stati
realizzati secondo delle specifiche norme sismiche.
Il tema è di particolare attualità grazie a disposizioni legislative (Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n°3274/2003 ) che, per la prima volta nel nostro paese, hanno
imposto agli enti proprietari la verifica di sicurezza sismica di tutte le opere di interesse
strategico ai fini della protezione civile, tra le quali si annoverano anche le strutture
ospedaliere. Le passate esperienze di eventi sismici intensi hanno mostrato una elevata
vulnerabilità delle strutture ospedaliere. Ciò è certamente dovuto a fattori intrinseci,
come la complessità delle funzioni ospitate, l’elevato tasso di occupazione, ed
all’impreparazione all’evento; pur tuttavia, l’inadeguatezza di molti edifici ospedalieri è
stata la principale causa della scadente prestazione risultata. Il rischio sismico di una
struttura è funzione dell’effetto combinato della pericolosità del sito dove l’opera sorge e
della vulnerabilità al terremoto dell’opera stessa. La pericolosità di sito è oggi disponibile ad
un accurato livello di precisione per tutto il territorio nazionale. La vulnerabilità
dell’edificio deve essere invece valutata caso per caso.
Le disposizioni normative vigenti (Norme Tecniche per le Costruzioni, Decreto Ministeriale
14/1/2008) necessitano di integrazioni in più ambiti al fine di eseguire la valutazione di
sicurezza di strutture ospedaliere. Gli aspetti di maggior rilievo riguardano la definizione
degli obiettivi di sicurezza, che non sono comuni a quelli propri dei normali edifici, e la
valutazione della risposta e le tecniche di adeguamento dei componenti non strutturali
(arredi, impianti, attrezzature mediche, etc. ), essenziali al mantenimento delle funzioni
operative dell’ospedale anche a seguito di un evento sismico.
Sorge quindi la necessità di uno studio approfondito della struttura capace di descrivere il
comportamento non lineare, le prestazioni ai vari stati limite e i possibili meccanismi di
collasso. Lo strumento più completo ed affidabile è costituito dall’analisi dinamica non
lineare (Time History Analysis), che valuta la risposta tramite l’integrazione al passo delle
equazioni del moto. Questo metodo presenta, però, dei forti limiti di utilizzo legati alla
necessità di una modellazione agli elementi finiti piuttosto complessa e di una potenza di
calcolo tali da confinarne attualmente l’uso al solo ambito della ricerca. D’altro canto
l’analisi lineare, pur essendo caratterizzata da una complessità notevolmente inferiore sia in
termini di basi teoriche che di impegno di calcolo, risulta inadeguata e troppo carente nella
previsione della risposta sismica delle strutture, specie di quelle in cui gli effetti della non
linearità hanno un ruolo determinante.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INTRODUZIONE 2
Un’alternativa attraente è l’uso di procedure di analisi statiche non lineari (analisi di
pushover) che, pur conservando la notevole semplicità d’uso e di interpretazione dei risultati
tipica delle analisi statiche lineari, consentono stime più realistiche ed affidabili della
risposta strutturale anche in campo non lineare. L’analisi di pushover risolve, tramite una
procedura iterativa incrementale, le equazioni di equilibrio statico corrispondenti ad un
modello strutturale non lineare, soggetto ad un sistema di forze laterali di forma costante
che riproduce gli effetti di un sisma, la cui intensità viene gradualmente e monotonicamente
aumentata fino al raggiungimento delle condizioni ultime.
Il lavoro svolto in questa tesi si è basato su un’analisi statica non-lineare di una struttura in
acciaio non regolare in altezza adibita ad uso ospedaliero dove:
1. le non linearità geometriche sono state considerate tramite gli effetti P-Δ;
2. le non linearità di materiale sono state considerate mediante l’introduzione di
cerniere plastiche definite secondo la FEMA 356 (Federal Emergency Management
Agency-356):
a. cerniere assiali per i controventi;
b. cerniere flessionali per le travi;
c. cerniere presso-flessionali per le colonne.
3. sono stati svolti tre casi di analisi diversi con e senza effetti P-Δ:
a. CASO 1: analisi con distribuzione di forze uniforme da intendersi come
derivata da una distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della
costruzione;
b. CASO 2: analisi con distribuzione di forze corrispondente ad una
distribuzione di accelerazioni proporzionale alla forma del modo di vibrare
fondamentale;
c. CASO 3: MPA (Modal Pushover Analysis, Chopra A.K. e Goel R.K. [2001])
la quale consiste essenzialmente nell’eseguire tante analisi statiche non lineari
quanti sono i modi di vibrare significativi, ognuna con una distribuzione di
forze orizzontali proporzionale alla deformata del modo considerato e
successivamente si determina la risposta globale combinando i singoli effetti
ottenuti da ciascuna analisi.
Sono risultati molto utili, per la modellazione e l’analisi dell’ospedale con il software di
calcolo agli elementi finiti SAP2000®, una serie di esempi raccolti nelle due appendici
perché hanno permesso di comprendere meglio gli aspetti legati alla modellazione delle
cerniere plastiche e al metodo di analisi statica non lineare.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE i
INDICE
INTRODUZIONE .................................................................................................................. 1
1 - RISCHIO SISMICO E APPROCCIO PRESTAZIONALE ......................................... 3
1.1 - RISCHIO SISMICO ........................................................................................................ 3
1.2 - VULNERABILITA’ SISMICA ....................................................................................... 4
1.2.1 - Metodi per la valutazione della vulnerabilità ............................................................ 4
1.3 - DOMANDA SISMICA ................................................................................................... 5
1.4 - LIVELLI DI PRESTAZIONE ......................................................................................... 7
1.4.1 - Livelli di prestazione secondo FEMA 356................................................................ 7
1.4.1.1 - Struttura .............................................................................................................. 8
1.4.1.2 - Componenti non strutturali ................................................................................ 9
1.4.1.3 - Combinazione delle prestazioni ....................................................................... 10
1.4.2 - Livelli di prestazione secondo DM 2008 ................................................................ 12
1.4.3 - Livello prestazionale per gli ospedali ..................................................................... 13
1.5 - BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 14
2 - STRUTTURA OSPEDALIERA .................................................................................... 15
2.1 - ANALISI DEL SISTEMA OSPEDALIERO ................................................................ 15
2.2 - RISPOSTA DEL SISTEMA OSPEDALIERO AD UN EVENTO SISMICO ............. 17
2.3 - ADEGUAMENTO ........................................................................................................ 19
2.3.1 - Strategia di adeguamento ........................................................................................ 19
2.3.2 - Processo di adeguamento ........................................................................................ 19
2.3.3 – Confronto tra strategie alternative di adeguamento................................................ 20
2.3.4 - Scelta tra strategie alternative di adeguamento ....................................................... 21
2.4 - VULNERABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA ................................... 22
2.4.1 - Cause di vulnerabilità in ospedale ........................................................................... 22
2.4.2 - Valutazione della vulnerabilità strutturale .............................................................. 23
2.4.3 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale ....................................................... 25
2.4.3.1 - Elementi non strutturali .................................................................................... 25
2.4.3.2 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale ............................................... 27
2.4.3.3 - Rapida visuale delle referenze selezionate ....................................................... 29
2.4.3.4 - Riduzione della vulnerabilità non strutturale ................................................. 34
2.5 – BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 41

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE ii
3 - COMPORTAMENTO NON LINEARE DEI TELAI IN ACCIAIO ......................... 42
3.1 – INTRODUZIONE ......................................................................................................... 42
3.2 - LE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE ..................................................................... 43
3.2.1 - L’effetto PΔ ........................................................................................................... 44
3.2.2 - L’effetto P ........................................................................................................... 45
3.2.3 - P-Δ ed effetti dei grandi spostamenti nel SAP 2000 ............................................... 46
3.2.3.1 - P-Δ vs. True Large Displacements ................................................................... 46
3.2.4 - Effetto P-δ nel SAP 2000 ........................................................................................ 48
3.2.4.1 - Necessità di considerare gli effetti P-δ ............................................................. 50
3.2.5 - Effetto sulla resistenza della colonna ...................................................................... 50
3.2.6 - Opzioni del SAP 2000 ............................................................................................. 50
3.2.6.1 - Effetti P-δ .......................................................................................................... 50
3.2.6.2 - Effetti P−Δ del secondo ordine ........................................................................ 50
3.3 - LE NON LINEARITÀ DI MATERIALE ..................................................................... 52
3.3.1 - Modellazione a plasticità concentrata ..................................................................... 52
3.3.2 - Il concetto di cerniera plastica ................................................................................. 53
3.3.2.1 - La definizione di momento limite ultimo .......................................................... 54
3.3.3 – Cerniere plastiche secondo FEMA 356 applicate nel SAP 2000 ........................... 58
3.3.3.1 - Controvento: cerniera assiale con legame rigido plastico incrudente
asimmetrico secondo FEMA 356 .................................................................................... 58
3.3.3.1.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 58
3.3.3.2 - Trave: cerniera flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo
FEMA356 ........................................................................................................................ 63
3.3.3.2.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 63
3.3.3.3 - Colonna: cerniera presso/tenso-flessionale con legame rigido plastico
incrudente secondo FEMA 356 ....................................................................................... 68
3.3.3.3.1 - Dominio di interazione .................................................................................. 68
3.3.3.3.2 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 70
3.4 - PROCEDURE DI SOLUZIONE DI PROBLEMI NON LINEARI .............................. 77
3.5 – BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 80
4 - ANALISI NON LINEARE STATICA .......................................................................... 81
4.1 - INTRODUZIONE .......................................................................................................... 81
4.2 - SISTEMI SDOF ............................................................................................................. 82
4.3 - SISTEMI MDOF ........................................................................................................... 83
4.4 - CURVA DI CAPACITA’ .............................................................................................. 84

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE iii
4.4.1 - Individuazione degli stati limite sulla curva di capacità ......................................... 86
4.5 - ANALISI NON LINEARE STATICA SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA .. 87
4.5.1 - L’analisi non lineare statica secondo NTC 2008 .................................................... 87
4.5.2 - Risposta alle diverse componenti dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale
del moto .............................................................................................................................. 88
4.5.3 - Analisi non lineare statica secondo la bozza esplicativa del 07/03/2008 ............... 88
4.6 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
CONVENZIONALI ............................................................................................................... 90
4.6.1 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze uniforme ....................................... 91
4.6.2 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze proporzionale al modo
fondamentale di vibrare ...................................................................................................... 92
4.7 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
MULTIMODALE .................................................................................................................. 93
4.7.1 - Analisi Modale Pushover (MPA) ............................................................................ 94
4.7.1.1 - Determinazione della domanda sismica totale ................................................ 96
4.7.1.2 - Rapporto FEMA-440 sul metodo MPA ............................................................ 97
4.8 - ANALISI DI PUSHOVER DELLA STRUTTURA SPAZIALE ................................. 98
4.9 - ANALISI DI PUSHOVER NEL SAP 2000 .................................................................. 99
4.9.1 - In/Output step nel SAP 2000 ................................................................................... 99
4.9.1.1 - Salvataggio di più steps .................................................................................... 99
4.9.1.2 - Minimo e massimo numero di steps salvati ...................................................... 99
4.9.1.3 - Salva solo gli incrementi positivi ................................................................... 101
4.9.1.4 - Influenza della scelta degli steps sull’aspetto numerico ................................ 101
4.9.1.5 - Massimo numero di iterazioni per step .......................................................... 104
4.9.1.6 - Tolleranza di convergenza dell’iterazione ..................................................... 104
4.9.1.7 - Controllo dell’iterazione “event to event” ..................................................... 104
4.9.2 - Metodo di scarico della cerniera plastica nel SAP 2000 ....................................... 104
4.9.2.1 - Scarico dell’intera struttura ........................................................................... 105
4.9.2.2 - Applicare la ridistribuzione locale ................................................................. 105
4.9.2.3 – Ripartire usando la rigidezza secante ........................................................... 106
4.10 – BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................... 107
5 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA .................................................................... 108
5.1 - DESCRIZIONE DELL’OPERA .................................................................................. 108
5.1.1 - Collocamento geografico ...................................................................................... 108
5.1.2 - Caratterizzazione Architettonica ........................................................................... 108

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE iv
5.1.3 - Caratterizzazione Strutturale ................................................................................. 109
5.1.3.1 – Solaio ............................................................................................................. 110
5.1.3.2 – Colonne .......................................................................................................... 111
5.1.3.3 – Controventi .................................................................................................... 111
5.1.3.4 - Vano Scala e Ascensore .................................................................................. 112
5.1.3.5 – Fondazioni ..................................................................................................... 113
5.1.4 – Materiali ................................................................................................................ 113
5.1.4.1 - Acciaio da carpenteria metallica ................................................................... 113
5.1.4.2 - Acciaio per bulloni e connessioni................................................................... 114
5.1.4.3 - Acciai speciali................................................................................................. 114
5.1.4.4 - Acciaio per cemento armato ........................................................................... 114
5.1.4.5 - Acciaio per cemento armato precompresso ................................................... 115
5.1.4.6 – Calcestruzzo ................................................................................................... 115
5.1.4.7 - Prodotti per uso strutturale ............................................................................ 116
5.2 – AZIONI ....................................................................................................................... 116
5.2.1 - Carichi verticali ..................................................................................................... 116
5.2.1.1 - Carichi permanenti strutturali e non strutturali ............................................ 117
5.2.1.2 - Carico Antropico ............................................................................................ 118
5.2.2 – Azione sismica ...................................................................................................... 118
5.2.2.1 – Combinazione delle azioni ............................................................................. 120
5.3 - SCELTE PROGETTUALI .......................................................................................... 121
5.3.1 - Scelte progettuali globali ....................................................................................... 121
5.3.2 - Scelte progettuali locali ......................................................................................... 121
5.4 - MODELLAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI........................................ 125
5.4.1 - Modellazione del solaio ........................................................................................ 125
5.4.2 - Modellazione delle travi ........................................................................................ 127
5.4.3 - Modellazione delle colonne .................................................................................. 130
5.4.4 - Posizionamento e modellazione dei controventi ................................................... 130
5.5 - MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA ............................................................... 131
5.5.1 - Modellazione delle cerniere plastiche ................................................................... 132
5.5.1.1 - Cerniere plastiche assiali ............................................................................... 132
5.5.1.1.1 - Cerniere plastiche assiali nel piano XZ (lato lungo) .................................. 133
5.5.1.1.2 - Cerniere plastiche assiali nel piano YZ (lato corto) ................................... 137
5.5.1.2 - Cerniere plastiche flessionali ......................................................................... 143
5.5.1.3 - Cerniere plastiche presso-flessionali ............................................................. 144

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE v
5.6 – BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 147
6 - ANALISI NON LINEARE STATICA DELL’OSPEDALE ..................................... 148
6.1 – IMPOSTAZIONE DEI SCENARI DI CARICO ........................................................ 148
6.2 - ANALISI PUSHOVER E RELATIVE DISTRIBUZIONI DI FORZE ...................... 150
6.2.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse ................................................ 161
6.2.1.1 - Stima della domanda allo SLC ....................................................................... 161
6.2.1.1.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 161
6.2.1.1.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 166
6.2.1.2 - Stima della domanda allo SLV ....................................................................... 170
6.2.1.2.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 170
6.2.1.2.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 173
6.2.1.3 - Stima della domanda allo SLD ....................................................................... 176
6.2.1.3.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 176
6.2.1.3.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 179
6.2.1.4 - Stima della domanda allo SLO ....................................................................... 181
6.2.1.4.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 181
6.2.1.4.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 183
6.2.2 - CASO 2: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
modo di vibrare principale ................................................................................................ 185
6.2.2.1 - Stima della domanda allo SLC ....................................................................... 185
6.2.2.1.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 185
6.2.2.1.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 186
6.2.2.2 - Stima della domanda allo SLV ....................................................................... 187
6.2.2.2.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 187
6.2.2.2.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 188
6.2.2.3 - Stima della domanda allo SLD ....................................................................... 189
6.2.2.3.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 189
6.2.2.3.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 190
6.2.2.4 - Stima della domanda allo SLO ....................................................................... 191
6.2.2.4.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 191
6.2.2.4.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 192
6.2.3 - CASO 3: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
dei modi di vibrare principali (MPA) ............................................................................... 193
6.2.3.1 - Stima della domanda allo SLC ....................................................................... 193
6.2.3.1.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 193

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE vi
6.2.3.1.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 194
6.2.3.2 - Stima della domanda allo SLV ....................................................................... 196
6.2.3.2.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 196
6.2.3.2.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 196
6.2.3.3 - Stima della domanda allo SLD ....................................................................... 197
6.2.3.3.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 197
6.2.3.3.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 198
6.2.3.4 - Stima della domanda allo SLO ....................................................................... 199
6.2.3.4.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 199
6.2.3.4.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 199
6.2.4 - CASO 1 e CASO 2 con effetti P-Δ ....................................................................... 201
6.2.4.1 - Stima della domanda allo SLC ....................................................................... 201
6.2.4.1.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 201
6.2.4.1.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 202
6.2.4.2 - Stima della domanda allo SLV ....................................................................... 202
6.2.4.2.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 202
6.2.4.2.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 204
6.2.4.3 - Stima della domanda allo SLD ....................................................................... 205
6.2.4.3.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 205
6.2.4.3.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 206
6.2.4.4 - Stima della domanda allo SLO ....................................................................... 207
6.2.4.4.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 207
6.2.4.4.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 208
6.2.5 - CASO 3 con effetti P-Δ ......................................................................................... 209
6.2.5.1 - Stima della domanda allo SLC ....................................................................... 209
6.2.5.1.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 209
6.2.5.1.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 210
6.2.5.2 - Stima della domanda allo SLV ....................................................................... 211
6.2.5.2.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 211
6.2.5.2.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 212
6.2.5.3 - Stima della domanda allo SLD ....................................................................... 213
6.2.5.3.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 213
6.2.5.3.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 214
6.2.5.4 - Stima della domanda allo SLO ....................................................................... 215
6.2.5.4.1 - Distribuzione nella direzione X ................................................................... 215

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE vii
6.2.5.4.2 - Distribuzione nella direzione Y ................................................................... 215
6.3 - CONFRONTI E COMMENTI DEI RISULTATI OTTENUTI .................................. 216
6.3.1 - L’influenza della distribuzione di forze adottata sulla curva di capacità e quindi sul
performance point ai relativi stati limite .......................................................................... 217
6.3.2 - Studio dell’evoluzione in campo non-lineare della struttura ................................ 221
6.3.3 - Curve di capacità per il CASO 1 e il CASO 2 con e senza effetti P-Δ ................. 224
6.3.4 - L’importanza dei modi superiori in termini di spostamenti e drifts di piano ....... 226
6.3.5 - Valutazione della risposta attraverso l’inviluppo dei risultati ottenuti da due analisi
.......................................................................................................................................... 228
APPENDICE A - CERNIERE PLASTICHE E CURVA DI CAPACITA’ .................. 232
A.1 - LEGAMI CERNIERA PLASTICA ASSIALE .......................................................... 232
A.1.1 – Materiale .............................................................................................................. 232
A.1.2 – Cerniera plastica assiale ....................................................................................... 233
A.1.3 - Caso di analisi: PUSHOVER ............................................................................... 234
A.1.4 - MODELLO 1: legame rigido plastico simmetrico ............................................... 236
A.1.4.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 236
A.1.4.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’ ............................................. 238
A.1.5 - MODELLO 2: legame rigido plastico asimmetrico ............................................. 239
A.1.5.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 239
A.1.5.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’ ............................................. 242
A.1.6 - MODELLO 3: legame rigido plastico asimmetrico (χ secondo EC3) ................. 244
A.1.6.1 - Calcolo del coefficiente χ funzione della snellezza dell'asta secondo EC3 ... 244
A.1.6.2 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 245
A.1.6.3 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’ ............................................. 247
A.1.7 - MODELLO 4: legame rigido plastico incrudente asimmetrico ........................... 249
A.1.7.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 249
A.1.7.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’ ............................................. 253
A.1.8 - MODELLO 5: legame secondo FEMA 356 ........................................................ 254
A.1.8.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................... 254
A.1.8.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’ ............................................. 259
A.2 - LUNGHEZZA E POSIZIONE DELLA CERNIERA PLASTICA ASSIALE .......... 261
A.2.1 – Materiale .............................................................................................................. 261
A.2.2 - Cerniera plastica assiale ....................................................................................... 261
A.2.3 – Modello trave tesa ................................................................................................ 262
A.2.3.1 - Caso con unica cerniera assiale al centro (x=0,5L) con R.L.=1 .................. 262

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE viii
A.2.3.2 - Caso con doppia cerniera assiale a x=0L E x=1L con R.L.=0,5 .................. 265
A.2.3.3 - Caso con doppia cerniera assiale a x=0,25L E x=0,75L con R.L.=0,5 ........ 268
A.2.3.4 - Confronto tra i 3 modelli ............................................................................... 271
A.2.3.5 – Conclusioni .................................................................................................... 272
A.3 - MODELLO TRAVE ................................................................................................... 273
A.3.1 – Materiale .............................................................................................................. 273
A.3.2 – Cerniera plastica assiale ....................................................................................... 273
A.3.3 - Caso di analisi: PUSHOVER ............................................................................... 275
A.3.4 - Modello trave tesa ................................................................................................ 275
A.3.4.1 - Risultati dell’analisi ....................................................................................... 275
A.3.4.2 - Modelli trave tesa a confronto ....................................................................... 276
A.3.4.3 - Curva di capacità ........................................................................................... 278
A.4 - MODELLO TELAIO CONTROVENTATO 2D ....................................................... 281
A.4.1 – Materiale .............................................................................................................. 281
A.4.2 – Cerniera plastica assiale nei controventi ............................................................. 282
A.4.3 - Caso di analisi: PUSHOVER ............................................................................... 284
A.4.4 - Risultati dell’analisi .............................................................................................. 284
A.4.5 - Modelli a confronto .............................................................................................. 286
A.4.5.1 - Curva di capacità ........................................................................................... 290
A.5 - BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 293
APPENDICE B - METODO N2 (FAJFAR) .................................................................... 294
B.1 – INTRODUZIONE ...................................................................................................... 294
B.2 - MODELLO 1 .............................................................................................................. 295
B.2.1 – Materiale .............................................................................................................. 296
B.2.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356 ................................................. 297
B.2.2.1 - Trave: cerniera flessionale secondo FEMA 356 ........................................... 297
B.2.2.1.1 - Definizione del legame della cerniera ........................................................ 297
B.2.2.2 - Colonna: cerniera presso -flessionale secondo FEMA 356 .......................... 304
B.2.2.2.1 - Dominio di interazione ................................................................................ 304
B.2.2.1.2 - Definizione del legame della cerniera ........................................................ 308
B.2.3 - Analisi PUSHOVER............................................................................................. 331
B.2.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse ......................................... 333
B.2.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del primo modo di vibrare ........................................................................... 338
B.3 - MODELLO 2 .............................................................................................................. 343

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE ix
B.3.1 – Materiale .............................................................................................................. 343
B.3.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356 ................................................. 344
B.3.3 - Analisi PUSHOVER............................................................................................. 344
B.3.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse ......................................... 346
B.3.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del primo modo di vibrare ........................................................................... 352
B.4 - MODELLO 3 .............................................................................................................. 358
B.4.1 – Materiale .............................................................................................................. 358
B.4.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356 ................................................. 359
B.4.3 - Analisi PUSHOVER............................................................................................. 359
B.4.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse ......................................... 361
B.4.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del primo modo di vibrare ........................................................................... 366
B.5 - MODELLO 4 .............................................................................................................. 371
B.5.1 – Materiale .............................................................................................................. 371
B.5.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356 ................................................. 372
B.5.3 - Analisi PUSHOVER............................................................................................. 372
B.5.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse ......................................... 374
B.5.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del primo modo di vibrare ........................................................................... 379
B.6 - BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 384
CONCLUSIONI ................................................................................................................. 385
BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................ 387

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE x
INTRODUZIONE

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xi
1 - RISCHIO SISMICO E LIVELLI DI PRESTAZIONE
1.1 - RISCHIO SISMICO
1.2 - VULNERABILITA’ SISMICA
1.2.1 - Metodi per la valutazione della vulnerabilità
1.3 - DOMANDA SISMICA
1.4 - LIVELLI DI PRESTAZIONE
1.4.1 - Livelli di prestazione secondo FEMA 356
1.4.1.1 - Struttura
1.4.1.2 - Componenti non strutturali
1.4.1.3 - Combinazione delle prestazioni
1.4.2 - Livelli di prestazione secondo DM 2008
1.4.1 - Livello prestazionale per gli ospedali
1.5 - BIBLIOGRAFIA

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xii
2 – STRUTTURA OSPEDALIERA
2.1 - ANALISI DELLA COMPONENTE FISICA
2.2 - RISPOSTA DEL SISTEMA OSPEDALIERO AD UN EVENTO SISMICO
2.3 – ADEGUAMENTO
2.3.1 - Strategia di adeguamento
2.3.2 - Processo di adeguamento
2.3.3 – Confronto tra strategie alternative di adeguamento
2.3.4 - Scelta tra strategie alternative di adeguamento
2.4 - VULNERABILITA’ IN OSPEDALE
2.4.1 - Cause di vulnerabilità in ospedale
2.4.2 - Valutazione della vulnerabilità strutturale
2.4.3 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale
2.4.3.1 - Elementi non strutturali
2.4.3.2 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale
2.4.3.3 - Rapida visuale delle referenze selezionate
2.4.3.3 - Riduzione della vulnerabilità non strutturale
2.5 – BIBLIOGRAFIA

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xiii
3 - ASPETTI DEL COMPORTAMENTO NON LINEARE DEI TELAI IN ACCIAIO
3.1 – INTRODUZIONE
3.2 - LE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE
3.2.1 - L’effetto PΔ
3.2.2 - L’effetto P
3.2.3 - P-Δ ed effetti dei grandi spostamenti nel SAP 2000
3.2.3.1 - P-Δ vs. True Large Displacements
3.2.4 - Effetto P-δ
3.2.4.1 - Necessità di considerare gli effetti P-δ
3.2.5 - Effetto sulla resistenza della colonna
3.2.6 - Opzioni del SAP 2000
3.2.6.1 - Effetti P-δ
3.2.6.2 - Effetti P−Δ del secondo ordine
3.3 - LE NON LINEARITÀ DI MATERIALE
3.3.1 - Modellazione a plasticità concentrata
3.3.2 - Il concetto di cerniera plastica
3.3.2.1 - La definizione di momento limite ultimo
3.3.3 – Cerniere plastiche secondo FEMA 356 applicate nel SAP 2000
3.3.3.1 - Controvento: cerniera assiale con legame rigido plastico incrudente asimmetrico secondo FEMA 356
3.3.3.1.1 - Definizione del legame della cerniera
3.3.3.2 - Trave: cerniera flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo FEMA356
3.3.3.2.1 - Definizione del legame della cerniera
3.3.3.3 - Colonna: cerniera presso/tenso-flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo FEMA 356
3.3.3.3.1 - Dominio di interazione

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xiv
3.3.3.3.2 - Definizione del legame della cerniera
3.4 - PROCEDURE DI SOLUZIONE DI PROBLEMI NON LINEARI
3.5 – BIBLIOGRAFIA
4 - ANALISI NON LINEARE STATICA
4.1 – INTRODUZIONE
4.2 - SISTEMI SDOF
4.3 - SISTEMI MDOF
4.4 – CURVA DI CAPACITA’
4.4.1 - Individuazione degli stati limite sulla curva di capacità
4.5 - ANALISI NON LINEARE STATICA SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA
4.5.1 - L’analisi non lineare statica secondo NTC 2008
4.5.2 - Risposta alle diverse componenti dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale del moto
4.5.3 - Analisi non lineare statica secondo la bozza esplicativa del 07/03/2008
4.6 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
CONVENZIONALI
4.6.1 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze uniforme
4.6.2 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze proporzionale al modo
fondamentale di vibrare 4.7 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
MULTIMODALE
4.7.1 - Analisi Modale Pushover (MPA)
4.7.1.1 – Determinazione della domanda sismica totale
4.7.1.2 – Rapporto FEMA-440 sul metodo MPA 4.8 - ANALISI DI PUSHOVER DELLA STRUTTURA SPAZIALE

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xv
4.9 - ANALISI DI PUSHOVER NEL SAP 2000
4.9.1 - In/Output step nel SAP 2000
4.9.1.1 - Salvataggio di più steps
4.9.1.2 - Minimo e massimo numero di steps salvati
4.9.1.3 - Salva solo gli incrementi positivi
4.9.1.4 - Influenza della scelta degli steps sull’aspetto numerico
4.9.1.5 - Massimo numero di iterazioni per step
4.9.1.6 - Tolleranza di convergenza dell’iterazione
4.9.1.7 - Controllo dell’iterazione “event to event” 4.9.2 - Metodo di scarico della cerniera plastica nel SAP 2000
4.9.2.1 - Scarico dell’intera struttura
4.9.2.2 - Applicare la ridistribuzione locale
4.9.2.3 – Ripartire usando la rigidezza secante 4.10 – BIBLIOGRAFIA
5 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 5.1 - DESCRIZIONE DELL’OPERA
5.1.1 - Collocamento geografico
5.1.2 - Caratterizzazione Architettonica
5.1.3 - Caratterizzazione Strutturale
5.1.3.1 – Solaio
5.1.3.2 – Colonne
5.1.3.3 – Controventi
5.1.3.4 - Vano Scala e Ascensore
5.1.3.5 – Fondazioni
5.1.4 – Materiali
5.1.4.1 - Acciaio da carpenteria metallica
5.1.4.2 - Acciaio per bulloni e connessioni
5.1.4.3 - Acciai speciali
5.1.4.4 - Acciaio per cemento armato
5.1.4.5 - Acciaio per cemento armato precompresso
5.1.4.6 – Calcestruzzo
5.1.4.7 - Prodotti per uso strutturale
5.2 – AZIONI
5.2.1 - Carichi verticali
5.2.1.1 - Carichi permanenti strutturali e non strutturali
5.2.1.2 - Carico Antropico
5.2.2 – Azione sismica
5.2.2.1 – Combinazione delle azioni
5.3 - SCELTE PROGETTUALI

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xvi
5.3.1 - Scelte progettuali globali
5.3.2 - Scelte progettuali locali
5.4 - MODELLAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
5.4.1 - Modellazione del solaio 5.4.2 - Modellazione delle travi
5.4.3 - Modellazione delle colonne
5.4.4 - Posizionamento e modellazione dei controventi 5.5 - MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA
5.5.1 - Modellazione delle cerniere plastiche
5.5.1.1 - Cerniere plastiche assiali
5.5.1.1.1 - Cerniere plastiche assiali nel piano XZ (lato lungo)
5.5.1.1.2 - Cerniere plastiche assiali nel piano YZ (lato corto)
5.5.1.2 - Cerniere plastiche flessionali
5.5.1.3 - Cerniere plastiche presso-flessionali
5.6 – BIBLIOGRAFIA

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xvii
6 - ANALISI NON LINEARE STATICA DELL’OSPEDALE
6.1 – IMPOSTAZIONE DEI SCENARI DI CARICO
6.2 - ANALISI PUSHOVER E RELATIVE DISTRIBUZIONI DI FORZE
6.2.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
6.2.1.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.1.1.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.1.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.1.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.1.2.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.1.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.1.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.1.3.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.1.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.1.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.1.4.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.1.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.2 - CASO 2: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata modo di vibrare principale
6.2.2.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.2.1.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.2.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.2.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.2.2.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.2.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.2.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.2.3.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.2.3.2 - Distribuzione nella direzione Y

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xviii
6.2.2.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.2.4.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.2.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.3 - CASO 3: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata dei modi di vibrare principali (MPA)
6.2.3.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.3.1.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.3.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.3.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.3.2.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.3.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.3.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.3.3.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.3.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.3.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.3.4.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.3.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.4 - CASO 1 e CASO 2 con effetti P-Δ
6.2.4.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.4.1.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.4.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.4.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.4.2.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.4.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.4.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.4.3.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.4.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.4.4 - Stima della domanda allo SLO

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xix
6.2.4.4.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.4.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.5 - CASO 3 con effetti P-Δ
6.2.5.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.5.1.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.5.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.5.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.5.2.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.5.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.5.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.5.3.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.5.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.2.5.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.5.4.1 - Distribuzione nella direzione X
6.2.5.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
6.3 - CONFRONTI E COMMENTI DEI RISULTATI OTTENUTI
6.3.1 - L’influenza della distribuzione di forze adottata sulla curva di capacità e quindi sul performance point ai relativi stati limite
6.3.2 - Studio dell’evoluzione in campo non-lineare della struttura
6.3.3 - Curve di capacità per il CASO 1 e il CASO 2 con e senza effetti P-Δ
6.3.4 - L’importanza dei modi superiori in termini di spostamenti e drifts di piano
6.3.5 - Valutazione della risposta attraverso l’inviluppo dei risultati ottenuti da due analisi

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xx
APPENDICE A: CERNIERE PLASTICHE E CURVA DI CAPACITA’
A.1 - LEGAMI CERNIERA PLASTICA ASSIALE
A.1.1 – Materiale
A.1.2 – Cerniera plastica assiale
A.1.3 - Caso di analisi: PUSHOVER
A.1.4 - MODELLO 1: legame rigido plastico simmetrico
A.1.4.1 - Definizione del legame della cerniera
A.1.4.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’
A.1.5 - MODELLO 2: legame rigido plastico asimmetrico
A.1.5.1 - Definizione del legame della cerniera
A.1.5.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’
A.1.6 - MODELLO 3: legame rigido plastico asimmetrico (χ secondo EC3)
A.1.6.1 - Calcolo del coefficiente χ funzione della snellezza dell'asta secondo EC3
A.1.6.2 - Definizione del legame della cerniera
A.1.6.3 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’
A.1.7 - MODELLO 4: legame rigido plastico incrudente asimmetrico secondo EC3
A.1.7.1 - Definizione del legame della cerniera
A.1.7.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’
A.1.8 - MODELLO 5: legame rigido plastico incrudente asimmetrico secondo FEMA 356
A.1.8.1 - Definizione del legame della cerniera
A.1.8.2 - Risultati dell’analisi: CURVA DI CAPACITA’
A.2 - LUNGHEZZA E POSIZIONE DELLA CERNIERA PLASTICA ASSIALE
A.2.1 – Materiale
A.2.2 - Cerniera plastica assiale
A.2.3 – Modello trave tesa
A.2.3.1 - Caso con unica cerniera assiale al centro (x=0,5L) con R.L.=1

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xxi
A.2.3.2 - Caso con doppia cerniera assiale a x=0L E x=1L con R.L.=0,5
A.2.3.3 - Caso con doppia cerniera assiale a x=0,25L E x=0,75L con R.L.=0,5
A.2.3.4 - Confronto tra i 3 modelli
A.2.3.5 – Conclusioni
A.3 - MODELLO TRAVE
A.3.1 – Materiale
A.3.2 – Cerniera plastica assiale
A.3.3 - Caso di analisi: PUSHOVER
A.3.4 - Modello trave tesa
A.3.4.1 - Risultati dell’analisi
A.3.4.2 - Modelli trave tesa a confronto
A.3.4.3 - Curva di capacità
A.4 - MODELLO TELAIO CONTROVENTATO 2D
A.4.1 – Materiale
A.4.2 – Cerniera plastica assiale nei controventi
A.4.3 - Caso di analisi: PUSHOVER
A.4.4 - Risultati dell’analisi
A.4.5 - Modelli a confronto
A.4.5.1 - Curva di capacità

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xxii
APPENDICE B - METODO N2 (FAJFAR-1999)
B.1 – INTRODUZIONE
B.2 - MODELLO 1
B.2.1 – Materiale
B.2.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356
B.2.2.1 - Trave: cerniera flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo FEMA 356
B.2.2.1.1 - Definizione del legame della cerniera
B.2.2.2 - Colonna: cerniera presso/tenso-flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo FEMA 356
B.2.2.2.1 - Dominio di interazione
B.2.2.1.2 - Definizione del legame della cerniera
B.2.3 - Analisi PUSHOVER
B.2.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
B.2.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del primo modo di vibrare
B.3 - MODELLO 2
B.3.1 – Materiale
B.3.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356
B.3.3 - Analisi PUSHOVER
B.3.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
B.3.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del primo modo di vibrare
B.4 - MODELLO 3
B.4.1 – Materiale
B.4.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356
B.4.3 - Analisi PUSHOVER

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
INDICE xxiii
B.4.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
B.4.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del primo modo di vibrare
B.5 - MODELLO 4
B.5.1 – Materiale
B.5.2 - Modello telaio con cerniere secondo FEMA 356
B.5.3 - Analisi PUSHOVER
B.4.3.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
B.4.3.2 - CASO 2: Distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del primo modo di vibrare
CONCLUSIONI

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 3
1 - RISCHIO SISMICO E APPROCCIO PRESTAZIONALE
1.1 - RISCHIO SISMICO [1]
RISCHIO SISMICO ( PTd[L] )
Misura probabilistica del grado di severità degli effetti (perdite L) che possono essere
prodotti dai terremoti, in un sito prefissato, durante un intervallo di tempo prefissato Td.
VULNERABILITÀ SISMICA (P[D|I,T] )
Misura probabilistica del grado di severità del danno (D) che un manufatto di prefissata
tipologia T subisce per effetto di un terremoto di prefissata intensità I.
PERICOLOSITÀ SISMICA ( PTd[I] ) Misura probabilistica del grado di severità dei terremoti (Intensità I) che possono presentarsi
in un sito prefissato, durante un intervallo di tempo prefissato Td.
ESPOSIZIONE ( P[E|T] ) Misura probabilistica della quantità di beni e attività (E) che si accompagnano ad una
prefissata tipologia (T).
Rischio=… Vulnerabilità ∙ Pericolosità ∙ Esposizione
𝐏𝐓𝐝[𝐋] = ∑ 𝐏[𝐋|𝐃, 𝐄, 𝐓 ]
𝐈,𝐓,𝐃,𝐄
∙ 𝐏[𝐃|𝐈, 𝐓] ∙ 𝐏𝐓𝐝[𝐈] ∙ 𝐏𝐓𝐝[𝐓] ∙ 𝐏[𝐄|𝐓]
La definizione del rischio sismico deriva dall’incrocio di tre competenze:
INGEGNERE GEOLOGO ECONOMISTA ( STRUTTURISTA ) ( SISMOLOGO ) ( PIANIFICATORE )
P[D|I,T] PTd[I] P[E|T]
VULNERABILITÀ PERICOLOSITÀ ESPOSIZIONE
[1]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 4
1.2 - VULNERABILITA’ SISMICA
1.2.1 – Metodi per la valutazione della vulnerabilità [2]
I metodi disponibili per la valutazione della vulnerabilità di un edificio possono essere
classificati per livelli di crescente complessità ed accuratezza:
1. I livello: procedure di natura statistica/esperienziale basate su schede sviluppate
appositamente per i complessi ospedalieri;
2. II livello: analisi numeriche di dettaglio, di differente complessità (lineari e/o non-
lineari, statiche e/o dinamiche), utilizzato nella pratica professionale;
3. III livello: metodi di natura probabilistica che rappresentano lo stato dell’arte in
materia dove tutte le variabili in gioco e le incertezze ad esse associate sono
considerate e quantificate.
VULNERABILITÀ SISMICA
Tipologia Costruttiva
Epoca di realizzazione e
qualità costruttiva
Storia e stato di
manutenzione del fabbricato
Muratura
c.a.
Acciaio

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 5
1.3 - DOMANDA SISMICA
[3]
NO
NO
Sisma
Classificazione del
terreno
Classificazione
topografica
Tipo di
terreno
Valutazione del periodo
fondamentale
𝑇1<4sec?
Studi approfonditi
Il terreno appartiene alle
tipologie A, B, C, D, o E?
SI
SI
Tipo di
modello
L’azione sismica viene
modellata tramite uno
spettro di risposta?
NO
Spettro di risposta Accelerogramma
Valutazione delle non
linearità
Ritorna al livello
precedente
SI ( 1. )

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 6
SOTTOPROCEDURA ( 1. )
[3]
Spettro
Valutazione dei parametri di definizione
dell’azione sismica
Valutazione del fattore di struttura q
Definizione dello spettro per lo Stato
Limite di Collasso SLC
Definizione dello spettro per lo Stato
Limite di Salvaguardia della Vita SLV
Definizione dello spettro per lo Stato
Limite di Danno SLD
Definizione dello spettro per lo Stato
Limite di Operatività SLO
Ritorna al livello
precedente
Spettri di risposta
per gli Stati Limite
Ultimi
Spettri di risposta
per gli Stati Limite
di Esercizio

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 7
1.4 - LIVELLI DI PRESTAZIONE
1.4.1 - Livelli di prestazione secondo FEMA 356
[1]
Livelli di prestazione della FEMA 356
STRUTTURA
S-1 Occupabilità immediata
S-2 Controllo del danno
S-3 Salvaguardia della vita
S-4 Limitata sicurezza strutturale
S-5 Prevenzione del collasso
S-6 Nessuna prestazione considerata
COMPONENTI NON STRUTTURALI
N-A Operatività
N-B Occupabilità immediata
N-C Salvaguardia della vita
N-D Pericolo ridotto
N-E Nessuna prestazione considerata
Livelli di prestazione dell’edificio
(nel suo complesso )

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 8
1.4.1.1 - Struttura [4]
S-1 Occupabilità Immediata: Lo stato di danneggiamento post-sisma garantisce la
sicurezza dell’occupazione dell’edificio. Il rischio per le persone dovuto ai danni
strutturali è molto basso e, sebbene possano essere necessari alcuni limitati interventi
di riparazione, questi non sono necessari perché l’edificio possa essere di nuovo
occupato.
S-2 Controllo del danno: campo di prestazioni compreso tra S-1 e S-3.
S-3 Salvaguardia della vita: Stato di danneggiamento post-sisma che include un
danneggiamento degli elementi strutturali tale da mantenere un margine rispetto
all’inizio di un collasso parziale o totale.
S-4 Limitata sicurezza strutturale: campo di prestazioni compreso tra S-3 e S-5.
S-5 Prevenzione del collasso: Stato di danneggiamento post-sisma che include un
danneggiamento agli elementi strutturali tale da garantire ancora la portanza nei
confronti dei carichi verticali ma da non garantire alcun margine nei confronti del
collasso.
S-6 Nessuna prestazione considerata: In questo livello di prestazione non si
richiede che l’edificio raggiunga alcuna prestazione strutturale specificata.
Figura 1.1 - Livelli di prestazione della struttura [1]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 9
1.4.1.2 - Componenti non strutturali [4]
N-A Operatività: Stato post-sisma in cui i componenti non strutturali presenti nella
struttura sono ancora in grado di sostenere le funzioni precedenti al sisma.
N-B Occupabilità Immediata: I danneggiamenti ai componenti non strutturali non
precludono l’accesso all’edificio ed i sistemi di sicurezza (tra i quali si includono le
porte, le scale, gli ascensori e le luci d’emergenza) generalmente rimangono
operativi. Le persone che occupano l’edificio possono rimanere al suo interno a patto
che la struttura sia sicura dal punto di vista strutturale. Sebbene possano non essere
disponibili l’energia, l’acqua, il gas e le linee di comunicazione richieste per il
normale uso dell’edificio, il rischio di ferimenti dovuti a danni di componenti
strutturali è molto basso.
N-C Salvaguardia della vita: Stato in cui i danni ai componenti non strutturali non
comportano gravi rischi per gli occupanti dell’edificio. In questa situazione si
possono verificare danni significativi e costosi ma senza il crollo o la caduta dei
componenti.
N-D Pericolo ridotto: Possibilità di danni a componenti non strutturali tali da farne
rischiare anche il crollo o la caduta. I componenti più pericolosi, tuttavia, sono
ancora sicuri nei confronti del crollo o della caduta in aree aperte al pubblico.
N-E Nessuna prestazione considerata: In questo livello di prestazione non si
richiede che l’edificio raggiunga alcuna prestazione strutturale specificata.
Figura 1.2 - Correlazione tra i livelli di prestazione strutturale e non strutturale [1]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 10
1.4.1.3 - Combinazione delle prestazioni
La prestazione attesa è definita dalla combinazione delle prestazioni strutturali e non-
strutturali.
Livelli e campi di prestazione strutturale
S-1
Occupabilità
immediata
S-2
Controllo
del danno
S-3
Salvaguardia
della vita
S-4
Limitata
sicurezza
strutturale
S-5
Prevenzione
del collasso
S-6
Nessuna
prestazione
considerata
Liv
elli
di
pre
staz
ion
e n
on
str
utt
ura
le N-A
Operatività
1-A
( O )
2-A NR
(Non
raccomandato)
NR NR NR
N-B
Occupabilità
immediata
1-B
( OI )
2-B 3-B NR NR NR
N-C
Salvaguardia
della vita
1-C 2-C 3-C
( SV )
4-C 5-C 6-C
N-D
Pericolo
ridotto
NR 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D
N-E
Nessuna
prestazione
considerata
NR NR NR 4-E 5-E
( PC )
6-E
Nessuna
prestazione
Tabella 1.1 - Combinazione tra i livelli di prestazione strutturale e non strutturale [2]
Le combinazioni di interesse per la valutazione di sicurezza sismica degli ospedali sono:
Operatività ( O ): prevede un lieve danneggiamento delle strutture (S-1), tale da
consentire l’immediata agibilità dell’edificio, come anche degli elementi
architettonici in genere ed, inoltre, il funzionamento di tutte le principali reti
impiantistiche (acqua, luce, gas, comunicazioni, ascensori, ect.) (N-A);
Occupabilità immediata ( OI ): lo stato delle strutture è analogo alla condizione
precedente (S-1), mentre per quanto riguarda le componenti non-strutturali sono
garantite le condizioni di agibilità (tamponature, infissi, controsoffitti) ma NON la
funzionalità delle principali reti (N-B);
Salvaguardia della vita ( SV ): prevede un danno strutturale significativo (S-3), ma
per il quale è ancora ragionevolmente garantita la sicurezza per la vita degli
occupanti. L’edificio potrebbe aver necessità di riparazioni o opere provvisionali
prima di essere riutilizzato. Analogamente, danni significativi ed estesi sono previsti
per tutti gli elementi non-strutturali (N-C);
Prevenzione del collasso ( PC ): l’organismo strutturale è ai limiti del collasso,
parziale o totale, anche se complessivamente ancora in grado di sostenere la forza di
gravità (S-5); lo stato degli elementi non-strutturali non è preso in considerazione,
supponendo gli stessi irreparabilmente danneggiati o distrutti (N-E).

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 11
Figura 1.3 - Livelli di prestazione strutturale e non strutturale per edifici nel loro complesso [1]
L’associazione tra gli stati limite definiti nelle nuove norme e i livelli di prestazione
identificati dalle norme statunitensi è immediata:
Fema 356 NTC 2008
O SLO
OI SLD
SV SLV
PC SLC Tabella 1.2 – Corrispondenza tra livelli di prestazione U.S.A. e stati limite italiani [2]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 12
1.4.2 - Livelli di prestazione secondo DM 2008 [5]
Gli stati limite di esercizio sono:
Stato Limite di Operatività (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni
d’uso significativi;
Stato Limite di Danno (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo
complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le
apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a
rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza
e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi
immediatamente utilizzabile pur nell’interruzione d’uso di parte delle
apparecchiature.
Gli stati limite ultimi sono:
Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV): a seguito del terremoto la
costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e
significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa
di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una
parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei
confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;
Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC): a seguito del terremoto la
costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed
impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva
ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza
nei confronti del collasso per azioni orizzontali.
La norma specifica che:
Qualora la protezione nei confronti degli stati limite di esercizio sia di prioritaria
importanza, l’intensità dell’azione può essere aumentata in funzione del grado di
protezione che si vuole raggiungere (NTC08, § 3.2). Questo è certamente il caso
degli ospedali.
Nel caso di edifici esistenti, il livello di intensità dell’azione sismica per la verifica
dello Stato Limite di Operatività può essere stabilito dal Progettista di concerto con il
Committente (NTC08, § 8.3.).

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 13
1.4.3 - Livello prestazionale per gli ospedali
Gli ospedali si differenziano rispetto alla maggior parte delle costruzioni fondamentalmente
per i seguenti aspetti:
1. la funzione sociale;
2. il ruolo strategico in caso di calamità naturali (come un evento sismico);
3. l’elevato valore del contenuto (superiore rispetto al contenitore – edificio);
4. l’elevato tasso di occupazione, il ciclo ininterrotto d’attività, la complessità dei
sistemi e delle funzioni.
In particolare i presidi ospedalieri più importanti devono mantenere l’operatività delle
principali funzioni anche a seguito di un evento sismico intenso.
Livello
prestazionale
Operativo Agibile Stabile Collasso
Danni
strutturali
Danni non
strutturali
Danni
contenuto
Assenti
assenti
lievi
lievi
lievi
moderati
moderati
moderati / estesi
estesi
estesi
-
-
Sicurezza
Economici
Funzionali
Si
0-10%
Operativo con
minimi disagi
Si
10-30%
Operativo con
lievi disagi
( giorni )
Si
30-60%
Non operativo
necessarie
riparazioni ( mesi )
No
60-100%
Non operativo
Stato
Tabella 1.3 - Livelli di prestazione per gli ospedali [2]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 1 14
1.5 - BIBLIOGRAFIA
[1] Braga F. (2009), “Dispense del corso di costruzioni in zona sismica”, Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma.
[2] Lupoi G., Lupoi A., Pinto P.E., Ansovini P. (2008), “Documento di Supporto alle
Autorità Regionali per la redazione di Linee Guida”,11 Marzo 2008.
[3] Bontempi F. (2010), “Progetto e analisi di ospedali come costruzioni strategiche: visione
di sistema, norme tecniche, azione sismica, robustezza strutturale”, 7° Congresso Nazionale
per Operatori degli Uffici Tecnici, Rieti, 24-25-26 Giugno 2010.
[4] FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of
buildings”, Federal Emergency Management Agency-356, Washington D.C. (USA),
November 2000.
[5] NTC (2008), “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 14 Gennaio 2008.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 15
2 – STRUTTURA OSPEDALIERA
2.1 - ANALISI DEL SISTEMA OSPEDALIERO [6]
La componente fisica include una grande varietà di elementi differenti in natura e scopi,
come strutture, installazioni, forniture e attrezzature.
SISTEMA STRUTTURALE
[6]
Le attrezzature e le funzioni mediche devono essere spazialmente distribuite: la Degenza è
quasi interamente adibita alla funzione di “hotel”, mentre tutti i servizi medici essenziali
sono concentrati nella Piastra.
GENERICA EROGAZIONE DI BASE
[6]
GAS MEDICO
[6]
Sistema strutturale
Piastra
Degenze
Torre scala
Distribuzione
Generica Erogazione
di Base
Produzione
Normale
Emergenza
Attrezzature
Gas Medico
( fornitura fissa )
Ossigeno
Bottiglie
Bombole
Nitrogeno
Bombole
Linea di
fornitura
N.B.: Per evitare il danno sono
importanti ancoraggi adeguati e
unioni flessibili

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 16
ENERGIA ELETTRICA
[6]
SISTEMA DELL’ACQUA
[6]
SISTEMA ASCENSORE
[6]
Energia Elettrica
Collegamenti delle
linee di Trasmissione
MV = Medio voltaggio
LV = Basso voltaggio
UPS = Sistema di Energia Ininterrotto
EPG = Generatore di Energia di Emergenza
N.B.: Per evitare il danno sono importanti
ancoraggi adeguati e unioni flessibili
Generatore di
Energia
UPS
EPG
Energia Normale
dell’edificio
MV/LV
Trasformatori
Nodi delle linee di
Distribuzione
Rotaie Guida
Sistema Ascensore
Motore
Energia
Macchina
Contrappesi
Porte
N.B.: Il danno all’ascensore interessa le componenti
meccaniche e i loro supporti e ancoraggi sono i più
danneggiati durante un terremoto
Sistema dell’acqua
N.B.: Per evitare il danno sono
importanti ancoraggi adeguati e
unioni flessibili
Attrezzature
Energia
elettrica
Pompe
elettriche
Caldaie
Fornitura
dell’acqua
Acqua
della città
Serbatoio
Tubazioni

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 17
2.2 - RISPOSTA DEL SISTEMA OSPEDALIERO AD UN EVENTO SISMICO
I diversi fattori che influenzano la risposta di un ospedale ad un evento sismico possono
essere suddivisi in due gruppi conformemente ai loro effetti:
1. quelli che producono un aumento della domanda di cura;
2. quelli che producono una diminuzione delle risorse disponibili e quindi della capacità
di cura.
La situazione è così schematizzata [6]:
Una rappresentazione qualitativa dell’evoluzione temporale della domanda e della capacità
di cura in conseguenza ad un terremoto è fornita in figura 2.1, dove:
Figura 2.1 - La risposta medica di emergenza ad un evento pericoloso (terremoto) [6]
Influenza sul
sistema ospedaliero
Diminuzione
della capacità
Aumento
della domanda
Aumento
della domanda Diminuzione
della capacità
Diminuzione
della capacità
Aumento
della domanda
Diminuzione
della capacità
Conseguenze sul
sistema ospedaliero
Limitazione o scarsità di
provviste
( componente materiale )
Aumento di pazienti
( componente organizzativa,
umana e materiale )
Aumento di pazienti
Diminuzione del personale medico
( componente organizzativa, umana e
materiale )
Inefficienza dei servizi medici
( componente materiale )
Necessità di evacuazione
( componente organizzativa )
insufficienze
della rete
perdite
perdite
insufficienza di
apparecchiatura
insufficienza
di strutture
Disastro
esterno
Disastro
interno
Sisma
Danno strutturale
e non strutturale
Linee vita
Strutture
Ospedale
Ambiente

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 18
Per garantire una risposta sicura, efficace e competente:
NO
SI
l’organizzazione deve pre-definire le procedure in grado di ottimizzare le risorse
(umane e materiali) disponibili;
gli operatori devono essere addestrati a prestare servizi di cura nelle situazioni
emergenziali;
gli edifici devono garantire, oltre alla sicurezza fisica dei pazienti e degli operatori,
anche la funzionalità di tutti i principali servizi necessari per l’erogazione delle cure
(acqua, energia, etc.). [6]
START
C’è interazione tra
l’organizzazione,
gli operatori e gli
edifici?
risposta NON
sicura, efficace e
competente
risposta sicura,
efficace e
competente
END

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 19
2.3 - ADEGUAMENTO
2.3.1 - Strategia di adeguamento
Approccio Tempo di
inagibilità
Tempo di
realizzazione
Costo Risultato
Demolizione e
costruzione
nuova struttura
Limitato se la
costruzione
è altrove, alto
se la
costruzione
coincide con la
precedente
Alto Alto Struttura pienamente rispondente alle
nuove normative sia strutturali
(sisma) che impiantistiche e
funzionali
Adeguamento
con un
singolo
intervento
Medio-alto Medio Medio Struttura migliorata, ma non
pienamente rispondente alle nuove
normative
Adeguamento
per passi
Molto limitato Alto Limitato Struttura migliorata, ma non
pienamente rispondente alle nuove
normative Tabella 2.1 - Strategia di adeguamento [2]
Le Norme Sismiche del 1996 (D.M. 16/01/1996) distinguevano tra due tipi di interventi:
1. adeguamento, definito come la messa a norma dell’edificio;
2. miglioramento, che realizza un incremento della capacità resistente dell’opera ma
non in misura tale da rendere la stessa in grado di soddisfare gli standard vigenti.
2.3.2 - Processo di adeguamento
la pianificazione ha un duplice scopo:
SI 1) minimizzare le interferenze tra attività;
2) coinvolgere tutti i soggetti.
START
Verifica di sicurezza dell’esistente
Il progetto dell’intervento di adeguamento
La pianificazione e gestione del processo
Pianificazione e gestione
corrette?
END
NO

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 20
2.3.3 – Confronto tra strategie alternative di adeguamento
Criterio Indicatore Recupero Recupero
Incrementale
Riedificazione Costruzione
ex novo Tecnico Prestazione
SLO
Tr=?? Tr=?? Tr=475anni Tr=475anni
Sanitario Disagi Elevati Medi ?? Nulli
Posti letto
indisponibili
?? Limitati Tutti Nessuno
Economico Costi
complessivi
Elevati Modesti 300000/PL +
costi indiretti +
demolizione
300000/PL +
eventuali
proventi per la
cessione delle
aree
sociale Qualità
servizi/standard
sanitari
invariata Invariata Stato dell’arte Stato dell’arte
Tabella 2.2 - Confronto strategie di adeguamento [2]
Criterio Tecnico: Livello di prestazione
Indicatore: periodo medio di ritorno dell’azione sismica che soddisfa lo stato limite di
operatività, SLO
Criteri Sanitario: Interruzione del Servizio Sanitario
Indicatore: Aree non disponibili, misurate su base annua in percentuale rispetto ai mq totali.
Indicatore: Posti-letto persi, misurati su base annua in percentuale rispetto ai posti-letto
totali dell’ospedale.
Criterio Economico: Costi complessivi
Indicatore: costi complessivi dell’intervento, diretti + indiretti.
Per costi diretti si intende la somma necessaria per l’esecuzione del progetto di
adeguamento.
I costi indiretti sono quelli che derivano dalla mancata erogazione del servizi medici.
Criterio Sociale: Qualità del servizio
Indicatore: qualità dei servizi e standard sanitari

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 21
2.3.4 - Scelta tra strategie alternative di adeguamento
Criterio
Tecnico
NO
Criterio
Economico/
SI Sanitario NO
Criterio
Economico/ SI
Sanitario
NO
Criterio
Sociale SI
NO
SI
START
Definizione degli obiettivi di sicurezza
Criteri di valutazione (INDICATORI)
Prestazione per lo SLO
della struttura post-
adeguamento > del
valore di riferimento?
Riedificazione / Costruzione ex novo
Recupero
Posso sostenere
elevati disagi ed
elevati costi?
Approccio
incrementale
Intervento
unico
Minor costo e
nessun disagio? Riedificazione
Costruzione
ex novo
Qualità dei
servizi e
standard sanitari
sufficienti?
END

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 22
2.4 - VULNERABILITA’ DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
2.4.1 - Cause di vulnerabilità in ospedale
Gli ospedali sono altamente vulnerabili per le seguenti caratteristiche [7]:
Complessità: un ospedale è un servizio molto complesso il quale, deve provvedere
alle cure sanitarie, deve anche funzionare come un hotel, un ufficio, un laboratorio e
un magazzino.
Occupazione: gli ospedali hanno un alto livello di occupazione, con pazienti, staff
medico e di supporto, e visitatori presenti 24 ore al giorno.
Forniture critiche: la maggioranza delle forniture richieste dagli ospedali (medicine,
stecche, bendaggi, etc.) sono essenziali alla sopravvivenza dei pazienti e cruciali per
la cura delle vittime del disastro.
Attrezzature di base: nessun servizio dipende dai servizi pubblici o di soccorso alla
vita più di un ospedale, il quale non può funzionare senza energia, acqua, gas clinici,
ossigeno, combustibile e comunicazioni.
Materiali pericolosi: molti prodotti che si trovano in un ospedale sono pericolosi se
versati o persi.
Oggetti pesanti: durante un disastro le attrezzature potrebbero cadere causando serie
ferite o ostruendo i percorsi di evacuazione.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 23
2.4.2 - Valutazione della vulnerabilità strutturale
Una struttura serve da scheletro in modo analogo al ruolo delle ossa del corpo umano. La
procedura di analisi della valutazione qualitativa sulla vulnerabilità sismica comprende:
1. Identificazione delle caratteristiche strutturali;
2. Analisi delle loro interrelazioni in riguardo alla azione del terremoto;
3. Determinazione della fragilità.
[8]
START
Identificazione della tipologia strutturale
Scelta di una appropriata funzione di fragilità
Identificazione dei fattori di vulnerabilità
Controllo delle condizioni di stress delle componenti
critiche tramite calcoli matematici
Stima dell’influenza dei fattori di vulnerabilità sulla
prestazione sismica degli edifici
Interpretazione della fragilità strutturale basata sui
fattori di vulnerabilità identificati
Fare una relazione di sicurezza strutturale riguardante i
fattori dell’edificio
Identificazione delle opzioni di intervento strutturale
END

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 24
1. Identificazione della tipologia strutturale
I parametri base della categorizzazione strutturale sono il sistema resistente alla forza
laterale, i materiali usati, l’altezza dell’edificio e il diaframma di piano.
2. Scelta di una appropriata funzione di fragilità
La funzione fragilità, la quale descrive il livello di danno su un particolare tipo di
costruzione sotto differenti livelli di intensità di terremoto, deve essere scelta in base
all’edificio ospedaliero in questione.
3. Identificazione dei fattori di vulnerabilità
La conoscenza di pericoli geologici del sito specifico, forme strutturali, sistema
resistente alla forza laterale, connessioni degli elementi, diaframmi e pericoli non
strutturali è richiesta per il giudizio e l’analisi.
4. Controllo delle condizioni di stress delle componenti critiche tramite calcoli
matematici
Queste verifiche sono generalmente ideate per il controllo delle condizioni di stress
degli elementi critici, condizioni che possono facilmente accadere a causa di speciali
configurazioni e costruzione dell’edificio.
5. Stima dell’influenza dei fattori di vulnerabilità sulla prestazione sismica degli
edifici
I possibili effetti dei fattori di vulnerabilità sul target strutturale dovrebbero essere
identificati sulla relativa scala (la scala è in termini di incremento di vulnerabilità e
definita come alto, medio, basso, non applicabile e sconosciuto).
6. Interpretazione della fragilità strutturale basata sui fattori di vulnerabilità
identificati
La funzione fragilità descritta precedentemente per una particolare tipologia
strutturale dovrebbe essere ulteriormente raffinata basandoci sulle informazioni
descritte al punto precedente. I miglioramenti saranno in termini di debole, medio e
buono.
7. Fare una relazione di sicurezza strutturale riguardante i fattori dell’edificio
Il danno atteso sull’edificio alle differenti intensità dovrebbe essere giudicato usando
la matrice del grado di danno. La matrice ottiene dichiarazioni sulla prestazione
sismica dell’edificio basata sulla tipologia e specifica rifinitura della vulnerabilità
strutturale come debole, medio e buono. Le valutazioni si riferiscono alla prestazione
degli edifici in termini del grado di danno atteso per i differenti livelli di intensità del
terremoto misurati nella scala di Intensità Mercalli Modificata (MMI)
8. Identificazione delle opzioni di intervento strutturale
Non è possibile progettare la ristrutturazione con i livelli di valutazione descritti
sopra. Comunque opzioni di intervento per la debolezza degli edifici possono essere
identificati basandoci sulla valutazione di prestazione, costruzioni con deficienze
gravi e con materiali da costruzione deboli e deteriorati potrebbero necessitare la
ricostruzione.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 25
2.4.3 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale
2.4.3.1 - Elementi non strutturali
Gli elementi non-strutturali sono di primaria importanza per gli ospedali in quanto:
a) il fuori servizio degli arredi, degli impianti e delle apparecchiature pregiudica la
operatività delle funzioni ospedaliere dopo il sisma;
Figura 2.2 - Domanda dei servizi medici dopo il terremoto [8]
b) l’incolumità dei pazienti, del personale può essere messa a repentaglio per un
danneggiamento elevato;
c) rappresentano più dell’ottanta per cento del valore economico dell’intero ospedale;
Figura 2.3 - Tipici investimenti nella realizzazione di un edificio [3]
Tutti gli elementi che non hanno una
funzione strutturale
Elementi
architettonici
Impianti Contenuto
degli edifici
Sistemi di
collegamento

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 26
d) le esperienze passate hanno dimostrato l’elevata vulnerabilità anche per eventi
sismici di media-bassa intensità.
Livelli di prestazione
I livelli di prestazione da considerare per gli elementi non strutturali sono due:
a) la operatività, O, che si ottiene per una prestazione di livello N-A da perseguire per
le componenti essenziali per la funzionalità;
b) l’occupabilità immediata, OI, che si ottiene per una prestazione di livello N-B da
perseguire per gli altri elementi.
Selezione degli elementi più importanti
Dato l’elevato numero di elementi non-strutturali presenti in un ospedale, è necessario
operare una selezione degli elementi più importanti in base a:
caratteristiche di vulnerabilità;
importanza per la funzionalità dei servizi ospedalieri in situazioni di emergenza;
valore economico del componente;
pericolosità associata al danneggiamento.
Parametri di risposta
Il danneggiamento dei componenti non-strutturali in caso di evento sismico è
principalmente funzione di tre quantità di risposta:
a) la deformazione delle strutture (drift) tra i vari livelli di un edificio;
b) l’accelerazione di piano;
c) lo spostamento differenziale tra parti strutturali separate da un giunto.
Verifica dei livelli di prestazione
Il livello di codifica per la valutazione delle componenti non-strutturali è ancora
insoddisfacente, le ragioni sono molteplici:
recente interesse per livelli di performance differenti dalla sicurezza per la vita;
la grande varietà di elementi e di tipologie costruttive rende difficile la definizione di
standard applicabili a tutte le situazioni.
Per queste ragioni si deve adottare una metodologia di verifica diversa da quella
convenzionalmente utilizzata per gli elementi strutturali.
La fase verifica deve essere, in questo caso, composta di due parti:
1) esame in loco delle reali condizioni degli elementi non-strutturali (caratteristiche
costruttive e di installazione) ed eventuale adeguamento in assenza degli
accorgimenti necessari a garantirne l’operatività / la funzionalità in caso di evento
sismico;
2) verifica “convenzionale” che la domanda, misurata attraverso le quantità di risposta
indicate in precedenza, non superi una soglia massima (capacità) oltre la quale non è
più possibile garantirne l’integrità e / o il corretto funzionamento.
La definizione delle soglie limite: in letteratura sono disponibili un certo numero di studi
che mettono appunto in relazione il danneggiamento dei componenti non-strutturali con lo
stato di deformazione della struttura.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 27
2.4.3.2 - Valutazione della vulnerabilità non strutturale
[8]
START
La valutazione
qualitativa strutturale
dell’ospedale è stata
già svolta
Esecuzione della valutazione
strutturale
Identificazione dei sistemi critici e
delle attrezzature mediche
Valutazione delle componenti
individuali
Valutazione della vulnerabilità dei
sistemi
Valutazione delle prestazioni non
strutturali
END
NO
SI (1.)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 28
( 1. )
[8]
Contributo delle componenti ospedaliere alla
funzionalità dell’ospedale dopo un terremoto
Componenti
strutturali
Componenti
Non-strutturali
Piano di
emergenza
Attrezzature della
linea della vita
Attrezzature
mediche
Elementi
architettonici
Sistema di uscita di emergenza
Sistema anti-incendio
Sistema elettrico
Sistema supplementare dell’acqua
Sistema supplementare del gas medico
Sistema di comunicazione
Sistemi critici

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 29
2.4.3.3 - Rapida visuale delle referenze selezionate
Ciascuna referenza fornisce il grado di rischio di tipi differenti di componenti in relazione:
1. al sito del terremoto;
2. alla posizione nell’edificio;
3. ai differenti fattori di vulnerabilità.
Il rischio è classificato come Basso, Moderato, Alto e Molto Alto dove Basso significa che
l’attrezzatura è salva e Molto Alto che essa è altamente vulnerabile e necessita di un
miglioramento appropriato a raggiungere i livelli di sicurezza.
Lista delle referenze selezionate:
1. Trasformatori
2. Pannelli di controllo per generatori
3. Scatole e pannelli di distribuzione
4. Batterie e scaffali
5. Generatori
6. Apparecchiatura di controllo delle comunicazioni
7. Laboratorio medico e attrezzature di unità medica
8. Refrigeratori per la banca del sangue
9. Pompe
10. Compressori e aspiratori
11. Serbatoi su gambe
12. Serbatoi orizzontali
13. Serbatoi verticali ancorati
14. Attrezzatura antincendio

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 30
Trasformatori
Figura 2.4a [8] Figura 2.4b [8]
Descrizione Terremoto
Moderato
Terremoto
Severo
Posizione
nell’edificio
Posizione
nell’edificio
Terzo alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Terzo alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Rischio base Basso Moderato Moderato Moderato Moderato Alto
1 Assenza di
ancoraggio
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
2 Ancoraggio
“povero”
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
3 Riguarda
martellamento /
impatto
Moderato Moderato Alto Moderato Alto Alto
4 Percorso di
carico scadente
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
5 Riguarda
l’interazione
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
6 Bobine non
trattenute
saldamente
Alto Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
7 Altro ……
Tabella 2.3 – Grado di rischio [8]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 31
Generatori
Figura 2.5a [8] Figura 2.5b [8]
Descrizione Terremoto
Moderato
Terremoto
Severo
Posizione
nell’edificio
Posizione
nell’edificio
Terzo alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Terzo
alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Rischio base Basso Basso Moderato Basso Moderato Moderato
1 Assenza di
ancoraggio
Alto Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
2 Ancoraggio
“povero”
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
3 Riguarda la
vibrazione
dell’isolatore
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
4 Riguarda
l’unione rigida
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
5 Spostamento diff.
Elemento motore /
Generatore
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
6 Riguarda
l’interazione
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
7 Altro ……
Tabella 2.4 - Grado di rischio [8]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 32
Serbatoi in piedi
Figura 2.6a [8] Figura 2.6b [8]
Descrizione Terremoto
Moderato
Terremoto
Severo
Posizione
nell’edificio
Posizione
nell’edificio
Terzo alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Terzo alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Rischio base Moderato Moderato Alto Moderato Alto Alto
1 Il serbatoio non è
ancorato o l’ancoraggio è
scarso
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
2 Se ancorato ad una slitta e
questa non è ancorata
Moderato Alto Alto Alto Alto Molto
Alto
3 Tubazione attaccata è
troppo rigida per resistere
allo spostamento atteso
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
4 Le gambe sembrano
essere piccole per il peso
del serbatoio, o la slitta ha
aperture non rinforzate
Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
5 Altro ……
Tabella 2.5 - Grado di rischio [8]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 33
Attrezzatura antincendio
Figura 2.7 [8]
Descrizione Terremoto
Moderato
Terremoto
Severo
Posizione
nell’edificio
Posizione
nell’edificio
Terzo
alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Terzo
alla
Base
Terzo
medio
Terzo
superiore
Rischio base Basso Basso Basso Basso Basso Basso
1 Non c’è regolare ispezione
dei dispositivi per assicurare
la propria funzione
Molto
Alto
Molto
Alto
Molto
Alto
Molto
Alto
Molto
Alto
Molto
Alto
2 Unità non accessibili Alto Alto Molto
Alto
Alto Molto
Alto
Molto
Alto
3 Altro ……
Tabella 2.6 - Grado di rischio [8]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 34
2.4.3.4 - Riduzione della vulnerabilità non strutturale
Rimozione [7]: in molti casi è probabilmente il migliore intervento.
Figura 2.8a [8] Figura 2.8b [8]
Figura 2.8a : Questi pacchi di documenti riposti sopra le librerie e gli armadi sono un
pericolo per la salvaguardia della vita.
Figura 2.8b : I pericoli per la salvaguardia della vita possono essere ridotti mediante la
rimozione delle cose meno importanti dal posto di lavoro.
Ricollocazione [7]: in molti casi riduce il pericolo.
Figura 2.9a [8] Figura 2.9b [8]
Figura 2.9a : Il frigorifero posto vicino una porta di uscita è un pericolo per la salvaguardia
della vita.
Figura 2.9b : Questi armadi possono ostruire il corridoio e proporre un pericolo per la
salvaguardia della vita.
Mobilità ristretta per certi oggetti [7]: è una buona misura. Qualche volta i
generatori sono montati su molle per ridurre il rumore e le vibrazioni quando essi
sono in funzione, ma queste molle potrebbero amplificare notevolmente il moto.
Quindi supporti di ritenuta o catene dovrebbero essere posizionati intorno alle molle
per impedire lo spostamento o la caduta fuori dal supporto del generatore stesso.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 35
Figura 2.10a [8] Figura 2.10b [8]
Figura 2.10a : Un generatore su rotelle può scivolare e capovolgersi durante un terremoto
causando una perdita funzionale.
Figura 2.10b : Generatori e altre attrezzature vibranti possono essere fissate da speciali
supporti, i quali permettono alcuni movimenti ma prevengono loro dal capovolgimento.
Ancoraggio [7]: è la precauzione più largamente usata.
Figura 2.11a [8] Figura 2.11b [8]
Figura 2.11a : Macchina autoclave senza ancoraggio.
Figura 2.11b : Questa macchina può essere fissata al pavimento tramite il getto di una base
di cemento.
Figura 2.12a [8] Figura 2.12b [8]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 36
Figura 2.12a : Serbatoio per i trattamenti dell’acqua, il quale ha una predisposizione per il
bullonaggio alla base, ma non è bullonato.
Figura 2.12b : Il bullonaggio alla base può prevenire il ribaltamento degli oggetti pesanti
durante un terremoto.
Figura 2.13a [8] Figura 2.13b [8]
Figura 2.13a : Oggetti alti e stretti come frigoriferi possono facilmente capovolgersi durante
i terremoti.
Figura 2.13b : Tali oggetti possono essere protetti dal capovolgimento tramite bullonaggio
alla parete.
Agganciamento [7]: in molti ospedali, molta dell’attrezzatura come i monitor, le
unità di aspirazione, i ventilatori, gli incubatori, l’attrezzatura di rianimazione, etc. è
tenuta su rotelle o su carrelli con rotelle, e i sistemi a rotella sono necessari per una
migliore mobilità. Questa attrezzatura su rotelle però può scivolare o impattare con
persone, pareti, letti o altre cose causando danno. Lo sviluppo di un proprio sistema
di agganciamento usando catene e ganci può proteggere questa attrezzatura e può
diminuire il pericolo di impatto durante l’uso e il deposito.
Figura 2.14a [8] Figura 2.14b [8]
Figura 2.14a : ECG schermi su rotelle con rischio potenziale di scivolamento e
capovolgimento.
Figura 2.14b : Provvista di catene sulla parete per agganciare tali macchine.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 37
Figura 2.15a [8] Figura 2.15b [8]
Figura 2.15a : Raggi X mobile su rotelle.
Figura 2.15b : Agganciamento dei raggi X mobile alla parete.
Figura 2.16a [8] Figura 2.16b [8]
Figura 2.16a : Attrezzatura di rianimazione su carrelli con rotelle.
Figura 2.16b : Agganciamento del carrello e chiusura per mezzo di cinghie.
Figura 2.17a [8] Figura 2.17b [8]
Figura 2.17a : Bombole di ossigeno non agganciate potrebbero cadere sopra.
Figura 2.17b : Agganciando il cilindro con una catena lo posso salvare dalla caduta.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 38
Chiusura per mezzo di cinghie [7]: in molti ospedali, le forniture e i contenuti dei
laboratori, le scorte mediche e quelle generiche sono tenute in condizioni non sicure
su scaffali e negli armadi e potrebbero cadere giù rompendosi durante un terremoto.
Non è difficile mitigare questo rischio:
Figura 2.18a [8] Figura 2.18b [8]
Figura 2.18a : Bottiglie chimiche e medicinali sui scaffali costituiscono un rischio di caduta.
Figura 2.18b : Chiusura dei scaffali per mezzo di cinghie di nylon dopo l’ancoraggio
dell’armadio alla parete è un modo facile di rendere quelle bottiglie sicure.
Unioni flessibili [7]: sono usati perché ciascun oggetto separato si muove
indipendentemente dall’altro in risposta ad un terremoto.
Figura 2.19a [8] Figura 2.19b [8]
Figura 2.19a : Tubi rigidi connessi con un serbatoio di acqua pesante possono rompersi
durante un terremoto.
Figura 2.19b : Tubazione flessibile su attrezzatura pesante protegge essa dalla rottura
durante un terremoto.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 39
I supporti [7]: sono adatti in molti casi, per esempio nel caso dei soffitti appesi.
Figura 2.20a [8] Figura 2.20b [8]
Figura 2.20a : Questo tipo di ventola necessita di un supporto extra.
Figura 2.20b : Supporto extra alla ventola.
Sostituzione [7]: di qualcosa che non rappresenta un pericolo simico è appropriato in
alcune situazioni, per esempio nel caso di un pesante tetto tegolato.
Alterazione [7]: è una soluzione possibile per un oggetto che rappresenta un pericolo
sismico. Per es. rotoli di plastica adesiva trasparente possono essere usati per coprire
le superfici interne del vetro delle finestre in modo da prevenire che questi si
frantumino diventando una minaccia interna.
Figura 2.21a [8] Figura 2.21b [8]
Figura 2.21a : Questa finestra di vetro può causare un pericolo per la salvaguardia della vita.
Figura 2.21b : La semplice laminazione della plastica può proteggere le vite.
Isolamento [7]: è utile per piccoli e slegati oggetti.
Rinforzo [7]: è fattibile in molti casi. Per esempio, una parete o un camino possono
essere rinforzati, senza una grande spesa, coprendo la superficie con una rete
metallica e cemento.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 40
Ridondanza [7]: è consigliabile. Piani di risposta di emergenza, che richiedono
provviste aggiuntive per raggiungere un certo livello di indipendenza dagli
approvvigionamenti esterni i quali potrebbero essere interrotti in caso di terremoto.
Rapida risposta e riparazione [7]: certe volte non è possibile fare qualcosa per
prevenire la rottura di una tubazione in un dato posto, quindi le parti di ricambio sono
accumulate e i dispositivi sono costruiti per entrare velocemente nell’area in caso che
un tubo si rompa durante un terremoto.
Incremento della sicurezza delle sale operatorie [7]: la maggior parte
dell’attrezzatura nelle sale operatorie è mantenuta su rotelle o su carrelli su rotelle
senza nessun fissaggio e può quindi essere altamente vulnerabile.
Figura 2.22a [8] Figura 2.22b [8]
Figura 2.22a : La maggior parte dell’attrezzatura nelle sale operatorie è su carrelli con
rotelle. Il rischio di caduta è alto.
Figura 2.22b : Legando tutta l’attrezzatura ad una trave di acciaio può migliorare la
situazione.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 2 41
2.5 - BIBLIOGRAFIA
[2] Lupoi G., Lupoi A., Pinto P.E., Ansovini P. (2008), “Documento di Supporto alle
Autorità Regionali per la redazione di Linee Guida”,11 Marzo 2008.
[3] Bontempi F. (2010), “Progetto e analisi di ospedali come costruzioni strategiche: visione
di sistema, norme tecniche, azione sismica, robustezza strutturale”, 7° Congresso Nazionale
per Operatori degli Uffici Tecnici, Rieti, 24-25-26 Giugno 2010.
[6] Lupoi G., Franchin P., Lupoi A., Pinto P.E., Calvi G.M. (2008), “Probabilistic Seismic
Assessment for Hospitals and Complex-Social Systems”, IUSS Press, Pavia, Gennaio 2008.
[7] Pan American Health Organization (2000), “Principles of Disaster Mitigation in Health
Facilities”, Washington D.C. (USA), 2000.
[8] Guragain R., Pandey B.H., Shrestha S.N. (2004), “Guidelines for Seismic Vulnerability
Assessment of Hospitals”, National Society for Earthquake Technology-Nepal, Kathmandu,
April 2004.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 42
3 - COMPORTAMENTO NON LINEARE
DEI TELAI IN ACCIAIO
3.1 - INTRODUZIONE
La progettazione di edifici è generalmente svolta utilizzando codici di calcolo ad hoc per
l’analisi strutturale, nei quali sono state implementate le teorie strutturali (travi, lastre e
gusci). Tali teorie nascono dall’esigenza di ottenere, per mezzi continui dotati di particolare
struttura, soluzioni più agevoli rispetto a quelle offerte dalla meccanica del continuo,
utilizzando ipotesi semplificative senza compromettere la correttezza della formulazione.
In particolare gli elementi generalmente utilizzati per modellare edifici con struttura a telaio
(costituiti da travi e colonne o da elementi riconducibili a questi) soddisfano le ipotesi della
teoria delle travi: generati da una superficie piana (sezione trasversale) che trasla
mantenendosi ortogonale alla traiettoria descritta dal suo baricentro (asse geometrico), in
modo tale che sviluppo e raggi di curvatura dell’asse geometrico risultino grandi rispetto a
qualunque dimensione lineare della sezione trasversale (elementi snelli), essi si deformano
mantenendo piane le sezioni rette e possono quindi essere rappresentati dal solo asse
geometrico. I codici di calcolo descrivono quindi le strutture a telaio tramite elementi mono-
dimensionali.
E’ importante comunque ricordare che per quegli elementi strutturali per i quali non vale
l’ipotesi di snellezza (le dimensioni della sezione sono comparabili con quelle della
lunghezza) e quindi di indeformabilità della sezione, è necessario fare ricorso ad altri
modelli: ad esempio per pareti e trave spesse si possono utilizzare elementi bidimensionali
che si rifanno alla teoria delle lastre, per blocchi di muratura si possono utilizzare elementi
tridimensionali propri della meccanica del continuo.
Sebbene la teoria elastica lineare sia una formulazione efficiente del problema strutturale, le
stesse ipotesi su cui essa si basa la rendono del tutto inadatta a cogliere il reale
comportamento di una struttura, all’insorgere di una qualunque non linearità.
La caratteristica fondamentale dell’analisi non lineare risiede nell’impossibilità di garantire,
da parte della teoria stessa, l’esistenza di una soluzione e quand’anche essa vi sia, la sua
unicità. Risulta inoltre non più applicabile il principio di sovrapposizione degli effetti,
basato sull’indipendenza della risposta del sistema dalla storia di carico, inoltre in generale
il sistema non è più conservativo e quindi non può più essere definita una energia potenziale
totale.
Vi sono casi in cui gli aspetti non lineari sono particolarmente rilevanti e quindi è
consigliabile, e talvolta necessario, far ricorso all’analisi non lineare, ad esempio:
valutazione della capacità portante di strutture esistenti danneggiate;
autotensioni dovute a variazioni termiche;
analisi di strutture snelle;
analisi sismica;
casi in cui si hanno forti ridistribuzioni di momento in fase fessurata;
strutture molto deformabili in esercizio.
In generale si possono individuare due fonti di non linearità:
1) non linearità geometrica: il materiale continua ad avere un comportamento elastico
lineare, ma sono inclusi gli effetti di deformazioni e spostamenti finiti nella

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 43
formulazione delle equazioni di equilibrio, che saranno formulate nella configurazione
deformata della struttura;
2) non linearità di materiale: è dovuta al fatto che il materiale, di cui è composta la
struttura, risponde in modo differente al crescere dei carichi, ovvero lo stesso materiale
cambia caratteristiche alla progressiva deformazione che esso subisce. In particolare la
legge del legame costitutivo di materiale può essere olonoma, ossia identica in fase di
carico e scarico, o anolonoma, ossia avente andamenti diversi nei vari cicli di carico e di
scarico e quindi dipendente dall’effettiva storia deformativa;
In tali casi la soluzione del problema può anche non esistere, od esistere ma non essere
unica. Come detto, non vale più il principio di sovrapposizione degli effetti ed in generale il
sistema non è più conservativo e quindi non può più essere definita un’energia potenziale
totale.
Figura 3.1 - Mancata validità del principio di sovrapposizione degli effetti in campo non lineare [9]
3.2 - LE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE Nella modellazione di strutture che subiscono elevati spostamenti e deformazioni, è
necessario tenere in conto la non linearità geometrica della risposta strutturale che causa una
variazione degli spostamenti non proporzionale ai carichi. Infatti, quando un corpo elastico
si deforma in modo significativo non è più valida l’ipotesi della teoria dell’elasticità lineare
secondo la quale è possibile, in un processo deformativo, confondere configurazione iniziale
e finale. Poter confondere la configurazione iniziale con quella finale implica, in termini di
modellazione, di poter utilizzare un sistema di riferimento che rimane invariato durante
l’analisi e, in termini di soluzione, una linearità tra causa ed effetti.
In questo paragrafo viene indagata la non linearità geometrica nei confronti prima degli
effetti sul singolo elemento (Effetto P-), poi sull’intera struttura (Effetto P-).
Le travi e le colonne di un telaio sono elementi strutturali soggetti all’azione combinata
della sollecitazioni assiale e flettente, che interagiscono tra di loro per effetto degli
spostamenti che si verificano nella struttura.
Il momento flettente in un elemento trave-colonna di una struttura è composto da due
contributi:
1. momento flettente del I° ordine che è generato dai carichi trasversali agenti
sull’elemento e dalle coppie distribuite lungo la trave o concentrate agli estremi

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 44
2. momento flettente del II° ordine causato dall’interazione fra la forza assiale agente
nell’elemento e la configurazione trasversale deformata dell’elemento stesso, a sua
volta il momento flettente del II° ordine può essere di due diverse tipologie :
a. momento dovuto all’effetto P-, causato dall’interazione dell’azione assiale
agente nell’elemento e lo spostamento dell’elemento relativo alla sua corda;
b. momento dovuto all’effetto P-, causato dall’interazione dell’azione assiale
con lo spostamento relativo fra i due estremi dell’elemento.
I momenti del II° ordine sono dannosi perché diminuiscono la resistenza ultima degli
elementi snelli compressi e quindi vanno considerati nella modellazione strutturale degli
elementi compressi.
3.2.1 - L’effetto PΔ
Per comprendere in che modo la presenza di grandi spostamenti/rotazioni nella risposta
della struttura elastica renda non soddisfatte le ipotesi della teoria della elasticità lineare, si
consideri una mensola caricata con una forza inizialmente in direzione ortogonale all’asse.
Figura 3.2 - Mensola soggetta a carico ortogonale e non linearità della risposta per effetto dei grandi
spostamenti/rotazioni indotti [10]
Supporre che, per tutta la storia deformativa dell’elemento, configurazione iniziale e finale
coincidano, corrisponde a considerare il sistema di riferimento della mensola fisso e, quindi,
il carico sempre ortogonale all’asse della trave: il taglio crescerà linearmente con lo
spostamento verticale dell’estremo libero.
Se invece, come è anche intuibile fisicamente, si considera che, man mano che il carico
cresce, l’elemento cambia configurazione rispetto a quella iniziale, assunto solidale con il
corpo un sistema di riferimento locale, quest’ultimo risulterà ruotato rispetto alla direzione
del carico agente in modo tale che:
a) la componente del carico ortogonale all’asse non crescerà più linearmente con lo
spostamento;
b) anche il momento di conseguenza crescerà non linearmente in quanto una quota del
carico diventerà azione assiale.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 45
Nell’analisi di un telaio piano in condizioni di non linearità geometrica, si utilizza uno
schema di calcolo in cui si considerano gli effetti dovuti agli spostamenti dei punti di
applicazione dei carichi. Il fenomeno per cui le forze verticali P interagiscono con gli
spostamenti laterali prodotti dal sistema di forze H è denominato effetto P- e nell’analisi
non lineare dei telai è fondamentale in quanto considera il fatto che ciascun elemento è parte
integrante e interagente con il sistema strutturale. Ciò può essere spiegato facendo
riferimento al caso del telaio di fig. 3.3 in cui i carichi verticali sono applicati direttamente
sui nodi trave-pilastro e sul quale sono presenti anche carichi orizzontali. Questi ultimi
provocano, sulle aste verticali, spostamenti tali da far sì che i carichi verticali generino un
momento ai piedi delle stesse. L’effetto della non linearità viene computato considerando
tale momento aggiunto a quello dovuto ai carichi orizzontali. Questa nuova configurazione
di carico genererà un nuovo campo di spostamenti orizzontali che varierà l’entità dei
momenti del secondo ordine dovuti ai carichi verticali.
Figura 3.3 - Configurazione deformata relativa all’effetto P-Δ [11]
Quando le forze laterali H agiscono sul telaio, questo si sposta lateralmente fino a che una
configurazione di equilibrio non è raggiunta. Il corrispondente spostamento laterale I può
essere calcolato sulla base della configurazione originale del telaio. Se ai carichi orizzontali
Hi si aggiungono i carichi verticali Pi, l’interazione con gli spostamenti laterali I provoca
un ulteriore spostamento II che sommandosi al precedente definisce lo spostamento totale
=I +II.
Attraverso un continuo aggiornamento dei momenti fittizi e degli spostamenti generati, si
può trovare, qualora esista, la configurazione di equilibrio stabile, cioè quella in cui il
campo di spostamenti raggiunge la convergenza.
3.2.2 - L’effetto P
Per comprendere in che modo la presenza di effetti del secondo ordine nella risposta di una
struttura elastica renda non soddisfatte le ipotesi della teoria dell’elasticità lineare, si
consideri un elemento verticale soggetto ad un carico verticale V e ad un carico orizzontale
H tale da imporre uno spostamento δ.
H H
P P I I + II

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 46
Figura 3.4 - Effetti del secondo ordine [10]
Supporre che configurazione indeformata e deformata coincidano, corrisponde a considerare
il sistema di riferimento dell’elemento fisso e, quindi, il carico verticale sempre parallelo
all’asse della colonna: la struttura sarà soggetta ad una azione assiale pari a V e ad un
momento flettente alla base pari ad Hxh.
Se invece si considera che, a causa dello spostamento δ, l’elemento ha cambiato
configurazione rispetto a quella iniziale inflettendosi, assunto solidale con il corpo un
sistema di riferimento locale, quest’ultimo carico risulterà ruotato rispetto alla direzione dei
carichi agenti in modo che il carico V contribuirà anche al taglio ed incrementerà il
momento flettente di Vxδ.
3.2.3 - P-Δ ed effetti dei grandi spostamenti nel SAP 2000 [12]
3.2.3.1 - P-Δ vs. True Large Displacements
Nelle analisi ai piccoli spostamenti ci sono due ipotesi principali, come segue.
(1) Il rapporto geometrico tra spostamenti nodali e deformazioni di elemento è una
relazione lineare.
(2) Le equazioni di equilibrio si possono scrivere nella posizione indeformata della
struttura.
In realtà nessuna di queste ipotesi è corretta.
Matematicamente, la prima ipotesi è corretta solo quando gli spostamenti tendono a zero.
Come gli spostamenti dei nodi (o, più correttamente, le rotazioni degli elementi) aumentano,
il rapporto tra spostamenti nodali e deformazioni di elemento diventa progressivamente
sempre più non-lineare. La seconda ipotesi non è corretta per la semplice ragione che
l’equilibrio deve essere soddisfatto nella posizione deformata. Come le rotazioni
dell’elemento diventano progressivamente più grandi, questa ipotesi diventa sempre meno
corretta.
La vera analisi ai grandi spostamenti prende in considerazione entrambi i tipi di non
linearità. L’analisi P-Δ mantiene l’ipotesi (1), ma considera l’equilibrio nella posizione
deformata (in realtà non lo fa esattamente, ma questo non è un punto critico). La figura 3.5
illustra la differenza per una semplice barra.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 47
Figure 3.5 - Non linearità geometrica [12]
Supponiamo per questo esempio che l’estensione assiale della barra sia trascurabile (si
presuppone che EA è molto grande). Le tre parti della figura sono i seguenti.
(A) Teoria dei piccoli spostamenti. Questa teoria dice che:
(i) la parte superiore della barra si muove orizzontalmente (questa è geometria
dei piccoli spostamenti, che prevede anche che l’estensione della barra è
zero);
(ii) l’equilibrio può essere considerato in posizione indeformata. Quindi, la
forza H è zero per tutti i valori di Δ (prendiamo i momenti intorno alla
base del barra).
(B) Teoria P-Δ. Questa teoria dice che:
(i) la barra si muove orizzontalmente e l’estensione della barra è pari a zero
(geometria dei piccoli spostamenti);
(ii) l’equilibrio è considerato in posizione deformata. Quindi H = PΔ/h.
(C) Teoria dei grandi spostamenti. Questa teoria dice che:
(i) la parte superiore della barra si muove in un arco, quindi si muove
verticalmente e orizzontalmente, in modo che l’estensione della barra sia
infatti pari a zero;
(ii) l’equilibrio è considerato in posizione deformata. Quindi H = PΔ/hcosθ.
La differenza tra il valore di H ottenuto dalla teoria P-Δ e quello ottenuto dalla teoria dei
grandi spostamenti è piccola fino a rotazioni piuttosto grandi. Ad esempio per Δ/h = 0,05
(un drift di grandi dimensioni per la maggior parte delle strutture), la teoria P-Δ dà H =
0.05V e la teoria dei grandi spostamenti dà H = 0.05006V, che è una differenza trascurabile.
Inoltre, per Δ/h = 0,05 lo spostamento verticale nel caso (C) è 0.00125h. La teoria P-Δ
predice zero, che non è un errore significativo nella maggior parte dei casi. Quindi, per la
maggior parte delle strutture è sufficientemente accurato utilizzare la teoria P-Δ.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 48
Si consideri, tuttavia, la semplice struttura “barra” in Figura 3.6.
Figure 3.6 - Caso dove la Teoria P-Δ non è accurata [12]
Per questa struttura, la teoria dei piccoli spostamenti dice che la struttura dispone di
rigidezza pari a zero, poiché la teoria non prevede estensione delle barre con l’aumentare
della flessione, e quindi nessuna forza assiale. Quindi, forza V è zero per tutte le deviazioni.
Se la forza iniziale nelle barre è pari a zero, la teoria P-Δ dice anche che la forza V deve
essere zero, in quanto la teoria predice ancora nessuna estensione delle barre.
La teoria dei grandi spostamenti, tuttavia, prevede che le barre si estendano, e che ci sia una
forza V progressivamente crescente con l’aumentare della deflessione. Se la forza iniziale
nelle barre è P in tensione, la teoria P-Δ dice che questa forza rimane costante, e che esiste
una relazione lineare V = 2PΔ/L tra la forza verticale e lo spostamento verticale (applicare
l’equilibrio come nell’esempio precedente) . La rigidezza 2P/L è la rigidezza "geometrica" o
"stress iniziale" delle due barre. La teoria dei grandi spostamenti predice correttamente una
rigidezza in progressivo aumento, con una rigidezza iniziale pari a 2P/L.
Nella maggior parte delle strutture costruite sottoposte a carichi del tipo terremoto, il
comportamento è più strettamente analogo alla figura 3.5 rispetto alla figura 3.6. La teoria
P-Δ funziona bene in questo caso, e ha il vantaggio che è più semplice da applicare rispetto
alla teoria dei grandi spostamenti, e richiede meno calcoli. Il tipo di comportamento in
figura 3.6 (azione catenaria) si può verificare nei membri di piano nell’analisi di crollo
progressivo.
3.2.4 - Effetto P-δ nel SAP 2000
La figura 3.7 (a) mostra una colonna a sbalzo con carichi verticali e orizzontali.
Figure 3.7 - Gli effetti P-Δ and P-δ [12]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 49
Se la colonna rimane elastica, si deforma come mostrato. Quindi, considerando l’equilibrio
nella posizione deformata, il diagramma momento flettente è come mostrato nella figura 3.7
(b) (non proprio, se consideriamo i veri grandi spostamenti, ma ad un alto grado di
precisione).
Il diagramma momento flettente ha tre parti, come segue.
(1) Una parte dei piccoli spostamenti, con un momento alla base Hh. Questo è il
momento per la teoria dei piccoli spostamenti.
(2) Un parte P-Δ, con un momento alla base PΔ. Questo dipende dallo spostamento
laterale nella parte alta della colonna.
(3) Un parte P-δ. Questo dipende dalla curvatura della colonna all’interno della sua
lunghezza.
Computazionalmente, è facile tener conto della parte P-Δ del momento, poiché dipende solo
dalla rotazione complessiva della colonna. È più difficile spiegare la parte P-δ, dato che
dipende dalla deformazione di curvatura della colonna (che a sua volta dipende dai momenti
e dal fatto che la colonna si snerva o rimane elastica).
E’ possibile tener conto dell’effetto P-δ nelle analisi strutturali. Tuttavia, è importante fare
attenzione quando si considera questo effetto. Nella figura 3.7, la colonna è elastica. La
figura 3.8 mostra la stessa colonna, ma ora si snerva e si forma una cerniera plastica alla
base.
Figure 3.8 - Gli effetti P-δ quando si snerva la Colonna [12]
Come mostra la figura, per un dato Δ i momenti P-Δ sono gli stessi di prima, ma i momenti
P-δ ora sono molto più piccoli. La teoria P-δ deve tenere conto di questo. Se i momenti P-δ
sono calcolati in base alla deformazione elastica di una colonna, questi momenti possono
essere sostanzialmente in errore.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 50
3.2.4.1 - Necessità di considerare gli effetti P-δ
Se una colonna o controvento forma cerniere plastiche solo alle sue estremità, è poco
probabile, in ogni caso concreto che i momenti P-δ saranno significativi. Se una colonna è
abbastanza rigida in modo da attirare momenti notevoli, le sue deformazioni elastiche a
flessione di solito sono così piccole che gli effetti P-δ sono insignificanti. Se una colonna è
abbastanza flessibile, anche se potrebbe avere gravi effetti P-δ, di solito non attirerà molto
momento e le sue deformazioni elastiche di curvatura sono ancora piccole. Nella maggior
parte dei casi gli effetti P-δ possono essere ignorati.
Questo vale però solo per le colonne o controventi che si snervano soltanto alle loro
estremità. Gli effetti P-δ possono essere notevoli se una colonna o controvento presenti una
cerniera plastica nella sua lunghezza, dal momento che le deformazioni che contribuiscono
all’effetto P-δ includono ora le deformazioni anelastiche così come le deformazioni
elastiche.
Infine, si noti che se si divide un membro di colonna in, diciamo, due elementi, con un nodo
al centro del membro, l’effetto P-δ si applica solo all'interno di ogni elemento, e sarà quasi
certamente molto piccolo. Eventuali effetti associati con spostamento del nodo centrale sono
ora effetti P-Δ. Questo è un modo per tenere conto degli effetti P-δ (cioè, aggiungete i nodi
e gli elementi in più, e convertirli in effetti P-Δ).
3.2.5 - Effetto sulla resistenza della colonna
Figura 3.8 mostra anche perché gli effetti P-Δ riducono la resistenza effettiva a flessione di
una colonna. Ipotizzate che la capacità flessionale di una cerniera plastica sia M. Si tratta di
una quantità costante - non è influenzata da effetti P-Δ. Se usiamo la teoria dei piccoli
spostamenti, la cerniera plastica si forma quando M = Hh, e la forza orizzontale predetta
della colonna è H = M/h. Se consideriamo gli effetti P-Δ, la cerniera si forma quando M =
Hh + PΔ, e la forza prevista è = H (M - PΔ)/h.
3.2.6 - Opzioni del SAP 2000
3.2.6.1 - Effetti P-δ
SAP 2000 correntemente non considera gli effetti P-δ (cioè non si considera la non linearità
geometrica all’interno della lunghezza di un elemento colonna o controvento). Quindi, se si
utilizza un singolo elemento per modellare un elemento controvento, SAP 2000 non
modella il buckling del controvento nella sua lunghezza. È possibile, tuttavia, modellare
questo tipo di buckling dividendo un elemento controvento in una serie di elementi più
corti, e specificando che gli effetti P-Δ sono da considerare. Instabilità di questo tipo
possono risultare sensibili ad una iniziale fuori-rettilineità nel membro, e si può fare il
membro storto deliberatamente al fine di avviare il carico di punta. Se si vuole considerare
questo tipo di comportamento, si consiglia di testare prima il membro modellato in un
piccolo sub-assemblaggio, per assicurarsi che si ottiene il comportamento previsto.
Un’alternativa più semplice per un carico di punta di una barra è quello di utilizzare il
buckling di materiale tipo acciaio.
3.2.6.2 - Effetti P−Δ del secondo ordine
Generalmente le normative richiedono che gli effetti P−Δ del secondo ordine vengano
considerati quando si progettano telai in acciaio. Gli effetti P−Δ hanno origine da due fonti.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 51
Tali fonti sono la traslazione laterale globale del telaio e la deformazione locale degli
elementi del telaio.
Si consideri l’elemento asta mostrato nella figura, che è estratto da un livello di piano di una
struttura più grande. La traslazione globale totale di questo elemento asta è indicata con Δ,
mentre la deformazione locale dell'elemento è indicata con δ. Gli effetti P-Δ del secondo
ordine totali nell’elemento asta sono quelli causati da entrambi Δ e δ.
Figura 3.9 - Effetti P-Delta del secondo ordine totali in un elemento asta causati da entrambi Δ e δ [13]
Il programma è provvisto di un'opzione per considerare gli effetti P-Δ nell’analisi. Quando
si considerano gli effetti P-Δ nell’analisi, il programma fa un buon lavoro nel catturare gli
effetti dovuti alla deformazione Δ mostrata nella figura 3.9, ma tipicamente non cattura gli
effetti della deformazione δ (a meno che, nel modello, l'elemento asta non sia spezzato in
più parti lungo la sua lunghezza).
Nei codici di calcolo, la considerazione degli effetti P-Δ è generalmente ottenuta
computando la capacità a flessione di progetto usando una formula simile a questa
equazione :
𝑀𝐶𝐴𝑃 = 𝑎𝑀𝑛𝑡 + 𝑏𝑀𝑙𝑡 dove:
MCAP = capacità a flessione di progetto
Mnt = capacità a flessione richiesta dall’elemento assumendo che non ci sia
traslazione dell'asta (associata alla deformazione δ nella figura 3.9)
Mlt = capacità a flessione richiesta dall'elemento come risultato della traslazione
laterale soltanto dell’asta (associata alla deformazione Δ nella figura 3.9)
a = fattore adimensionale che moltiplica Mnt
b = fattore adimensionale che moltiplica Mlt (assunto uguale a 1 dal programma; a tal
proposito si veda sotto)
Quando il programma esegue la progettazione aste in acciaio, assume che il fattore b sia
uguale ad 1 e usa le formule specifiche della normativa di progetto per calcolare il fattore a.
Assumere b=1 significa che si sono considerati gli effetti P-Δ nell’analisi come descritto

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 52
precedentemente. Quindi, più in generale, eseguendo una progettazione aste in acciaio, gli
effetti P-Δ dovrebbero essere considerati nell’analisi prima di eseguire la progettazione.
3.3 - LE NON LINEARITÀ DI MATERIALE
L’importanza e la necessità di considerare la risposta in campo anelastico del materiale
richiedono l’utilizzo di programmi di calcolo in grado di descrivere la non linearità del
materiale. I programmi attualmente disponibili sono in grado di fare questo utilizzando due
diversi approcci:
modellazione tramite cerniere plastiche (“a plasticità concentrata”);
modellazione tramite fibre (“a plasticità diffusa”).
In questa tesi si utilizzerà la modellazione “a plasticità concentrata” e quindi non si tratterà
quella “a plasticità diffusa”.
3.3.1 - Modellazione a plasticità concentrata
E’ stata la prima tecnica di modellazione implementata in programmi di analisi strutturale
per descrivere il comportamento anelastico di una struttura sotto l’azione ciclica del sisma.
Essa prevede che tutti gli elementi costituenti la struttura rimangano sempre in campo
elastico e che vengano introdotti, alle estremità di questi, elementi cerniera con
comportamento anelastico laddove si preveda la formazione della cerniera plastica.
La non linearità della struttura rimane quindi concentrata in pochi elementi.
Poiché la curva caratteristica di una cerniera plastica non è univocamente definita, ma
dipende dalla sua posizione nella struttura e dal comportamento del singolo elemento
strutturale e da quello globale della struttura, i codici spesso forniscono un’ampia libreria di
legami costitutivi fra i quali scegliere di caso in caso.
Il vantaggio di questa modellazione è che permette di lavorare principalmente con elementi
elastici computazionalmente meno onerosi e più facilmente gestibili, lasciando a pochi punti
della struttura la concentrazione della non linearità del materiale.
Il limite di questa modellazione è che richiede una certa esperienza dell’operatore per
stabilire dove distribuire gli elementi non lineari e per scegliere lunghezze e curve
caratteristiche che permettano di cogliere il reale comportamento delle cerniere plastiche.
I modelli a plasticità concentrata hanno come oggetto la valutazione diretta del carico di
collasso di strutture costituite da materiali duttili, quali i metalli, in regime di piccoli
spostamenti. La crisi viene in tal caso identificata con la situazione in cui risulta impossibile
soddisfare contemporaneamente l’equilibrio e le limitazioni sul livello di sforzo
sopportabile dal materiale, situazione che la duttilità consente effettivamente di avvicinare
in casi reali.
Il modello a cerniera plastica riconduce l’analisi evolutiva di travi ad una sequenza di
soluzioni elastiche, riferita a strutture il cui grado di iperstaticità viene man mano degradato
dall’attivazione delle successive cerniere, fino alla formazione di un meccanismo. A rigore,
tali soluzioni dovrebbero includere anche la valutazione del regime deformativo, onde
assicurare che le rotazioni nelle cerniere siano compatibili con il verso concesso dalla
plasticizzazione.
Lo snervamento nel singolo elemento di trave è assunto come localizzato strettamente nella
regione in cui si ha la formazione della cerniera plastica. Quest’ultima si forma, infatti,
quando il momento flettente nel punto considerato raggiunge il momento di completa
plasticizzazione MP.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 53
Si ricorda a tal proposito che MP è funzione, per una medesima sezione, dell’azione assiale
in essa presente e, in modo minore, anche dell’azione tagliante presente.
La natura delle deformazioni plastiche è irreversibile, in caso contrario si verificherebbe
infatti uno scarico elastico: la sezione tornerebbe a comportarsi come un mutuo incastro ed
il momento decrescerebbe, in valore assoluto, dal valore limite precedentemente raggiunto.
Al di fuori della zona in cui si ha la formazione di una cerniera plastica si fa l’ipotesi di un
comportamento puramente elastico dell’elemento. In altre parole, tutte le sezioni trasversali
presentano delle relazioni bilineari elasto-plastiche tra momento-curvatura.
3.3.2 - Il concetto di cerniera plastica [11]
Si può impostare la teoria della flessione plastica sull’osservazione seguente: in prima
approssimazione il momento flettente massimo che un’asta qualsiasi di una travatura a nodi
rigidi in acciaio dolce può sopportare è pari a:
MP = σ0 ∙ Z
dove Z è il modulo plastico della sezione, mentre σ0 è la tensione limite di snervamento del
materiale. Tale momento può provocare nell’asta una curvatura molto grande, ed in teoria,
addirittura infinita.
Consideriamo ora una trave semplicemente appoggiata e caricata da un carico di entità P in
mezzeria. La sezione trasversale dell’elemento è di tipo a “doppio T”.
Incrementando la forza P fintanto che in mezzeria, dove il momento è massimo, si
raggiunge la sollecitazione flettente MP, si trova che le deformazioni plastiche si estendono
lungo la zona della trave in cui M > Me. Pertanto ipotizzato un fattore di forma della sezione
=1.14 (ragionevole per sezioni di tale tipo), l’estensione di tale zona sarà (vedi figura
3.10):
∆l = l ∙ (MP −Me
MP
) = 0,123 ∙ l
Data la forma del diagramma M-1/r, si deduce che la curvatura resta piccolissima intorno ai
punti in cui la sezione si affaccia alla fase elasto-plastica, mentre ha valori enormi in
prossimità del punto dove è applicato il carico e si ha la completa plasticizzazione della
sezione. Quindi la trave assume una deformata simile a quella di due aste rigide incernierate
nel punto in cui è applicato il carico, dove di fatto le curvature sono elevate.
Anche in presenza di un carico distribuito sulla trave, la zona delle deformazioni importanti
resta localizzata e si può quindi ammettere che la deformata si componga di due tronconi
rigidi incernierati tra loro.
Da quanto detto emerge che si ha la formazione di una cerniera ad attrito che rimane rigida
fintanto che M < MP e che permette la rotazione relativa tra i due tronconi di trave quando il
momento raggiunge il suo valore limite MP. Tale cerniera è nota col nome di cerniera
plastica.
Rispetto ad una cerniera strutturale, la cerniera plastica presenta due differenze:
pur consentendo delle rotazioni relative tra i due tratti contigui di trave, essa
trasmette un momento costante pari a MP;

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 54
è una cerniera unidirezionale, può ruotare cioè solo nel verso di plasticizzazione, vale
a dire compatibilmente col segno del momento flettente.
Figura 3.10 - Rappresentazione della nozione di cerniera plastica [11]
3.3.2.1 - La definizione di momento limite ultimo [11]
Si consideri il caso di flessione semplice, retta, su di una trave prismatica infinitamente
lunga. Inoltre si faccia l’ipotesi che le deformazioni plastiche siano continue e non vi siano
direzioni privilegiate di deformazione. In tali condizioni le sue sezioni rette rimangono
piane e normali al piano di inflessione della trave.
P
M
Deformata
approssimata
Cerniera plastica
Mp Me
Zona
plasticizzata
della trave

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 55
Il momento elastico massimo Me viene raggiunto quando lo sforzo nelle fibre estreme
assume il valore del limite elastico 0 del metallo e vale:
Me = σ0 ∙ W
dove W è il modulo di resistenza della sezione, pertanto la curvatura corrispondente a tale
stato di tensione risulta essere:
χe =Me
EJ
la curvatura può anche essere espressa così:
{
χe =
Me
EJMe = σ0 ∙ W
W =2 ∙ J
h
ε0 =σ0E
→ χe =2 ∙ ε0h
Se si supera il momento limite elastico Me succede che le fibre estreme della sezione della
trave si plasticizzano; a mano a mano che il momento di sollecitazione cresce, le zone
plasticizzate della sezione aumentano estendendosi verso l’asse baricentrico.
Figura 3.11 - Schema evolutivo della plasticizzazione della sezione [11]
0 0 MAX
0 0 0 0
0

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 56
Facciamo ora l’ipotesi che la sezione sia dotata di doppia simmetria. Imponendo la
condizione di equilibrio alla traslazione orizzontale, per una flessione semplice si trova che
l’asse neutro rimane sempre coincidente con l’asse baricentrico.
La curvatura anche in campo elasto-plastico, sotto tali ipotesi è legata alla distanza y
dell’interfaccia elasto-plastica dall’asse neutro dalla relazione di Bernoulli:
χ =ε0y
e facendo il rapporto tra e e si ottiene questa relazione:
{
χ =ε0y
χe =2 ∙ ε0h
→ 2y
h=χeχ
dove si vede come l’altezza del nucleo elastico della sezione, cioè 2y è inversamente
proporzionale alla curvatura presente nella stessa. Quindi in teoria per curvature tendenti
all’infinito il nucleo elastico tende a sparire e la distribuzione degli sforzi sulla sezione
tende ad essere bi-rettangolare (vedi figura 3.11). A tale situazione deformativa corrisponde
il massimo momento flettente che la sezione, e quindi la trave può sopportare. Tale
momento è noto come Momento Limite Plastico MP.
Dalla suddetta definizione appare chiaro come tale Momento Limite Plastico sia solo
un’idealizzazione visto che per essere raggiunto sono necessarie deformazioni sicuramente
inaccettabili nella realtà. Basti pensare che anche qualora si potesse ripiegare la trave su se
stessa, la curvatura massima raggiungibile sarebbe pari a 2/h (dove con h si è indicata
l’altezza della trave) e quindi ben lontana da valori infiniti. Ciò per dire che nella realtà la
sezione presenta sempre, anche a collasso, un nucleo elastico. Tuttavia, per acciai dolci si ha
che nel relativo diagramma - il punto limite del tratto orizzontale è caratterizzato da
deformazioni delle fibre estreme della sezione mediamente pari a tredici volte la
deformazione limite elastica. Quindi significa che la zona mediana elastica della sezione ha
un’ampiezza pari ad 1/13 dell’altezza sezionale con conseguente momento relativo totale
che differisce di appena 1/500 da quello di completa plasticizzazione.
Quanto detto finora per il caso della flessione pura, può essere esteso con ottima
approssimazione anche a travi soggette a flessione semplice per effetto di carichi trasversali.
Infatti l’azione tagliante ha un’influenza debolissima sul valore del momento limite plastico
a patto che tale azione sia contenuta al punto di evitare una plasticizzazione anticipata
dell’anima nei confronti della sezione. La stessa teoria si può applicare anche nel caso di
colonne presso-inflesse fino a che l’azione assiale presente costituisce una frazione
“sufficientemente piccola” dell’azione assiale limite NP = 0 A .
Vediamo ora di esprimere la legge di variazione del momento con la curvatura. Scrivendo
l’equilibrio alla rotazione tra le forze interne ed il momento sollecitante esterno si ha:
𝑀 = ∫ y dA𝐴

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 57
Dalla figura 3.11 si vede come in campo elasto-plastico la distribuzione degli sforzi sia di
tipo trapezoidale.
Risulta allora comodo scomporre tale distribuzione come indicato in figura 3.12, in modo
da poter scrivere la relazione di equilibrio nel seguente modo:
𝑀 = 0 𝑊𝑒 + 0 𝑍 − 0 𝑍𝑒
dove:
We indica il modulo di flessione della sola porzione elastica della sezione;
Z è il modulo plastico della sezione;
Ze è il modulo plastico della zona elastica della sezione pensata anch’essa come
elasticizzata.
Figura 3.12 - Scomposizione della distribuzione delle tensioni sulla sezione [11]
Ricordando allora che MP = 0 Z e raccogliendo 1/Me a fattore comune la relazione di
equilibrio può essere scritta come:
𝑀
𝑀𝑒
=𝑀𝑃
𝑀𝑒
[1 −𝑍𝑒 −𝑊𝑒
𝑍]
In generale si ha che Ze e We dipendono dall’ampiezza relativa tra il nucleo elastico e
l’intera altezza della sezione, e pertanto da 2y
h=
χe
χ anche dal rapporto tra la curvatura in
campo elasto-plastico e la curvatura elastica, cioè:
(𝑍𝑒 −𝑊𝑒) = 𝜙 (2𝑦
ℎ) = 𝜙 (
𝜒
𝜒𝑒)
Questa relazione permette di disegnare per ogni tipo di sezione la curva momento-curvatura
normalizzata ossia (M/Me - /e).
Per curvature “molto grandi” tende ad annullarsi ed M tende al momento di completa
plasticizzazione. In pratica allora, i citati diagrammi M-1/r normalizzati tendono
asintoticamente al valore = M/MP comunemente noto col nome di Fattore di Forma della
sezione.
= + _

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 58
Quest’ultimo è fortemente condizionato dalla forma della sezione. La sezione rettangolare
ad esempio conta di un fattore di forma pari ad 1.5. Per la putrella ideale vale 1 mentre nelle
putrelle ad ali larghe varia da 1.10 ad 1.22.
In generale si può dire che è minimo nei profili ad ali sottili, mentre è massimo per quelli
ad ali spesse.
3.3.3 – Cerniere plastiche secondo FEMA 356 applicate nel SAP 2000
3.3.3.1 - Controvento: cerniera assiale con legame rigido plastico incrudente asimmetrico
secondo FEMA 356
In questo caso si è attribuito a compressione la Forza e lo Spostamento a trazione ridotti del
coefficiente χ , funzione della snellezza dell'asta, determinato secondo EC 3:
Fc = χ Ft
Uc = χ Ut
3.3.3.1.1 - Definizione del legame della cerniera
Si è utilizzato per la cerniera un legame rigido plastico incrudente asimmetrico partendo da
un legame costitutivo elastoplastico incrudente come in figura:
Figura 3.13 - Legame costitutivo elastoplastico incrudente [4]
La risposta lineare è descritta tra il punto A (componente scarica) ed il punto B di effettivo
snervamento. La pendenza da B a C è tipicamente una piccola percentuale (0-10%) della
pendenza elastica, ed è necessaria per rappresentare il fenomeno dell'incrudimento. Il punto
C ha una ordinata che rappresenta la resistenza ed un valore in ascissa uguale alla
deformazione alla quale inizia una significativa degradazione di resistenza. Dopo il punto D
la componente risponde con una sostanziale riduzione di resistenza sino al punto E. A
deformazioni più grandi del punto E la resistenza è nulla.
Sperimentalmente per la maggioranza dei casi si è riscontrato che per travi e colonne la
pendenza del tratto soggetto a incrudimento può essere assunta pari al 3% di quella elastica.
Nel programma SAP 2000 tramite il comando “Drops to zero” si attribuisce alla cerniera
una perdita di resistenza al di là del punto “E”. La brusca perdita di resistenza è spesso
irrealistica e potrebbe essere molto difficile da analizzare. Per arrivare a convergenza il

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 59
programma automaticamente limita la pendenza negativa di una cerniera ad essere non più
rigida del 10% della rigidezza elastica dell’elemento contenente la cerniera stessa.
Il valore trovato dal SAP 2000 dello spostamento della cerniera prima della perdita di
resistenza non coincide con quello del nodo di controllo poiché a causa del suo legame
rigido-plastico non può cogliere lo spostamento elastico:
U1nodo (al limite di resistenza) = U1cerniera (al limite di resistenza) + U1nodo (al limite elastico)
E’ necessario definire due parametri della cerniera plastica:
1. Lunghezza
La cerniera plastica è modellata come un punto discreto (cerniera concentrata). Tutte
le deformazioni plastiche avvengono all’interno della cerniera concentrata, questo
significa che si deve assumere una lunghezza per la cerniera sulla quale la
deformazione o la curvatura plastica è integrata.
Si può approssimare la plasticità che è distribuita sulla lunghezza dell’elemento
tramite l’inserimento di molte cerniere. Per esempio si potrebbero inserire 10
cerniere a posizioni relative all’interno dell’elemento di 0.05, 0.15, 0.25, …, 0.95,
ciascuna con proprietà di deformazione basate su una lunghezza di cerniera assunta
pari ad 1
10 della lunghezza dell’elemento.
2. Posizione
Il punto dove concentrare tutte le risorse inelastiche.
Seguiamo le indicazioni delle FEMA 356 per definire il legame della nostra cerniera
plastica assiale. I parametri di modellazione e il criterio di accettazione per le procedure non
lineari di una sezione circolare cava, soggetta a compressione e trazione, risultano espressi
nella tabella 5-7 delle FEMA 356.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 60
Figura 3.14 - Tabella 5-7 [4]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 61
Abbiamo tre possibili casi a seconda del rapporto tra il diametro “d”e lo spessore “t” della
sezione circolare cava. Una volta determinato a quale caso appartiene la nostra sezione i
parametri di modellazione e i criteri di accettazione da considerare sono quelli del caso
trovato.
Avendo ora a disposizione tutti i parametri necessari sia a trazione che a compressione è
possibile definire il legame della cerniera assiale determinando il Fy e uy:
𝐹𝑦 = 𝐴 ∙ 𝑓𝑦𝑒
𝑢𝑦 = 𝐿 ∙ 𝜀𝑦𝑒
Dove:
Fy = resistenza a snervamento attesa;
fye = tensione a snervamento attesa del materiale;
A = area della sezione;
uy = spostamento a snervamento atteso;
εye = deformazione a snervamento attesa del materiale;
L = lunghezza del controvento.
Noti i fattori di scala (Fy e uy) sarà possibile calcolare i valori del legame forza-spostamento
sia adimensionale che dimensionale.
Grafico 3.1 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
F (K
N)
Spost. (m)
Legame FORZA-SPOSTAMENTO

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 62
Dal programma SAP è possibile definire una cerniera assiale secondo le FEMA 356
utilizzando il comando “auto”, tramite il quale è possibile accedere a dei modelli di cerniera
predefiniti.
Figura 3.15 - Assegnazione “Auto” della cerniera
Figura 3.16 - Proprietà cerniera
La cerniera così definita coincide con quella determinata manualmente seguendo le
indicazioni impartite dalle FEMA 356.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 63
3.3.3.2 - Trave: cerniera flessionale con legame rigido plastico incrudente secondo
FEMA356
3.3.3.2.1 - Definizione del legame della cerniera
Si è utilizzato per la cerniera un legame rigido plastico incrudente partendo da un legame
costitutivo elastoplastico incrudente come in figura:
Figura 3.17 - Legame costitutivo elastoplastico incrudente [4]
La risposta lineare è descritta tra il punto A (componente scarica) ed il punto B di effettivo
snervamento. La pendenza da B a C è tipicamente una piccola percentuale (0-10%) della
pendenza elastica, ed è necessaria per rappresentare il fenomeno dell’incrudimento. Il punto
C ha una ordinata che rappresenta la resistenza ed un valore in ascissa uguale alla
deformazione alla quale inizia una significativa degradazione di resistenza. Dopo il punto D
la componente risponde con una sostanziale riduzione di resistenza sino al punto E. A
deformazioni più grandi del punto E la resistenza è nulla.
Sperimentalmente per la maggioranza dei casi si è riscontrato che per travi e colonne la
pendenza del tratto soggetto a incrudimento può essere assunta pari al 3% di quella elastica.
Nel programma SAP 2000 tramite il comando “Drops to zero” si attribuisce alla cerniera
una perdita di resistenza al di là del punto “E”. La brusca perdita di resistenza è spesso
irrealistica e potrebbe essere molto difficile da analizzare. Per arrivare a convergenza il
programma automaticamente limita la pendenza negativa di una cerniera ad essere non più
rigida del 10% della rigidezza elastica dell’elemento contenente la cerniera stessa.
Seguiamo le indicazioni delle FEMA 356 per definire il legame della cerniera plastica
flessionale. I parametri di modellazione e il criterio di accettazione per le procedure non
lineari delle sezioni in acciaio, soggette a flessione, risultano espressi nella tabella 5-6 delle
FEMA 356.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 64
Figura 3.18 - Tabella 5-6 [4]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 65
Abbiamo tre possibili casi a seconda della snellezza dell’anima e delle ali della sezione in
acciaio. Una volta determinato a quale caso appartiene la nostra sezione i parametri di
modellazione e i criteri di accettazione da considerare sono quelli del caso trovato.
Rimane da definire la rotazione a snervamento θy, per fare ciò si seguono le indicazioni del
paragrafo 5.5.2.2.2 ( Procedura statica non lineare) delle FEMA 356.
Figura 3.19 - Definizione della rotazione di corda [4]
Quando si prevede che il punto di flesso sia a metà lunghezza della trave allora per il calcolo
di θy è possibile usare questa equazione:
𝜃𝑦 =𝑍 𝐹𝑦𝑒 𝑙𝑏
6 𝐸 𝐼𝑏
Dove:
Z = Modulo della sezione plastica;
Fye = Resistenza a snervamento attesa del materiale;
lb = Lunghezza della trave;
Ib = Momento di inerzia della trave;
E = Modulo di elasticità.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 66
Noto θy è possibile determinare i parametri di modellazione e i criteri di accettazione:
Criteri di accettazione
Parametri di modellazione primari secondari
a b c IO LS CP LS CP
Tabella 3.1 - Parametri di modellazione e criteri di accettazione [4]
Avendo ora a disposizione tutti i parametri necessari è possibile definire il legame della
cerniera flessionale determinando il 𝑀𝑝𝑙:
𝑀𝑝𝑙 = 𝑍 𝐹𝑦𝑒
Noti i fattori di scala (Mpl e θy) sarà possibile calcolare i valori del legame momento-
rotazione sia adimensionale che dimensionale.
Grafico 3.2 - Legame MOMENTO-ROTAZIONE
M (
KN
m)
θ (-)
Legame Momento-Rotazione
IO
LS
CP

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 67
La cerniera flessionale così definita è stata inserita manualmente nel programma di calcolo
SAP2000:
Figura 3.20 - Tipo di cerniera (SAP2000)
Figura 3.21 - Proprietà cerniera (SAP2000)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 68
3.3.3.3 - Colonna: cerniera presso/tenso-flessionale con legame rigido plastico incrudente
secondo FEMA 356
3.3.3.3.1 - Dominio di interazione
Il primo passo sarà quello di calcolare il dominio di interazione P-M per la sezione
considerata; tale dominio lo si otterrà secondo NTC-08 e FEMA-356 e sarà poi definito nel
programma SAP2000.
Dominio di interazione N-M secondo NTC-08
Per sezioni a doppio T di classe 1-2 doppiamente simmetriche, soggette a presso o tenso
flessione si ha:
1. Nel piano dell’anima:
𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
(1 − 𝑛)
(1 − 0,5𝑎)≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑
2. Nel piano delle ali:
a) 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑛 ≤ 𝑎
b) 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 = 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 [1 − (𝑛−𝑎
1−𝑎)2
] 𝑝𝑒𝑟 𝑛 > 𝑎
Dove: 𝑛 =𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 ; 𝑎 =
(𝐴−2𝑏 𝑡𝑓)
𝐴≤ 0,5 𝑐𝑜𝑛 {
𝐴 = area lorda della sezione𝑏 = 𝑙𝑎𝑟𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑡𝑓 = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑖
L’ultimo parametro necessario rimane il coefficiente di instabilità χ.
A questo punto abbiamo tutti i parametri per definire il dominio di interazione N-M.
Dominio di interazione P-M secondo FEMA-356
La resistenza flessionale attesa per l’elemento colonna sarà:
𝑀𝑝𝑙 = 1,18 𝑍 𝐹𝑦𝑒 (1 −𝑃
𝑃𝑦𝑒) ≤ 𝑍 𝐹𝑦𝑒
Dove:
Z = Modulo della sezione plastica;
Fye = Resistenza a snervamento attesa del materiale;
P = Forza assiale nel membro allo spostamento fissato per l’analisi statica non
lineare;
Pye = Forza assiale a snervamento attesa nel membro = Ag · Fye ;
Ag = Area lorda della sezione orizzontale.
L’ultimo parametro necessario rimane il coefficiente di instabilità χ.
A questo punto abbiamo tutti i parametri per definire il dominio di interazione N-M.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 69
Con il programma SAP2000 è possibile definire tale dominio, con l’unica accortezza di
accertare la convessità della curva stessa.
Figura 3.22 - Definizione della curva di interazione N-M3
Grafico 3.3 - Confronto FEMA-356 / SAP2000
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
-800,0 -600,0 -400,0 -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0N[K
N]
M [KN m]
INTERAZIONE N-M3
FEMA 356
SAP2000

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 70
3.3.3.3.2 - Definizione del legame della cerniera
Si è utilizzato per la cerniera un legame rigido plastico incrudente partendo da un legame
costitutivo elastoplastico incrudente come in figura:
Figura 3.23 - Legame costitutivo elastoplastico incrudente [4]
La risposta lineare è descritta tra il punto A (componente scarica) ed il punto B di effettivo
snervamento. La pendenza da B a C è tipicamente una piccola percentuale (0-10%) della
pendenza elastica, ed è necessaria per rappresentare il fenomeno dell'incrudimento. Il punto
C ha una ordinata che rappresenta la resistenza ed un valore in ascissa uguale alla
deformazione alla quale inizia una significativa degradazione di resistenza. Dopo il punto D
la componente risponde con una sostanziale riduzione di resistenza sino al punto E. A
deformazioni più grandi del punto E la resistenza è nulla.
Sperimentalmente per la maggioranza dei casi si è riscontrato che per travi e colonne la
pendenza del tratto soggetto a incrudimento può essere assunta pari al 3% di quella elastica.
Nel programma SAP 2000 tramite il comando “Drops to zero” si attribuisce alla cerniera
una perdita di resistenza al di là del punto “E”. La brusca perdita di resistenza è spesso
irrealistica e potrebbe essere molto difficile da analizzare. Per arrivare a convergenza il
programma automaticamente limita la pendenza negativa di una cerniera ad essere non più
rigida del 10% della rigidezza elastica dell’elemento contenente la cerniera stessa.
Seguiamo le indicazioni delle FEMA 356 per definire il legame della cerniera plastica
presso/tenso-flessionale. I parametri di modellazione e il criterio di accettazione per le
procedure non lineari delle sezioni in acciaio, soggette sia a sforzo normale che a flessione,
risultano espressi nella tabella 5-6 delle FEMA 356 in funzione prima di tutto del rapporto
fra lo sforzo normale agente P e il più piccolo valore di capacità a compressione assiale PCL.
Le FEMA-356 per un’analisi Pushover in controllo di spostamento impongono due campi
all’interno dei quali può variare il valore dello sforzo assiale agente P:
1. P/PCL < 0,2
2. 0,2 < P/PCL <0,5
Il programma SAP2000 consiglia l’utilizzo di almeno tre curve momento rotazione per
definire il legame di una cerniera presso/tenso-flessionale secondo FEMA-356 capace di

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 71
considerare la variabilità dello sforzo assiale. In base ai campi sopra definiti si troveranno
tre sforzi assiali con PCL= χ Ag Fye .
In corrispondenza dei tre sforzi assiali caratteristici determinati troviamo tre punti del
dominio di interazione N-M3 e quindi siamo capaci di delimitare i due campi di interesse.
Grafico 3.4 - Visualizzazione dei due campi di interesse
Adesso bisogna determinare le tre curve:
CURVA 1
P/PCL = 0,4999 => 0,2 < 0,4999 < 0,5
CURVA 2:
P/PCL = 0,2009 => 0,2 < 0,2009 < 0,5
CURVA 3:
P/PCL = 0,1999 < 0,2
Il procedimento lo si svolgerà solo per la CURVA 1 mentre sarà omesso per le altre visto
che è il medesimo.
N[KN]
M [KN m]
INTERAZIONE N-M3
P / PCL = 0,4999
P / PCL = 0,2009
P / PCL = 0,1999

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 72
CURVA 1: P/PCL = 0,4999 => 0,2 < 0,4999 < 0,5
Figura 3.24 - Tabella 5-6 [4]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 73
Abbiamo tre possibili casi a seconda della snellezza dell’anima e delle ali della sezione in
acciaio. Una volta determinato a quale caso appartiene la nostra sezione i parametri di
modellazione e i criteri di accettazione da considerare sono quelli del caso trovato.
Rimane da definire la rotazione a snervamento θy, per fare ciò si seguono le indicazioni del
paragrafo 5.5.2.2.2 ( Procedura statica non lineare) delle FEMA 356.
Figura 3.25 - Definizione della rotazione di corda [4]
Quando si prevede che il punto di flesso sia a metà lunghezza della colonna allora per il
calcolo di θy è possibile usare questa equazione:
𝜃𝑦 =𝑍 𝐹𝑦𝑒 𝑙𝑐
6 𝐸 𝐼𝑐(1 −
𝑃
𝑃𝑦𝑒)
Dove:
Z = Modulo della sezione plastica;
Fye = Resistenza a snervamento attesa del materiale;
lc = Lunghezza della colonna;
Ic = Momento di inerzia della colonna;
E = Modulo di elasticità;
P = Forza assiale nel membro allo spostamento fissato per l’analisi statica non
lineare;
Pye = Forza assiale a snervamento attesa del membro = Ag · Fye ;
Ag = Area lorda della sezione orizzontale.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 74
Noto θy è possibile determinare i parametri di modellazione e i criteri di accettazione:
Criteri di accettazione
Parametri di modellazione Primari secondari
a b C IO LS CP LS CP
Tabella 3.2 - Parametri di modellazione e criteri di accettazione [4]
Avendo ora a disposizione tutti i parametri necessari è possibile definire il legame della
cerniera presso/tenso-flessionale determinando il 𝑀𝑝𝑙:
𝑀𝑝𝑙 = 1,18 𝑍 𝐹𝑦𝑒 (1 −𝑃
𝑃𝑦𝑒) ≤ 𝑍 𝐹𝑦𝑒
Noti i fattori di scala (Mpl e θy) sarà possibile calcolare i valori del legame momento-
rotazione sia adimensionale che dimensionale.
Grafico 3.5 - Legame MOMENTO-ROTAZIONE
La cerniera a presso/tenso-flessione così definita verrà inserita nel programma di calcolo
SAP2000:
Figura 3.26 - Tipo di cerniera
M (
KN
m)
θ (-)
Legame MOMENTO-ROTAZIONE
LegameMomento-RotazioneIO
LS
CP

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 75
Figura 3.27 - Interazione P-M3
Figura 3.28 - Legame Momento-Rotazione (CURVA 1)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 76
Figura 3.29 - Definizione della curva di interazione P-M3
Il SAP 2000 sembra fissare una fattore di scala uguale per le tre curve anche se soggette a
diversi sforzi normali, mentre in realtà gli effetti di tali sforzi sulla rotazione θy vengono
considerati direttamente nei valori delle tabelle descriventi il legame della cerniera.
La formula completa per la rotazione a snervamento data dalle FEMA-356 è la seguente:
𝜃𝑦 =𝑍 𝐹𝑦𝑒 𝑙𝑐
6 𝐸 𝐼𝑐(1 −
𝑃
𝑃𝑦𝑒)
Il SAP2000 invece la scompone così:
1. Inserisce in fig. 3.27 una rotazione a snervamento calcolata come se l’elemento fosse
una trave
θy(SAP) =Z Fye lc
6 E Ic
2. Calcola il fattore che tiene conto degli effetti prodotti dallo sforzo normale e lo
moltiplica per tutti i valori della tabella del legame Momento-Rotazione
(1 −P
Pye)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 77
3.4 - PROCEDURE DI SOLUZIONE DI PROBLEMI NON LINEARI [10]
Considerare la risposta strutturale non lineare, a causa della presenza di non linearità
geometriche e/o del materiale, implica l’utilizzo di metodi di analisi non lineari in cui sono
impiegate procedure di soluzione di tipo incrementale iterativo.
Queste ultime prevedono l’applicazione del carico agente sulla struttura tramite incrementi
successivi predefiniti e la ricerca della condizione di equilibrio in ogni incremento tramite
iterazioni.
Facendo riferimento ad un approccio agli spostamenti, solitamente utilizzato nei codici
strutturali, si consideri una struttura lineare sollecitata da un carico applicato
incrementalmente pari a λiP0 con λi fattore di carico all’incremento i-esimo: risolvere la
struttura significa verificare che, ad ogni incremento, sia verificato l’equilibrio fra le forze
interne resistenti FS e i carichi esterni.
Essendo FS funzione lineare degli spostamenti tramite la matrice K, il tutto si riduce a
risolvere il sistema lineare:
𝐾𝑈𝑖 = 𝜆𝑖𝑃0
Se, invece, si considera una struttura non lineare, l’equilibrio sarà descritto dal sistema non
lineare:
𝑅(𝑈𝑖) = 𝜆𝑖 ∙ 𝑃0
dove R(Ui) sono le forze resistenti funzione non lineare degli spostamenti.
Figura 3.30 - Confronto fra la risposta di un sistema lineare e uno non lineare [10]
Per risolvere l’equazione non lineare si utilizza una approssimazione per cui si assume che,
nel passo infinitesimo δU, la funzione δR è lineare e pari a:
δR = KTδU

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 78
essendo KT la matrice di rigidezza tangente definita come:
KT =
[ 𝜕𝑅1𝜕𝑈1
⋯𝜕𝑅1𝜕𝑈𝑛
⋮ ⋱ ⋮𝜕𝑅𝑛𝜕𝑈1
⋯𝜕𝑅𝑛𝜕𝑈𝑛]
Lo spostamento U soluzione dell’equazione non lineare si ottiene con procedure
incrementali. Le più comunemente utilizzate nei codici strutturali sono la procedura di
Newton-Raphson e quella di Newton-Raphson modificata. Entrambe prevedono di calcolare
l’incremento ΔUi corrispondente all’incremento di carico λi(P0)-λi-1(P0) tramite iterazioni
successive per cui:
∆𝑈𝑖 = ∆𝑈𝑖0 + ∆𝑈𝑖
1 +⋯+ ∆𝑈𝑖𝑗+⋯+ ∆𝑈𝑖
𝑛
Nel caso di Newton-Raphson lo spostamento correttivo ∆𝑈𝑖𝑗 è calcolato a patire dalla
soluzione all’iterazione precedente Rj(Ui-1+∆𝑈𝑖𝑘) con k=0,j-1, supponendo la funzione R
lineare, secondo la relazione:
∆𝑈𝑖𝑗= (𝐾𝑇
𝑗)−1× (𝜆𝑖𝑃0 − 𝑅
𝑗)
Il metodo prevede quindi che ad ogni iterazione venga calcolata la matrice tangente:
𝐾𝑇𝑗= 𝐾𝑇(𝑈𝑖−1 + ∆𝑈𝑖
𝑘)
con k=0, .., j-1. Nell’iterazione iniziale ∆𝑈𝑖0 la tangente verrà calcolata in corrispondenza
della soluzione al passo incrementale precedente Ui-1.
Figura 3.31 - Procedura iterativa di Newton-Raphson [10]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 79
Nel metodo Newton-Raphson modificato gli spostamenti correttivi sono determinati
utilizzando in tutte le iterazioni la rigidezza iniziale 𝐾𝑇0 risulta quindi:
∆𝑈𝑖𝑗= (𝐾𝑇
0)−1 × (𝜆𝑖𝑃0 − 𝑅𝑗)
Figura 3.32 - Procedura iterativa di Newton-Raphson modificata [10]
E’ possibile inoltre utilizzare altri metodi derivanti dalla combinazione dei due descritti che
si differenziano per il numero di volte in cui nell’incremento viene ricalcolatala la matrice di
rigidezza. Solitamente le prestazioni migliori si ottengono aggiornando la matrice nei primi
passi e poi mantenendola costante.
In tutti i metodi l’iterazione nell’incremento si interrompe quando è soddisfatto un criterio
di tolleranza, che solitamente si basa sulla norma dello spostamento correttivo e/o sulla
norma dello sbilanciamento delle forze. Si richiede cioè che siano soddisfatte
rispettivamente le condizioni:
‖ ∆Ui
n
∆Ui‖ ≤ tol ‖
λiP0 − Rn
P0‖ ≤ tol
essendo ‖u‖ = √(uT ∙ u) la norma del vettore u
Sebbene gran parte dei codici di calcolo di analisi e progettazione permettono all’utente di
svolgere analisi non lineari senza dover compiere alcuna scelta in termini di parametri o
metodi, è d’altra parte consigliabile conoscere lo strumento che si sta utilizzando ed essere
eventualmente in grado di modificarlo.
Infatti, le possibilità generalmente lasciate dai codici sono:
1. scegliere il metodo incrementale;
2. stabilire il numero di volte in cui è aggiornata la matrice di rigidezza;
3. definire i numeri di incrementi da compiere nel passo di carico;
4. definire il massimo numero di iterazioni di equilibrio da compiere nel singolo
incremento;
5. scegliere i diversi criteri di convergenza basati su spostamenti o forze o una loro
combinazione.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 3 80
3.5 - BIBLIOGRAFIA
[4] FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of
buildings”, Federal Emergency Management Agency-356, Washington D.C. (USA),
November 2000.
[9] A. Mattei, Tesi di Laurea: “Verifiche prestazionali di un edificio industriale in acciaio in
presenza di sisma”, Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture, Facoltà di
Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Anno Accademico 2005-2006.
[10] L. Petrini, R. Pinho, G. M. Calvi (2006), “Criteri di progettazione antisismica degli
edifici”, IUSS Press, Novembre 2006-3a edizione.
[11] A. Moretti, M. Zambelli, Tesi di Laurea: “Metodi numerici per la valutazione della
capacità portante di telai piani in acciaio in presenza di effetti del II ordine”, Dipartimento
di Ingegneria Strutturale, Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano, Anno Accademico
1996-97.
[12] Computers and Structures, Inc. (2006), “PERFORM COMPONENTS AND
ELEMENTS FOR PERFORM-3D AND PERFORM-COLLAPSE”, University Avenue
Berkeley, California (USA), August 2006.
[13] M. Brunetta, L. Bandini, M. De Lorenzi (2006), “SAP2000® software per analisi e
verifiche di strutture”, Pordenone, Settembre 2006.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 81
4 - ANALISI NON LINEARE STATICA
4.1 - INTRODUZIONE [14]
Per ottenere una previsione accurata e realistica della risposta sismica di una struttura è
necessario disporre di strumenti di analisi che permettano di coglierne il comportamento
non lineare e la sua evoluzione nel tempo.
L’analisi dinamica non lineare al passo è indubbiamente lo strumento più completo ed
efficace (assumendo ovviamente che il modello strutturale riproduca con accuratezza il
sistema reale): la risposta della struttura viene determinata mediante integrazione al passo
delle equazioni del moto di un sistema a molti gradi di libertà (MDOF) non lineare.
Questa presenta però alcuni aspetti che ne impediscono un diffuso impiego nella pratica
professionale:
la scelta dei parametri che intervengono è delicata ed influenza sensibilmente i
risultati dell’analisi stessa;
sono necessarie numerose analisi impiegando differenti accelerogrammi
opportunamente selezionati per ottenere un risultato rappresentativo della risposta
attesa;
l’accuratezza dell’analisi va a scapito della semplicità e della rapidità di esecuzione;
l’interpretazione dei risultati è complessa ed onerosa.
I codici sismici consentono infatti di utilizzare analisi elastiche lineari (statiche e dinamiche)
che conseguentemente, pur con i relativi limiti, risultano ancora procedure largamente
diffuse.
Un’alternativa attraente è l’uso di procedure di analisi statiche non lineari che, pur
conservando la notevole semplicità d’uso e di interpretazione dei risultati tipica delle analisi
statiche lineari, consentono stime più realistiche ed affidabili della risposta strutturale anche
in campo non lineare. In effetti, è sempre più frequente la loro applicazione sia nella
progettazione che nella verifica strutturale.
Questo tipo di analisi comprende essenzialmente due aspetti:
1. la determinazione di un legame forza-spostamento (curva di capacità o curva di
pushover), rappresentativo del reale comportamento monotono della struttura, per la
cui definizione si richiede un’analisi di spinta o di pushover ;
2. la valutazione dello spostamento massimo o punto di funzionamento (performance
point) raggiunto dalla struttura a fronte di un evento sismico definito tramite uno
spettro di risposta elastico in accelerazione.
L’analisi di spinta consente quindi di descrivere il comportamento della struttura tramite un
semplice legame monodimensionale forza-spostamento detto curva di capacità. In tal modo
l’analisi della risposta della struttura viene ricondotta a quella di un sistema ad un solo
grado di libertà (SDOF) equivalente alla struttura di partenza. I metodi statici non lineari
permettono di individuare lo spostamento massimo di tale sistema SDOF equivalente e
quindi la risposta della struttura (punto prestazionale) soggetta ad un evento sismico
descritto dal relativo spettro di risposta in accelerazione.
L’analisi pushover consiste nello “spingere” la struttura fino a che questa collassa o un
parametro di controllo di deformazione non raggiunge un valore limite prefissato; la
“spinta” si ottiene applicando in modo incrementale monotono un profilo di forze o di

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 82
spostamenti prestabilito. In sostanza è una tecnica di soluzione incrementale-iterativa delle
equazioni di equilibrio statico della struttura in cui la forzante è rappresentata dal sistema di
spostamenti o forze applicato.
L’analisi di spinta consente di definire un legame scalare forza-spostamento caratteristico
del sistema studiato, detto curva di capacità, che permette di ricondurre la ricerca dello
spostamento massimo di un sistema soggetto ad una certa azione esterna a quella di un
sistema SDOF equivalente.
4.2 - SISTEMI SDOF [14]
Nel caso di sistemi SDOF l’analisi di spinta è particolarmente intuitiva.
Un sistema SDOF può essere idealizzato come una massa concentrata m sorretta da un
elemento privo di massa con rigidezza laterale k e collegato ad un elemento (privo di massa
e rigidezza) responsabile dello smorzamento.
La configurazione deformata (o campo di spostamento) del sistema è definita quindi da un
unico parametro che può identificarsi con lo spostamento relativo della massa rispetto al
suolo (spostamento orizzontale Dt in figura).
Figura 4.1 - Schematizzazione di sistema ad un grado di libertà (SDOF) [14]
Un caso evidente di struttura riconducibile ad un sistema SDOF è quello delle pile da ponte
che possono considerarsi, con buona approssimazione, pendoli rovesci ossia oscillatori
semplici in cui la totalità della massa (impalcato, pulvino e fusto della pila) è concentrata in
testa mentre la rigidezza del sistema può attribuirsi ad un elemento di massa nulla (il fusto
della pila stessa).
In questi semplici casi, l’analisi di spinta consiste nell’applicare alla massa del sistema uno
spostamento D o una forza F la cui intensità viene gradualmente incrementata nella
direzione dell’unico grado di libertà disponibile. Il valore iniziale della forza o dello
spostamento non ha ovviamente importanza. Le espressioni che definiscono la forzante
(intesa in senso generalizzato come forza o spostamento) possono esprimersi come:
𝐷 = 𝛼𝑑
𝐹 = 𝛽𝑓
Dunque, fissato arbitrariamente il valore di d o f, il fattore moltiplicativo α o β viene
gradualmente incrementato da zero fino ad un valore finale che permetta di investigare il
campo di risposta di interesse per il sistema in esame. Ad ogni valore di α o β corrisponde
quindi un valore di D o F che rappresenta lo spostamento o la forza applicati alla massa del
sistema.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 83
Il comportamento del sistema è definito da un legame forza-spostamento in cui la forza
coincide con il taglio alla base Vb e lo spostamento con quello della massa Dt:
nel caso di analisi a forze imposte (F è la forza applicata ad m): Vb=F e Dt=D
essendo D lo spostamento di m prodotto da F;
nel caso di analisi a spostamenti imposti (D è lo spostamento applicato ad m): Dt=D
e Vb=F essendo F la reazione vincolare risultante;
4.3 - SISTEMI MDOF [14]
Nel caso di sistemi MDOF, l’approccio è simile a quello visto per i sistemi SDOF con la
differenza che la struttura viene “spinta” applicando un profilo di forze o di spostamenti
orizzontali in corrispondenza di ciascun piano e che, per descrivere il comportamento
dell’intero sistema in termini di legame forza-spostamento, è necessario scegliere un solo
parametro di forza ed un solo parametro di spostamento.
La scelta di tali parametri non è univoca e può dar luogo a differenti legami forza
spostamento ossia a differenti legami costitutivi del sistema SDOF equivalente detti curva di
capacità.
Solitamente, come parametri di forza e di deformazione, si selezionano il taglio alla base e
lo spostamento del baricentro dell’ultimo piano dell’edificio anche se, in realtà, questa
scelta non ha un preciso fondamento teorico ma è più probabilmente un retaggio delle
originarie applicazioni di questa tecnica alle pile da ponte delle quali si monitorava, per
ovvie ragioni, lo spostamento in sommità.
Figura 4.2 - Applicazione dell’analisi di spinta ad un telaio [14]
Considerando che l’obiettivo è di simulare la risposta dinamica della struttura, sorge la
questione se l’analisi di spinta debba essere condotta applicando un sistema di spostamenti o
di forze. Se la struttura avesse un comportamento elastico lineare i due approcci
condurrebbero agli stessi risultati ma la presenza di effetti anelastici comporta una sensibile
differenza tra le due alternative.
Concettualmente l’analisi dinamica viene condotta con le forze inerziali per cui l’analisi di
spinta a forze imposte sembrerebbe più appropriata ma, in un’analisi dinamica, perfino
quando un modo è dominante, l’andamento delle forze di piano non rimane inalterata (ossia

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 84
non variano proporzionalmente ad un fattore costante), per cui applicare una distribuzione
di forze constante non è comunque esatto; inoltre possono sorgere difficoltà nel condurre
analisi anelastiche stabili con controllo in forze, poiché queste non sono in grado di cogliere
un eventuale comportamento softening della struttura né di seguire accuratamente risposte
associate a rigidezze molto piccole, per cui può essere preferibile eseguire analisi a
spostamenti controllati. Di contro, lavorando a spostamenti imposti, si vincola la deformata
della struttura, per cui si rischia di conseguire campi di forze completamente errati rispetto a
quelli attesi in una struttura “libera” di deformarsi a fronte dell’evento sismico e quindi a
risultati seriamente fuorvianti.
Comunque, l’approccio basato sulle forze è quello che ha attirato maggiormente l’interesse
tra ricercatori ed ingegneri professionisti anche perché di facile implementazione su tutti i
più comuni programmi di calcolo.
4.4 - CURVA DI CAPACITA’ [14]
Il risultato più immediato di un’analisi di pushover è la definizione della curva di capacità
(o curva di pushover) della struttura ossia della curva forza-spostamento espressa,
solitamente, in termini di taglio alla base (Vb) e spostamento in sommità (Dt) che
rappresenta appunto la capacità esibita dal sistema a fronteggiare una certa azione esterna.
Considerando un sistema SDOF, l’andamento della curva di capacità dipende dalla
rigidezza k o dalla flessibilità 𝑘−1 del sistema che a loro volta dipendono essenzialmente
dalle caratteristiche geometriche e meccaniche del sistema e sono funzioni non lineari
rispettivamente dello spostamento e della forza applicata al sistema:
𝐹 = 𝑘(𝐷) oppure 𝑉𝑏 = 𝑘(𝐷𝑡)
𝐷 = 𝑘−1(𝐹) oppure 𝐷𝑡 = 𝑘−1(𝑉𝑏)
In figura sono diagrammati i legami forza-spostamento ossia le curve di capacità
rappresentativi di tre comportamenti emblematici caratterizzati da un iniziale
comportamento elastico lineare fino alla soglia di snervamento (rappresentato da un ramo
sostanzialmente lineare) seguito da un comportamento post-elastico non lineare
incrudente(i), perfetto (p) o degradante (d).
Figura 4.3 - Curva di capacità di un sistema reale [14]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 85
Nel caso più complesso, ma di maggiore interesse, di sistemi MDOF la curva di capacità
mostra andamenti analoghi caratterizzati ancora da un tratto inizialmente rettilineo,
corrispondente al comportamento lineare della struttura, che si incurva quando inizia la
plasticizzazione e la risposta progredisce in campo non lineare.
Grafico 4.1 - Comportamento della curva di capacità
E’ possibile individuare sulla curva di capacità quattro segmenti [15]:
Un iniziale segmento lineare corrispondente a un comportamento elastico-lineare, nel
quale la domanda di deformazione laterale è proporzionale all'intensità del sisma, a
prescindere dalle caratteristiche del sistema o del moto del suolo. Questo segmento si
estende dall’origine all’inizio di plasticizzazione.
Un secondo segmento pseudo-lineare, nel quale la domanda di deformazione laterale
è circa proporzionale all'intensità del sisma.
Un terzo segmento curvilineo corrispondente ad un comportamento nel quale la
domanda anelastica di deformazione laterale non è più proporzionale all'intensità del
sisma. Con l'aumentare dell'intensità, le domande di deformazione laterale
aumentano a un ritmo più veloce. Questo segmento corrisponde al rammollimento
del sistema, o alla riduzione della rigidezza. In questo segmento, il sistema "transita"
da un comportamento lineare ad una eventuale instabilità dinamica. Anche se un
segmento curvilineo è sempre presente, in alcuni casi la transizione può essere
relativamente lunga e graduale, mentre in altri casi può essere molto breve e brusca.
Un segmento finale lineare che è orizzontale o quasi orizzontale, nel quale le
domande di deformazione laterale infinitamente grandi si verificano per piccoli
incrementi di intensità del sisma. Questo segmento corrisponde al punto in cui un
sistema diventa instabile (instabilità laterale dinamica).

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 86
La curva di capacità definisce la capacità della struttura indipendentemente da qualsiasi
specifica richiesta sismica (infatti non si fa riferimento alcuno all’azione sismica) e quindi
descrive le caratteristiche intrinseche del sistema resistente; in altre parole è una sorta di
legame costitutivo semplificato della struttura. Trattandosi di un legame scalare forza-
spostamento il comportamento del sistema MDOF viene così ricondotto sostanzialmente a
quello di un sistema SDOF che può ragionevolmente definirsi equivalente dato che la curva
di capacità è stata costruita tenendo conto del comportamento dell’intero sistema MDOF.
Quando un terremoto induce uno spostamento laterale sulla struttura la sua risposta è
rappresentata da un punto su tale curva e, poiché la deformazione di tutti i suoi componenti
è correlata allo spostamento globale della struttura stessa, ogni punto di questa curva
definisce anche uno specifico stato di danno strutturale.
4.4.1 - Individuazione degli stati limite sulla curva di capacità Si riporta di seguito il classico andamento di una curva Forza - Spostamento. Su questa
curva, valida sia a livello globale della struttura sia in un punto specifico di essa, si possono
individuare gli stati limite di controllo.
Figura 4.4 - Comportamento deformativo della struttura [16]
il punto B evidenzia l’abbandono della fase elastica, e la comparsa del primo
meccanismo plastico (cerniera plastica a momento/taglio o effetti combinati PMM,
svergolamento di un elemento compresso, snervamento per trazione, ecc);
il punto IO evidenzia il raggiungimento del primo stato limite denominato Immidiate
Occupancy (rioccupazione immediata), superato il quale si ha un danneggiamento
basso, ma comunque tale da rendere necessario un intervento di ripristino locale per
la rioccupazione dell’edificio;
il punto LS evidenzia il raggiungimento del secondo stato limite denominato Life
Safety (Salvataggio della vita), superato il quale si ha un danneggiamento alto, e non
si ha la certezza del salvataggio delle vite degli occupanti dell’edificio;
il punto CP evidenzia il raggiungimento dell’ultimo stato limite denominato Collapse
Prevention (Prevenzione del Collasso). Questo livello segna un danneggiamento
molto pronunciato prossimo a quello di Collasso (individuato dal punto C).
Si fa notare che il collasso individuato dal punto C, risulta un Collasso in termini di forza
orizzontale, cioè le membrature della struttura sono così danneggiate da non portare più

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 87
forze orizzontali, ma permane una resistenza ai carichi verticali. Il collasso vero e proprio è
indicato dal punto E. Inoltre, mentre il valore di IO e CP sono dettati da ragionamenti fisici,
il valore LS è un valore di comodo scelto opportunamente tra i due precedenti.
Questa curva è valida sia a livello globale per la struttura, e in questo caso assume
l’importanza della individuazione dei diversi stati limite, sia a livello locale. In tal caso,
assume un valore di assegnazione dei diversi livelli di danneggiamento di quella particolare
"hinge"(cerniera).
4.5 - ANALISI NON LINEARE STATICA SECONDO LA NORMATIVA ITALIANA
4.5.1 - L’analisi non lineare statica secondo NTC 2008 [5]
L’analisi non lineare statica consiste nell’applicare alla struttura i carichi gravitazionali e,
per la direzione considerata dell’azione sismica, un sistema di forze orizzontali distribuite,
ad ogni livello della costruzione, proporzionalmente alle forze d’inerzia ed aventi risultante
(taglio alla base) Fb. Tali forze sono scalate in modo da far crescere monotonamente, sia in
direzione positiva che negativa e fino al raggiungimento delle condizioni di collasso locale
o globale, lo spostamento orizzontale dc di un punto di controllo coincidente con il centro di
massa dell’ultimo livello della costruzione (sono esclusi eventuali torrini).
Il diagramma Fb - dc rappresenta la curva di capacità della struttura.
Questo tipo di analisi può essere utilizzato soltanto se ricorrono le condizioni di
applicabilità nel seguito precisate per le distribuzioni principali (Gruppo 1); in tal caso esso
si utilizza per gli scopi e nei casi seguenti:
- valutare i rapporti di sovraresistenza au/a1 di cui ai §§ 7.4.3.2, 7.4.5.1, 7.5.2.2,
7.6.2.2, 7.7.3, 7.8.1.3 e 7.9.2.1 delle NTC;
- verificare l’effettiva distribuzione della domanda inelastica negli edifici progettati
con il fattore di struttura q;
- come metodo di progetto per gli edifici di nuova costruzione sostitutivo dei metodi di
analisi lineari;
- come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti.
Si devono considerare almeno due distribuzioni di forze d’inerzia, ricadenti l’una nelle
distribuzioni principali (Gruppo 1) e l’altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2)
appresso illustrate.
Gruppo 1 - Distribuzioni principali:
- distribuzione proporzionale alle forze statiche di cui al § 7.3.3.2, applicabile solo se il
modo di vibrare fondamentale nella direzione considerata ha una partecipazione di
massa non inferiore al 75% ed a condizione di utilizzare come seconda distribuzione
la 2 a);
- distribuzione corrispondente ad una distribuzione di accelerazioni proporzionale alla
forma del modo di vibrare, applicabile solo se il modo di vibrare fondamentale nella
direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al 75%;
- distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano calcolati in
un’analisi dinamica lineare, applicabile solo se il periodo fondamentale della struttura
è superiore a TC.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 88
Gruppo 2 - Distribuzioni secondarie:
a) distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione
uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
b) distribuzione adattiva, che cambia al crescere dello spostamento del punto di
controllo in funzione della plasticizzazione della struttura.
L’analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale
equivalente ad un grado di libertà.
4.5.2 - Risposta alle diverse componenti dell’azione sismica ed alla variabilità spaziale
del moto [5]
Se la risposta viene valutata mediante analisi statica in campo non lineare, ciascuna delle
due componenti orizzontali (insieme a quella verticale, ove necessario, e agli spostamenti
relativi prodotti dalla variabilità spaziale del moto, ove necessario) è applicata
separatamente. Come effetti massimi si assumono i valori più sfavorevoli così ottenuti.
4.5.3 - Analisi non lineare statica secondo la bozza esplicativa del 07/03/2008 [17]
Questo metodo d’analisi è utilizzabile solo per costruzioni il cui comportamento sotto la
componente del terremoto considerata è governato da un modo di vibrare naturale
principale, caratterizzato da una significativa partecipazione di massa.
L’analisi richiede che al sistema strutturale reale venga associato un sistema strutturale
equivalente ad un grado di libertà.
Figura 4.5 - Sistema e diagramma bilineare equivalente [17]
La forza F* e lo spostamento d* del sistema equivalente sono legati alle corrispondenti
grandezze Fb e dc del sistema reale dalle relazioni:
F* = Fb / Γ
d* = dc / Γ
dove Γ è il “fattore di partecipazione modale” definito dalla relazione:
Γ = φT M τ / φT M φ

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 89
Il vettore τ è il vettore di trascinamento corrispondente alla direzione del sisma considerata;
il vettore φ è il modo di vibrare fondamentale del sistema reale normalizzato ponendo dc=1;
la matrice M è la matrice di massa del sistema reale.
Alla curva di capacità del sistema equivalente occorre ora sostituire una curva bilineare
avente un primo tratto elastico ed un secondo tratto perfettamente plastico (vedi figura 4.5).
Detta Fbu la resistenza massima del sistema strutturale reale ed F*bu = Fbu/Γ la resistenza
massima del sistema equivalente, il tratto elastico si individua imponendone il passaggio per
il punto 0,6 F*bu della curva di capacità del sistema equivalente, la forza di plasticizzazione
F*y si individua imponendo l’uguaglianza delle aree sottese dalla curva bilineare e dalla
curva di capacità per lo spostamento massimo d*u corrispondente ad una riduzione di
resistenza ≤ 0,15Fbu.
Il periodo elastico del sistema bilineare è dato dall’espressione:
𝑇∗ = 2𝜋√𝑚∗
𝑘∗
dove m* = φTMτ e k* è la rigidezza del tratto elastico della bilineare.
Nel caso in cui il periodo elastico della costruzione T* risulti T* ≥ TC la domanda in
spostamento per il sistema anelastico è assunta uguale a quella di un sistema elastico di pari
periodo (vedi figura 4.6):
d*max = d*
e,max = SDe (T*)
Figura 4.6 - Spostamento di riferimento per T > TC [17]
Nel caso in cui T* < TC la domanda in spostamento per il sistema anelastico è maggiore di
quella di un sistema elastico di pari periodo (vedi figura 4.7) e si ottiene da quest’ultima
mediante l’espressione:
𝑑𝑚𝑎𝑥∗ =
𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
𝑞∗[1 + (𝑞∗ − 1)
𝑇𝐶
𝑇∗] ≥ 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 90
dove q* = Se (T*) m*/Fy* rappresenta il rapporto tra la forza di risposta elastica e la forza di
snervamento del sistema equivalente.
Figura 4.7 - Spostamento di riferimento per T ≤ TC [17]
Se risulta q*≤1 allora si ha d*max = d*
e,max .
Gli effetti torsionali accidentali sono considerati nel modo previsto al § 7.2.6 delle NTC.
Una volta trovata la domanda in spostamento d*max per lo stato limite in esame si verifica
che sia d*max ≤ d*
u e si procede alla verifica della compatibilità degli spostamenti per gli
elementi/meccanismi duttili e delle resistenze per gli elementi/meccanismi fragili.
L’analisi non lineare statica condotta nei modi previsti dalle NTC può sottostimare
significativamente le deformazioni sui lati più rigidi e resistenti di strutture flessibili
torsionalmente, cioè strutture in cui il modo di vibrare torsionale abbia un periodo superiore
ad almeno uno dei modi di vibrare principali traslazionali. Per tener conto di questo effetto,
tra le distribuzioni secondarie delle forze occorre scegliere la distribuzione adattiva.
L’azione sismica deve essere applicata, per ciascuna direzione, in entrambi i possibili versi e
si devono considerare gli effetti più sfavorevoli derivanti dalle due analisi.
4.6 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
CONVENZIONALI L’analisi di pushover consiste nell’esame della struttura sottoposta ai carichi verticali (pesi
propri, permanenti ed accidentali) e ad un sistema di forze laterali al crescere delle quali
aumenta monotonicamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo della
struttura (posto tipicamente in sommità dell’edificio), fino al raggiungimento delle
condizioni ultime.
Le distribuzione di forze convenzionali sono:
distribuzione uniforme di forze;
distribuzione corrispondente alla distribuzione dei tagli di piano;
distribuzione triangolare;
distribuzione proporzionale al modo fondamentale.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 91
Tali metodologie di analisi di pushover convenzionali sono proposte, dalle varie normative
internazionali (EC8, FEMA, ATC), come metodi standard di analisi statica non-lineare per
le strutture regolari.
Le tipologie di pushover convenzionali si distinguono fra loro solamente per la diversa
modalità di distribuzione delle forze sulla struttura.
La caratteristica che contraddistingue le tipologie di pushover convenzionali da quelle
adattive è l’invariabilità della forma dei carichi laterali applicati al crescere del
moltiplicatore dei carichi.
4.6.1 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze uniforme Nei telai piani per pushover uniforme si intende applicare ad ogni piano del telaio una forza
orizzontale proporzionale ai pesi sismici di ciascun piano, poi tramite un moltiplicatore dei
carichi si incrementano tali valori fino ad arrivare alle condizioni ultime della struttura,
oppure fino ad un prefissato livello di deformazione o spostamento.
In ogni caso riferendoci al caso oggetto di studio ogni peso sismico di ciascun piano non è
uguale e dunque la distribuzione di forze è uniforme in corrispondenza di ogni piano ma
non in tutta la sua altezza.
La relazione utilizzata per valutare le forze di piano è valutata in funzione della massa di
ciascun piano normalizzata rispetto a quella totale dell’edificio:
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖
𝑀𝑡𝑜𝑡
dove:
𝐹𝑖: forza dello i-esimo piano;
𝑀𝑖: massa dello i-esimo piano;
𝑀𝑡𝑜𝑡: massa totale dell’edificio.
Ricordiamo che l’analisi con distribuzione uniforme è proposta dalle normative perché si
presuppone che tale distribuzione di forze riesca a cogliere il comportamento ultimo di una
struttura che va in crisi con un meccanismo di piano debole formatosi alla base. Con un
meccanismo di rottura del tipo appena descritto le accelerazioni, indotte dall’azione sismica,
che si innescano sull’altezza dell’edificio non possono essere che uguali fra loro. Difatti
quando si forma un meccanismo di piano debole alla base della struttura, quest’ultima si
deformerà traslando con un moto rigido rispetto al piano andato in crisi, quindi la forma
modale della struttura passerà da lineare a costante sull’altezza.
Purtroppo quanto appena detto vale per i telai piani, ma non è affatto vero per una struttura
spaziale, nella quale potrebbe generarsi una crisi di piano debole in entrambe le direzioni x e
y, oppure solamente in una delle due direzioni. Ovviamente non esiste un metodo per
saperlo a priori, tutto dipende dalla direzione di provenienza del sisma e da come sono
disposti (in pianta) gli elementi di controventamento della struttura.
Nel caso di strutture spaziali non si sa quindi in quale direzione applicare le forze; se solo in
una, in entrambe contemporaneamente oppure se fare due analisi di pushover distinte nelle
due direzioni e poi combinare i risultati con le regole di quadratura. Ovviamente se l’input
sismico proviene da una direzione parallela ad x o y le forze si applicheranno solamente in
quella direzione, ma nel caso di eccitazione sismica bidirezionale il problema permane.
L’idea più semplice, ma non supportata da alcuna evidenza sperimentale, potrebbe essere

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 92
quella di effettuare due analisi di pushover distinte in entrambe le direzioni ortogonali. In
alternativa si potrebbero prendere in considerazione diverse direzioni di provenienza
dell’input sismico ed applicare delle forze laterali parallele alle supposte direzioni di
provenienza del sisma.
Fino ad ora si è parlato di come distribuire le forze di pushover lungo l’altezza della
struttura e con quale direzione, rimane però ancora il problema di capire come distribuire le
forze laterali a livello del singolo piano. Su di un piano infatti si trovano diversi punti, tutti
appartenenti al medesimo solaio, in cui sarebbe possibile applicare le forze laterali di
pushover. Per estendere l’applicazione del pushover uniforme alle strutture spaziali è quindi
necessario un nuovo criterio che stabilisca come distribuire le forze all’interno del piano.
Diversi studi fatti da vari autori (Chopra e Goel [2004], Kilar e Fajfar [2002], Penelis e
Kappos [2002], Moghadam e Tso [1996]) hanno mostrato che la soluzione migliore, ed
anche la più logica, è quella di applicare la risultante delle forze di piano nel centro di massa
(CM) del piano stesso. Tale evidenza deriva dal fatto che le forze laterali di pushover
cercano di esprimere le forze d’inerzia che si innescano sotto l’azione sismica, quindi tali
forze non possono essere che distribuite proporzionalmente alla distribuzione delle masse a
livello dei singoli piani. Ovviamente, per le regole della geometria delle masse, la forza
risultante che ne deriva passa per il centro di massa del piano considerato.
Per i motivi appena detti, se la struttura presenta dei solai infinitamente rigidi è possibile
applicare direttamente un’unica forza di pushover per ogni piano, tale forza sarà applicata
appunto nel CM
del piano considerato. L’infinita rigidezza del solaio farà si che le forze
siano distribuite a livello del singolo piano. Le forze applicate hanno tutte lo stesso modulo,
non solo lungo l’altezza, ma anche a livello di piano. Ciò è dovuto al fatto che il centro di
massa CM
coincide con il centro di simmetria del solaio. Nel caso in cui il CM non fosse
esattamente al centro del solaio allora la distribuzione delle forze nei nodi d’angolo non
sarebbe la stessa, in tal caso bisognerebbe ripartire la forza di piano in maniera
proporzionale alla distribuzione delle masse all’interno del piano.
Si osserva che la curva di capacità è funzione del punto di applicazione della risultante delle
forze applicate: alla distribuzione uniforme in genere corrisponde un punto di applicazione
basso e quindi una grande resistenza e piccoli spostamenti allo snervamento ed allo stato
limite di collasso.
L’analisi di pushover con distribuzione uniforme non si rivela adatta per le strutture spaziali
irregolari in pianta: essa non riesce a prevedere le massime rotazioni di piano che si
sviluppano a seguito dell’evento sismico.
4.6.2 - Analisi di Pushover con distribuzione di forze proporzionale al modo
fondamentale di vibrare Questa tipologia di pushover è in relazione al comportamento della struttura nella fase
elastica e vuole essere un affinamento del caso triangolare: in questo caso si adotta una
distribuzione delle forze laterali proporzionale al modo di vibrare fondamentale in una certa
direzione (modo con maggiore massa partecipante nella direzione prescelta). Se l’input
sismico proviene dalla direzione x, allora si adotterà una distribuzione delle forze
proporzionale al modo fondamentale lungo la direzione x, ovvero, proporzionalmente al
modo che possiede la maggior massa partecipante traslazionale lungo tale direzione; in
modo analogo si procede se l’input sismico proviene dalla direzione y.
La miglioria apportata dell’analisi di pushover con distribuzione proporzionale al modo
fondamentale (rispetto a quella con distribuzione triangolare) consiste nella rimozione

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 93
dell’ipotesi che il modo di vibrare fondamentale della struttura sia di forma simile alla
triangolare, ma viene effettivamente valutata la forma modale fondamentale.
Distribuire le forze laterali secondo una forma proporzionale ad un modo dominante
permette di approssimare meglio la risposta sia di una struttura irregolare spaziale ma anche
di un telaio piano (per tali strutture i modi fondamentali non sono di forma triangolare); si
ottiene quindi una migliore descrizione delle forze d’inerzia che si innescano sotto azione
sismica.
Per strutture intelaiate piane ci sono essenzialmente modi con percentuale di massa
partecipante preponderanti nella direzione del piano mentre per le strutture spaziali ed
irregolari in pianta accade che i modi traslazionali e rotazionali si accoppiano fra loro
generando dei modi roto-traslazionali che presentano componenti di spostamento in
entrambe le direzioni x e y.
A questo punto rimane da definire quale sia il modo fondamentale da prendere in
considerazione per la distribuzione delle forze; il buonsenso suggerisce di prendere il modo
che possiede la maggior massa partecipante lungo la direzione di provenienza dell’input
sismico.
Nelle relazioni seguenti si valutano le forze per ciascun piano.
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖
Dove:
𝐹𝑖: forza dello i-esimo piano;
𝑀𝑖: massa dello i-esimo piano;
𝜑𝑖: spostamento modale dello i-esimo piano normalizzato rispetto al massimo
spostamento modale.
Lo spostamento 𝜑𝑖 è quello del punto corrispondente al centro di massa dello i-esimo piano.
Si osserva che la curva di capacità è funzione del punto di applicazione della risultante delle
forze applicate: alla distribuzione di forze proporzionale al modo fondamentale di vibrare
corrisponde in genere un punto di applicazione alto e quindi una piccola resistenza e grandi
spostamenti allo snervamento ed allo stato limite di collasso.
Questa analisi entra in crisi quando non è soddisfatta l’ipotesi di poter assimilare la risposta
strutturale ad un unico modo di vibrare fondamentale perché diventano significativi i
contributi forniti dagli altri modi, è il caso di strutture irregolari in altezza.
4.7 - ANALISI DI PUSHOVER CON DISTRIBUZIONE DI FORZE LATERALI
MULTIMODALE L’analisi pushover basata sul metodo N2 convenzionale non è direttamente applicabile agli
edifici irregolari in altezza, ovvero per edifici disomogenei nella distribuzione delle masse e
delle rigidezze lungo l’altezza, dove non è soddisfatta l’ipotesi di poter assimilare la risposta
strutturale ad un unico modo di vibrare fondamentale. Per quanto riguarda la distribuzione
delle rigidezze, l’irregolarità in altezza può essere causata dalla presenza nella struttura di
piani di altezza inferiore o dalla rastremazione degli elementi verticali. In riferimento alla
distribuzione delle masse, l’eventuale irregolarità in altezza è solitamente causata dalla
presenza nell’edificio di un piano molto caricato rispetto agli altri.
L’irregolarità in altezza provoca una risposta dinamica caratterizzata non da un unico modo
di vibrare che attiva la quasi totalità della massa, come invece accade per le strutture

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 94
regolari, ma da più modi che attivano ciascuno una significativa percentuale della massa
totale. Questo fatto rende inapplicabile l’analisi pushover convenzionale che considera la
distribuzione di forze orizzontali proporzionale alla deformata di un modo di vibrare, e
rende necessaria l’applicazione di un metodo che riesca ad includere gli effetti di tutti i modi
di vibrare significativi.
Uno studio finalizzato all’analisi pushover di edifici irregolari in altezza è quella condotto
da Chopra e Goel e descritto in un articolo del 2001 dal titolo “A modal pushover analysis
procedure for estimating seismic demands for buildings” pubblicato nella rivista scientifica
“Earthquake Engineering and Structural Dynamics”. In questo studio viene proposto un
metodo di analisi statica non lineare per edifici irregolari in altezza, ovvero per strutture che
hanno una risposta dinamica caratterizzata da più modi di vibrazione naturale significativi,
che va sotto il nome di “analisi pushover multimodale” o “modal pushover” proprio perché
considera l’effetto di più modi di vibrare.
4.7.1 - Analisi Modale Pushover (MPA) [18]
L’analisi modale pushover di Chopra e Goel consiste essenzialmente nell’eseguire tante
analisi statiche non lineari quanti sono i modi di vibrare significativi, ognuna con una
distribuzione di forze orizzontali proporzionale alla deformata del modo considerato;
successivamente si determina la risposta globale combinando i singoli effetti ottenuti da
ciascuna analisi.
L’equazione differenziale che governa la risposta di una struttura multipiano soggetta
all’accelerazione sismica �̈�𝑔(𝑡) è la seguente:
𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑈 = −𝑀𝐼�̈�𝑔(𝑡)
dove M, C e K sono rispettivamente le matrici delle masse, dello smorzamento viscoso e
della rigidezza, mentre U è il vettore degli spostamenti laterali di piano e I è il vettore unità.
Il secondo membro dell’equazione può essere interpretato come l’effettiva forzante sismica:
𝑝𝑒𝑓𝑓(𝑡) = −𝑀𝐼�̈�𝑔(𝑡) = −𝑠 �̈�𝑔(𝑡)
dove s è il vettore che definisce la distribuzione delle forze orizzontali lungo l’altezza
dell’edificio.
Dalla relazione si ha che:
𝑀𝐼 = 𝑠 = ∑ 𝑠𝑛
𝑁
𝑛=1
= ∑ 𝛤𝑛 𝑀 𝛷𝑛
𝑁
𝑛=1
dove il pedice n si riferisce al modo di vibrare della struttura n-esimo.
In questa equazione è racchiuso il senso dell’analisi multimodale, ovvero a differenza
dell’analisi pushover convenzionale in cui, considerando un unico modo di vibrare, il
vettore s si determina come segue:
𝑠 = 𝛤𝑀𝛷
nel modal pushover esso non è più riferito ad un solo modo di vibrazione ma si calcola con
la relazione:

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 95
𝑠 = ∑ 𝑠𝑛
𝑁
𝑛=1
= ∑ 𝛤𝑛 𝑀 𝛷𝑛
𝑁
𝑛=1
ovvero la distribuzione delle forze laterali espresse come la somma delle distribuzioni di
forze relative a ciascuno degli n modi di vibrare significativi della struttura.
Nella pratica questo si traduce eseguendo n analisi pushover secondo il metodo N2, per
ciascuna delle quali si determina la domanda di spostamento d*max.
Successivamente i parametri relativi alla domanda, determinati per ciascuna delle analisi
statiche non lineari, si combinano in accordo ad una appropriata regola di combinazione
modale per ottenere la domanda totale, riferita alla risposta strutturale globale.
Figura 4.8 - Esempio delle deformate relative ai primi tre modi di vibrare di un edificio di 9 piani [18]
In figura si riporta l’esempio di un edificio di 9 piani, ed in particolare si mostrano le
deformate relative ai primi tre modi naturali di vibrazione. Ipotizzando che si tratti di un
edificio irregolare in altezza la massa totale non sarà attivata solamente dal primo modo di
vibrare ma una parte significativa sarà attivata dal secondo e terzo modo.
Dunque, in un caso del genere per eseguire l’analisi statica non lineare è necessario
applicare il metodo di modal pushover. Si devono eseguire, quindi tre analisi considerando
per ciascuna la distribuzione di forze orizzontali proporzionale alla deformata del modo di
vibrare corrispondente. Tali distribuzioni di forze statiche orizzontali sono espresse dalla
relazione seguente:
𝑠𝑛∗ = 𝑀𝛷𝑛
in cui 𝑠𝑛∗ si ottiene dividendo i membri dell’equazione
𝑠 = ∑ 𝑠𝑛
𝑁
𝑛=1
= ∑ 𝛤𝑛 𝑀 𝛷𝑛
𝑁
𝑛=1

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 96
per il fattore di partecipazione modale 𝛤𝑛, il quale essendo costante non influenza i rapporti
relativi tra le forze orizzontali della distribuzione considerata; 𝛷𝑛 è il vettore degli
spostamenti di piano relativi alla deformata di vibrare n-esimo.
Figura 4.9 - Distribuzione delle forze orizzontali s*n=MΦn, n=1,2, e 3 [18]
Ciascuna delle analisi viene condotta con il metodo N2 usuale, e quindi, dalla curva di
capacità del sistema MDOF si determina la bilineare equivalente del sistema SDOF e,
procedendo al confronto di quest’ultima con lo spettro di risposta in formato ADRS si
determina la domanda di spostamento d*max. Successivamente si ottiene la risposta globale
combinando i risultati ottenuti da ciascuna analisi.
4.7.1.1 – Determinazione della domanda sismica totale
Una volta effettuate le n analisi di pushover separatamente, per ottenere la domanda di
spostamento totale, occorre combinare tra di loro le domande massime di spostamento d*max
ottenute da ciascuna analisi.
I tipi di combinazione suggeriti dagli autori del metodo sono le usuali combinazioni usate
per l’analisi modale, ovvero la combinazione quadratica semplice (SRSS) oppure la
combinazione quadratica completa (CQC). In particolare, come si procede usualmente nella
combinazione dei modi in una analisi modale con spettro di risposta, al fine di calcolare la
domanda di spostamento complessiva può essere usata una combinazione quadratica
semplice se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10% da tutti gli
altri. In caso contrario si dovrà utilizzare una combinazione quadratica completa.
Indicando con d la domanda totale e con di la domanda ottenuta dall’analisi pushover riferita
al modo i-esimo, la combinazione quadratica semplice è definita dalla relazione seguente:
𝑑 = (∑ 𝑑𝑖2
𝑁
𝑖=1
)
1/2

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 97
in cui N è il numero dei modi significativi considerato.
Analogamente si definisce la combinazione quadratica completa:
𝑑 = (∑ ∑ 𝜌𝑖𝑗𝑑𝑖𝑑𝑗
𝑁
𝑗=1
𝑁
𝑖=1
)
1/2
in cui i pedici i e j sono riferiti al modo i-esimo ed al modo j-esimo, mentre ρij è il
coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j calcolato con l’espressione seguente:
𝜌𝑖𝑗 =(8 𝜉2(1 + 𝛽𝑖𝑗)𝛽𝑖𝑗
3/2)
((1 − 𝛽𝑖𝑗2)
2+ 4 𝜉2𝛽𝑖𝑗(1 + 𝛽𝑖𝑗)
2)
dove ξ è il coefficiente di smorzamento viscoso e 𝛽ij è così definito:
𝛽𝑖𝑗 =𝜔𝑖
𝜔𝑗
in cui 𝜔𝑖 ed 𝜔𝑗 sono le frequenze rispettivamente del modo i e del modo j.
In questo modo si ottiene la domanda di spostamento complessiva, includendo in essa gli
effetti dovuti a tutti i modi di vibrare significativi della struttura.
4.7.1.2 – Rapporto FEMA-440 sul metodo MPA [19]
Secondo il rapporto FEMA-440 con il metodo MPA si possono ottenere risultati che, sia in
termini di forze, sia in termini di spostamenti di piano assoluti e relativi appaiono migliori
rispetto a quelli conseguiti con un’analisi di Pushover di tipo tradizionale. Tuttavia, nel
documento viene anche messo in luce il fatto che l’accuratezza di tali risultati dipende
significativamente dal parametro indagato, dalle caratteristiche della struttura e dai dettagli
della specifica procedura. Inoltre viene evidenziata la tendenza a sovrastimare gli effetti del
sisma, in particolare forze e momenti, a causa delle caratteristiche del sistema di
combinazione dei risultati SRSS. Infine viene rilevato come, a causa dell’invariabilità dei
profili adottati nelle singole analisi il metodo MPA sia fondamentalmente limitato, al pari
dei criteri convenzionali. Sebbene tale metodo costituisca un miglioramento significativo
rispetto alle tecniche di analisi Pushover convenzionali, permangono alcune importanti
insufficienze legate al fatto che gli effetti dell’accumulazione dei danni indotti dal crescente
livello di deformazione non vengono considerati. Dunque non vengono conteggiati i
possibili cambiamenti del comportamento strutturale indotti dalle riduzioni delle rigidezze
degli elementi e dalle conseguenti elongazioni dei periodi relativi ai diversi modi di vibrare.
Appare chiaro come tali insufficienze siano dovute alla invariabilità del vettore dei carichi
laterali applicato durante l’analisi, sia esso rappresentativo del solo modo di vibrare
fondamentale o di più modi, a causa dell’inadeguatezza nel riflettere il progressivo degrado
strutturale attraverso un vettore dalla forma fissata. Per questi motivi gli ultimi sviluppi di
questi ultimi anni nei riguardi dell’analisi statica non lineare si sono rivolti verso analisi
Pushover di tipo adattivo.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 98
4.8 - ANALISI DI PUSHOVER DELLA STRUTTURA SPAZIALE [20]
Le problematiche che investono tali tipi di strutture non è legata solo alle differenze dei
modelli in cui possono essere studiate ma senza entrare nello specifico di quanto già detto
sulle analisi di pushover, sono indubbie le difficoltà nel valutare la direzione, il punto di
applicazione e la distribuzione di forze sulla struttura al variare delle azioni d’inerzia
sismiche.
Nel modello oggetto di studio si sono fatte delle ipotesi semplificative inerenti i problemi
elencati in precedenza:
Le forme delle distribuzioni delle forze laterali sono applicate sempre in entrambe le
direzioni x e y e sono:
a. distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una
distribuzione uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione;
b. distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la deformata del primo
modo di vibrare;
c. distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la deformata dei modi di
vibrare principali (MPA).
Le forze sismiche di pushover seguono la direzione degli assi x e y ma sono applicate
singolarmente e non contemporaneamente.
Il punto di applicazione delle forze corrisponde al baricentro delle masse di ogni
piano. Per il calcolo di questo punto si è fatto riferimento alla geometria delle masse
in particolar modo al rapporto tra momento statico delle masse di piano e le masse
stesse. Il momento statico si valuta moltiplicando la massa di una membratura (per
esempio pilastro, trave, scale o pannello murario) per la relativa distanza rispetto agli
assi coordinati x o y che sono posizionati generalmente all’origine della griglia su cui
è stata modellata la struttura.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 99
4.9 - ANALISI DI PUSHOVER NEL SAP 2000 [21]
4.9.1 - In/Output step nel SAP 2000
Normalmente solo lo stato finale è salvato per una analisi non lineare statica. Si può
scegliere invece di salvare i risultati intermedi per vedere come la struttura ha risposto
durante la fase di carico. Questo è particolarmente importante per l’analisi non lineare
statica dove si ha la necessità di sviluppare la curva di capacità.
4.9.1.1 - Salvataggio di più steps
Se si sceglie di salvare più steps, lo stato all’inizio dell’analisi (step 0) sarà salvato, così
come un numero di stati intermedii. Da un punto di vista terminologico, il salvataggio di
cinque steps significa la stessa cosa di salvare sei stati (da step0 a step5): lo step è
l’incremento mentre lo stato è il risultato.
Il numero di steps salvati dipende dai parametri:
Minimo numero di steps salvati;
Massimo numero di steps salvati;
Opzione di salvare solo gli incrementi positivi.
4.9.1.2 - Minimo e massimo numero di steps salvati
Il minimo e il massimo numero di steps salvati operano un controllo sul numero di punti
attualmente salvati nell’analisi. Se il minimo numero di steps salvati è troppo piccolo, si
potrebbe non avere abbastanza punti per rappresentare adeguatamente una curva di
Pushover. Se il minimo e il massimo numero di steps salvati è troppo grande, allora l’analisi
potrebbe richiedere un eccessivo onere computazionale.
Il programma determina automaticamente la spaziatura degli steps da essere salvati come
segue. La massima lunghezza degli steps è uguale alla forza totale fissata o allo spostamento
totale fissato diviso il minimo numero di steps salvati. Il programma comincia dal
salvataggio degli steps a questo incremento. Se avviene un evento significativo ad uno step
di lunghezza minore di questo incremento, allora il programma salverà anche quello step e
continuerà con il massimo incremento da lì.
Per esempio, supponiamo che il minimo e il massimo numero di steps salvati sono fissati
pari a 20 e 30 rispettivamente, e il target è fissato ad uno spostamento di 10 mm.
L’incremento massimo di steps salvati sarà 10/20=0.5 mm. Così, il dato è salvato a 0.5, 1,
1.5, 2, 2.5 mm. Supponiamo che avviene un evento significativo a 2.7 mm. Allora il dato è
anche salvato a 2.7 mm, e continua da lì salvando a 3.2, 3.7, 4.2, 4.7, 5.2, 5.7, 6.2, 6.7, 7.2,
7.7, 8.2, 8.7, 9.2, 9.7 e 10.0 mm.
Il massimo numero di steps salvati controlla il numero di eventi significativi per i quali il
dato sarà salvato. Il programma raggiungerà sempre la forza o lo spostamento fissati
all’interno del numero di steps massimi salvati, comunque, nel fare così il programma
potrebbe saltare il salvataggio degli steps agli eventi successivi.
Per esempio, supponiamo che il minimo e il massimo numero di steps salvati sono fissati
pari a 20 e 21 rispettivamente, e il target è fissato ad uno spostamento di 10 mm.
L’incremento massimo di steps salvati sarà 10/20=0.5 mm. Così, il dato è salvato a 0.5, 1,
1.5, 2, 2.5 mm. Supponiamo che avviene un evento significativo a 2.7 mm. Allora il dato è
anche salvato a 2.7 mm, e continua da lì salvando a 3.2 e 3.7 mm. Supponiamo che avvenga
un altro evento significativo a 3.9 mm. Il programma non salverà il dato a 3.9 mm, perché

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 100
se lo facesse non sarebbe capace di limitare il massimo incremento a 0.5 mm e ancora di
portare a termine il pushover completamente in non più di 21 steps. Si nota che se avvenisse
un secondo evento significativo a 4.1 mm piuttosto che a 3.9 mm, allora il programma
sarebbe capace di salvare lo step e ancora di incontrare il criterio specificato per
l’incremento massimo e il massimo numero di steps.
CASO 1
Minimo numero di steps salvati = 20;
Massimo numero di steps salvati = 21;
L’incremento massimo = 0,5mm;
Eventi significativi a 2,7mm e a 3,9mm.
CASO 2
Minimo numero di steps salvati = 20;
Massimo numero di steps salvati = 21;
L’incremento massimo = 0,5mm;
Eventi significativi a 2,7mm e a 4,1mm.
CASO 1 CASO 2
(mm) (mm)
0,5 0,5
1 1
1,5 1,5
2 2
2,5 2,5
evento significativo 2,7 2,7
3,2 3,2
3,7 3,7
evento significativo 3,9 4,1
4,4 4,6
4,9 5,1
5,4 5,6
5,9 6,1
6,4 6,6
6,9 7,1
7,4 7,6
7,9 8,1
8,4 8,6
8,9 9,1
9,4 9,6
9,9 10
Tabella 4.1 - Stati dell’analisi Pushover

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 101
4.9.1.3 - Salva solo gli incrementi positivi
Questa opzione è di primario interesse per l’analisi pushover sotto il controllo in
spostamento. Nel caso di estrema non linearità, particolarmente quando una cerniera perde
carico, la curva pushover potrebbe mostrare incrementi negativi nello spostamento
monitorato mentre la struttura sta provando a ridistribuire la forza proveniente da una
componente collassata.
Si può scegliere o no di voler salvare solo gli steps aventi incrementi positivi. Gli incrementi
negativi rendono spesso l’aspetto della curva pushover confuso.
Si potrebbe quindi voler scegliere di salvare solo gli incrementi positivi nella maggioranza
dei casi eccetto quando l’analisi sta avendo una convergenza preoccupante.
4.9.1.4 - Influenza della scelta degli steps sull’aspetto numerico
Prendiamo in considerazione il telaio 2D (H=4m; B=4m) raffigurato in figura 4.10:
Figura 4.10 - Telaio 2D
Elemento strutturale Profilo L elemento (m) Materiale
Colonna HE360M 4 S450
Trave IPE400 4 S355
Asta del controvento TUBO 219,1/8 5,65 S235 Tabella 4.2 - Elementi costituenti il telaio 2D
I tipi di acciaio utilizzati nel telaio preso in esame sono riportati in tabella 4.3:
ACCIAIO Ftk (N/mm^2) fyk(N/mm^2) gmo fyd(N/mm^2) Es(N/mm^2)
S235 360 235 1,05 223,8 210000
S355 510 355 1,05 338,1 210000
S450 550 440 1,05 419,0 210000
Tabella 4.3 - Proprietà acciaio con t ≤ 40mm
Abbiamo variato il minimo e il massimo numero di steps salvati avendo fissato un target ad
uno spostamento pari a 1 m per tutti e quattro i modelli.
Modello 1:
Minimo numero di steps salvati = 1000
Massimo numero di steps salvati = 3000

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 102
Modello 2:
Minimo numero di steps salvati = 500
Massimo numero di steps salvati = 1500
Modello 3:
Minimo numero di steps salvati = 250
Massimo numero di steps salvati = 1000
Modello 4:
Minimo numero di steps salvati = 100
Massimo numero di steps salvati = 500
La massima lunghezza degli steps è uguale allo spostamento totale fissato diviso il minimo
numero di steps salvati, l’incremento massimo di steps salvati sarà:
min/max num steps 1000/3000 500/1500 250/1000 100/500
spostamento tot (m) 1 1 1 1 min num steps 1000 500 250 100
max incremento (m) 0,001 0,002 0,004 0,01 Tabella 4.4 - Incremento max dei 4 modelli studiati
A questo punto abbiamo lanciato l’analisi e poi verificato tramite dei parametri significativi
la bontà della stessa:
min/max num steps steps salvati steps nulli steps totali
Modello 1 1000/3000 1005 2 2479
Modello 2 500/1500 506 4 1500
Modello 3 250/1000 253 2 629
Modello 4 100/500 103 0 257 Tabella 4.5 - Parametri significativi dei 4 modelli studiati
Gli steps totali rappresentano il massimo numero di steps considerati nell’analisi. Potrebbe
includere steps salvati così come sotto-steps i quali risultano non essere salvati. In tutti i
modelli si è raggiunto lo spostamento fissato con un numero di steps totali inferiore o
uguale al massimo numero di steps salvati.
Gli steps nulli avvengono durante la procedura di soluzione non lineare quando:
una cerniera si sta scaricando;
un evento (snervamento, scarico, ecc.) innesca un altro evento;
l’iterazione non converge e ci si attende un step più piccolo.
Un eccessivo numero di steps nulli potrebbe indicare che la soluzione è andata in stallo
dovuta ad un collasso catastrofico o ad una sensibilità numerica; non è il nostro caso visto
che il massimo numero di steps nulli lo riscontriamo nel modello 2 ed è pari a 4, quindi
piccolo.
Gli steps salvati devono essere maggiori o uguali al minimo numero di steps salvati. Nel
nostro caso sono sempre maggiori, ciò significa che sono avvenuti degli eventi significativi
a degli steps di lunghezza minore dell’incremento massimo.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 103
Dimostrata la bontà dell’analisi si passa al confronto degli sforzi assiali di compressione
trovati nell’asta compressa del controvento per i quattro modelli facendo particolare
attenzione al valore di snervamento.
Riportiamo in tabella 4.6 tutti i valori della N di compressione (Nc) sino allo step10,
riportiamo cioè i risultati sino allo stato 11 per i quattro modelli:
Modello 1 Modello 2 Modello 3 Modello 4
1000/3000 500/1500 250/1000 100/500
STEP Nc (KN) Nc (KN) Nc (KN) Nc (KN)
0 1,361 1,361 1,361 1,361
1 132,416 263,471 525,581 916,291
2 263,471 525,581 916,291 916,291
3 394,526 787,691 916,291 916,291
4 525,581 916,291 916,291 916,291
5 656,636 916,291 916,291 916,291
6 787,691 916,291 916,291 916,291
7 916,291 916,291 916,291 916,291
8 916,291 916,291 916,291 916,291
9 916,291 916,291 916,291 916,291
10 916,291 916,291 916,291 916,291 Tabella 4.6 - Nc dei 4 modelli studiati
I quattro modelli raggiungeranno la N di snervamento in corrispondenza di steps diversi
come era facile aspettarsi visto che hanno incrementi massimi diversi.
Inoltre i quattro modelli trovano lo stesso valore di N di snervamento indipendentemente
dalla diversa scelta del numero di steps fatta per ciascun modello come si vede nel grafico
4.2:
Grafico 4.2 - Nc per i diversi modelli al variare degli steps
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nc
(KN
)
Step
Nc in funzione del Min/Max numero steps
1000/3000
500/1500
250/1000
100/500

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 104
4.9.1.5 - Massimo numero di iterazioni per step
L’iterazione è usata per assicurarsi che l’equilibrio sia raggiunto a ciascuno step dell’analisi.
Per ciascuno step è tentata per prima l’iterazione a rigidezza costante. Se la convergenza
non è raggiunta allora si tenta l’iterazione Newton-Raphson (rigidezza tangente). Se
entrambe falliscono, la lunghezza dello step è ridotta, e il processo è ripetuto.
Si può controllare separatamente il numero delle iterazioni a rigidezza costante e N-R
permesse in ogni step. Il settaggio di uno dei due parametri a zero impedisce quel tipo di
iterazione. Il settaggio di entrambi a zero spinge il programma a determinare
automaticamente il numero e il tipo di iterazioni permesse. Le iterazioni a rigidezza costante
sono più veloci di quelle N-R, ma le ultime sono usualmente le più efficaci. I valori di
default lavorano bene in molte situazioni.
4.9.1.6 - Tolleranza di convergenza dell’iterazione
L’iterazione è usata per assicurarsi che l’equilibrio sia raggiunto a ciascuno step dell’analisi.
Si può fissare la relativa tolleranza di convergenza la quale è usata per comparare la
grandezza della forza con la grandezza della forza agente sulla struttura.
Si potrebbe avere la necessita di usare valori significativamente più piccoli della tolleranza
di convergenza al fine di ottenere buoni risultati per problemi ai grandi spostamenti che non
per altri tipi di non linearità. Si può decrementare questo valore sino ad ottenere risultati
congrui.
4.9.1.7 - Controllo dell’iterazione “event to event”
L’algoritmo della soluzione non lineare usa una strategia “event to event” per le cerniere. Se
si ha un grande numero di cerniere nel modello, questo potrebbe derivare in un enorme
numero di steps risolti. Si può specificare una tolleranza dell’evento cumulo la quale è usata
per raggruppare gli eventi insieme allo scopo di ridurre il tempo di risoluzione.
Quando una cerniera snerva o si muove verso un altro segmento della curva forza-
spostamento (momento-rotazione), un evento è messo in ordine. Se altre cerniere sono
chiuse facendo esperienza del loro proprio evento, all’interno dell’evento cumulo di
tolleranza, loro saranno trattate come se hanno raggiunto l’evento. Questo induce un piccolo
ammontare di errore nel livello di forza (momento) in corrispondenza del quale avviene lo
snervamento o il cambio in segmento.
Specificando una più piccola tolleranza dell’evento cumulo si incrementerà l’accuratezza
dell’analisi, al costo di un maggiore tempo computazionale.
Si può chiudere il processo “event to event” completamente, in quel caso il programma sarà
iterato sulle cerniere. Questo potrebbe essere utile in modelli con un gran numero di
cerniere, ma non è raccomandato se ci si aspetti che le cerniere perdano resistenza in modo
repentino.
4.9.2 - Metodo di scarico della cerniera plastica nel SAP 2000
Questa opzione è primariamente intesa per l’analisi pushover usando proprietà di cerniera
che esibiscono improvvisi cali nella loro capacità di carico trasportato.
Quando una cerniera scarica, il programma deve trovare una via per rimuovere il carico che
la cerniera stava portando e possibilmente ridistribuirlo al resto della struttura. Lo scarico
della cerniera avviene dovunque la curva tensioni-deformazioni (forze-deformazioni e
momenti-rotazioni) mostra un calo in capacità, così come è spesso assunto dal punto C al
punto D, o dal punto E al punto F (completa rottura).

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 105
Così lo scarico lungo una pendenza negativa può essere instabile nelle analisi statiche, e una
soluzione unica non è sempre matematicamente garantita. Nelle analisi dinamiche (e il
mondo reale) l’inerzia produce stabilità e una soluzione unica.
Per l’analisi statiche, sono necessari dei metodi speciali per risolvere questo problema di
instabilità. Differenti metodi potrebbero lavorare meglio con differenti problemi. Metodi
diversi potrebbero produrre risultati diversi con lo stesso problema. SAP2000 fornisce tre
diversi metodi per risolvere questo problema dello scarico della cerniera, i quali sono
descritti successivamente.
Se tutte le pendenze tensione-deformazione sono positive o nulle, questi metodi non sono
usati a meno che la cerniera oltrepassa il punto E e si rompe. L’instabilità causata dagli
effetti geometrici non è trattata da questi metodi.
4.9.2.1 - Scarico dell’intera struttura
Quando una cerniera raggiunge una porzione della curva tensione-deformazione a pendenza
negativa, il programma continua a provare ad incrementare il carico applicato. Se questo
risulta in una deformazione incrementata (tensione decrementata) l’analisi procede. Se la
deformazione prova a invertire, il programma invece inverte il carico sull’intera struttura
sino a che la cerniera è completamente scarica per il prossimo segmento sulla curva
tensioni-deformazioni. A questo punto il programma ritorna ad incrementare il carico sulla
struttura. Altre parti della struttura potrebbero ora raccogliere il carico che è stato rimosso
dalla cerniera scarica.
Se il carico deve essere invertito o no per scaricare la cerniera dipende dalla flessibilità
relativa della cerniera scaricante comparata con altre parti della struttura che agiscono in
serie con la cerniera.
Questo metodo è il più efficiente dei tre metodi disponibili, ed è usualmente il primo
metodo che si dovrebbe provare. Esso generalmente lavora bene se la cerniera scaricante
non richiede grandi riduzioni nel carico applicato alla struttura. Esso fallisce se due cerniere
concorrono allo scarico, i.e., dove una cerniera richiede il carico applicato per incrementare
mentre l’altra richiede il carico per decrementare. In questo caso, l’analisi si fermerà con il
messaggio “incapace a trovare una soluzione”, in quel caso si dovrebbe provare uno degli
altri due metodi.
Questo metodo usa un moderato numero di steps nulli.
4.9.2.2 - Applicare la ridistribuzione locale
Questo metodo è simile al primo metodo, eccetto che invece di scaricare l’intera struttura,
solo l’elemento contenente la cerniera è scaricato. Quando una cerniera è su una porzione
della curva tensione-deformazione a pendenza negativa e il carico applicato causa l’invertire
della deformazione, il programma applica un temporaneo, localizzato, auto-equilibrante,
carico interno che scarica l’elemento. Questo causa lo scarico della cerniera. Una volta che
la cerniera è scaricata, il carico temporaneo è invertito, trasferendo il carico rimosso verso
gli elementi contigui. Questo processo è inteso per imitare come le forze di inerzia locale
potrebbero stabilizzare un elemento scaricante rapidamente.
Questo metodo è spesso il più efficace dei tre metodi disponibili, ma usualmente richiede
più steps rispetto al primo metodo, includendo molti piccoli steps e un sacco di steps nulli. Il
limite sugli steps nulli dovrebbe usualmente essere fissato tra il 40% e il 70% degli steps
totali permessi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 106
Questo metodo fallirà se due cerniere nello stesso elemento concorrono allo scarico, i.e.,
dove una cerniera richiede il carico temporaneo per incrementare mentre l’altra richiede il
carico per decrementare. In questo caso, l’analisi si fermerà con il messaggio “incapace a
trovare una soluzione”, dopo il quale si dovrebbe dividere l’elemento così che le cerniere
siano separate e riprovare di nuovo. Si controlla il .LOG file per vedere quali elementi
stanno avendo problemi. L’approccio più facile è assegnare le cerniere sovrascritte, e
scegliere di suddividere automaticamente dalle cerniere.
4.9.2.3 – Ripartire usando la rigidezza secante
Questo metodo è abbastanza differente dai primi due. Dovunque una cerniera raggiunge una
porzione della curva tensioni-deformazioni a pendenza negativa, tutte le cerniere che sono
diventate non lineari sono riformate usando le proprietà della rigidezza secante, e l’analisi è
ripartita.
La rigidezza secante per ciascuna cerniera è determinata come la secante dal punto O al
punto X sulla curva tensione-deformazione, dove: il punto O è il punto di tensione-
deformazione all’inizio del caso di carico (il quale usualmente include la tensione dovuta al
carico di gravità); e il punto X e il punto corrente sulla curva tensione-deformazione se la
pendenza è zero o positiva, o altrimenti è il punto all’estremo inferiore del segmento a
pendenza negativa della curva tensione-deformazione.
Quando il carico è riapplicato dall’inizio dell’analisi, ciascuna cerniera si muove lungo la
secante sino a raggiungere il punto X, dopo il quale la cerniera riprende usando la curva
tensione-deformazione data.
Questo metodo è simile all’approccio suggerito dalle guide linea FEMA-356, e ha senso
quando si considera l’analisi pushover come un carico ciclico di incremento della grandezza
piuttosto che come una spinta statica monotona.
Questo metodo è il meno efficiente dei tre, con il numero di steps richiesti incrementati
come la radice dello spostamento target. Esso è anche il più robusto (il meno probabile a
fallire) a patto che il carico di gravità non sia troppo grande. Questo metodo potrebbe fallire
quando la tensione in una cerniera sotto il carico di gravità è grande abbastanza che la
secante da O a X è negativa. In un altro modo, questo metodo potrebbe essere utile a fornire
soluzioni dove gli altri due metodi falliscono dovute a cerniere con piccole (vicino
all’orizzontale) pendenze negative.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 4 107
4.10 - BIBLIOGRAFIA
[5] NTC (2008), “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 14 Gennaio 2008.
[14] T. Albanesi, C. Nuti (2007), Dispensa: “ANALISI STATICA NON LINEARE
(PUSHOVER)”, Dipartimento di Strutture, Università degli studi di Roma Tre, Roma,
Maggio 2007.
[15] FEMA, (2009): “Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response”,
Federal Emergency Management Agency-P440A, Washington D.C. (USA), June 2009.
[16] A. Habibullah, S. Pyle (1998), “Practical Three Dimensional Nonlinear Static Pushover
Analysis”, Published in Structure Magazine, Winter 1998.
[17] Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2008), “Bozza di Istruzioni per l’applicazione
delle Norme tecniche per le Costruzioni”, aggiornamento al 07/03/2008.
[18] Chopra A.K., Goel R.K. (2001), “A modal pushover analysis procedure for estimating
seismic demands for buildings”, Earthquake Engineering Research Center, University of
California, Berkeley, 31 August 2001.
[19] FEMA (2005): “Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures”,
Federal Emergency Management Agency-440, Washington (USA), June 2005.
[20] Fausto Viesi (2008), Tesi di Laurea: “Confronto tra modellazione a plasticità diffusa e
concentrata per strutture in c.a.: la scuola di Bisignano”, Corso di Laurea in Ingegneria
Civile - Indirizzo Strutture -, Università degli studi di Bologna, anno accademico2007/2008.
[21] Computers and Structures, Inc. (2010), “CSI Analysis Reference Manual For
SAP2000®, ETABS®, and SAFE® ”, Berkeley, California (USA), March 2010.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 108
5 - DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
5.1 - DESCRIZIONE DELL’OPERA
La struttura ospedaliera studiata è in acciaio di nove piani, di cui tre interrati e sei fuori
terra, la cui destinazione d’uso prevista è quella di parcheggi e locali per impianti e
macchinari per i primi tre, ambienti ad uso ospedaliero per i restanti sei piani.
5.1.1 - Collocamento geografico
La costruzione dell’opera è prevista a Rieti. Le coordinate geografiche sono:
LAT 42° 25’ 58’’ N
LONG 12° 51’ 83’’ E
visualizzabili nell’immagine seguente presa direttamente da Google Earth.
Il sottosuolo su cui la struttura sorgerà è costituito da terreni a grana grossa mediamente
addensati, per cui può essere associata alla categoria C secondo le N.T.C. 2008.
Figura 5.1 - Posizione e coordinate geografiche [22]
5.1.2 - Caratterizzazione Architettonica L’edificio ha una forma in pianta rettangolare sia per i piani interrati che per i piani fuori
terra. L’impronta dei piani interrati può essere definita da un rettangolo con lato maggiore di
circa 218 m e lato minore di 82,5 m, mentre a partire dal primo piano fuori terra l’impronta
si restringe rimanendo comunque rettangolare di lati 158x37,5m e centrata rispetto a quella
sottostante. Tutta la struttura è organizzata in pianta mediante una suddivisione regolare in
maglie quadrate di lato 7,5 m. Le superfici totali associate ai piani interrati e fuori terra
risultano essere rispettivamente circa pari a 17950 mq e 5900 mq.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 109
La struttura si sviluppa per una altezza totale di 33 m, 12 dei quali interrati. I tre livelli
inferiori presentano un’altezza di interpiano pari a 4 m, mentre i restanti sei pari a 3,5 m.
Il materiale utilizzato per tamponare le pareti esterne è il vetro intervallato, in
corrispondenza di ogni solaio, da una fascia di piano in acciaio che ha la funzione di
individuare chiaramente ogni livello e di fornire una trama orizzontale al prospetto
dell’edificio. Sono state utilizzate due tipologie differenti di vetro: vetro specchiato, usato
nelle due facciate lungo i lati lunghi dell’edificio, dove verranno realizzate le stanze di
degenza, e vetro trasparente, usato nei lati corti in corrispondenza del telaio centrale, dove
verranno realizzati i corpi scala e nel telaio centrale sul lato lungo per interrompere la trama
continua. Tutti i livelli, tranne quello di copertura, presentano un pacchetto del solaio di
altezza complessiva pari a 78 cm, realizzato in modo tale da consentire il passaggio
dell’impiantistica di servizio. In relazione a ciò, il rivestimento di piano esterno ha altezza
pari a 2 m e si estende per 1.2 m al di sopra del piano finito e 0.8 al di sotto.
In corrispondenza dell’ultimo piano, l’altezza del pacchetto solaio risulta essere di 52,5 cm
e la copertura, progettata come non praticabile, è costituita da lastre metalliche continue
disposte su un orditura di supporto di listelli in legno necessaria a fornire la pendenza
desiderata.
Figura 5.2 - Render dell’ospedale [22]
5.1.3 - Caratterizzazione Strutturale
La struttura portante dell’opera è interamente realizzata in acciaio. La struttura è a telaio
nella direzione del lato lungo, con la particolarità che i telai in questa direzione presentano
travi binate continue, ad eccezione di quelli esterni dove le travi sono collegate alle colonne
con unioni bullonate a squadrette, mantenendo il filo esterno di queste ultime. Nella
direzione del lato corto non sono presenti travi se non nei due telai esterni, dove queste sono
collegate con la stessa tipologia di unione adoperata per il lato lungo. In altezza le colonne
sono continue e alla base è stato schematizzato un vincolo di incastro. Sia per le travi che
per le colonne sono stati impiegati profili a doppio T.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 110
Il pacchetto del solaio è costituito da pannelli alveolari precompressi poggianti sulle travi
binate cui si è fatto riferimento in precedenza. Queste travi hanno la particolarità di essere
travi con fori esagonali lungo lo sviluppo dell’anima. Con questa soluzione si è evitata una
orditura di travi secondarie limitando l’altezza totale del pacchetto solaio e consentendo
comunque di avere un adeguato spazio per il passaggio degli impianti. Le travi binate
inoltre sono rese collaboranti con la soletta mediante l’inserimento di pioli.
Figura 5.3 - Modello della struttura portante
Per quanto riguarda i controventi verticali sono stati utilizzati due sistemi diversi di
controventamento per le due direzioni principali. Per il lato corto sono stati utilizzati
controventi a croce (su due piani) per tutti i piani tranne l’ultimo dove sono presenti
controventi a V rovescia. Per il lato lungo sono stati utilizzati sempre controventi a due
piani che però non si intersecano tra di loro. Questa scelta è maturata da esigenze
architettoniche che prevedono l’inserimento di porte nella parte centrale del telaio
considerato
Per i controventi sono stati impiegati profili tubolari collegati alle colonne tramite
collegamenti a perno.
La tipologia di fondazione adottata è quella di plinti collegati da cordoli, mentre solo al di
sotto dei corpi scala-ascensori sono realizzate delle piccole platee.
5.1.3.1 - Solaio La struttura portante del solaio è costituita da pannelli alveolari precompressi tipo Neocem
H16 di spessore pari a 16 cm, completati dal getto in opera di una soletta integrativa di 6
cm. Il solaio è privo di travi secondarie, i pannelli poggiano direttamente sulle travi
principali binate, costituite da profili forati di tipo ISE HEA280-400 saldati alle ali delle
colonne, con l’asse in direzione del lato maggiore della struttura; si hanno quindi delle
strisce di luce 6,8 m che si estendono per tutta la lunghezza dell’edificio.
Il pacchetto del solaio è, chiuso inferiormente da un controsoffitto utile al passaggio degli
impianti. Questo è costituito da fibra minerale e si sorregge tramite dei sostegni fissati
direttamente sulle ali delle travi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 111
Figura 5.4 - Pacchetto solaio
5.1.3.2 - Colonne
La colonna utilizzata è di tipo continua. Data l’altezza si è provveduto a collegare, mediante
collegamenti con doppio coprigiunto d’anima e d’ala, quattro profili per ciascuna colonna.
Partendo dal basso i primi due profili mantengono la stessa sezione, successivamente i
restanti due profili diminuiscono progressivamente di area. I vari profili che costituiscono
l’intera colonna, partendo dal basso verso l’alto sono lunghi rispettivamente 6,8,10 e 9 m. I
profili utilizzati sono riassunti nella seguente tabella.
Tabella 5.1 - Profili colonne [22]
5.1.3.3 - Controventi
Nella struttura si è reso necessario solamente l’utilizzo di controventi verticali, per i quali
sono stati impiegati profili tubolari cavi, recanti alle estremità delle pinze appositamente
sagomate per il collegamento di questi ultimi alle piastre saldate alle colonne. Tutti i
collegamenti dei controventi sono stati realizzati mediante perni. La tabella sottostante
indica la gamma dei profili impiegati.
Tabella 5.2 - Profili utilizzati per i controventi [22]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 112
5.1.3.4 - Vano Scala e Ascensore In tutta la struttura sono presenti cinque vani scala e ascensore, i quali sono collocati
ciascuno all’interno di una maglia di lato 7,5m ed equamente distribuiti lungo lo sviluppo
della costruzione. Al centro della maglia sono presenti un nucleo ascensore porta lettighe ed
un ascensore di dimensioni più ridotte.
Figura 5.5 - Tipologie di ascensori [22]
Sono stati scelti come ascensore montalettighe quello di dimensione in pianta di 330 x 240
cm con portata massima di 2000 kg e l’altro di dimensione in pianta di 180 x 240 cm con
portata massima di 630 kg.
La scala si snoda intorno a questi due corpi ed è realizzata mediante due rampe parallele
collegate tramite un pianerottolo intermedio. Ciascuna rampa è realizzata attraverso una
coppia di cosciali paralleli collegati, mediante unioni bullonate con squadrette, a delle
colonne appositamente previste per lo scopo. A livello di piano è presente un solaio con
pannelli alveolari precompressi come quello precedentemente descritto, mentre il
pianerottolo è costituito da lastre di vetro satinato sorrette da una serie di travi. Gli elementi
strutturali usati per il corpo scala ascensore sono profili a doppio T per le colonne, IPE per
le travi, UPN per i cosciali, per i controventi di questi ultimi e del telaio ascensore, profili
tubolari cavi per il collegamento trasversale dei cosciali.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 113
5.1.3.5 - Fondazioni La tipologia di fondazione utilizzata è una fondazione a plinti isolati collegati da cordoli.
Solo al di sotto del corpo scala ascensore viene realizzata una piccola platea. I plinti
possono essere raggruppati in base alla geometria in tre tipologie fondamentali:
PL1: 1,5x1,5 m in pianta e 1 m in profondità;
PL2: 1,8x1,8 m in pianta e 1 m in profondità;
PL3: 2,5x2,5 m in pianta e 1,5 m in profondità
5.1.4 - Materiali
In seguito si riportano le principali caratteristiche dei materiali utilizzati per la parte
strutturale dell’opera. In allegato verranno riportate le schede tecniche sia di questi materiali
che di quelli per uso non strutturale.
5.1.4.1 - Acciaio da carpenteria metallica
Gli acciai utilizzati per gli elementi strutturali travi, colonne, cosciali, controventi del telaio
ascensore, piatti di rinforzo nei collegamenti sono appartenenti alle classi riportate in
tabella:
Tabella 5.3 - Laminati a caldo con profili a sezione aperta [5]
Mentre per quanto riguarda gli elementi di controventamento si fa riferimento alla seguente
tabella:
Tabella 5.4 - Laminati a caldo con profili a sezione cava [5]
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali
delle proprietà dell’acciaio:
modulo elastico E = 210.000 N/mm²
modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm²
coefficiente di Poisson ν = 0,3
coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
(per temperature fino a 100 °C)
densità ρ = 7850 kg/m3

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 114
5.1.4.2 - Acciaio per bulloni e connessioni
Per le varie unioni bullonate sono stati impiegati bulloni di classe 6.8 e 8.8 aventi le
seguenti caratteristiche:
Tabella 5.5 - Classi bulloni e corrispondenti tensioni di snervamento e rottura [22]
5.1.4.3 - Acciai speciali
Per tutte le connessioni a perno e per i tirafondi impiegati nei collegamenti di fondazione tra
colonne e plinti, sono stati utilizzati acciai speciali per grossa bulloneria aventi le seguenti
caratteristiche:
Tabella 5.6 - Acciai speciali per grossa bulloneria [22]
5.1.4.4 - Acciaio per cemento armato
L’acciaio utilizzato nelle parti in cemento armato è del tipo B450C, caratterizzato dai
seguenti valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura utilizzate nei calcoli:
Tabella 5.7 - Valori nominali delle tensioni di snervamento e rottura [5]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 115
e conforme al rispetto dei seguenti requisiti previsti dalle NTC08:
Tabella 5.8 - Requisiti richiesti dalle norme per acciaio B450C [5]
5.1.4.5 - Acciaio per cemento armato precompresso
Per i pannelli di solaio alveolare precompresso sono stati utilizzati trefoli a 7 fili di acciaio
dalle seguenti caratteristiche:
Tabella 5.9 - Caratteristiche geometriche e meccaniche dell’acciaio per c.a.p. [22]
5.1.4.6 - Calcestruzzo
In tutta la struttura il calcestruzzo gettato in opera è stato impiegato esclusivamente nella
realizzazione delle fondazioni e della soletta del solaio. In entrambe i casi si è adoperato un
calcestruzzo di classe C28/35.
Per quanto riguarda invece i pannelli alveolari precompressi di cui è composto il solaio, è
stato utilizzato uno di classe C45/55.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 116
Le caratteristiche di tali calcestruzzi sono riassunte in tabella:
Tabella 5.10 - Caratteristiche meccaniche cls C28/35 [22]
Tabella 5.11 - Caratteristiche meccaniche cls C28/35 [22]
5.1.4.7 - Prodotti per uso strutturale
Sono stati utilizzati dispositivi di vincolo dinamico del tipo Fip-industriale OT 40/40 per
trasmettere le sollecitazioni dinamiche prodotte da sisma e vento, evitando così il
martellamento tra le due porzioni di edificio; questi apparecchi consentono comunque le
deformazioni lente, come quelle dovute alle variazioni di temperatura.
Sono stati impiegati, in corrispondenza del giunto strutturale, dei connettori a taglio per il
trasferimento dello stesso tra le due semistrutture al fine di mantenere un comportamento
globale dell’intera costruzione come in assenza del giunto. Tali connettori sono del tipo
HALFEN HSD-CRET 122.
5.2 - AZIONI Si considerano le azioni che interessano la costruzione. I carichi vengono calcolati in base
alle disposizioni del “D.M. 14 gennaio 2008”.
5.2.1 - Carichi verticali
I carichi verticali agenti sulla costruzione sono i carichi permanenti strutturali e non
strutturali e i carichi antropici.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 117
5.2.1.1 - Carichi permanenti strutturali e non strutturali
PIANO TIPO:
Tabella 5.12 - Carichi permanenti strutturali [22]
Tabella 5.13 - Carichi permanenti non strutturali [22]
Tabella 5.14 - Carichi variabili [22]
COPERTURA:
Tabella 5.15 - Carichi permanenti strutturali [22]
Tabella 5.16 - Carichi permanenti non strutturali [22]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 118
Tabella 5.17 - Carichi variabili [22]
5.2.1.2 - Carico Antropico
La destinazione d’uso della struttura è quella di parcheggio e locali per macchinari nei tre
piani interrati e ambienti ad uso ospedaliero per i sei piani fuori terra. Il valore del carico
antropico da considerare è stato richiesto dal committente e valutato pari a 6 kN/m2; fa
eccezione la copertura che viene considerata accessibile per la sola manutenzione, il carico
in questo caso è di 0,5 kN/m2. Sulle scale, che appartengono alla categoria C2, agisce una
pressione pari a 4 kN/m2. Nella tabella sono riassunte le azioni considerate.
Tabella 5.18 - Carichi antropici agenti sulla struttura [22]
5.2.2 – Azione sismica
La normativa attuale propone degli spettri di risposta in funzione al sito di costruzione
(coordinate geografiche), alla classe dell’edificio, alla vita nominale e al tipo di terreno in
cui sorge l’edificio. In particolare, per la struttura in esame, sono riportati i parametri che
hanno permesso la costruzione degli spettri tramite il foglio di calcolo SPETTRI-NTC.
L’ospedale è situato a Rieti:
Figura 5.6 – Individuazione della pericolosità del sito

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 119
Essendo un edificio di pubblica importanza, è stata scelta una vita nominale pari a:
𝑉𝑁 = 100 𝑎𝑛𝑛𝑖
e la classe d’uso III dato che è una costruzione che prevede affollamenti significativi. Il
relativo coefficiente d’uso vale:
𝐶𝑢 = 1,5
Per cui le azioni sismiche vengono valutate in relazione ad un periodo di riferimento VR:
𝑉𝑅 = 𝑉𝑁 ∙ 𝐶𝑢 = 150 𝑎𝑛𝑛𝑖
Figura 5.7 - Scelta della strategia di progettazione
L’azione sismica viene calcolata con riferimento agli stati limite. Si considera una categoria
di terreno C, cioè terreni a grana grossa mediamente addensati, mentre la categoria
topografica risulta essere T1 (superficie pianeggiante). Si considera uno smorzamento
convenzionale pari al 5%.
SITO RIETI
VITA NOMINALE (anni) 100
CLASSE D’USO III
COEFFICIENTE D’USO 1,5
CATEGORIA DI SOTTOSUOLO C
CATEGORIA TOPOGRAFICA T1 Tabella 5.19 - Parametri utili a definire gli spettri di risposta

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 120
Gli spettri ottenuti dal calcolo, riferiti alla componente orizzontale del moto sismico (l’unica
che si considera), sono riportati in figura.
Grafico 5.1 - Spettri di risposta elastici (componente orizzontale)
5.2.2.1 - Combinazione delle azioni
Per quanto concerne la combinazione dell’azione sismica con i carichi verticali la normativa
specifica che questa debba essere effettuata, per gli Stati Limite secondo la formula:
𝐹𝑑 = 𝛾𝐸𝐸 + 𝛾𝐺𝐺𝐾 + 𝛾𝑃𝑃𝐾 + ∑(𝛹2𝑖𝛾𝑄𝑄𝐾𝑖)
𝑖
dove:
E rappresenta l’azione sismica per lo stato limite considerato e per la classe di
importanza in esame;
GK rappresenta il valore caratteristico della azione permanente (peso proprio, carichi
permanenti portati, precompressione, ecc);
QK rappresenta il valore caratteristico dell'azione variabile;
PK rappresenta il valore caratteristico della deformazione impressa (effetto della
temperatura, deformazione del terreno, viscosità, ritiro, etc.);
γE, γG, γQ, γP rappresentano i coefficienti parziali;
𝝭2i sono i coefficienti di combinazione delle azioni variabili.
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Se [
g]
T [s]
SLC
SLV
SLD
SLO

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 121
5.3 - SCELTE PROGETTUALI
5.3.1 - Scelte progettuali globali L’opera in questione sarà adibita ad uso ospedaliero. Risulta quindi essere una costruzione
di notevole importanza, non solo in relazione alle funzioni svolte al suo interno, ma anche
riguardo le dimensioni.
Per quanto riguarda le scelte progettuali globali, la strategia di progettazione adottata è stata
quella per specializzazione. Ciò significa che si sono voluti individuare due sistemi
resistenti differenti per resistere ai carichi verticali e orizzontali. Si è scelto di realizzare una
struttura nella quale i percorsi di carico dalla sommità fino in fondazione fossero chiari e
facilmente individuabili. Tale scelta comporta anche la possibilità di operare una
ottimizzazione locale degli elementi, i quali assolvono solamente alla funzione specifica per
la quale sono stati progettati, e inoltre in presenza di eventuali danneggiamenti si ha il
vantaggio di poter procedere a una manutenzione più semplice e mirata, sostituendo
direttamente gli elementi messi fuori servizio. Tuttavia questa strategia di progettazione
porta con se anche dei possibili svantaggi, quali la canalizzazione di elevate concentrazioni
di tensione in zone localizzate, come ad esempio gli scarichi dei controventi in fondazione.
Di tutto ciò si è tenuto conto cercando, nonostante la specializzazione dei diversi sistemi
resistenti, di distribuire, nel rispetto dei vincoli progettuali, i controventi nei vari telai della
struttura.
Il sistema resistente ai carichi verticali è costituito dalle colonne, dalle travi binate e dal
solaio alveolare precompresso. Il vantaggio di adottare questa scelta rispetto a un più
classico solaio con travi principali, secondarie e lamiera grecata, è stato quello di avere una
maggiore resistenza al fuoco, un minor numero di connessioni da realizzare tra travi
principali e secondarie, una posa in opera dei pannelli facile e rapida, ed è stato dettato
anche da esigenze di tipo architettonico che limitavano l’altezza massima del pacchetto
solaio.
Il sistema resistente ai carichi orizzontali è costituito invece dai controventi, per i quali si è
scelta una configurazione che li vedesse distribuiti abbastanza uniformemente nell’ambito
dei vari telai, sempre nel rispetto dei vincoli architettonici. Questa scelta è stata fatta anche
cercando di evitare, per quanto possibile, un eccessiva concentrazione di tensioni localizzata
in fondazione nelle zone di scarico degli stessi.
Per quanto riguarda la scelta progettuale sulla tipologia di fondazioni da adottare, si è deciso
per una fondazione diretta, nello specifico una fondazione su plinti collegati tra loro
mediante cordoli per garantire alla fondazione un comportamento d’insieme sotto azioni
sismiche; solo al di sotto del corpo scala ascensore viene realizzata una piccola platea.
5.3.2 - Scelte progettuali locali
Unione trave-trave
L’unione tra il moncone di trave saldato alla colonna e le travi forate ISE è stata prevista ad
una distanza di 500 mm a partire dalla fine dell’ala della colonna, il collegamento è
realizzato con coprigiunti d’ala e d’anima bullonati alle due parti in modo da ripristinare
totalmente la continuità dell’elemento.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 122
Per i coprigiunti è stato utilizzato lo stesso tipo di acciaio della colonna.
Figura 5.8 - Unione trave-trave [22]
Unione colonna-colonna
L’unione tra i diversi profili delle colonne è stato realizzato al livello di piano, questa scelta
è stata fatta sia per poter ottimizzare al meglio i profili scelti che per nascondere il
collegamento all’interno del solaio. Questo collegamento è realizzato con coprigiunti d’ala e
d’anima bullonati alle due parti in modo da ripristinare totalmente la continuità
dell’elemento.
Figura 5.9 - Unione colonna-colonna [22]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 123
Unione colonna-travi-controventi
In corrispondenza del nodo analizzato, convergono due controventi sullo stesso lato, uno dal
basso e uno dall’alto, costituiti da profili tubolari collegati mediante unioni a perno, ad un
piatto saldato al centro dell’ala della colonna in corrispondenza dell’anima. I controventi
hanno alle estremità delle pinze sagomate in modo tale che il collegamento avvenga facendo
entrare il piatto saldato, che sporge dalla colonna, nella pinza e in seguito si possano unire
questi piatti tramite un perno.
Figura 5.10 - Unione colonna-travi-controventi [22]
Unione trave-controventi a V rovescia
In corrispondenza dell’ultimo piano della struttura, in diversi telai del lato corto sono stati
inseriti dei controventi a V rovescia, costituiti sempre da profili tubolari collegati, mediante
unioni a perno, in basso ad un piatto saldato sull’ala della colonna e in alto in
corrispondenza di un piatto saldato al centro della trave, facente parte del telaio, sotto l’ala
inferiore. I controventi hanno alle estremità delle pinze sagomate in modo tale che il
collegamento avvenga facendo entrare il piatto saldato, che sporge dalla colonna, nella
pinza e in seguito si possano unire questi piatti tramite un perno. Per quanto riguarda la
parte superiore, i controventi presentano all’estremità un piatto asimmetrico rispetto all’asse
in modo tale che le estremità dei controventi durante la posa in opera risultino ciascuna sui
lati opposti del piatto saldato alla trave e in seguito il collegamento possa avvenire sempre
attraverso il perno che attraversa i tre piatti.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 124
Figura 5.11 - Unione trave-controventi a V rovesvia [22]
Unione colonna-plinto di fondazione
Il collegamento tra le colonne e i plinti di fondazione è stato progettato come vincolo ideale
di incastro. Le colonne in acciaio vengono vincolate a terra mediante una struttura di
fondazione costituita da un plinto in cemento armato,
Figura 5.12 - Plinto per colonna in acciaio
con forma parallelepipeda, alla quale le colonne vengono collegate tramite una piastra di
base e bulloni semplicemente annegati nel calcestruzzo del plinto.
Figura 5.13 - Collegamento colonna-plinto

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 125
5.4 - MODELLAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI
5.4.1 - Modellazione del solaio Il solaio è stato modellato in SAP 2000 mediante elementi bidimensionali di piastra “shell”,
di forma rettangolare o triangolare a seconda delle esigenze geometriche imposte dallo
sviluppo in pianta della struttura.
Le caratteristiche degli elementi shell sono determinate in modo tale che il modello risulti
equivalente al solaio reale in termini di rigidezze di piano e flessionali, mentre la massa
strutturale è stata posta pari a zero e assegnata successivamente come carico uniformemente
distribuito sulla superficie dell’elemento stesso.
Figura 5.14 - Solaio alveolare [22]
Lo spessore dell’elemento finito definito col nome di “membrana” è stato calcolato
imponendo che l’area per unità di lunghezza del solaio sia la stessa che nel caso reale,
mentre quello indicato con il nome di “flessione” è stato determinato uguagliando le inerzie
flessionali:
Figura 5.15 - Caratteristiche del solaio [22]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 126
La rigidezza dell’elemento shell associata allo spessore “h” considerato, eguaglia solamente
quella effettivamente presente nel solaio alveolare nella direzione di maggior rigidezza,
ossia quella degli alveoli, pertanto si è inserito in SAP, nella casella “Modificatori
rigidezza” presente nella finestra di definizione della sezione dell’elemento shell, un
coefficiente correttivo, pari al rapporto tra la rigidezza flessionale del solaio nella direzione
di minor rigidezza e la rigidezza dell’elemento shell associata allo spessore “h”, in modo da
eguagliare quelle presenti nel solaio reale.
Figura 5.16 - Finestra definizione caratteristiche elemento [22]
L’ipotesi fatta è che il solaio abbia comportamento prevalentemente unidirezionale vista
l’ortotropia.
Questi coefficienti sono stati ottenuti come spiegato di seguito:
Coefficienti delle rigidezze flessionali m11, m22, m12 ottenuti come rapporto tra
l’inerzia per unità di lunghezza del solaio reale e l’inerzia dell’elemento shell nella
direzione considerata;
Coefficienti delle rigidezze di piano f11, f22, f12 ottenuti come rapporto tra le aree per
unità di lunghezza del solaio reale e l’area dell’elemento shell, nella direzione
considerata;
Coefficienti di taglio V13, V23 ottenuti come i precedenti, dipendentemente dalla
direzione considerata
Gli elementi shell inseriti per costruire il modello del solaio hanno il sistema di riferimento
locale orientato come mostrato in figura, dove l’asse 1 è quello avente colore rosso e
parallelo all’asse y, l’asse 2 avente colore bianco parallelo all’asse x, e l’asse 3 ortogonale al
piano individuato dai precedenti ed ortogonale all’asse z.
Figura 5.17 - Sistema di riferimento locale delle shell [23]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 127
Il modello, con un solaio realizzato con elementi shell, è risultato computazionalmente
troppo oneroso (8 ore di calcolo tramite il programma SAP 2000) se sottoposto ad analisi
statica non lineare. Tale onere computazionale è stato ridotto (di 5 ore) sostituendo gli
elementi shell con un diaframma rigido per ciascun piano e inserendo le masse mancanti
nel relativo master joint di piano.
5.4.2 - Modellazione delle travi
Gli elementi strutturali, quali in particolare travi, pilastri e controventi, sono modellati
attraverso elementi monodimensionali indicati nel programma con nome di “frame”, a
ciascuno dei quali assegnata la corrispondente sezione.
Figura 5.18 - Trave modellata tramite elementi "frame" [23]
L’elemento Frame è rappresentato da una linea retta che congiunge due punti, i e j (nodi),
ognuno dei quali ha sei gradi di libertà (3 traslazioni e 3 rotazioni). Ciascun elemento ha il
proprio sistema di coordinate locale per la definizione delle proprietà della sezione e dei
carichi e per l’interpretazione dei risultati. Gli assi di questo sistema locale sono indicati con
i numeri 1, 2 e 3; il primo asse è diretto lungo l’elemento, gli altri due giacciono nel piano
perpendicolare ad esso.
Figura 5.19 - Sistema di riferimento locale dell'elemento "frame" [23]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 128
Per quanto riguarda la modellazione dei vincoli alle estremità delle travi dei telai
perimetrali, essendo queste collegate alle colonne mediante cerniere, vengono assegnati dei
“release” , ovvero rilasci, di momento.
Figura 5.20 - Assegnazione dei release alle travi [22]
Per le travi binate sono stati modellati due frame paralleli, distanti tra loro 58 cm. Esse sono
poi collegate alla colonna attraverso dei bracci rigidi. Per quanto riguarda le caratteristiche
inerziali, non è sufficiente assegnare le sezione poiché essa non ha rigidezza costante, per
effetto dei fori alveolari ed inoltre è una trave mista acciaio-calcestruzzo e quindi bisogna
tener conto del contributo dato dalla soletta. E’ stato quindi necessario ricavare la corretta
rigidezza della stessa, ricorrendo ad una modellazione di dettaglio agli elementi finiti.
L’inerzia della trave è stata valutata imponendo una forza unitaria distribuita o concentrata
nella mezzeria e leggendo la freccia della trave, nota la quale sono invertibili le relazioni
note da scienza delle costruzioni per una trave appoggiata:
𝐽 =𝑝 ∙ 𝑙3
48 ∙ 𝑓 ∙ 𝐸
𝐽 =5 ∙ 𝑝 ∙ 𝑙3
384 ∙ 𝑓 ∙ 𝐸
La prima relazione è per una trave appoggiata con carico concentrato, mentre la seconda con
carico distribuito.
Sono stati introdotti più modelli per valutare come la modalità con la quale è stato assegnato
il carico influisce sulla rigidezza. I risultati osservati sono riportati sulla tabella che segue :
1. trave in acciaio modellata come elemento frame con sezione costante (HEA
400x280) e carico unitario applicato distribuito lungo l’elemento;
2. trave in acciaio modellata con elementi shell con sezione costante (HEA 400x280) e
carico unitario applicato distribuito lungo l’elemento;

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 129
3. trave in acciaio modellata con elementi shell e fori esagonali con carico unitario
distribuito;
4. trave in acciaio modellata con elementi shell e fori esagonali con carico unitario
concentrato in mezzeria;
5. trave mista acciaio-calcestruzzo modellata con elementi shell e fori esagonali con
carico unitario concentrato in mezzeria
Modello Elemento finito I (mm4) 1 Frame 294x106
2 Shell 297x106
3 Shell 259x106
4 Shell 258x106
5 Shell 757x106 Tabella 5.20 - Inerzie per i diversi modelli [22]
Dai primi due modelli si è verificata la correttezza della modellazione elementi shell; dal
terzo e dal quarto si è osservata l’influenza sulla rigidezza di come è stato applicato il
carico. Essendo quest’ultima non significativa, nel modello 5, si è inserito anche il blocco di
calcestruzzo collaborante e valutata I applicando una forza unitaria concentrata.
Ricavata l’inerzia della sezione mista acciaio- calcestruzzo, questa è stata introdotta nel
modello globale assegnando un elemento frame con sezione in acciaio HEA 400x280, e
intervenendo sui modificatori come riportato sotto. Nello specifico si è ridotta la massa, per
tenere conto dei fori e incrementata l’inerzia come rapporto tra quella della sezione in
acciaio e quello della sezione mista.
Figura 5.21 - Modificatori proprietà/rigidezza per la trave alveolare modellata con elemento frame [22]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 130
5.4.3 - Modellazione delle colonne Anche le colonne ed i controventi, come specificato sopra, sono state modellate attraverso
elementi frame aventi sezioni di area opportuna. Per le colonne sono state previste tre
rastremazioni.
Figura 5.22 - Rastermazione delle colonne [22]
N° rastremazione Z [m]
1° 12
2° 22,5
3° 33 Tabella 5.21 - Rastremazioni delle colonne [22]
La soluzione scelta prevede che l’unione tra colonne di sezioni differenti sia di tipo
bullonata ed eseguita direttamente in cantiere. Le colonne infine vengono realizzate tutte in
continuità.
5.4.4 - Posizionamento e modellazione dei controventi Sebbene la scelta del sistema finale di controventamento sia giunta a termine di un processo
iterativo che ha portato a una soluzione finale totalmente diversa da quella ipotizzata in
partenza, tuttavia la modellazione dei controventi è stata eseguita sempre utilizzando, com’è
ovvio, elementi frame, ai quali, durante i vari tentativi, è stata cambiata di volta in volta
sezione e/o posizionamento.
Nelle varie configurazioni adottate prima di giungere a quella definitiva, il fattore comune a
tutte è stato il vincolo progettuale che impediva di posizionare controventi nei telai
perimetrali del lato lungo e la necessità di prevedere spazi sufficienti per l’accesso ai vari
ambienti, accessi che secondo un architettonico di massima realizzato in fase preliminare,
sono stati previsti per la maggior parte nei telai del lato lungo.
Tutti i controventi a croce sono stati posti in modo da comprendere due piani, analogamente
anche la maggior parte dei controventi in direzione X, tranne quelli di piano terra in tutte e
due le direzioni e quelli dell’ultimo piano nella direzione Y.
Anche ai controventi, come alle travi, vengono assegnati i “release” dei momenti in quanto
si vuole che il loro collegamento alle colonne schematizzi una cerniera.
La scelta progettuale relativa al posizionamento dei controventi è stata effettuata tenendo in
considerazione due aspetti fondamentali:

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 131
Il comportamento dinamico dell’edificio ed in particolare i suoi modi naturali di
vibrare;
Le limitazioni imposte dai vincoli architettonici, presenti sia all’interno della
struttura, dovuti alla divisione degli ambienti, che all’esterno, legati invece alle
necessità estetiche di mantenere libere le facciate.
5.5 - MODELLAZIONE DELLA STRUTTURA Il modello si può sintetizzare in tre punti salienti:
1. La struttura è formata da tre tipi di telai:
telai perimetrali incastrati alla base con travi collegate alle colonne da nodi
cerniera
Figura 5.23 - Telaio perimetrale nel piano XZ
Figura 5.24 - Telaio perimetrale nel piano YZ
telai nel piano XZ incastrati alla base con travi binate collegate alle colonne
da nodi incastro
Figura 5.25 - Telaio interno nel piano XZ

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 132
telai nel piano YZ incastrati alla base con controventi collegati alle colonne
da nodi cerniera
Figura 5.26 - Telaio interno nel piano YZ
2. Sono stati inseriti controventi a trazione/compressione con profili tubolari cavi che, a
parità di area sbandano per un N di buckling molto più alto e si prestano a lavorare
meglio a trazione/compressione.
3. Si incastrano tutte le travi binate alle colonne. Questa soluzione si è posta a seguito
della decisione su come realizzare le connessioni dei vari elementi strutturali nei nodi
dove convergono contemporaneamente colonna, travi binate, controventi. Avendo
previsto, per risolvere il suddetto problema, che le colonne dovessero uscire dallo
stabilimento già con i due monconi di trave saldati parallelamente sulle due ali, si è
provveduto a modificare nel modello globale il vincolo tra questi ultimi due elementi
strutturali, passando da cerniera a incastro.
5.5.1 - Modellazione delle cerniere plastiche
5.5.1.1 - Cerniere plastiche assiali
La struttura è composta da due sistemi diversi di controventamento per le due direzioni
principali.
Per il lato corto sono stati utilizzati controventi a croce (su due piani) per tutti i piani tranne
l’ultimo dove sono presenti controventi a V rovescia.
Per il lato lungo sono stati utilizzati sempre controventi a due piani che però non si
intersecano tra di loro. Questa scelta è maturata da esigenze architettoniche che prevedono
l’inserimento di porte nella parte centrale del telaio considerato.
Nelle aste dei controventi del lato lungo sono state assegnate delle cerniere plastiche assiali
che si distinguono per la dimensione della sezione e per la lunghezza dell’asta.
Nelle aste dei controventi del lato corto sono state assegnate delle cerniere plastiche assiali
che si distinguono per la dimensione della sezione, per la lunghezza dell’asta, per la
posizione e il numero di cerniere all’interno dell’asta.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 133
5.5.1.1.1 - Cerniere plastiche assiali nel piano XZ (lato lungo)
Per il lato lungo sono stati utilizzati controventi a due piani che però non si intersecano tra
di loro, e quindi è stato possibile inserire a ciascun asta una cerniera plastica al centro
essendo lo sforzo assiale costante su tutta la lunghezza del controvento.
Sezione L [m] Legame cerniera
177,8x6 10,26 Tipo 1
219,1x8 10,26 Tipo 2
244,5x8
10,26 Tipo 3
10,61 Tipo 4
10,97 Tipo 5
273x10 5,48 Tipo 6 Tabella 5.22 - Elenco dei legami usati per le cerniere plastiche assiali nel piano XZ
Tipo 1
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -49,8 -0,0132
D- -49,8 -0,0016
C- -209,4 -0,0016
B- -206,3 0,0000
A 0,0 0,0000
B 760,9 0,0000
C 1012,0 0,1263
D 608,7 0,1263
E 608,7 0,1607 Tabella 5.23 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.2 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 134
Tipo 2
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -96,9 -0,0134
D- -96,9 -0,0022
C- -492,0 -0,0022
B- -484,7 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1246,9 0,0000
C 1658,4 0,1263
D 997,5 0,1263
E 997,5 0,1607 Tabella 5.24 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.3 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Tipo 3
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -130,6 -0,0161
D- -130,6 -0,0027
C- -662,8 -0,0027
B- -653,0 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1396,8 0,0000
C 1857,8 0,1263
D 1117,5 0,1263
E 1117,5 0,1607 Tabella 5.25 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 135
Grafico 5.4 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Tipo 4
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -123,9 -0,0158
D- -123,9 -0,0026
C- -628,9 -0,0026
B- -619,6 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1396,8 0,0000
C 1857,8 0,1306
D 1117,5 0,1306
E 1117,5 0,1662 Tabella 5.26 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.5 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20
F [K
N]
Spostamento [m]
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
-0,04 -0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 136
Tipo 5
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -117,4 -0,0155
D- -117,4 -0,0026
C- -595,9 -0,0026
B- -587,1 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1396,8 0,0000
C 1857,8 0,1350
D 1117,5 0,1350
E 1117,5 0,1718 Tabella 5.27 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.6 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Tipo 6
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -341,5 -0,0162
D- -341,5 -0,0027
C- -1733,1 -0,0027
B- -1707,5 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1941,6 0,0000
C 2582,3 0,0675
D 1553,3 0,0675
E 1553,3 0,0859 Tabella 5.28 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 137
Grafico 5.7 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
5.5.1.1.2 - Cerniere plastiche assiali nel piano YZ (lato corto)
Per il lato corto sono stati utilizzati controventi a croce, nei quali sono state inserite due
cerniere plastiche alle estremità, e controventi a V rovescia, nei quali è stata inserita una
cerniera plastica al centro.
In questo caso è stato utile distinguere i controventi a croce da quelli a V rovescia per
facilitare la lettura della sequenza delle plasticizzazioni.
Cerniere plastiche assiali nei controventi a V rovescia
Sezione L [m] Legame cerniera Posizione cerniera
177,8x6 5,13 Tipo 7
al centro 219,1x8 10,97 Tipo 8
273x8 5,48 Tipo 9 Tabella 5.29 - Elenco dei legami usati per le cerniere plastiche assiali nel piano YZ
Tipo 7
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -112,0 -0,0199
D- -112,0 -0,0020
C- -430,5 -0,0020
B- -424,2 0,0000
A 0,0 0,0000
B 602,8 0,0000
C 801,7 0,0631
D 482,2 0,0631
E 482,2 0,0804 Tabella 5.30 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 138
Grafico 5.8 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Tipo 8
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -86,5 -0,0128
D- -86,5 -0,0021
C- -439,2 -0,0021
B- -432,7 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1246,9 0,0000
C 1658,4 0,1350
D 997,5 0,1350
E 997,5 0,1718 Tabella 5.31 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.9 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
F [K
N]
Spostamento [m]
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 139
Tipo 9
Punto F (KN) SPOST.(m)
E- -275,8 -0,0162
D- -275,8 -0,0027
C- -1399,6 -0,0027
B- -1378,9 0,0000
A 0,0 0,0000
B 1565,1 0,0000
C 2081,6 0,0675
D 1252,1 0,0675
E 1252,1 0,0859 Tabella 5.32 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Grafico 5.10 - Legame FORZA-SPOSTAMENTO
Cerniere plastiche assiali nei controventi a croce
Per le cerniere dei controventi a croce sono state inserite due cerniere a posizioni relative
all’interno dell’elemento di 0 e 1, ciascuna con proprietà di deformazione basate su una
lunghezza di cerniera assunta pari ad 1
2 della lunghezza dell’elemento.
In questo caso abbiamo deciso di esprimere il legame non come forza-deformazione ma
come STRESS-STRAIN per facilitare l’assegnazione nel programma SAP2000.
Sezione L [m] Legame cerniera Posizione cerniera
219,1x8 10,26 Tipo 10
alle due estremità
244,5x8
10,26 Tipo 11
10,61 Tipo 12
10,97 Tipo 13 Tabella 5.33 - Elenco dei legami usati per le cerniere plastiche assiali nel piano YZ
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
-0,02 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10
F [K
N]
Spostamento [m]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 140
Tipo 10
Punto σ (KN/m2) ε(-)
E- -18271,6 -0,0013
D- -18271,6 -0,0002
C- -92728,5 -0,0002
B- -91358,2 0,0000
A 0,0 0,0000
B 235000,0 0,0000
C 312550,0 0,0123
D 188000,0 0,0123
E 188000,0 0,0157 Tabella 5.34 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
Grafico 5.11 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
Tipo 11
Punto σ (KN/m2) ε(-)
E- -21970,8 -0,0016
D- -21970,8 -0,0003
C- -111501,9 -0,0003
B- -109854,1 0,0000
A 0,0 0,0000
B 235000,0 0,0000
C 312550,0 0,0123
D 188000,0 0,0123
E 188000,0 0,0157 Tabella 5.35 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020
σ [
KN
/m2 ]
ε [-]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 141
Grafico 5.12 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
Tipo 12
Punto σ (KN/m2) ε(-)
E- -20847,1 -0,0015
D- -20847,1 -0,0002
C- -105799,0 -0,0002
B- -104235,5 0,0000
A 0,0 0,0000
B 235000,0 0,0000
C 312550,0 0,0123
D 188000,0 0,0123
E 188000,0 0,0157 Tabella 5.36 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
Grafico 5.13 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020
σ [
KN
/m2 ]
ε [-]
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020
σ [
KN
/m2 ]
ε [-]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 142
Tipo 13
Punto σ (KN/m2) ε(-)
E- -19755,1 -0,0014
D- -19755,1 -0,0002
C- -100257,2 -0,0002
B- -98775,6 0,0000
A 0,0 0,0000
B 235000,0 0,0000
C 312550,0 0,0123
D 188000,0 0,0123
E 188000,0 0,0157 Tabella 5.37 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
Grafico 5.14 - Legame TENSIONE-DEFORMAZIONE
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
-0,004 -0,002 0,000 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018
σ [
KN
/m2
]
ε [-]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 143
5.5.1.2 - Cerniere plastiche flessionali
E’ stato definito un solo tipo di cerniera flessionale poiché la struttura ha solo i telai interni
del lato lungo a nodi colonna-travi rigidi e le travi hanno tutte la stessa sezione e la stessa
lunghezza.
Le caratteristiche della sezione della trave sono mostrate nella finestra del SAP 2000:
Figura 5.27 - Proprietà della sezione della trave
Tipo 14
Figura 5.28 – Legame MOMENTO-ROTAZIONE

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 144
5.5.1.3 - Cerniere plastiche presso-flessionali
Le cerniere plastiche presso-flessionali delle colonne sono state inserite con il comando
“AUTO” del SAP2000. In questo modo il programma prende tutti i parametri utili a definire
le cerniere plastiche direttamente dalle tabelle della FEMA-356.
Nelle seguenti figure è mostrata la procedura per l’inserimento delle cerniere plastiche
presso-flessionali di una colonna posizionata alla base della struttura (HE360M):
Figura 5.29 - Interazione P-M2-M3
Figura 5.30 - Numeri e valori di forze assiali e angoli

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 145
Figura 5.31 - Legame Momento-Rotazione
Figura 5.32 - Definizione della curva di interazione P-M2-M3

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 146
Con la stessa procedura sono state definite le cerniere plastiche delle restanti colonne
posizionate alla base e alla sommità di ciascuna colonna.
Sezione H [m] Legame cerniera
HE300B 4 Tipo 15
HE300M 3,5 Tipo 16
HE320A 3,5 Tipo 17
4 Tipo 18
HE320B 3,5 Tipo 19
HE340A 3,5 Tipo 20
HE340B 3,5 Tipo 21
HE360M 4 Tipo 22 Tabella 5.38 - Elenco dei legami usati per le cerniere plastiche presso-flessionali

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 5 147
5.6 - BIBLIOGRAFIA
[5] NTC (2008), “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 14 Gennaio 2008.
[22] Necci S., Schwarz R., Valleriani D., “Esame di costruzioni metalliche: progetto di un
edificio in acciaio adibito ad uso ospedaliero”, Anno Accademico 2009-2010.
[23] Computers and Structures, Inc. (2010), “SAP2000® Help, Linear and Nonlinear Static
and Dynamic Analysis and Design of Three Dimensional Structures ”, Berkeley, California
(USA), 2010.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 148
6 - ANALISI NON LINEARE STATICA DELL’OSPEDALE
6.1 - IMPOSTAZIONE DEI SCENARI DI CARICO E PARAMETRI DI ANALISI
L’analisi viene eseguita impostando in successione i seguenti scenari di carico:
Si imposta un primo “load case”, che chiamiamo “push-v” ,di analisi non lineare a
“Load control” per carichi verticali. Come carico è stato impostato il peso proprio, il
carico permanente strutturale e non, il carico antropico, il carico dovuto alle
tamponature e ai tramezzi.
Figura 6.1 - Analisi non lineare push-v.
Si crea un successivo caso di analisi non-lineare, chiamato “pushover”, che avrà
come base di partenza il precedente e si riferirà ad uno scenario di carico orizzontale
appositamente definito. Questo caso sarà a “displacement control”.
Figura 6.2 - Analisi non lineare pushover.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 149
Figura 6.3 - Tendina definizione dell’applicazione del carico
Figura 6.4 - Tendina definizione dei risultati salvati
Figura 6.5 - Tendina definizione dei parametri non lineari

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 150
La definizione dei risultati salvati e dei parametri non lineari è dipesa da varie ragioni:
Minore approssimazione nel calcolo
Maggiore accuratezza nel tracciamento della curva pushover
Problemi di convergenza della soluzione a ciascun step
Tempo di calcolo non eccessivo (< 4 ore)
6.2 - ANALISI PUSHOVER E RELATIVE DISTRIBUZIONI DI FORZE
Bisogna scegliere i modi di vibrare significativi nelle due direzioni X e Y utili per la
definizione della distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la deformata di un
modo di vibrare.
Per fare questo si considerano i valori di partecipazione di massa ottenuti con l’analisi
modale della struttura.
Massa modale partecipante
Modo di vibrare Periodo Direzione X Direzione Y
[s] [%] [%]
I Modo Principale (dir.Y) 1,062 0 55
I Modo Principale (dir.X) 0,805 59 0
II Modo Principale (dir.Y) 0,423 0 30
II Modo Principale (dir.X) 0,363 29 0
III Modo Principale (dir.Y) 0,205 0 9
Massa modale partecipante cumulata 88 94 Tabella 6.1 - Valori di partecipazione di massa ottenuti con SAP2000
Grafico 6.1 – Modi principali di vibrare nella direzione X e Y
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Se [
g]
T [s]
Sp.elastico
I MODO dir.Y
II MODO dir.Y
III MODO dir.Y
I MODO dir.X
II MODO dir.X
Amplificazione
Mx = 29%
Mx = 59%
My = 9%My = 30%
My = 55%

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 151
Per la struttura in esame si svolgono le seguenti analisi pushover:
1. con distribuzione uniforme di forze, da intendersi come derivata da una distribuzione
uniforme di accelerazioni lungo l’altezza della costruzione.
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖
𝑀𝑡𝑜𝑡
PIANO MASSA Mi / Mtot F
[n°] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 0,03 2,63
8 5729,35 0,07 6,85
7 5727,37 0,07 6,84
6 5769,82 0,07 6,89
5 5777,98 0,07 6,90
4 5794,44 0,07 6,92
3 17507,763 0,21 20,92
2 17596,97 0,21 21,03
1 17591,16 0,21 21,02
tot 83693,70 1,00 100,00 Tabella 6.2 - Distribuzione delle forze
2. con distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la deformata del I modo
principale di vibrare nella direzione considerata;
Questa distribuzione è possibile secondo le NTC-08 solo se il modo di vibrare
principale nella direzione considerata ha una partecipazione di massa non inferiore al
75%, i valori di partecipazione di massa ottenuti con l’analisi modale della struttura
non confortano.
per la direzione X si ha:
𝑀𝑃(𝐼 𝑚𝑜𝑑𝑜) = 100 ∙ 0,59 = 59% ≤ 75%
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖
PIANO MASSA U φ Mi * φ Mi * φ / (M * φ)tot F
[n°] [KNs2/m] [m] [-] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 0,0075 1,000 2198,85 0,07 7,25
8 5729,35 0,0070 0,923 5289,51 0,17 17,44
7 5727,37 0,0063 0,831 4762,03 0,16 15,70
6 5769,82 0,0054 0,717 4135,97 0,14 13,64
5 5777,98 0,0044 0,584 3374,39 0,11 11,12
4 5794,44 0,0034 0,447 2588,99 0,09 8,54
3 17507,76 0,0019 0,250 4376,36 0,14 14,43
2 17596,97 0,0010 0,139 2440,06 0,08 8,04
1 17591,16 0,0005 0,066 1165,89 0,04 3,84
tot 83693,70 30332,05 1,00 100,00 Tabella 6.3 - Distribuzione delle forze (I modo)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 152
Si calcola il fattore di partecipazione modale Γ definito dalla relazione:
𝛤 =∑ 𝑀𝑖φ𝑖
∑ 𝑀𝑖φ𝑖2
Mi * φ^2 Γ
[KNs2/m] [-]
2198,85 1,627
4883,44
3959,40
2964,78
1970,67 1156,77
1093,94
338,35
77,27
18643,48
Tabella 6.4 - Coefficiente di partecipazione modale (I modo)
per la direzione Y si ha:
𝑀𝑃(𝐼 𝑚𝑜𝑑𝑜) = 100 ∙ 0,55 = 55% ≤ 75%
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖
PIANO MASSA U φ Mi * φ Mi * φ / (M * φ)tot F
[n°] [KNs2/m] [m] [-] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 -0,0082 1,000 2198,85 0,08 8,21
8 5729,35 -0,0073 0,888 5086,70 0,19 19,00
7 5727,37 -0,0063 0,767 4391,54 0,16 16,41
6 5769,82 -0,0052 0,632 3646,06 0,14 13,62
5 5777,98 -0,0041 0,504 2910,83 0,11 10,87
4 5794,44 -0,0029 0,358 2073,48 0,08 7,75
3 17507,76 -0,0018 0,218 3825,15 0,14 14,29
2 17596,97 -0,0009 0,114 2003,85 0,07 7,49
1 17591,16 -0,0003 0,036 630,55 0,02 2,36
tot 83693,70 26767,02 1,00 100,00 Tabella 6.5 - Distribuzione delle forze (I modo)
Si calcola il fattore di partecipazione modale Γ definito dalla relazione:
𝛤 =∑ 𝑀𝑖φ𝑖
∑ 𝑀𝑖φ𝑖2

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 153
Mi * φ^2 Γ
[KNs2/m] [-]
2198,85 1,707
4516,14
3367,28
2304,01
1466,42 741,97
835,73
228,19
22,60
15681,19
Tabella 6.6 - Coefficiente di partecipazione modale (I modo)
3. con distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la deformata dei modi di
vibrare principali (MPA).
In questo caso, essendo la struttura irregolare in altezza, è stato necessario
considerare gli effetti dei modi di vibrare superiori. Il tipo di analisi utilizzata per
risolvere questo problema è la MPA (Analisi Modale Pushover, Chopra e Goel
[2001]), che consiste nel condurre tante analisi Pushover quanti sono i modi di
vibrare significativi utilizzando profili delle forze laterali diversi, che rappresentino
la risposta della struttura relativa a quel modo.
Le diverse curve di capacità così ottenute vengono trasformate in quelle dei sistemi
SDOF equivalenti e successivamente idealizzate rendendole bilineari. Vengono
quindi valutate separatamente le richieste in termini di deformazioni spettanti ad
ognuno dei sistemi SDOF ed infine combinate con il metodo SRSS.
Per la struttura in esame si sono scelte le seguenti distribuzioni di forze
nella direzione X:
i. una distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del I modo principale di vibrare in direzione X
Tale caso è stato già trattato al punto 2 di questo elenco
ii. una distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale di vibrare in direzione X
𝑀𝑃(𝐼𝐼 𝑚𝑜𝑑𝑜) = 100 ∙ 0,29 = 29%
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 154
PIANO MASSA U φ Mi * φ Mi * φ / (M * φ)tot F
[n°] [KNs2/m] [m] [-] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 0,0070 1,000 2198,85 0,09 9,48
8 5729,35 0,0043 0,612 3505,42 0,15 15,11
7 5727,37 0,0023 0,332 1899,00 0,08 8,18
6 5769,82 -0,0002 -0,022 -129,80 -0,01 -0,56
5 5777,98 -0,0022 -0,318 -1838,79 -0,08 -7,92
4 5794,44 -0,0036 -0,514 -2980,66 -0,13 -12,85
3 17507,76 -0,0050 -0,715 -12523,11 -0,54 -53,97
2 17596,97 -0,0035 -0,508 -8938,42 -0,39 -38,52
1 17591,16 -0,0017 -0,250 -4395,90 -0,19 -18,95
tot 83693,70 23203,40 1,00 100,00 Tabella 6.7 - Distribuzione delle forze (II modo)
Si calcola il fattore di partecipazione modale Γ definito dalla relazione:
𝛤 =∑ 𝑀𝑖φ𝑖
∑ 𝑀𝑖φ𝑖2
Mi * φ^2 Γ
[KNs2/m] [-]
2198,85 1,070
2144,74
629,64
2,92
585,18 1533,25
8957,64
4540,29
1098,50
21691,02
Tabella 6.8 - Coefficiente di partecipazione modale (II modo)
nella direzione Y:
i. una distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del I modo principale di vibrare in direzione Y
Tale caso è stato già trattato al punto 2 di questo elenco
ii. una distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale di vibrare in direzione Y
𝑀𝑃(𝐼𝐼 𝑚𝑜𝑑𝑜) = 100 ∙ 0,30 = 30%

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 155
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖
PIANO MASSA U φ Mi * φ Mi * φ / (M * φ)tot F
[n°] [KNs2/m] [m] [-] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 0,0063 1,000 2198,85 0,08 8,39
8 5729,35 0,0042 0,676 3873,31 0,15 14,77
7 5727,37 0,0018 0,291 1665,83 0,06 6,35
6 5769,82 -0,0004 -0,056 -325,67 -0,01 -1,24
5 5777,98 -0,0024 -0,386 -2228,41 -0,08 -8,50
4 5794,44 -0,0037 -0,598 -3467,95 -0,13 -13,23
3 17507,76 -0,0054 -0,862 -15097,44 -0,58 -57,58
2 17596,97 -0,0034 -0,539 -9487,85 -0,36 -36,19
1 17591,16 -0,0012 -0,190 -3350,03 -0,13 -12,78
tot 83693,70 26219,35 1,00 100,00 Tabella 6.9 - Distribuzione delle forze (II modo)
Si calcola il fattore di partecipazione modale Γ definito dalla relazione:
𝛤 =∑ 𝑀𝑖φ𝑖
∑ 𝑀𝑖φ𝑖2
Mi * φ^2 Γ
[KNs2/m] [-]
2198,85 0,970
2618,54
484,51
18,38
859,44 2075,56
13018,94
5115,61
637,97
27027,81
Tabella 6.10 - Coefficiente di partecipazione modale (II modo)
iii. una distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale di vibrare in direzione Y
𝑀𝑃(𝐼𝐼𝐼 𝑚𝑜𝑑𝑜) = 100 ∙ 0,09 = 9%
𝐹𝑖 = 100 ∙𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖
∑ 𝑀𝑖 ∙ 𝜑𝑖𝑖

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 156
PIANO MASSA U [m] φ Mi * φ Mi * φ / (M * φ)tot F [KN]
n° [KNs2/m] [m] [-] [KNs2/m] [-] [KN]
9 2198,85 0,0009 -0,164 -361,52 -0,02 -2,18
8 5729,35 0,0002 -0,031 -176,88 -0,01 -1,07
7 5727,37 -0,0018 0,333 1908,43 0,12 11,52
6 5769,82 0,0000 0,002 11,59 0,00 0,07
5 5777,98 0,0005 -0,089 -516,16 -0,03 -3,12
4 5794,44 0,0008 -0,151 -877,53 -0,05 -5,30
3 17507,76 0,0040 -0,725 -12700,64 -0,77 -76,70
2 17596,97 -0,0055 1,000 17596,97 1,06 106,27
1 17591,16 -0,0036 0,664 11674,95 0,71 70,50
tot 83693,70 16559,21 1,00 100,00 Tabella 6.11 - Distribuzione delle forze (III modo)
Si calcola il fattore di partecipazione modale Γ definito dalla relazione:
𝛤 =∑ 𝑀𝑖φ𝑖
∑ 𝑀𝑖φ𝑖2
Mi * φ^2 Γ
[KNs2/m] [-]
59,44 0,467
5,46
635,91
0,02
46,11 132,90
9213,42
17596,97
7748,46
35438,69
Tabella 6.12 - Coefficiente di partecipazione modale (III modo)
Le distribuzioni sopra elencate sono di tipo invariante.
Le analisi con le prime due distribuzioni conducono a valutazioni della risposta della
struttura approssimate sebbene tale approssimazione sia ancora buona per strutture basse o
medio alte in cui gli effetti dei modi alti sono probabilmente minimi e la plasticizzazione
ben distribuita in altezza.
L’analisi MPA conduce a valutazioni della risposta della struttura migliori poichè
l’irregolarità in altezza della struttura provoca una risposta dinamica caratterizzata non da
un unico modo di vibrare che attiva la quasi totalità della massa, come invece accade per le
strutture regolari, ma da più modi che attivano ciascuno una significativa percentuale della
massa totale.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 157
Le analisi sopra elencate saranno svolte per la stessa struttura senza e con gli effetti P-Δ. Per
ogni analisi si troveranno tramite il metodo N2 le domande della struttura per i quattro stati
limite richiesti dalle NTC 2008.
Adesso è possibile rappresentare tutte le distribuzioni di forze ottenute.
DIREZIONE X:
Figura 6.6 - Vista XZ della struttura ospedaliera
Grafico 6.2 - Distribuzioni di forze convenzionali
0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Proporzionale alle masse(UNIFORME)
Proporzionale al prodottodelle masse per la deformatadel I modo di vibrare lungol'asse X

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 158
Grafico 6.3 - Distribuzioni di forze per la MPA
DIREZIONE Y:
Figura 6.7 - Vista YZ della struttura ospedaliera
0
5
10
15
20
25
30
35
-60,00 -40,00 -20,00 0,00 20,00 40,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Proporzionale al prodottodelle masse per ladeformata del I modo divibrare lungo l'asse X
Proporzionale al prodottodelle masse per ladeformata del II modo divibrare lungo l'asse X

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 159
Grafico 6.4 - Distribuzioni di forze convenzionali
Grafico 6.5 - Distribuzioni di forze per la MPA
0
5
10
15
20
25
30
35
0 5 10 15 20 25
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Proporzionale alle masse(UNIFORME)
Proporzionale al prodottodelle masse per la deformatadel I modo di vibrare lungol'asse Y
0
5
10
15
20
25
30
35
-100,00 -50,00 0,00 50,00 100,00 150,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Proporzionale al prodottodelle masse per la deformatadel I modo di vibrare lungol'asse Y
Proporzionale al prodottodelle masse per la deformatadel II modo di vibrare lungol'asse Y
Proporzionale al prodottodelle masse per la deformatadel III modo di vibrare lungol'asse Y

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 160
In tutte le distribuzioni di forze si ha una forte discontinuità nel passaggio dal terzo al quarto
piano dovuta soprattutto ad una grande variazione di massa di piano proprio a questa altezza
della struttura ospedaliera (irregolarità in altezza).
Infatti si riscontra tale distribuzione delle masse di piano:
PIANO MASSA
[n°] [KN s2/m]
9 2198,85
8 5729,352
7 5727,372
6 5769,818
5 5777,984
4 5794,435
3 17507,763
2 17596,97
1 17591,16 Tabella 6.13 – Valori della massa per ciascun piano
Grafico 6.6 – Masse di piano
I profili di carico proporzionali al prodotto delle masse per la deformata dei modi di vibrare
non dipendono solo dalla distribuzione in altezza delle masse ma anche dalla forma del
modo considerato, infatti i modi superiori al I modo principale di vibrare risultano
importanti ai piani bassi e alti della struttura.
0,00
2000,00
4000,00
6000,00
8000,00
10000,00
12000,00
14000,00
16000,00
18000,00
20000,00
1° piano
2° piano
3° piano
4° piano
5° piano
6° piano
7° piano
8° piano
9° piano
Mp
ian
o[K
N s
2/m
]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 161
6.2.1 - CASO 1: Distribuzione proporzionale alle masse
6.2.1.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.1.1.1 - Distribuzione nella direzione X
1. Dati: si realizza il modello strutturale non lineare del sistema a n-GDL e si definisce
l’azione sismica tramite gli spettri di risposta elastici in accelerazione e spostamento.
Grafico 6.7 - Spettri di Risposta Elastici in Accelerazione e Spostamento (SLC)
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: il formato AD assicura una
interpretazione visiva diretta della procedura. Si procede alla conversione dello spettro di
risposta elastico; le ascisse devono essere determinate in funzione dei valori delle ordinate.
𝑆𝐷𝑒(𝑇) = 𝑆𝑒 ∙ (𝑇
2𝜋)
2
Grafico 6.8 - Curva di Domanda Elastica (ADRS: Acceleration Displacement Response Spectrum)
0
2
4
6
8
10
12
0 10 20 30 40 50
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB (SLC)
TC (SLC)
TD (SLC)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 162
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: il vettore dei carichi
laterali {F} è definito in modo che la distribuzione dei carichi laterali {ψ} si
mantenga costante nel corso dell’analisi e sia correlata alla forma del vettore degli
spostamenti di piano {Ф}.
Grafico 6.9 - Curva di Capacità del sistema reale a MDOF
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente.
a) Il tratto elastico si determina imponendo il passaggio per il punto (0.60-0.70
F∗bu) 𝑘∗ =
0,60 F∗bu
d∗0,60
b) Il tratto plastico è individuato dalla forza di plasticizzazione F*y individuato
uguagliando le aree sottese dalla bilineare e dalla curva di capacità.
Si passa dal sistema MDOF a quello a 1-GDL attraverso il coefficiente di
partecipazione Γ che nel caso di distribuzione proporzionale alle masse è assunto pari
ad 1.
F*bu 0,6F*bu d*c (0,6 F*bu) K* F*u d*u(F*u)
[KN] [KN] [m] [KN/m] [KN] [m]
222653,6 133592,156 0,0538 2483345,276 222448,585 0,239946
F*y [KN] d*y [m] d*u [m] m* [KN s2/m] T* [s]
203863,747 0,0821 0,2399 83693,70 1,153 Tabella 6.14 - Caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare equivalente.
0
30000
60000
90000
120000
150000
180000
210000
240000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 163
Grafico 6.10 - Curva di Capacità del sistema a un SDOF a comportamento bilineare equivalente
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,532 s => T* ≥ TC
T* = 1,153 s
Se (T*) = 4,262 m / s2 => Se (T*) > Fy / m*
F*y / m* = 2,436 m / s2
Figura 6.8 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
0
30000
60000
90000
120000
150000
180000
210000
240000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(SDOF)
C. di capacitàbilineare (SDOF)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 164
Grafico 6.11 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,153 4,262 14,364 Tabella 6.15 - Performance Point per il sistema a un SDOF
E’ possibile passare dallo spettro di risposta elastico a quello anelastico attraverso il
fattore di riduzione delle forze Rμ che varia in funzione del fattore di duttilità μ e del
periodo T relazionato al periodo TC :
𝑅𝜇 = {1 + (𝜇 − 1)
𝑇
𝑇𝐶
𝑝𝑒𝑟 𝑇 < 𝑇𝐶
𝜇 𝑝𝑒𝑟 𝑇 ≥ 𝑇𝐶
Figura 6.9 - Fattore di riduzione
Nel caso in esame si ha:
𝜇 =𝑑𝑚𝑎𝑥
∗
𝑑𝑦∗
= 1,75
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 165
Lo spettro anelastico sarà quindi:
𝑆𝑎 =𝑆𝑒
𝑅𝜇
= 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑆𝐷 = 𝜇𝑆𝐷𝑒
𝑅𝜇
= 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
Grafico 6.12 - Curva di Domanda Anelastica
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
14,3639 1 14,3639
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.13 - Curva di Capacità e Performance Point
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2
]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB
TC
TD
Sp. Anelastico
TB anelastico
TC anelastico
TD anelastico
0
50000
100000
150000
200000
250000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 166
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
201731,4 0,14369 Tabella 6.16 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
1. Dati: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: si omette essendo lo stesso del
paragrafo 6.2.1.1.1
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: il vettore dei carichi
laterali {F} è definito in modo che la distribuzione dei carichi laterali {ψ} si
mantenga costante nel corso dell’analisi e sia correlata alla forma del vettore degli
spostamenti di piano {Ф}.
Grafico 6.14 - Curva di Capacità del sistema reale a MDOF
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente.
a) Il tratto elastico si determina imponendo il passaggio per il punto (0.60-0.70
F∗bu) 𝑘∗ =
0,60 F∗bu
d∗0,60
b) Il tratto plastico è individuato dalla forza di plasticizzazione Fy* individuato uguagliando le aree sottese dalla bilineare e dalla curva di capacità.
Si passa dal sistema MDOF a quello a 1-GDL attraverso il coefficiente di
partecipazione Γ che nel caso di distribuzione proporzionale alle masse è assunto pari
ad 1.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 167
F*bu 0,6F*bu d*c (0,6 F*bu) K* F*u d*u(F*u)
[KN] [KN] [m] [KN/m] [KN] [m]
172072,8 103243,7 0,0719 1436672,244 172072,84 0,2703
F*y [KN] d*y [m] d*u [m] m* [KN s2/m] T* [s]
157918,680 0,1099 0,2703 83693,70 1,517 Tabella 6.17 - Caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare equivalente.
Grafico 6.15 - Curva di Capacità del sistema a un SDOF a comportamento bilineare equivalente
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,532 s => T* ≥ TC
T* = 1,517 s
Se (T*) = 3,242 m / s2 => Se (T*) > Fy / m*
F*y / m* = 1,887 m / s2
Figura 6.10 - Calcolo della domanda
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(SDOF)
C. di capacitàbilineare (SDOF)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 168
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.16 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,517 3,242 18,885 Tabella 6.18 - Performance Point per il sistema a un SDOF
E’ possibile passare dallo spettro di risposta elastico a quello anelastico attraverso il
fattore di riduzione delle forze Rμ che varia in funzione del fattore di duttilità μ e del
periodo T relazionato al periodo TC :
𝑅𝜇 = {1 + (𝜇 − 1)
𝑇
𝑇𝐶
𝑝𝑒𝑟 𝑇 < 𝑇𝐶
𝜇 𝑝𝑒𝑟 𝑇 ≥ 𝑇𝐶
Figura 6.11 - Fattore di riduzione
Nel caso in esame si ha:
𝜇 =𝑑𝑚𝑎𝑥
∗
𝑑𝑦∗
= 1,72
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2
]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 169
Lo spettro anelastico sarà quindi:
𝑆𝑎 =𝑆𝑒
𝑅𝜇
= 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑆𝐷 = 𝜇𝑆𝐷𝑒
𝑅𝜇
= 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
Grafico 6.17 - Curva di Domanda Anelastica
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
18,885 1 18,885
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.18 - Curva di Capacità e Performance Point
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
Sp. Anelastico
TB anelastico
TC anelastico
TD anelastico
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 170
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
159989 0,18885 Tabella 6.19 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.1.2.1 - Distribuzione nella direzione X
1. Dati: si realizza il modello strutturale non lineare del sistema a n-GDL e si definisce
l’azione sismica tramite gli spettri di risposta elastici in accelerazione e spostamento.
Grafico 6.19 - Spettri di Risposta Elastici in Accelerazione e Spostamento (SLC)
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: il formato AD assicura una
interpretazione visiva diretta della procedura. Si procede alla conversione dello spettro di
risposta elastico; le ascisse devono essere determinate in funzione dei valori delle ordinate.
𝑆𝐷𝑒(𝑇) = 𝑆𝑒 ∙ (𝑇
2𝜋)
2
Grafico 6.20 - Curva di Domanda Elastica (ADRS: Acceleration Displacement Response Spectrum)
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 171
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,523 S => T* ≥ TC
T* = 1,153 S
Se (T*) = 3,737 m / s2 => Se (T*) > Fy / m*
F*y / m* = 2,436 m / s2
Figura 6.12 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.21 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,153 3,737 12,593 Tabella 6.20 - Performance Point per il sistema a un SDOF
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 172
E’ possibile passare dallo spettro di risposta elastico a quello anelastico attraverso il
fattore di riduzione delle forze Rμ che varia in funzione del fattore di duttilità μ e del
periodo T relazionato al periodo TC :
𝑅𝜇 = {1 + (𝜇 − 1)
𝑇
𝑇𝐶
𝑝𝑒𝑟 𝑇 < 𝑇𝐶
𝜇 𝑝𝑒𝑟 𝑇 ≥ 𝑇𝐶
Figura 6.13 - Fattore di riduzione
Nel caso in esame si ha:
𝜇 =𝑑𝑚𝑎𝑥
∗
𝑑𝑦∗
= 1,53
Lo spettro anelastico sarà quindi:
𝑆𝑎 =𝑆𝑒
𝑅𝜇
= 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑆𝐷 = 𝜇𝑆𝐷𝑒
𝑅𝜇
= 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
Grafico 6.22 - Curva di Domanda Anelastica
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
Sp. Anelastico
TB anelastico
TC anelastico
TD anelastico

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 173
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
12,593 1 12,593
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.23 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
194330 0,12593 Tabella 6.21 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
1. Dati: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.2.1
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: si omette essendo lo stesso del
paragrafo 6.2.1.2.1
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,523 s => T* ≥ TC
T* = 1,517 s
0
50000
100000
150000
200000
250000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 174
Se (T*) = 2,842 m / s2 => Se (T*) > Fy / m*
F*y / m* = 1,887 m / s2
Figura 6.14 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.24 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,517 2,842 16,556 Tabella 6.22 - Performance Point per il sistema a un SDOF
E’ possibile passare dallo spettro di risposta elastico a quello anelastico attraverso il
fattore di riduzione delle forze Rμ che varia in funzione del fattore di duttilità μ e del
periodo T relazionato al periodo TC :
𝑅𝜇 = {1 + (𝜇 − 1)
𝑇
𝑇𝐶
𝑝𝑒𝑟 𝑇 < 𝑇𝐶
𝜇 𝑝𝑒𝑟 𝑇 ≥ 𝑇𝐶
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 175
Figura 6.15 - Fattore di riduzione
Nel caso in esame si ha:
𝜇 =𝑑𝑚𝑎𝑥
∗
𝑑𝑦∗
= 1,51
Lo spettro anelastico sarà quindi:
𝑆𝑎 =𝑆𝑒
𝑅𝜇
= 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
𝑆𝐷 = 𝜇𝑆𝐷𝑒
𝑅𝜇
= 𝑎𝑠𝑐𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
Grafico 6.25 - Curva di Domanda Anelastica
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
16,556 1 16,556
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
Sp. Anelastico
TB anelastico
TC anelastico
TD anelastico

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 176
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.26 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
154086,9 0,16556 Tabella 6.23 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.1.3.1 - Distribuzione nella direzione X
1. Dati: si realizza il modello strutturale non lineare del sistema a n-GDL e si definisce
l’azione sismica tramite gli spettri di risposta elastici in accelerazione e spostamento.
Grafico 6.27 - Spettri di Risposta Elastici in Accelerazione e Spostamento (SLD)
2. domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: il formato AD assicura una
interpretazione visiva diretta della procedura. Si procede alla conversione dello spettro di
risposta elastico; le ascisse devono essere determinate in funzione dei valori delle ordinate.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 177
𝑆𝐷𝑒(𝑇) = 𝑆𝑒 ∙ (𝑇
2𝜋)
2
Grafico 6.28 - Curva di Domanda Elastica (ADRS: Acceleration Displacement Response Spectrum)
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente. si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,477 s => T* ≥ TC
T* = 1,153 s
Se (T*) = 1,758 m / s2 => Se (T*) ≤ Fy / m*
F*y / m* = 2,436 m / s2
Figura 6.16 - Calcolo della domanda
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 178
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.29 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,153 1,758 5,925 Tabella 6.24 - Performance Point per il sistema a un SDOF
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
5,925 1 5,925
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.30 - Curva di Capacità e Performance Point
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15 20 25 30
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max
0
50000
100000
150000
200000
250000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 179
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
141533,8 0,05925 Tabella 6.25 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
1. Dati: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.3.1
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: si omette essendo lo stesso del
paragrafo 6.2.1.3.1
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,477 s => T* ≥ TC
T* = 1,517 s
Se (T*) = 1,337 m / s2 => Se (T*) ≤ Fy / m*
F*y / m* = 1,887 m / s2
Figura 6.17 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 180
Grafico 6.31 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,517 1,337 7,790 Tabella 6.26 - Performance Point per il sistema a un SDOF
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
7,790 1 7,790
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.32 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
110121,7 0,07790 Tabella 6.27 - Performance Point per il sistema a MDOF
0
1
2
3
4
5
6
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 181
6.2.1.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.1.4.1 - Distribuzione nella direzione X
1. Dati: si realizza il modello strutturale non lineare del sistema a n-GDL e si definisce
l’azione sismica tramite gli spettri di risposta elastici in accelerazione e spostamento.
Grafico 6.33 - Spettri di Risposta Elastici in Accelerazione e Spostamento (SLD)
2. domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: il formato AD assicura una
interpretazione visiva diretta della procedura. Si procede alla conversione dello spettro di
risposta elastico; le ascisse devono essere determinate in funzione dei valori delle ordinate.
𝑆𝐷𝑒(𝑇) = 𝑆𝑒 ∙ (𝑇
2𝜋)
2
Grafico 6.34 - Curva di Domanda Elastica (ADRS: Acceleration Displacement Response Spectrum)
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.1
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 182
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,463 s => T* ≥ TC
T* = 1,153 s
Se (T*) = 1,392 m / s2 => Se (T*) ≤ Fy / m*
F*y / m* = 2,436 m / s2
Figura 6.18 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.35 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,153 1,392 4,691 Tabella 6.28 - Performance Point per il sistema a un SDOF
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
4,691 1 4,691
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15 20 25 30
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 183
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.36 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
123100,3 0,04691 Tabella 6.29 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.1.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
1. Dati: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.4.1
2. Domanda sismica per il sistema a 1-GDL nel formato AD: si omette essendo lo stesso del
paragrafo 6.2.1.4.1
3. Si determina la curva di capacità del sistema reale a n-GDL: si omette essendo lo
stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
4. Si determinano le caratteristiche del sistema a 1-GDL a comportamento bilineare
equivalente: si omette essendo lo stesso del paragrafo 6.2.1.1.2
5. Si determina la domanda sismica per il sistema a 1-GDL:
TC = 0,463 s => T* ≥ TC
T* = 1,517 s
Se (T*) = 1,059 m / s2 => Se (T*) ≤ Fy / m*
F*y / m* = 1,887 m / s2
0
50000
100000
150000
200000
250000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 184
Figura 6.19 - Calcolo della domanda
Si riscontra un sistema flessibile dove: 𝑑𝑚𝑎𝑥∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥
∗
Grafico 6.37 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,517 1,059 6,167 Tabella 6.30 - Performance Point per il sistema a un SDOF
6. Si determina la domanda sismica globale per il sistema a n-GDL:
d*max [cm] Г dmax [cm]
6,167 1 6,167
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0 5 10 15 20 25 30
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 185
7. Valutazione della prestazione (capacità).
Grafico 6.38 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
91056,64 0,06167 Tabella 6.31 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2 - CASO 2: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del I modo principale di vibrare
6.2.2.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.2.1.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.39 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 186
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
0,958 5,131 11,931 Tabella 6.32 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.40 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
113587 0,19412 Tabella 6.33 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.41 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 187
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,206 4,075 15,023 Tabella 6.34 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.42 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
101317,1 0,25643 Tabella 6.35 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.2.2.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.43 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 188
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
0,958 4,498 10,460 Tabella 6.36 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.44 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
111686 0,17018 Tabella 6.37 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.45 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 189
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,206 3,573 13,170 Tabella 6.38 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.46 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
97115,7 0,22481 Tabella 6.39 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.2.3.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.47 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0
1
2
3
4
5
6
0 3 6 9 12 15 18
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 190
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
0,958 2,116 4,921 Tabella 6.40 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.48 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
84193,75 0,08007 Tabella 6.41 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.49 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15 20 25
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 191
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,206 1,681 6,196 Tabella 6.42 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.50 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
74571,13 0,10577 Tabella 6.43 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.2.4.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.51 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0 3 6 9 12 15 18
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 192
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
0,958 1,676 3,896 Tabella 6.44 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.52 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
75155,65 0,06339 Tabella 6.45 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.2.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.53 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0 3 5 8 10 13 15 18 20 23
S [m
/s2
]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 193
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
1,206 1,331 4,906 Tabella 6.46 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.54 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
61749,4 0,08374 Tabella 6.47 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.3 - CASO 3: con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata dei modi principali di vibrare (MPA)
6.2.3.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.3.1.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.1.1 mentre per il caso di analisi
con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del II modo
principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2.
Grafico 6.55 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF (II modo)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)
P.P.
dmax
0
2
4
6
8
10
12
14
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 194
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,461 9,233 4,963 5,186 Tabella 6.48 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Grafico 6.56 - Curva di Capacità e Performance Point (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
145955,1 0,05547 Tabella 6.49 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Al fine di calcolare la domanda di spostamento complessiva può essere usata una
combinazione SRSS se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10%
da tutti gli altri.
T [s] ΔT [%]
I modo 0,805 54,9
II modo 0,363 Tabella 6.50 - Verifica sulla condizione ΔT ≥ 10%
I modo (SLC) II modo (SLC) SRSS (SLC)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
19,41 5,55 20,19 Tabella 6.51 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.1.2.
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0,00 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,18
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di capacità(MDOF)P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 195
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,243 9,233 1,383 2,159 Tabella 6.52 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
129487,2 0,02095 Tabella 6.53 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,148 8,317 0,461 0,461 Tabella 6.54 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
88537,14 0,00215 Tabella 6.55 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
Al fine di calcolare la domanda di spostamento complessiva può essere usata una
combinazione SRSS se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10%
da tutti gli altri.
T [s] ΔT [%]
I modo 1,062 60,2
II modo 0,423 51,5
III modo 0,205 Tabella 6.56 - Verifica sulla condizione ΔT ≥ 10%
I modo (SLC) II modo (SLC) III modo (SLC) SRSS (SLC)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
25,64 2,09 0,22 25,73 Tabella 6.57 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 196
6.2.3.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.3.2.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.2.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,461 8,240 4,429 4,550 Tabella 6.58 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
141849,6 0,04868 Tabella 6.59 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLV) II modo (SLV) SRSS (SLV)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
17,02 4,87 17,70 Tabella 6.60 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.2.2.
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,243 8,240 1,234 1,814 Tabella 6.61 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 197
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
128877,7 0,01760 Tabella 6.62 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,148 7,500 0,416 0,416 Tabella 6.63 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
84844,66 0,00194 Tabella 6.64 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLV) II modo (SLV) III modo (SLV) SRSS (SLV)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
22,48 1,76 0,19 22,55 Tabella 6.65 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.3.3.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.3.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,461 4,248 2,284 2,284 Tabella 6.66 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 198
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
104683,1 0,02443 Tabella 6.67 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLD) II modo (SLD) SRSS (SLD)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
8,01 2,44 8,37 Tabella 6.68 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.3.2.
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,243 4,248 0,636 0,636 Tabella 6.69 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
99904,89 0,00617 Tabella 6.70 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,148 3,855 0,214 0,214 Tabella 6.71 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 199
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
68378,66 0,00100 Tabella 6.72 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLD) II modo (SLD) III modo (SLD) SRSS (SLD)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
10,58 0,62 0,10 10,60 Tabella 6.73 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.3.4.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.4.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,461 3,469 1,865 1,865 Tabella 6.74 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
94574,17 0,01995 Tabella 6.75 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLO) II modo (SLO) SRSS (SLO)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
6,34 1,99 6,65 Tabella 6.76 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.3.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.2.4.2.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 200
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,243 3,469 0,520 0,520 Tabella 6.77 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
85433,69 0,00504 Tabella 6.78 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,148 3,38467 0,188 0,188 Tabella 6.79 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
72161,9 0,00088 Tabella 6.80 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLO) II modo (SLO) III modo (SLO) SRSS (SLO)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
8,37 0,50 0,09 8,39 Tabella 6.81 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 201
6.2.4 - CASO 1 e CASO 2 con effetti P-Δ
6.2.4.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.4.1.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.57 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,121 4,384 13,964
CASO 2 (P-Δ) - - - Tabella 6.82 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.58 - Curva di Capacità e Performance Point
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB (SLC)
TC (SLC)
TD (SLC)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
0 3 6 9 12 15 18 21
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 202
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 196157,9 0,13964
CASO 2 (P-Δ) - - Tabella 6.83 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.4.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.59 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
Non è possibile trovare il performance point allo SLC per il sistema equivalente SDOF sia
per il CASO 1 che per il CASO 2.
Per tale motivo si interrompe il metodo senza passare al sistema MDOF.
6.2.4.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.4.2.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB (SLC)
TC (SLC)
TD (SLC)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 203
Grafico 6.60 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,121 3,844 12,242
CASO 2 (P-Δ) 0,941 4,582 10,270 Tabella 6.84 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.61 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 189006,8 0,12242
CASO 2 (P-Δ) 106926,8 0,16708 Tabella 6.85 - Performance Point per il sistema a MDOF
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLV)
TB (SLV)
TC (SLV)
TD (SLV)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
0 3 6 9 12 15 18 21
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 204
6.2.4.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.62 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,513 2,848 16,519
CASO 2 (P-Δ) 1,200 3,591 13,105 Tabella 6.86 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.63 - Curva di Capacità e Performance Point
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 148957,5 0,16519
CASO 2 (P-Δ) 93389,07 0,22369 Tabella 6.87 - Performance Point per il sistema a MDOF
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLV)
TB (SLV)
TC (SLV)
TD (SLV)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
S [m
/s2
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)
P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 205
6.2.4.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.4.3.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.64 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,121 1,808 5,760
CASO 2 (P-Δ) 0,941 2,156 4,832 Tabella 6.88 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.65 - Curva di Capacità e Performance Point
0
1
2
3
4
5
6
0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLD)
TB (SLD)
TC (SLD)
TD (SLD)
T* (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
0 3 6 9 12 15 18 21
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)
P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 206
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 137972,4 0,05760
CASO 2 (P-Δ) 82186,47 0,07861 Tabella 6.89 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.4.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.66 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,513 1,340 7,772
CASO 2 (P-Δ) 1,200 1,689 6,166 Tabella 6.90 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.67 - Curva di Capacità e Performance Point
0
1
2
3
4
5
6
0 5 10 15 20 25
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLD)
TB (SLD)
TC (SLD)
TD (SLD)
T* (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)
P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 207
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 108024,8 0,07772
CASO 2 (P-Δ) 73301,65 0,10524 Tabella 6.91 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.4.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.4.4.1 - Distribuzione nella direzione X
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.1, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.68 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,121 1,432 4,560
CASO 2 (P-Δ) 0,941 1,707 3,825 Tabella 6.92 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.69 - Curva di Capacità e Performance Point
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLO)
TB (SLO)
TC (SLO)
TD (SLO)
T* (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
0 3 6 9 12 15 18 21
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 208
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 119764,5 0,04560
CASO 2 (P-Δ) 73607,62 0,06224 Tabella 6.93 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.4.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
Si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2, per tale motivo si omette
la trattazione completa e si riassumono i risultati:
Grafico 6.70 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF
T* [s] S (T*) [m/s2] d*max [cm]
CASO 1 (P-Δ) 1,513 1,061 6,153
CASO 2 (P-Δ) 1,200 1,337 4,881 Tabella 6.94 - Performance Point per il sistema a un SDOF
Grafico 6.71 - Curva di Capacità e Performance Point
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 17,5 20,0
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLO)
TB (SLO)
TC (SLO)
TD (SLO)
T* (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità(CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità(CASO 2)
P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 209
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
CASO 1 (P-Δ) 89372,45 0,06153
CASO 2 (P-Δ) 60471,7 0,08332 Tabella 6.95 - Performance Point per il sistema a MDOF
6.2.5 - CASO 3 con effetti P-Δ
6.2.5.1 - Stima della domanda allo SLC
6.2.5.1.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.1.1 mentre per il caso di analisi
con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del II modo
principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2.
Grafico 6.72 - Domanda sismica per il sistema a un SDOF (II modo)
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,439 9,233 4,498 4,864
Tabella 6.96 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
S [m
/s2]
SD [cm]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.
d*max

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 210
Grafico 6.73 - Curva di Capacità e Performance Point (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
142334,7 0,05203 Tabella 6.97 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Al fine di calcolare la domanda di spostamento complessiva può essere usata una
combinazione SRSS se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10%
da tutti gli altri.
T [s] ΔT [%]
I modo 0,805 54,9
II modo 0,363 Tabella 6.98 - Verifica sulla condizione ΔT ≥ 10%
I modo (SLC) II modo (SLC) SRSS (SLC)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
- 5,20 5,20 Tabella 6.99 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.5.1.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.1.2
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
Non è possibile trovare il performance point allo SLC per il sistema equivalente SDOF e
quindi neanche per quello MDOF.
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08
Tb [
KN
]
dc [m]
C. di Capacità(MDOF)
P.P.
dmax

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 211
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,152 8,452 0,497 0,497
Tabella 6.100 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
88093,08 0,00232 Tabella 6.101 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
Al fine di calcolare la domanda di spostamento complessiva può essere usata una
combinazione SRSS se il periodo di vibrazione di ciascun modo differisce di almeno il 10%
da tutti gli altri.
T [s] ΔT [%]
I modo 1,062 60,2
II modo 0,423 51,5
III modo 0,205 Tabella 6.102 - Verifica sulla condizione ΔT ≥ 10%
I modo (SLC) II modo (SLC) III modo (SLC) SRSS (SLC)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
- - 0,232 0,232 Tabella 6.103 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
Per lo stato limite di collasso i valori ottenuti nelle due direzioni non sono significativi visto
che sia in direzione X che in direzione Y risulta impossibile trovare il performance point per
il I modo di vibrare, il quale fornisce il contributo maggiore allo spostamento.
6.2.5.2 - Stima della domanda allo SLV
6.2.5.2.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.2.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 212
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,439 8,240 4,014 4,250
Tabella 6.104 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
138608,5 0,04547 Tabella 6.105 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLV) II modo (SLV) SRSS (SLV)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
16,71 4,55 17,32 Tabella 6.106 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.5.2.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.2.2.
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) >𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ > 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,245 8,240 1,250 1,860
Tabella 6.107 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
125649,5 0,01804 Tabella 6.108 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 213
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,152 7,622 0,448 0,448
Tabella 6.109 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
84286,79 0,00209 Tabella 6.110 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLV) II modo (SLV) III modo (SLV) SRSS (SLV)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
22,369 1,804 0,209 22,443 Tabella 6.111 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.5.3 - Stima della domanda allo SLD
6.2.5.3.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.3.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,439 4,248 2,070 2,070
Tabella 6.112 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
98588,58 0,02214 Tabella 6.113 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLD) II modo (SLD) SRSS (SLD)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
7,86 2,21 8,17 Tabella 6.114 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 214
6.2.5.3.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.3.2.
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,245 4,248 0,644 0,644
Tabella 6.115 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
99502,22 0,00625 Tabella 6.116 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,152 3,916 0,230 0,230
Tabella 6.117 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
67298,69 0,00108 Tabella 6.118 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLD) II modo (SLD) III modo (SLD) SRSS (SLD)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
10,524 0,625 0,108 10,544 Tabella 6.119 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 215
6.2.5.4 - Stima della domanda allo SLO
6.2.5.4.1 - Distribuzione nella direzione X
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.4.1.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo
6.2.1.1.2 e si riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per
favorire una maggiore snellezza dell’elaborato.
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,439 3,469 1,690 1,690
Tabella 6.120 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
89354,85 0,01808 Tabella 6.121 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLO) II modo (SLO) SRSS (SLO)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
6,22 1,81 6,48 Tabella 6.122 - Domanda di spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.2.5.4.2 - Distribuzione nella direzione Y
Il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata
del I modo principale è stato già svolto nel paragrafo 6.2.4.4.2
Per gli altri casi si ripete la medesima procedura eseguita nel paragrafo 6.2.1.1.2 e si
riportano soltanto i risultati in forma tabellare senza i rispettivi grafici per favorire una
maggiore snellezza dell’elaborato.
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del II modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,245 3,469 0,526 0,526
Tabella 6.123 - Performance Point per il sistema a un SDOF (II modo)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 216
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
85822,54 0,00510 Tabella 6.124 - Performance Point per il sistema a MDOF (II modo)
Per il caso di analisi con distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la
deformata del III modo principale si ha:
Si riscontra un sistema rigido dove: 𝑇∗ < 𝑇𝑐 𝑒 𝑆𝑒(𝑇∗) <𝐹𝑦
𝑚∗ → 𝑑𝑚𝑎𝑥
∗ = 𝑑𝑒,𝑚𝑎𝑥∗
T* [s] S (T*) [m/s2] d*e,max [cm] d*max [cm]
0,152 3,442 0,202 0,202
Tabella 6.125 - Performance Point per il sistema a un SDOF (III modo)
Il Performance Point del sistema a n-GDL sarà:
P.P.
Tb [KN] dmax [m]
72492,59 0,00095 Tabella 6.126 - Performance Point per il sistema a MDOF (III modo)
La domanda di spostamento complessiva viene calcolata usando la combinazione SRSS:
I modo (SLO) II modo (SLO) III modo (SLO) SRSS (SLO)
dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm] dmax [cm]
8,332 0,510 0,095 8,348 Tabella 6.127 - Domanda si spostamento complessiva ottenuta con la SRSS
6.3 - CONFRONTI E COMMENTI DEI RISULTATI OTTENUTI
Al termine di questo lavoro i risultati ottenuti sono molteplici e potrebbe essere dispersivo e
confuso mostrarli tutti. Si è pensato quindi di mostrare solo quelli più significativi e meno
ridondanti, in particolare mi sono concentrato su questi punti:
l’influenza della distribuzione di forze adottata sulla curva di capacità e quindi
sul performance point ai relativi stati limite;
lo studio dell’evoluzione in campo non-lineare della struttura;
la curva di capacità, divisa in vari tratti, capace di descrivere il
comportamento globale della struttura;
l’influenza degli effetti P-Δ sulla curva di capacità in termini di spostamenti e
drifts di piano;
l’importanza dei modi superiori in termini di spostamenti e drifts di piano;
valutazione della risposta attraverso l’inviluppo dei risultati ottenuti da due
analisi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 217
6.3.1 - L’influenza della distribuzione di forze adottata sulla curva di capacità e quindi
sul performance point ai relativi stati limite
Nei grafici inseriti sotto è mostrata l’influenza del profilo di carico applicato sulla curva di
capacità e quindi sulle domande agli stati limite.
Grafico 6.74 – Distribuzioni delle forze con relative risultanti nella direzione X
Grafico 6.75 - Performance Point per i diversi stati limite nella direzione X
0
5
10
15
20
25
30
35
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Distribuzione delle forze(CASO 1)
Risultante delle forze(CASO 1)
Distribuzione delle forze(CASO 2)
Risultante delle forze(CASO 2)
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 5 10 15 20 25 30
Tagl
io a
lla b
ase
[KN
]
Spostamento ultimo piano [cm]
Curva di Capacità(CASO 1)
Curva di Capacità(CASO 2)
P.P. (SLC)
P.P. (SLV)
P.P. (SLD)
P.P. (SLO)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 218
Grafico 6.76 – Distribuzioni delle forze con relative risultanti nella direzione Y
Grafico 6.77 - Performance Point per i diversi stati limite nella direzione Y
Si osserva che la curva forza-spostamento, la quale descrive la risposta globale dell’edificio
è funzione del punto di applicazione della risultante delle forze applicate e della
distribuzione delle rigidezze in altezza. Alla distribuzione uniforme corrisponde il punto di
applicazione più basso, quindi investe maggiormente la parte più rigida della struttura che
risponde con una maggiore resistenza e un minore spostamento ai diversi stati limite. La
0
5
10
15
20
25
30
35
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Distribuzione delle forze(CASO 1)
Risultante delle forze(CASO 1)
Distribuzione delle forze(CASO 2)
Risultante delle forze(CASO 2)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0 10 20 30 40
Tagl
io a
lla b
ase
[KN
]
Spostamento ultimo piano [cm]
Curva di Capacità(CASO 1)Curva di Capacità(CASO 2)P.P. (SLC)
P.P. (SLV)
P.P. (SLD)
P.P. (SLO)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 219
risultante della distribuzione proporzionale al prodotto delle masse per la deformata del I
modo principale è applicata in un punto più alto rispetto a quella della distribuzione
uniforme, quindi investe maggiormente la parte meno rigida della struttura che presenta di
contro minore resistenza e maggiore spostamento ai diversi stati limite. La struttura risulta
avere un comportamento più rigido nel caso di distribuzione uniforme.
Riassumiamo in quattro tabelle i valori ottenuti nelle due direzioni per i quattro stati limite:
P.P. (SLC) P.P. (SLV) P.P. (SLD) P.P. (SLO) dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
14,36 100,0 0,00 12,59 87,7 -12,33 5,92 41,2 -58,75 4,69 32,7 -67,34 Tabella 6.128 - Confronto tra i valori dei P.P. ottenuti per il CASO 1 nella direzione X
P.P. (SLC) P.P. (SLV) P.P. (SLD) P.P. (SLO) dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
19,41 100,0 0,00 17,02 87,7 -12,33 8,01 41,2 -58,75 6,34 32,7 -67,34 Tabella 6.129 - Confronto tra i valori dei P.P. ottenuti per il CASO 2 nella direzione X
P.P. (SLC) P.P. (SLV) P.P. (SLD) P.P. (SLO) dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
18,88 100,0 0,00 16,56 87,7 -12,33 7,79 41,2 -58,75 6,17 32,7 -67,34 Tabella 6.130 - Confronto tra i valori dei P.P. ottenuti per il CASO 1 nella direzione Y
P.P. (SLC) P.P. (SLV) P.P. (SLD) P.P. (SLO) dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
dmax [cm]
dmax [%]
Δdmax [%]
25,64 100,0 0,00 22,48 87,7 -12,33 10,58 41,2 -58,75 8,37 32,7 -67,34 Tabella 6.131 - Confronto tra i valori dei P.P. ottenuti per il CASO 2 nella direzione Y
In entrambe le direzioni si mantengono le medesime proporzioni tra i performance points
corrispondenti ai diversi stati limite, tali proporzioni sono così graficate:
Grafico 6.78 - Confronto tra i valori dei P.P. ottenuti
dmax [%]
P.P. (SLC) 100,0
P.P. (SLV) 87,7
P.P. (SLD) 41,2
P.P. (SLO) 32,7
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
dm
ax [
%]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 220
Per lo SLC in direzione X si ha:
Grafico 6.79 - Performance points dei sistemi SDOF ottenuti per i due casi di analisi
Grafico 6.80 - Performance points dei sistemi MDOF ottenuti per i due casi di analisi
0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2 ]
SD [cm]
Sp. Elastico (SLC)
TB (SLC)
TC (SLC)
TD (SLC)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
250000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Tb [
KN
]
dc [cm]
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 221
CASO 2 (dist. I modo) CASO 1 (dist. uniforme)
dmax [cm] dmax [%] Δdmax [%] dmax [cm] dmax [%] Δdmax [%]
19,41 135,1 35,14 14,36 100,0 0,00 Tabella 6.132 - Confronto tra i valori dei P.P.
Grafico 6.81 - Confronto tra i dmax dei diversi casi di analisi
Si vede ora l’incremento in termini di spostamento che si ha rispetto allo spostamento
trovato per il CASO 1 visto che è il valore più piccolo.
Grafico 6.82 – Incremento in termini di spostamento
6.3.2 - Studio dell’evoluzione in campo non-lineare della struttura
Dai risultati ottenuti si nota come i punti di prestazione corrispondenti agli stati limite di
esercizio si trovino al di là del punto di prima plasticizzazione, questo è confermato dallo
studio dell’evoluzione delle cerniere plastiche nella struttura.
Si creano infatti delle cerniere plastiche assiali nei controventi compressi già allo SLO. I
controventi che si plasticizzano per primi sono quelli di lunghezza maggiore (L>10m), ciò si
spiega facilmente visto e considerato che il carico di collasso per carico di punta si riduce al
dmax [cm]
CASO 2 (dist. I modo) 19,41
CASO 1 (dist. uniforme) 14,36
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
dm
ax [
cm]
Δdmax [%]
Δdmax(CASO2/CASO1) 35,14
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Δd
max
[%
]

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 222
crescere dell'esilità dell'asta, quantificata dalla snellezza, che dipende dalla resistenza alla
rotazione della sezione trasversale e dalla lunghezza, nonché dal modo in cui la stessa asta è
vincolata.
Si rappresenta un telaio interno nel piano XZ ai vari stati limite per il CASO 1 a conferma di
quanto sopra detto:
Figura 6.20 - Telaio interno nel piano XZ allo SLO
Figura 6.21 - Telaio interno nel piano XZ allo SLD
Figura 6.22 - Telaio interno nel piano XZ allo SLV
Figura 6.23 - Telaio interno nel piano XZ allo SLC
Si può aggiungere che il comportamento agli stati limite ultimi in termini di duttilità non è
negativo in quanto con l’aumentare dello stato deformativo le plasticizzazioni indicate dalla
formazione di nuove cerniere plastiche si sviluppano progressivamente in modo diffuso su

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 223
tutta la struttura. Inoltre non si creano meccanismi di piano debole e le cerniere sulle
colonne si creano poche e per ultime al contrario di quelle sui controventi che sono però
elementi di facile sostituzione.
La distribuzione di forze uniforme (CASO 1) rappresenta correttamente la distribuzione di
forze nella fase inelastica della struttura, supponendo che le deformazioni plastiche si
concentrino in corrispondenza della base dell’edificio, ma tale condizione non è sempre
verificata. La struttura, a causa della sua irregolarità in altezza, presenta la formazione di un
meccanismo di piano debole al 4°piano se soggetta ad una distribuzione di carico non
uniforme (CASO 2).
Si rappresenta un telaio interno nel piano XZ allo SLC per il CASO 2 a conferma di quanto
sopra detto:
Figura 6.24 – Meccanismo di piano debole al 4° piano della struttura per il CASO 2 allo SLC
Questo è in accordo con i profili di spostamento di piano e drift di interpiano:
Grafico 6.83 - Spostamenti di piano e drifts di interpiano considerati per il CASO 2 in direzione X

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 224
6.3.3 - Curve di capacità per il CASO 1 e il CASO 2 con e senza effetti P-Δ
Grafico 6.84 – Curva di capacità con e senza effetti P-Δ per il CASO 1 in direzione X
Grafico 6.85 – Curva di capacità con e senza effetti P-Δ per il CASO 1 in direzione Y
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 5 10 15 20 25 30
Tb [
KN
]
dc [cm]
LINEARE
PSEUDO LINEARE
SOFTENING
INSTABILITA'
LINEARE (P-Delta)
PSEUDO LINEARE(P-Delta)
SOFTENING (P-Delta)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
200000
0 5 10 15 20 25 30
Tb [
KN
]
dc [cm]
LINEARE
PSEUDO LINEARE
SOFTENING
LINEARE (P-Delta)
PSEUDO LINEARE(P-Delta)
SOFTENING (P-Delta)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 225
Grafico 6.86 - Curva di capacità con e senza effetti P-Δ per il CASO 2 in direzione X
Grafico 6.87 - Curva di capacità con e senza effetti P-Δ per il CASO 2 in direzione Y
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 5 10 15 20 25 30
Tb [
KN
]
dc [cm]
LINEARE
PSEUDO LINEARE
SOFTENING
INSTABILITA'
LINEARE (P-Delta)
PSEUDO LINEARE(P-Delta)
SOFTENING (P-Delta)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tb [
KN
]
dc [m]
LINEARE
PSEUDO LINEARE
SOFTENING
LINEARE (P-Delta)
PSEUDO LINEARE(P-Delta)
SOFTENING (P-Delta)

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 226
La non linearità geometrica della risposta strutturale causa una variazione degli spostamenti
non proporzionale ai carichi. Considerando gli effetti P-Δ nell’analisi non lineare statica si
tiene conto di tale non linearità e la curva di capacità che si ottiene muta rispetto a quella
ottenuta da una analisi non lineare statica senza effetti P-Δ:
il tratto LINEARE e PSEUDO LINEARE della curva non subiscono variazioni
significative;
il tratto di SOFTENING della curva possiede una pendenza minore, quindi si ha una
riduzione della rigidezza globale della struttura;
scompare il tratto di INSTABILITA’ della curva se presente.
I cambiamenti sopra menzionati della curva di capacità sono prodotti dal momento dovuto
all’effetto P-. Questo momento, causato dall’interazione dell’azione assiale con lo
spostamento relativo fra i due estremi dell’elemento, riduce la resistenza ultima degli
elementi snelli compressi. Questo fenomeno è pronunciato a causa di un alto tasso di lavoro
a compressione degli elementi compressi tale da produrre grandi momenti del II ordine
anche per modesti spostamenti relativi fra i due estremi di ciascun elemento.
6.3.4 - L’importanza dei modi superiori in termini di spostamenti e drifts di piano
E’ evidente e logico che l’uso di tecniche pushover multimodali (MPA) dovrebbe produrre
stime generalmente migliori di drift di interpiano rispetto ad un’analisi pushover con un solo
vettore di carico. Anche se i modi superiori tipicamente contribuiscono poco allo
spostamento, le analisi pushover multimodali possono essere utili per identificare i casi in
cui le risposte in spostamento sono dominate da un modo superiore.
Chopra e Goel (2001b) hanno trovato che l’MPA originale fornisce buone stime di
spostamento di piano e di drift di interpiano per un edificio a telaio in acciaio resistente a
momento di nove piani.
Chintanapakdee e Chopra (2003) hanno applicato la procedura MPA per la stima dei drift di
interpiano per telai a 3, 6, 9, 12, 15, e 18 piani. Hanno scoperto che la precisione delle stime
del drift di interpiano dipendono dal livello di piano e dal grado di inelasticità. La precisione
era migliore per bassi edifici e per i piani inferiori e medi di edifici più alti. Per i piani
superiori di telai alti, la procedura MPA non è stata in grado di fornire una stima
ragionevole dei drift di interpiano per i diversi terremoti.
La MPA si configura come una procedura fra le più accurate per la valutazione della
domanda sismica di strutture deformabili a comportamento debolmente non-lineare.
Per tale motivo si rappresentano i profili degli spostamenti di piano e drifts di interpiano
della struttura sottoposta ad un terremoto di modesta intensità, ovvero allo SLO, perché ci si
aspetta che il cimento della struttura in campo plastico sia limitato.
Ammettendo che l’analisi MPA porti a risultati corretti, l’analisi con distribuzione
proporzionale al modo fondamentale nella direzione X si discosta dalla precedente in
termini di drift di interpiano così:
sottostima del 34% il drift al 1° piano;
sovrastima del 20% il drift al 4° piano;
sottostima del 18% il drift al 9° piano.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 227
Grafico 6.88 – Spostamenti di piano e drifts di interpiano allo SLO in direzione X
Grafico 6.89 – Spostamenti di piano e drifts di interpiano allo SLO in direzione Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamenti di piano
MPA
Modo Fondamentale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
Modo Fondamentale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3
N°
Pia
no
U2 / Htot [%]
Spsostamenti di piano
MPA
ModoFondamentale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
Modo Fondamentale

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 228
Scaturiscono le seguenti osservazioni:
il contributo dei modi superiori è importante in termini di spostamenti di piano e
drifts di interpiano correggendo quelli ottenuti con un solo modo soprattutto ai piani
bassi e alti della struttura;
l’analisi MPA si configura come una procedura fra le più accurate per la valutazione
della domanda sismica di strutture dove l’irregolarità in altezza provoca una risposta
dinamica caratterizzata non da un unico modo di vibrare che attiva la quasi totalità
della massa, come invece accade per le strutture regolari, ma da più modi che
attivano ciascuno una significativa percentuale della massa totale.
6.3.5 - Valutazione della risposta attraverso l’inviluppo dei risultati ottenuti da due
analisi
Nell’eseguire un’analisi statica non lineare, la scelta del profilo di carico costituisce un
aspetto fondamentale, in grado di influenzare significativamente l’accuratezza dei risultati
ottenibili.
In ambito normativo i più recenti codici prevedono di valutare la risposta attraverso
l’inviluppo dei risultati ottenuti da due analisi, fornendo per ciascuna di esse, un gruppo di
profili di carico fra i quali scegliere la coppia più idonea per la struttura in oggetto. Il primo
gruppo, detto delle distribuzioni principali, è formato da profili di carico definiti a partire
dalle proprietà dinamiche della struttura a comportamento lineare, e il suo impiego si pone
l’obiettivo di riprodurre la risposta per effetto di terremoti di modesta intensità. In tali
condizioni, il cimento della struttura in campo plastico è limitato, e le variazioni delle
caratteristiche di rigidezza modificano soltanto parzialmente le proprietà dinamiche e la
forma dei modi propri di vibrare associati alla matrice di rigidezza tangente della struttura.
Ne consegue che, durante l’evento sismico, la distribuzione delle forze di inerzia e
dissipative lungo l’altezza si discosta poco da quella prevista attraverso lo studio delle
risposta elastica. Il secondo gruppo, contenente le distribuzioni secondarie, è formato da
profili di carico finalizzati a tenere in conto il profondo modificarsi delle caratteristiche
della struttura in presenza di diffuse deformazioni plastiche. La radicale variazione del
profilo degli spostamenti esibiti lungo l’altezza richiede una conseguente modifica della
distribuzione delle azioni che, agendo staticamente, tentano di riprodurre tale
comportamento.
Per il primo gruppo si considera l’analisi MPA vista la sua superiorità rispetto a quella con
un solo vettore di carico, mentre per il secondo gruppo si considera l’analisi con
distribuzione uniforme invece di quella con distribuzione adattiva. L’impiego di procedure
adattive, anche se in un gran numero di casi consente di ottenere stime della risposta più
accurate di quelle ottenibili con profili invarianti, spesso non fornisce risultati conservativi,
come è invece assicurato dall’impiego della distribuzione uniforme insieme ad una
distribuzione principale. D’altro canto, l’impiego della distribuzione uniforme, nella
maggioranza dei casi risulta eccessivamente penalizzante, conducendo ad una stima
fortemente cautelativa degli spostamenti dei piani inferiori.
I risultati sono espressi in termini di spostamento di piano e drift di interpiano sia per un
terremoto di modesta intensità (allo SLO), tale da produrre un cimento della struttura in
campo plastico limitato, che per un terremoto di grande intensità (allo SLC), tale da
produrre un cimento della struttura in campo plastico elevato.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 229
Grafico 6.90 - Spostamenti di piano e drift di interpiano allo SLO in direzione X
Grafico 6.91 - Spostamenti di piano e drift di interpiano allo SLO in direzione Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,05 0,1 0,15 0,2
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamenti di piano
MPA
UNIFORME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
UNIFORME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3
N°
Pia
no
U2 / Htot [%]
Spsostamenti di piano
MPA
UNIFORME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,2 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
UNIFORME

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 230
Grafico 6.92 - Spostamenti di piano e drift di interpiano allo SLC in direzione X
Grafico 6.93 - Spostamenti di piano e drift di interpiano allo SLC in direzione Y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamento di piano
UNIFORME
MPA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 2
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
UNIFORME
MPA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1
N°
Pia
no
U2 / Htot [%]
Spostamento di piano
UNIFORME
MPA0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1 1,5
N°
Pia
no
Drift [%]
Pushover direzione Y
UNIFORME
MPA

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CAPITOLO 6 231
Scaturiscono le seguenti osservazioni:
per un terremoto di modesta intensità (allo SLO) l’analisi MPA risulta più cautelativa
e probabilmente anche più accurata visto che il cimento della struttura in campo
plastico è limitato;
per un terremoto di grande intensità (allo SLC) l’analisi con distribuzione uniforme
risulta più cautelativa ai piani inferiori ed è finalizzata a tenere in conto il profondo
modificarsi delle caratteristiche della struttura in presenza di diffuse deformazioni
plastiche;
l’analisi con distribuzione uniforme coglie il comportamento ultimo di una struttura
che va in crisi con un meccanismo di piano debole formatosi alla base ma nel caso di
analisi con distribuzioni modali si forma un meccanismo di piano debole al 4° piano
che anticipa quello alla base della struttura.
Tali distribuzioni possono portare a risultati solo approssimati e talvolta a sfavore di
sicurezza nel caso di strutture dove il danno indotto dall’azione sismica modifica
significativamente nel tempo i modi di vibrare della struttura. In questi casi, l’utilizzo di
metodi di tipo adattivo (noti anche come metodi evolutivi), che tengono conto di modi di
vibrare superiori e modificano in continuazione la distribuzione dei carichi in funzione del
cambiamento delle caratteristiche della struttura durante il moto sismico, consente di
ottenere risultati più validi e precisi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CONCLUSIONI 385
CONCLUSIONI
Questa tesi ha permesso di approfondire due tematiche.
La prima tematica è quella del ruolo strategico dell’ospedale, il quale si differenzia
rispetto alla maggior parte delle costruzioni fondamentalmente per i seguenti aspetti:
1. la funzione sociale;
2. il ruolo strategico in caso di calamità naturali (come un evento sismico);
3. l’elevato valore del contenuto (superiore rispetto al contenitore – edificio);
4. l’elevato tasso di occupazione, il ciclo ininterrotto d’attività, la complessità dei
sistemi e delle funzioni.
Ciò significa che si deve porre una particolare attenzione non solo agli elementi portanti, ma
anche a quelli non strutturali e impiantistici, per i quali sono stati molto utili i documenti
citati all’interno della bibliografia del capitolo 2.
La seconda tematica è quella dell’analisi statica non-lineare, metodo che i più recenti
codici prediligono per i casi più complessi. Tale analisi è in grado di considerare in maniera
esplicita la duttilità strutturale e l’evoluzione del comportamento non-lineare della struttura.
Si raccomanda però particolare cautela nell’applicazione del metodo in quanto la
definizione del modello è complessa e richiede un gran numero di informazioni. In questa
tesi, mediante un’analisi non lineare statica eseguita con il software di calcolo agli elementi
finiti SAP2000®, è stato possibile lo studio del comportamento non lineare di una struttura
tridimensionale non regolare in altezza.
Dai risultati ottenuti si evincono i seguenti punti:
1. l’influenza della distribuzione di forze adottata sulla curva di capacità e quindi sul
cosiddetto “performance point” (punto di prestazione) ai relativi stati limite, in
particolare la struttura risponde in modo più rigido se sottoposta ad una distribuzione
di forze uniforme mentre con una distribuzione proporzionale al modo fondamentale
si ottiene un meccanismo di piano debole al 4° piano;
2. l’influenza degli effetti P-Δ sulla curva di capacità:
a. il tratto lineare e pseudo-lineare della curva non subiscono variazioni
significative;
b. il tratto di softening della curva possiede una pendenza minore, quindi si ha
una riduzione della rigidezza globale della struttura;
c. scompare il tratto di instabilità della curva se presente;
3. l’importanza dei modi superiori in termini di spostamenti e drifts di piano e quindi la
superiorità della MPA (Modal Pushover Analysis, Chopra A.K. e Goel R.K. [2001])
rispetto a quella con distribuzione proporzionale al modo fondamentale poiché
l’irregolarità in altezza provoca una risposta dinamica caratterizzata non da un unico
modo di vibrare che attiva la quasi totalità della massa, come invece accade per le
strutture regolari, ma da più modi che attivano ciascuno una significativa percentuale
della massa totale;
4. l’importanza della valutazione della risposta attraverso l’inviluppo dei risultati
ottenuti da almeno due analisi con distribuzioni di forze di inerzia differenti (CASO 1
e CASO 3), questione recepita anche dai più recenti codici i quali forniscono due

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
CONCLUSIONI 386
gruppi di profili di carico fra i quali scegliere la coppia più idonea per la struttura in
oggetto:
a. per un terremoto di piccola intensità (allo Stato Limite di Operatività) la MPA
risulta più cautelativa e anche più accurata visto che il cimento della struttura
in campo plastico è limitato;
b. per un terremoto di grande intensità (allo Stato Limite di prevenzione del
Collasso) l’analisi con distribuzione uniforme risulta più cautelativa ai piani
inferiori ed è finalizzata a tenere in conto il profondo modificarsi delle
caratteristiche della struttura in presenza di diffuse deformazioni plastiche;
c. l’analisi con distribuzione uniforme coglie il comportamento ultimo di una
struttura che va in crisi con un meccanismo di piano debole formatosi alla
base ma nel caso di analisi con distribuzioni modali si forma un meccanismo
di piano debole al 4° piano che anticipa quello alla base della struttura;
d. tali distribuzioni possono portare a risultati solo approssimati e talvolta a
sfavore di sicurezza nel caso di strutture dove il danno indotto dall’azione
sismica modifica significativamente nel tempo i modi di vibrare della
struttura. In questi casi, l’utilizzo di metodi di tipo adattivo (noti anche come
metodi evolutivi), che tengono conto di modi di vibrare superiori e modificano
in continuazione la distribuzione dei carichi in funzione del cambiamento
delle caratteristiche della struttura durante il moto sismico, consente di
ottenere risultati più validi e precisi.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA 387
BIBLIOGRAFIA
[1] Braga F. (2009), “Dispense del corso di costruzioni in zona sismica”, Dipartimento di
Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma.
[2] Lupoi G., Lupoi A., Pinto P.E., Ansovini P. (2008), “Documento di Supporto alle
Autorità Regionali per la redazione di Linee Guida”,11 Marzo 2008.
[3] Bontempi F. (2010), “Progetto e analisi di ospedali come costruzioni strategiche: visione
di sistema, norme tecniche, azione sismica, robustezza strutturale”, 7° Congresso Nazionale
per Operatori degli Uffici Tecnici, Rieti, 24-25-26 Giugno 2010.
[4] FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of
buildings”, Federal Emergency Management Agency-356, Washington D.C. (USA),
November 2000.
[5] NTC (2008), “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 14 Gennaio 2008.
[6] Lupoi G., Franchin P., Lupoi A., Pinto P.E., Calvi G.M. (2008), “Probabilistic Seismic
Assessment for Hospitals and Complex-Social Systems”, IUSS Press, Pavia, Gennaio 2008.
[7] Pan American Health Organization (2000), “Principles of Disaster Mitigation in Health
Facilities”, Washington D.C. (USA), 2000.
[8] Guragain R., Pandey B.H., Shrestha S.N. (2004), “Guidelines for Seismic Vulnerability
Assessment of Hospitals”, National Society for Earthquake Technology-Nepal, Kathmandu,
April 2004.
[9] A. Mattei, Tesi di Laurea: “Verifiche prestazionali di un edificio industriale in acciaio in
presenza di sisma”, Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Strutture, Facoltà di
Ingegneria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Anno Accademico 2005-2006.
[10] L. Petrini, R. Pinho, G. M. Calvi (2006), “Criteri di progettazione antisismica degli
edifici”, IUSS Press, Novembre 2006-3a edizione.
[11] A. Moretti, M. Zambelli, Tesi di Laurea: “Metodi numerici per la valutazione della
capacità portante di telai piani in acciaio in presenza di effetti del II ordine”, Dipartimento
di Ingegneria Strutturale, Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Milano, Anno Accademico
1996-97.
[12] Computers and Structures, Inc. (2006), “PERFORM COMPONENTS AND
ELEMENTS FOR PERFORM-3D AND PERFORM-COLLAPSE”, University Avenue
Berkeley, California (USA), August 2006.
[13] M. Brunetta, L. Bandini, M. De Lorenzi (2006), “SAP2000® software per analisi e
verifiche di strutture”, Pordenone, Settembre 2006.

Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Ingegneria Civile
_________________________________________________________________________
BIBLIOGRAFIA 388
[14] T. Albanesi, C. Nuti (2007), Dispensa: “ANALISI STATICA NON LINEARE
(PUSHOVER)”, Dipartimento di Strutture, Università degli studi di Roma Tre, Roma,
Maggio 2007.
[15] FEMA, (2009): “Effects of Strength and Stiffness Degradation on Seismic Response”,
Federal Emergency Management Agency-P440A, Washington D.C. (USA), June 2009.
[16] A. Habibullah, S. Pyle (1998), “Practical Three Dimensional Nonlinear Static Pushover
Analysis”, Published in Structure Magazine, Winter 1998.
[17] Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2008), “Bozza di Istruzioni per l’applicazione
delle Norme tecniche per le Costruzioni”, aggiornamento al 07/03/2008.
[18] Chopra A.K., Goel R.K. (2001), “A modal pushover analysis procedure for estimating
seismic demands for buildings”, Earthquake Engineering Research Center, University of
California, Berkeley, 31 August 2001.
[19] FEMA (2005): “Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures”,
Federal Emergency Management Agency-440, Washington (USA), June 2005.
[20] Fausto Viesi (2008), Tesi di Laurea: “Confronto tra modellazione a plasticità diffusa e
concentrata per strutture in c.a.: la scuola di Bisignano”, Corso di Laurea in Ingegneria
Civile - Indirizzo Strutture -, Università degli studi di Bologna, anno accademico2007/2008.
[21] Computers and Structures, Inc. (2010), “CSI Analysis Reference Manual For
SAP2000®, ETABS®, and SAFE® ”, Berkeley, California (USA), March 2010.
[22] Necci S., Schwarz R., Valleriani D., “Esame di costruzioni metalliche: progetto di un
edificio in acciaio adibito ad uso ospedaliero”, Anno Accademico 2009-2010.
[23] Computers and Structures, Inc. (2010), “SAP2000® Help, Linear and Nonlinear Static
and Dynamic Analysis and Design of Three Dimensional Structures ”, Berkeley, California
(USA), 2010.
[24] EN 1993-1-1: 2005, “Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-1: General rules
and rules for buildings”, Brussels, Maggio 2005.
[25] P. Fajfar (2000), “A nonlinear analysis method for performance-based seismic
design”, Earthquake Spectra, 16(3): 573-592.
[26] E. Del Monte (2010), “L’analisi statica non lineare secondo il D.M. 14/01/2008”,
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze, Firenze,
26/04/2010.

Analisi non lineare per lo studio delle prestazioni
di una struttura ospedaliera soggetta a sisma
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Civile
Relatore:Prof. Ing. F. BontempiCorrelatore:Ing. F. Petrini
Tesi di Laurea:
Laureando :Alessio Coppi

Introduzione Parte I Parte II Parte III
SCHEMA LOGICO DELLA PRESENTAZIONE
2Alessio CoppiConclusioni
Introduzione
Parte I
Parte II
Parte III
Conclusioni
Prestazioni degli ospedali
Basi teoriche sull’analisi statica non lineare
Modello e analisi dell’ospedale
Risultati dell’analisi
Considerazioni finali

Introduzione Parte I Parte II Parte III
PRESTAZIONI DEGLI OSPEDALI
3Alessio CoppiConclusioni
Gli ospedali si differenziano rispetto alla maggior parte delle costruzioni per i seguenti aspetti:
•la funzione sociale;
•il ruolo strategico in caso di calamità naturali (come un evento sismico);
•l’elevato valore del contenuto (superiore rispetto al contenitore – edificio);
•l’elevato tasso di occupazione, il ciclo ininterrotto d’attività, la complessità dei sistemi e delle
funzioni.
Livello
prestazionale
Operativo Agibile Stabile Collasso
Danni strutturali
Danni non
strutturali
Danni contenuto
Assenti
Assenti
lievi
Lievi
Lievi
moderati
Moderati
moderati / estesi
Estesi
Estesi
-
-
Sicurezza
Economici
Funzionali
Si
0-10%
Operativo con minimi
disagi
Si
10-30%
Operativo con lievi
disagi
( giorni )
Si
30-60%
Non operativo
necessarie riparazioni
( mesi )
No
60-100%
Non operativo
Stato
Lu
po
iG
., L
up
oiA
., P
into
P.E
., A
nso
vin
iP
. (2
00
8),
“D
ocu
men
to d
i S
up
po
rto
alle
Au
tori
tà R
egio
nal
i p
er l
a re
daz
ion
e d
i L
inee
Gu
ida”
,11
Mar
zo 2
00
8.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
NON LINEARITA’
4Alessio CoppiConclusioni
NON LINEARITA’
GEOMETRICAEFFETTI P-Δ
NON LINEARITA’
DI MATERIALE
MODELLAZIONE
A PLASTICITA’
CONCENTRATA
I metodi basati su un
comportamento
elastico-lineare della
struttura
I metodi di analisi
statica non-lineare
(analisi “push-over”)
NON SONO IN GRADO di considerare
in maniera esplicita la duttilità strutturale
e l’evoluzione del comportamento
non-lineare della struttura
SONO IN GRADO di considerare in
maniera esplicita la duttilità strutturale e
l’evoluzione del comportamento non-
lineare della struttura
Si possono
individuare
due fonti di
non
linearità

Introduzione Parte I Parte II Parte III
ANALISI STATICA NON LINEARE
5Alessio CoppiConclusioni
Consiste nell’esame della struttura sottoposta ai carichi verticali e ad un sistema di forze laterali
scalate in modo da far crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di
controllo della struttura (C.M. dell’ultimo livello della costruzione), fino al raggiungimento delle
condizioni ultime.
Il diagramma Taglio alla base – spostamento ultimo piano rappresenta la curva di capacità della
struttura.
Tagl
io a
lla b
ase
Spostamento ultimo piano
Curva diCapacità
P. Riva (2007), “Analisi Statica Non Lineare (Pushover)”, Dipartimento di Progettazione e Tecnologie, Università degli Studi
di Bergamo, Bergamo, 2007.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
METODO N2
6Alessio CoppiConclusioni
P. Fajfar (2000), “A nonlinear analysis method for performance-based seismic design”, Earthquake Spectra, 16(3): 573-592.
N = NON LINEARE2 = 2 MODELLI DI
CALCOLO (MDOF E SDOF)
Il metodo si articola nei seguenti punti:
1. Si passa dalla curva di capacità del sistema reale MDOF a quella del sistema SDOF
Fb [
F]
dc [L]
C. di capacità (MDOF)
C. di capacità (SDOF)
2. Si determinano le caratteristiche del sistema SDOF a comportamento bilineare equivalente
Tb [
F]
dc [L]
C. di capacità (SDOF)
C. di capacità bilineare (SDOF)
bF
F *
dd *
*FFb
*dd
Γ: COEFFICIENTE DI
PARTECIPAZIONE

Introduzione Parte I Parte II Parte III 7Alessio CoppiConclusioni
P. Fajfar (2000), “A nonlinear analysis method for performance-based seismic design”, Earthquake Spectra, 16(3): 573-592.
Fb[F
]
dc [L]
C. di capacità (MDOF)
P.P.
4. Si determina la domanda sismica globale per il sistema MDOF:
3. Si determina la domanda sismica per il sistema SDOF:
S [a
]
SD [L]
Sp. Elastico
TB
TC
TD
T*
Sp. Anelastico
C. di capacità
P.P.d*max
PUNTO DI
PRESTAZIONE
METODO N2
N = NON LINEARE2 = 2 MODELLI DI
CALCOLO (MDOF E SDOF)

Introduzione Parte I Parte II Parte III
STRUTTURA OSPEDALIERA
8Alessio CoppiConclusioni
Necci S., Schwarz R., Valleriani D. (2010), “Esame di costruzioni metalliche: progetto di un edificio in acciaio adibito ad
uso ospedaliero”, Anno Accademico 2009-2010.
Edificio multipiano costituito da:• 3 piani interrati di 18000 mq ciascuno
• 6 piani fuori terra di 6000 mq ciascuno
•Altezza totale dell’edificio è di 33 m
• 250 stanze, circa 750 posti letto

Introduzione Parte I Parte II Parte III
MODELLO DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA
9Alessio CoppiConclusioni
218m
82,5m
12m 30m
158m
37,5m
21m
22,5m
33m
Modello è così caratterizzato:• 11350 elementi monodimensionali e 7150 nodi;
• 9 solai infinitamente rigidi nel piano;
• non si considera l’interazione terreno struttura (incastro alla base);
• si considera l’effetto P-Δ;
• 10600 cerniere plastiche.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
CERNIERE PLASTICHE SECONDO FEMA 356
10Alessio CoppiConclusioni
FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings”, Federal Emergency Management
Agency-356, Washington D.C. (USA), November 2000.
Definizione del legame della cerniera nel SAP2000
Ottenuta dal tratto
elastico del legame
costitutivo del
materiale
Ottenuta tramite la
definizione di un
legame rigido
plastico incrudente

Introduzione Parte I Parte II Parte III
CERNIERE PLASTICHE SECONDO FEMA 356
11Alessio CoppiConclusioni
FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings”, Federal Emergency Management
Agency-356, Washington D.C. (USA), November 2000.
Controvento: cerniera assiale
Si ha a trazione un unico caso
mentre a compressione tre
possibili casi a seconda del
rapporto tra il diametro “d” e lo
spessore “t” della sezione.
I parametri di modellazione e il criterio di accettazione per le
procedure non lineari di una sezione in acciaio circolare cava,
soggetta a compressione e trazione, risultano espressi nella
tabella 5-7 delle FEMA 356.
Trave: cerniera flessionale
Si hanno tre possibili casi a
seconda della snellezza
dell’anima e delle ali della
sezione in acciaio.
I parametri di modellazione e il criterio di accettazione per le
procedure non lineari delle sezioni in acciaio, soggette a
flessione, risultano espressi nella tabella 5-6 delle FEMA 356.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
CERNIERE PLASTICHE SECONDO FEMA 356
12Alessio CoppiConclusioni
FEMA (2000), “Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings”, Federal Emergency Management
Agency-356, Washington D.C. (USA), November 2000.
Colonna: cerniera presso-flessionale
P[KN]
M [KN m]
INTERAZIONE P-M
P / PCL = 0,4999
P / PCL = 0,2009
P / PCL = 0,1999
I parametri di modellazione e il criterio di accettazione risultano espressi nella tabella 5-6 delle
FEMA 356 in due passi:
2. Scegliendo tra tre
possibili casi a
seconda della
snellezza
dell’anima e delle
ali della sezione
in acciaio.
1. Imponendo due
campi all’interno
dei quali può
variare il valore
dello sforzo
assiale agente P.
Co
mp
ute
rsa
nd
Str
uct
ure
s, I
nc.
(2
01
0),
“C
SI
An
alysi
s
Ref
eren
ce M
anu
al F
or
SA
P2
00
0®
, E
TA
BS
®, an
d S
AF
E®
”,
Ber
kel
ey,
Cal
ifo
rnia
(U
SA
), M
arch
20
10
.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
REGOLARITA’
13Alessio CoppiConclusioni
REGOLARE IN PIANTA
• La configurazione in pianta è compatta e
simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali
e il rapporto tra i lati di un rettangolo in cui la
costruzione risulta inscritta è inferiore a 4
• Non sono presenti rientri o sporgenze
• Gli orizzontamenti possono essere
considerati infinitamente rigidi nel loro piano
• Tutti i sistemi resistenti verticali non si
estendono per tutta l’altezza della costruzione.
• Massa e rigidezza variano in modo brusco tra
il 3° e 4° piano della costruzione.
• Il restringimento della sezione orizzontale
della costruzione tra il 3° e 4° piano è superiore
al 20% della dimensione del 3° piano.
IRREGOLARE IN ALTEZZA
NTC (2008), “Norme Tecniche per le Costruzioni”, DM 14 Gennaio 2008.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
MODI DI VIBRARE SIGNIFICATIVI
14Alessio CoppiConclusioni
Massa modale partecipante
Modo di vibrarePeriodo Direzione X Direzione Y
[s] [%] [%]
I Modo Principale (dir.Y) 1,062 0 55
I Modo Principale (dir.X) 0,805 59 0
II Modo Principale (dir.Y) 0,423 0 30
II Modo Principale (dir.X) 0,363 29 0
III Modo Principale (dir.Y) 0,205 0 9
Massa modale partecipante cumulata 88 94
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Se [
g]
T [s]
Sp.elastico
I MODO dir.Y
II MODO dir.Y
III MODO dir.Y
I MODO dir.X
II MODO dir.X
Amplificazione
Mx = 29%
Mx = 59%
My = 9% My = 30%
My = 55%

Introduzione Parte I Parte II Parte III
ANALISI PUSHOVER DELLA STRUTTURA 3D
15Alessio CoppiConclusioni
Difficoltà nel valutare la
direzione, il punto di applicazione
e la distribuzione di forze sulla
struttura al variare delle azioni
d’inerzia sismiche
Ipotesi semplificative
• Le forme delle distribuzioni delle forze laterali sono:
a) distribuzione uniforme di forze;
b) distribuzione delle forze proporzionale alle masse per la
deformata del modo di vibrare.
• Le forze sismiche di pushover, lungo la direzione longitudinale
e trasversale della struttura, sono applicate singolarmente e non
contemporaneamente.
• Il punto di applicazione delle forze corrisponde al baricentro
delle masse di ogni piano.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
ANALISI DI PUSHOVER SVOLTE
16Alessio CoppiConclusioni
CONVENZIONALI
Coglie il comportamento
ultimo di una struttura che va in
crisi con un meccanismo di piano debole
formatosi alla base
Permette una migliore descrizione delle forze
d’inerzia che si innescano sotto azione sismica
quando il modo fondamentale attiva la
quasi totalità della massa (STRUTTURA REGOLARE)
MPA
(Chopra e Goel-2001)
Fornisce una valutazione della risposta della struttura migliore quando la risposta dinamica è caratterizzata da più modi che
attivano ciascuno una percentuale significativa della
massa totale (STRUTTURA IRREGOLARE)
Chopra A.K., Goel R.K. (2001), “A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings”,
Earthquake Engineering Research Center, University of California, Berkeley, 31 August 2001.
P.
Riv
a(2
00
7),
“An
alis
iS
tati
caN
on
Lin
eare
(Pu
sho
ver
)”,
Dip
arti
men
to
di
Pro
get
tazi
on
ee
Tec
no
log
ie,
Univ
ersi
tàd
egli
Stu
di
di
Ber
gam
o,
Ber
gam
o,2
00
7.

0
2
4
6
8
10
12
0 5 10 15 20 25 30 35 40
S [m
/s2]
SD [cm]
P.P. per il sistema SDOFSp. Elastico (SLC)
TB (SLC)
TC (SLC)
TD (SLC)
T* (CASO 1)
Sp. Anelastico (CASO 1)
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
T* (CASO 2)
Sp. Anelastico (CASO 2)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27
Tb[K
N]
SD [cm]
P.P. per il sistema MDOF
C. di capacità (CASO 1)
P.P. (CASO 1)
C. di capacità (CASO 2)
P.P. (CASO 2)
dmax [cm]
CASO 2 (dist. I modo) 19,41
CASO 1 (dist. uniforme) 14,36
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
dm
ax [
cm]
Δdmax [%]
Δdmax(CASO2/CASO1) 35,14
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
Δd
max
[%
]
Γ
SLC nella direzione longitudinale:
Introduzione Parte I Parte II Parte III
IMPORTANZA DELLA DISTRIBUZIONE SCELTA
17Alessio CoppiConclusioni
0
5
10
15
20
25
30
35
0,00 10,00 20,00 30,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Distribuzione delle forze(CASO 1)
Risultante delle forze(CASO 1)
Distribuzione delle forze(CASO 2)
Risultante delle forze(CASO 2)
In direzione longitudinale:
0
50000
100000
150000
200000
250000
0 10 20 30
Tagl
io a
lla b
ase
[K
N]
Spostamento ultimo piano [cm]
Curva di Capacità(CASO 1)
Curva di Capacità(CASO 2)
P.P. (SLC)
P.P. (SLV)
P.P. (SLD)
P.P. (SLO)
La struttura avrà un comportamento più rigido nel CASO 1 rispetto al CASO 2.
0
5
10
15
20
25
30
35
0,00 10,00 20,00 30,00
Hp
ian
o [
m]
F [KN]
Distribuzione delle forze(CASO 1)
Risultante delle forze(CASO 1)
Distribuzione delle forze(CASO 2)
Risultante delle forze(CASO 2)
0
40000
80000
120000
160000
200000
0 10 20 30 40
Tagl
io a
lla b
ase
[K
N]
Spostamento ultimo piano [cm]
Curva di Capacità(CASO 1)
Curva di Capacità(CASO 2)
P.P. (SLC)
P.P. (SLV)
P.P. (SLD)
P.P. (SLO)
In direzione trasversale:
La struttura avrà un
comportamento più rigido nel
CASO 1 rispetto al CASO 2.

Introduzione Parte I Parte II Parte III
PLASTICIZZAZIONE DELLA STRUTTURA AL VARIARE DEGLI S.L.
18Alessio CoppiConclusioni
SLO:
SLD:
CASO 1 in direzione longitudinaleSLV:
SLC:

Meccanismo di piano debole al 4° piano:
Introduzione Parte I Parte II Parte III
MECCANISMO DI PIANO DEBOLE
19Alessio CoppiConclusioni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1 1,5 2
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
Modo Fondamentale
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,2 0,4 0,6 0,8
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamento di piano
Modo Fondamentale
SLC:
CASO 2 in direzione longitudinale

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
Modo Fondamentale
Introduzione Parte I Parte II Parte III
IMPORTANZA DEI MODI SUPERIORI (MPA)
20Alessio CoppiConclusioni
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,05 0,1 0,15 0,2
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamenti di piano
MPA
Modo Fondamentale
SLO nella direzione longitudinale:
-18%
+20%
-34%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamento di piano
UNIFORME
MPA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1 1,5 2
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
UNIFORME
MPA
Terremoto di grande intensità (allo SLC) nella direzione longitudinale:
Introduzione Parte I Parte II Parte III
MPA E ANALISI CON DISTRIBUZIONE UNIFORME
21Alessio CoppiConclusioni
Terremoto di piccola intensità (allo SLO) nella direzione longitudinale:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,1 0,2 0,3 0,4
N°
Pia
no
Drift [%]
Drift di interpiano
MPA
UNIFORME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
N°
Pia
no
U1 / Htot [%]
Spostamenti di piano
MPA
UNIFORME

Introduzione Parte I Parte II Parte III
CONCLUSIONI
22Alessio CoppiConclusioni
Terremoto di
piccola intensità
Cimento della
struttura in campo
plastico limitato
La MPA risulta più
cautelativa e più
accurata
Terremoto di
grande intensità
Cimento della
struttura in campo
plastico elevato L’analisi con
distribuzione
uniforme risulta
più cautelativa ai
piani inferiori
La MPA risulta più
cautelativa ai piani
superiori
dove il danno indotto
dall’azione sismica
modifica significativamente
nel tempo i modi di vibrare
della struttura
L’analisi con
distribuzione
adattiva risulta più
accurata

0
50000
100000
150000
200000
250000
0 5 10 15 20 25 30
Tagli
o a
lla b
ase
[K
N]
Spostamento ultimo piano [cm]
Curva di Capacità (CASO 1)
Curva di Capacità (CASO 2)
P.P. (SLC)
P.P. (SLV)
P.P. (SLD)
P.P. (SLO)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 0,5 1 1,5 2
N°
Pia
no
Drift [%]
UNIFORME
MPA