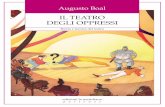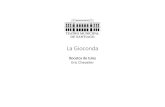TEATRO
-
Upload
carta-del-rischio -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
description
Transcript of TEATRO
46
CONTESTO TERRITORIALE
Teat
ro d
i Akr
ai
DATI IDENTIFICATIVI
insediamento storico:Akraiinsediamento attuale: Palazzolo Acreide (SR)datazione: III sec. a.C.ubicazione: extraurbanaquota altimetrica: 770 mtorientamento: norddiametro cavea: mt. 42 diametro orchestra: mt. 20.9
UBICAZIONE
L’edificio, si trova ubicato fuori dal con-testo urbano, posto a ridosso del decli-vio “Acremontes”, rivolto verso la valledell’Anapo ed il vulcano Etna (1-2).
1 2
Guida Archeologica - Sicilia - F. Coarelli, M.Torelli
Con
osce
nza
Palazzolo Acreide - F° 273 II S. E.
47
CAVEA
Teat
ro d
i Akr
aiREALTÀ FORMALE
In origine, la cavea (koilon) possedeva unaforma perfettamente semicircolare,senza prolungamenti laterali, ed eracostituita da 9 cunei (kerkides) e 8 scale(klimakes).In seguito ad interventi di restauro, imuri di analemma, completamente rico-struiti, hanno alterato tale configurazio-ne; infatti, quello occidentale taglia obli-quamente l’ultimo cuneo, rastremandoverso l’alto le file delle sedute, mentrequello orientale reseca totalmente insommità i primi tre cunei.La cavea consta di dodici file di sedili,senza alcuna suddivisione orizzontale(diazoma). Nella parte occidentale dellacavea, in corrispondenza del settimocuneo, un tunnel consente direttamenteil collegamento al bouleuterion postoappena in prossimità.
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
La cavea si adagia in parte sul pendio natu-rale (1). Le sedute poggiano su unasostruzione costituita da pietrame asecco; alcune sono realizzate con grossiblocchi monolitici in materiale calcareobianco, sagomati sul piano orizzontale,con lo spazio per la seduta e quello per ipiedi dello spettatore della fila soprastan-te (2), altre con blocchi squadrati posti inopera con riempimento a sacco, di pietra-me di varie dimensioni (3). Le scale hannodue gradini corrispondenti ad ogni ordinedi seduta (4); alcuni sono scavati diretta-mente nella roccia, altri costituiti anch’es-si da blocchi litici squadrati, posti in operaa secco. Le due ali della cavea, in operapoligonale, edificate su un riempimento diterra, sono sostenute dagli analemmata esono realizzate senza cortina e senzalegante, in materiale calcareo bianco;l’analemma occidentale (5) presentaconci alquanto irregolari, rinzeppati conpietrame; l’analemma orientale (6) ècostituito da grossi blocchi regolari. Il tun-nel di collegamento, con il bouleuterionnella parte alta della cavea è scavato nellaroccia (7).
1 2
6 7
43 5
Con
osce
nza
48
ORCHESTRA
Teat
ro d
i Akr
ai
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
In origine il piano di calpestio non dove-va essere lastricato (1); infatti l’attualepavimentazione (2), sempre in materialecalcareo bianco, si può attribuire ai rifa-cimenti, coevi alle modificazioni dell’edi-ficio scenico, avvenute in epoca romana.Lo spazio dell’orchestra, sempre in etàromano-imperiale, venne ridotto a causadell’avanzamento del palcoscenico (pulpi-tum) (3).L’accesso alle gradinate della cavea avve-niva direttamente tramite le scalette,direttamente dal piano pavimentale del-l’orchestra (4).
REALTÀ FORMALE
L’orchestra presenta l’originaria formasemicircolare; l’asse di simmetria centra-le coincide con il quinto cuneo, chesecondo lo schema compositivo grecoera sempre delimitato da due scalettelaterali.I corridoi laterali (parodos), che conduce-vano all’orchestra, poste solitamentelungo gli analemmata, in questo caso sitrovano lungo i lati corti dell’edificio sce-nico, e sono visibili i resti delle soglied’ingresso delle due porte.
1
3
Con
osce
nza
2
4
49
SCENA
Teat
ro d
i Akr
aiREALTÀ FORMALE
L’edificio scenico, destinato agli attori,alle scenografie e ai costumi, dalle mode-ste dimensioni, è a pianta rettangolaresenza parasceni (paraskenia).In seguito alle modifiche ed agli amplia-menti avvenuti in età imperiale, venneeliminato il proscenio (proskenion), che siapriva direttamente sul diametro dell’or-chestra, e venne avanzato di circa 2.20mt. il fronte del palcoscenico (pulpitum).Inoltre venne realizzata una piccolacostruzione sull’ingresso nel lato cortoorientale.Purtroppo le alterazioni subite neltempo non consentono, in maniera chia-ra, la lettura della originaria distribuzionedegli ambienti interni.
1
3
2
4
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
Delle strutture murarie originarie del-l’edificio in elevazione rimangono soltan-to parzialmente le fondamenta tagliatenella roccia (1).Sono ben visibili i resti dallo stilobate delproscenio (proskenion) dell’impiantogreco, costituito da una sequenza di ele-menti litici in materiale calcareo, con 12incavi a forma di L (2), che probabilmen-te dovevano alloggiare degli elementiverticali per sostenere la parte superio-re del loggiato.Del palcoscenico rimangono i resti delbasamento in pietra, costituito dal filaredi blocchi allineati con due nicchie inca-vate (3).La piccola costruzione (chioschetto) ori-ginariamente di legno (4), sul lato destrodell’edificio, è individuabile da una sogliae una perimetrazione in pietra.
Con
osce
nza
50
APPARATI DECORATIVI ED ELEMENTI ERRATICI
Teat
ro d
i Akr
ai All’interno dell’area archeologica sitrova un piccolo Antiquarium, attualmen-te non aperto al pubblico, che ospita sva-riati reperti, rinvenuti durante gli scavi.In prossimità del vicino bouleuterion sitrovano alcuni elementi modanati (1),probabilmente cornici dell’edificio sceni-co e appoggiati al muro di cinta, alcunelastre litiche che potrebbero essereappartenenti alle scalette della cavea(2); appena accanto, troviamo una por-zione di colonna scanalata ed un piccolocapitello (3).
2
1
3
Con
osce
nza
51
RISCHIO STATICO-STRUTTURA-
LE
Teat
ro d
i Akr
aiEventuali aree di criticità, in merito all’as-setto strutturale e geomorfologico,potrebbero essere indicate nel versantedelle due Latomie, dell’Intagliata edell’Intagliatella, immediatamente conti-gui alla cavea sul lato Est, dove si osser-vano modeste lesioni e disgregazionidell’ammasso roccioso.L’edificio, restaurato dopo gli scavi, si pre-senta in buono stato di conservazione;non sono evidenti particolari problemistatico-strutturali ad esclusione di (1)diffuse fessurazioni e scagliature indivi-duate nelle pareti e nell’intradosso delpassaggio sotterraneo, che dalla parte altadella cavea conduce al bouleuterion (2).Sono stati inoltre individuate lievi e loca-lizzate instabilità nelle strutture checompongono i sedili della cavea (3), conqualche fenomeno di distacco fra ele-menti verticali ed orizzontali anche inprossimità delle scale (4-5).
2
1 4
3 5
Con
osce
nza
52
Teat
ro d
i Akr
ai In generale l’edificio, come anzidetto,inserito in un contesto extraurbano,risente principalmente delle naturaliinterazioni esposizione-orientamento,che possono innescare processi di dete-rioramento. Infatti sulle superfici pocosoleggiate, con esposizione a Nord, siriscontrano diffuse alterazioni di originebiologica, causate dalla massiccia presen-za di licheni, tenacemente adesi (1),spesso associate ad erosioni superficialiprovocate dall’azione eolica.Alcune formazioni di colore nerastro siosservano, sia sui sedili costituiti da bloc-chi monolitici (2), che su quelli posti inopera a secco (3), dove inoltre vienefavorito lo sviluppo di vegetazione, conapparato radicale, grazie alla presenzadel terriccio frammisto al pietrameinforme del riempimento, che innescaprocessi disgregativi del materiale litico.Analoga condizione si riscontra sia sullepedate e sulle alzate delle scale (4).Sulle superfici verticali dei muri di ana-lemma (5), esposti a Nord, si rileva lapresenza di corpose alterazioni biologi-che e vegetazione fra gli interstizi del-l’apparecchiatura muraria.Anche sugli elementi litici dell’edificioscenico si scorgono leggere erosioni edalterazioni di origine biologica, con liche-ni e muschi di colore giallastro; in parti-colare localizzate sui lacerti in malta dicocciopesto, che rivestono le paretiinterne dei silos (6).
1
2 3
5 6
RISCHIO AMBIENTE-ARIA
Con
osce
nza
4
53
RISCHIO ANTROPICO
Teat
ro d
i Akr
aiC
onos
cenz
a
1
2
4
3
In epoca bizantina sull’edificio scenicovenne impiantato un mulino, demolendoe modificando impropriamente l’impian-to originario; tale riadattamento costitui-sce pertanto un effettivo fattore dirischio, indotto da trasformazioni e riusi,che innesca processi di stratificazionistoriche, archeologiche e culturali pocochiare; furono rinvenute delle macine eparte della scena conserva ancora diver-si silos (1), con le pareti interne rivestitecon malta di cocciopesto, per la conser-vazione delle granaglie. I primi rinveni-menti e restauri risalgono ad opera delBarone Judica; successivamente, furonoricostruiti i due muri di analemma, cosìcome il primo e l’ultimo cuneo. Da sot-tolineare la particolarità del “taglio” deiprimi tre cunei, trasversalmente resecatidal muro di analemma (2) e quello del-l’ultimo cuneo che viene rastremato insommità, quale risultato di interventi direstauro dalla dubbia fondatezza da uneffettivo riscontro archeologico (3).Vennero inoltre eseguiti interventi direstauro, mirati al riposizionamentodelle sedute, ai consolidamenti struttu-rali ed alla riconfigurazione delle partimancanti. (4). Gran parte degli elementidelle sedute vennero ricostruiti e poichégli originali vennero riutilizzati in passatoin diversi edifici di Palazzolo Acreide.
54
INGRESSO ALL’AREA, RECINZIONI,SISTEMI DI PROTEZIONE
L’accesso all’area è realizzato con can-cello e muro in pietra, provvisto di tabel-la segnaletica di informazione.È presente una struttura prefabbricata inmetallo adibita a biglietteria.L’intera area è delimitata da recinzionedi tipologia varia dotata di uscite di sicu-rezza provviste di punto luce e tabellaindicativa.
Teat
ro d
i Akr
ai
ACCESSI
Frui
zion
e
55
PERCORSI, AREE DI SOSTA, DISSUA-SORI, BARRIERE ARCHITETTONICHE
I percorsi sono realizzati attraverso unsistema di viali; un particolare percorso,unico esempio nei teatri antichi siciliani,collega la cavea al Bouleuterion.Non sono presenti barriere architettoni-che tali da impedire la fruizione.Alcune strutture archeologiche sonodelimitate da dissuasori in legno.
PERCORSI
Teat
ro d
i Akr
aiFr
uizi
one
56
Teat
ro d
i Akr
ai
PIANTUMAZIONI
SISTEMAZIONE A VERDE DELL’AREA
Con un eccezionale paesaggio naturale,l’area archeologica abbraccia una note-vole porzione della Sicilia orientale, conle valli dell’Anapo e del Tellaro, finoall’Etna.La vegetazione nelle immediate vicinanzedel teatro è rappresentata da un mantoerboso sistemato a prato e da alberi.Allontanandosi da esso, varietà arboreee arbustive crescono spontaneamente.
Frui
zion
e
57
PANNELLI DIDATTICI E DIVULGATIVI
All’ingresso dell’area archeologica è col-locato un pannello sul quale è riprodot-ta una veduta aerea dell’intero sito, e unaplanimetria con la localizzazione dellestrutture.In prossimità dei singoli monumentisono presenti supporti didattici alquantoprecari e di non facile leggibilità, che con-tengono testi concisi e non redatti in piùlingue.
SUPPORTI DIDATTICIIMPIANTISTICA
Teat
ro d
i Akr
ai
IMPIANTISTICA
L’area è dotata di punti luce presso labiglietteria e presso le uscite di emer-genza; non è provvisto di impianto divideosorveglianza.
Frui
zion
e
58
ALLESTIMENTO PALCOSCENICO
Il piano dell’orchestra rivestito in basola-to di pietrame calcareo è opportuna-mente protetto interponendo uno stra-to di materiale inerte, sul quale vienepoggiato il palcoscenico, realizzato inelementi modulari, facilmente assembla-bili in struttura metallica e pedana.La foto in basso a destra riporta l’allesti-mento scenico che risale agli anni ’80.
L’edificio è sede di eventi culturali di riso-nanza nazionale ed internazionale:
Festival Internazionale delTeatro Classico dei GiovaniMaggio 2004
L’iniziativa mette a confronto numerosiallievi / attori degli istituti di II grado italia-ni e stranieri : infatti, promuove la realizza-zione di rappresentazioni del teatro classi-co in cui i protagonisti sono gli studenti.Quest’anno hanno partecipato 40 scuoleitaliane ed europee (Grecia, Croazia,Spagna, Bulgaria, Serbia) per un totale di1400 ragazzi.
Teat
ro d
i Akr
ai
ATTIVITÀ TEATRALE
Frui
zion
e
59
SISTEMI DI SEDUTA, SCALE DI ACCES-SO, PERCORSI DIVERSIFICATI
Nella cavea non vengono realizzati néulteriori posti a sedere né scale di acces-so e percorsi diversificati, ma vengonoutilizzati solamente gli elementi originari.Una scala conduce ad una galleria checollega il teatro al contiguo bouleute-rion.
STRUTTURE DI SERVIZIO E IMPIANTISTICA
Al di fuori dell’area di stretta pertinenzadel teatro, è realizzata una struttura pre-fabbricata a servizio degli attori; questanon intercetta visuali privilegiate delmonumento.
ATTIVITÀ TEATRALE
Teat
ro d
i Akr
aiFr
uizi
one
60
Teat
ro d
i Akr
ai
BIBLIOGRAFIAESSENZIALE
- BERNABÒ BREA L., Akrai, Catania, 1956- COARELLI F.- TORELLI M., Sicilia (Guida archeologica), Bari, Laterza, 2000, pp. 293-295 - CURCIO G., Akrai: interessi nuovi per una città antica, in Sicilia archeologica, anno IV n. 16, 1971, pp. 47-53- ISLER H.P., Palazzolo Acreide,Akrai, in Teatri greci e romani.Alle origini del linguaggio rappresentato. Censimento analitico, Roma, 1994,
v. II, p. 549- Memoria del teatro.Teatri antichi di Sicilia, a cura di P. Ciancio Rossetto e G. Pisani Sartorio, Roma, 2002, pp. 24-29- MITENS K., Teatri greci e teatri ispirati all’architettura greca in Sicilia e nell’Italia meridionale: c. 350-50 a.C.: un catalogo, Roma, 1988,
pp. 84-87
- POLACCO L., La posizione del teatro di Siracusa nel quadro dell’architettura teatrale greca in Sicilia, in Aparcai. Nuove ricerche estudi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa, 1982, pp. 431-433
- La Sicilia antica. Città greche e indigene di Sicilia: documenti e storia,
- Autori dei testi: CONOSCENZA - Lucia Ventura Bordenca; FRUIZIONE - Teresa Ferlisi