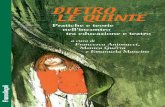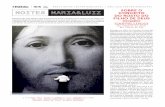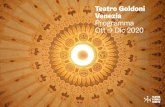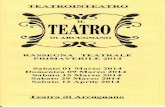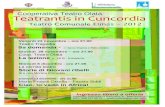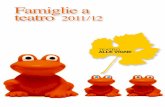TEATRO
-
Upload
carta-del-rischio -
Category
Documents
-
view
251 -
download
5
description
Transcript of TEATRO

TEATRO DI SYRACUSSAI

150
CONTESTO TERRITORIALE
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
DATI IDENTIFICATIVI
insediamento storico: Syrakussaiinsediamento attuale: Siracusadatazione: IV sec. a.C.ubicazione: urbanaquota altimetrica: mt. 35orientamento: Suddiametro cavea: mt. 138.6diametro orchestra: mt. 24
UBICAZIONE
Il teatro è inserito sul lato meridionaledel colle Temenite, all’interno dellaNeapolis.La scelta del luogo è da imputare conmolte probabilità a motivazioni di carat-tere religioso, poiché più in alto esistevaun santuario di età arcaica che ne con-notava di sacralità il luogo.Al contempo la conformazione naturaledella montagna si prestava bene all’inse-rimento dell’edificio (1-2).
1 2
Guida Archeologica - Sicilia - F. Coarelli, M.Torelli
Con
osce
nza
Siracusa - F° 274 II S. O.

151
REALTÀ FORMALE
La cavea (koilon), a semicerchio, racchiudenove cunei (kerkides) delimitati da dieci sca-lette (klimakes), comprese quelle lateralioggi mancanti. Conteneva originariamentecirca 67 ordini di seduta divisi da un unicoambulacro (diàzoma) dotato sul lato inter-no di un’alta parete. Successivamente, perla realizzazione degli accessi laterali all’or-chestra, venivano rettificate le ali e tagliatigli angoli della cavea, dove poi vi sarebberostati collocati dei sedili d’onore (prohedrìa)per attenuare l’impatto negativo che neconseguiva. In epoca romana la cavea infe-riore (ima cavea) veniva modificata attra-verso il restringimento di circa quattordicigradinate, l’eliminazione della prima e lacreazione, di un secondo ambulacro piùpiccolo e di un palco d’onore nel cuneocentrale. Negli angoli della cavea venivanoscavate delle gallerie (cryptae) e al di sopradi queste è probabile che vi fossero i palchid’onore (tribunalia). Muri di analemma peri-metravano la cavea; le ali frontali si presen-tavano interrotte da passaggi a baionetta; laparte posteriore seguiva l’andamento asemicerchio, ma all’angolo Sud-Ovest, acausa dell’intersezione con i due muriparalleli, della terrazza sovrastante (katato-mè), si presentava rettilineo.
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
La parte inferiore della cavea è scolpitanella montagna (1). In prossimità delle ali edella parte alta, fuoriuscendo dalla larghez-za della parete rocciosa, era costruita conblocchi, di calcare leggermente porosoricavato dallo stesso sbancamento poggian-ti su uno strato terroso.Le sedute scolpite e sagomate secondoforme semplici, hanno l’alzata verticale ret-tilinea e la seduta differenziata dalla parteposteriore, lievemente ribassata (2).La parete dell’ambulacro, interamente rica-vata dalla roccia riporta una fascia appenaaggettante, con iscrizioni dedicatoriesovraincise (3). Il muro di analemma di cuisi leggono ancora alcuni filari superstiti èrealizzato con conci squadrati di calcare,impostati direttamente sulla roccia secon-do una apparecchiatura a blocchi alternati:due per testa e uno per lungo (4). Il muro,in prossimità degli angoli assumeva la fun-zione di sostegno al terrapieno, in sommitàla funzione di delimitazione (5). Le numero-se trasformazioni operate nel teatro sonocaratterizzate da procedimenti tecnicimolto diversi tra loro e riflettono in manie-ra chiara la matrice culturale di apparte-nenza. In epoca romana le superfici litichedei palchi, dei sedili d’onore e delle gallerieerano rivestiti di marmi e di stucchi (6).
CAVEA
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
21
3 4
5 6
Con
osce
nza

152
REALTÀ FORMALE
L’orchestra a forma semicircolare ripor-tava in origine un altare (tymele) che neoccupava il centro. Intorno era delimita-ta da un canale di raccolta delle acque(euripos). Ai due estremi si innestavanodue passaggi frontali quali accessi all’or-chestra. In seguito il canale veniva spo-stato più verso la cavea e quello prece-dente veniva obliterato, in questo modolo spazio dell’orchestra risultava piùgrande.Vennero scavati i corridoi latera-li (parodoi) rettificando le ali dell’analem-ma. A questa fase è attribuita anche larealizzazione della fossa carontea colle-gata all’edificio scenico tramite un lungocorridoio. In epoca romana il canaleveniva ricoperto e il suo percorso, neitratti terminali, modificato per la realiz-zazione di un lungo sipario (auleum) dichiusura ad un nuovo palcoscenico. Icorridoi di ingresso venivano chiusi esostituiti da passaggi scavati sotto le alidella cavea (cryptae). In epoca tardoimperiale l’orchestra veniva trasformatain arena (konistra) e in seguito realizzatauna vasca (colymbetra) per gli spettacolid’acqua, e probabilmente il canale diforma trapezoidale, variamente interpre-tato, ne faceva parte.
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
Il piano dell’orchestra è ricavato dallospianamento roccioso di età greca (1) esu questo si conserva ancora il taglio delprimo euripo, e quello relativo al secon-do, più arretrato (2).Gli ingressi frontali erano anch’essi sca-vati nella roccia, ma le tracce sono anda-te in parte perdute. La fossa caronteaposta al centro e il relativo corridoio dicollegamento, rivelano una esecuzioneperfetta. I bracci, realizzati successiva-mente, denotano altrimenti una tecnicapiuttosto grossolana.I corridoi laterali di ingresso sono scava-ti nella roccia, lungo le ali della cavea,l’esecuzione di tali trincee ha determina-to i due piloni rocciosi (3). Si conserva-no lacerti del rivestimento pavimentalein lastre marmoree policrome (crustaemarmoreae) di epoca romana (4).Le lastre seguono un disegno geometri-co a reticolo ortogonale e sono allettatesu un sottofondo di calcestruzzo.
ORCHESTRA
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
1 2
43
Con
osce
nza

153
REALTÀ FORMALE
Diverse le ricostruzioni ipotetiche circala reale evoluzione nel tempo: una primascena (skenè), risalente alla nascita delteatro, doveva essere di piccole dimen-sioni e di semplice disegno, la seconda,più grande e più alta della precedente, èdetta fliacica in analogia con le scene tea-trali tramandateci nelle rappresentazionivascolari dell’Italia meridionale.Nel periodo tardo ellenistico dovevaessere connotata da larghe porte (thyro-mata), da un proscenio (proskenion) apilastri isolati e da due corpi di fabbrica(skenothekae), allineati sui lati ed impo-stati sui piloni rocciosi preesistenti.In epoca romana la scena assumevamonumentalità architettonica con avan-zamento verso l’orchestra e chiusuracon sipario (auleum)del nuovo palcosce-nico (pulpitum); l’edificio scenico dovevaessere a più livelli con un frontescena(scaenae frons) riccamente ornato.Contestualmente, in corrispondenza deicorridoi laterali, venivano realizzati dueampi ambienti (versurae) che univanol’edificio scenico alla cavea. In epocatardo imperiale la scena veniva ridimen-sionata per fare spazio all’arena.
MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE
Le prime scene sembrerebbero esserestate in legno, e di queste si conservanonumerosi fori, tagli e fosse (1). Dellescene monumentali in pietra rimangonoalcuni blocchi di riporto, di un calcarepiù compatto di quello cavato sul posto,collocati in maniera da porre la facciasuperiore alla quota del piano roccioso,e costituenti uno stilobate provvisto difori e tagli per l’inserzione di elementiverticali di sostegno al piano del palco-scenico; un filare di fondazione con bloc-chi litici grezzi da attribuire al prosceniodella scena tardo ellenistica; un grandespianamento riconducibile per dimensio-ni a una struttura imponente di epocaromana e una fossa per il sipario; diversiintagli sulla parte superiore dei piloni suiquali vennero costruite le scenoteche(2-3). Inoltre quest’ultimi, facenti partea pieno titolo della scena romana, con-servano le tracce del rivestimento mar-moreo che doveva ricoprire anche ilresto della scena. Una fossa più arretra-ta e più lunga corrisponderebbe ad unnuovo sipario di epoca tardo imperiale(4).
SCENA
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
1 2
43
Con
osce
nza

L’edificio ricavato nella montagna, costi-tuisce un unicum con essa, per cui il suocomportamento statico è intimamentelegato alle problematiche inerenti lamassa rocciosa e quindi, alle sue caratte-ristiche geomorfologiche correlate allapericolosità geologica del territorio.In prossimità del teatro sorgevano nel-l’antichità delle cave di pietra, la cui atti-vità interessava gli strati più profondidella montagna.Nel tempo le gallerie prodottesi si sonotrasformate in spettacolari cavità, dandoorigine alle latomie.La vulnerabilità intrinseca di tali forma-zioni dal punto di vista strutturale, inpassato sono stati registrati eventi frano-si e crolli, e le infiltrazioni di acqua, asso-ciate a materiale vario, attraverso lenumerose soluzioni di continuità,influenzano negativamente le condizionistatico strutturali della montagna.Non si registrano comunque movimentiin atto, ma le pareti rocciose manifesta-no lesioni e fenditure (1).Nella cavea si notano diverse venaturetrasversali che tagliano vistosamente legradinate ed in quanto costituite damateriale più tenero, disgregatosi pro-gressivamente nel tempo, alcune hannocreato delle fessurazioni molto evidentilungo i diversi ordini di sedili (2); altreinvece, costituite da un materiale cemen-tante più resistente e interessate da unadegradazione differenziale, emergonorispetto la restante superficie litica (3).La pietra, una calcarenite molto porosa,si presenta compromessa.Le diverse cavità, le numerose sbreccia-ture e le fessurazioni visivamente rileva-te, costituiscono un elemento di estremavulnerabilità.Infatti le cavità prodottesi nella pietra, diforme e dimensioni variabili, spingendosiprogressivamente all’interno del materia-le ne alterano negativamente le caratteri-stiche di resistenza meccanica (4-5-6).
154
RISCHIO STATICO-STRUTTURALE
Teat
ro d
i Syr
acus
sai 1
2 3
4
5 6
Con
osce
nza

155
RISCHIOAMBIENTE-ARIA
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Con
osce
nza
Il teatro si trova all’interno di un centrourbano con alta incidenza di traffico vei-colare e relativamente prossimo a cami-ni industriali. Ciò influenza la concentra-zione nell’aria di particelle carboniose,che in presenza di piogge interagiscononegativamente sulle superfici; si riscon-trano pertanto annerimenti diffusi, dovu-ti a depositi di natura carboniosa (1).Inoltre la vicinanza del mare determinaun clima umido per la presenza di aereo-sol marino.Da una prima osservazione macroscopi-ca si rileva una erosione superficiale eduna alveolizzazione molto estesa, conformazione di diversi alveoli che si allar-gano progressivamente a causa delletensioni provocate dagli agenti atmosfe-rici (2).Negli stessi alveoli, per la presenza diterriccio trasportato dal vento, si annida-no piante infestanti che con le loro radi-ci causano pericolose fessurazioni (3).Una patina biologica uniforme, di colorenerastro, interessa la parte superioredella cavea; alcune aree manifestano unacolorazione giallastra e macchie rossa-stre da ossidazione ferrosa (4).Da una analisi visiva ravvicinata, sullesuperfici dei sedili, si individua una incro-stazione lichenica molto aderente dicolore grigiastro, dalla tipica conforma-zione a isole sub-circolari (5); i licheni dicolore nero e giallo sono concentratisolo in prossimità degli antichi corridoi(6). Le depressioni delle sedute dei sedi-li favoriscono il ristagno di acqua e l’ac-cumulo di detriti di vario genere (7).Si osservano sulla superficie della rocciaconcrezioni di varia natura (8).
1
2 3
4 5
876

Le numerose trasformazioni succedutesidurante la lunga vita del teatro, in parti-colare quella di epoca romana, hannorappresentato pesanti eventi traumaticiche hanno segnato in maniera irreversi-bile l’integrità materica del monumento.Nel XVI secolo le strutture costruite delteatro vennero smontate dagli spagnoliper utilizzare il materiale ricavato nel-l’edificazione delle fortificazioni diOrtigia.In corrispondenza del masso rocciosoposto alla sommità del settimo cuneovenne edificata una torre di guardia (1).Ulteriori danni sono stati inferti quandosul monumento vennero costruiti deimulini e i solchi dei carri hanno tagliatotrasversalmente i gradini della caveasuperiore (2). L’accesso non regolamentato nella partealta della cavea dei turisti e soprattuttodei numerosi spettatori in occasionedelle rappresentazioni teatrali, provocatraumi meccanici da calpestio alle gradi-nate superstiti.La causa risiede nella completa assenzadi opportune passerelle e transenne diprotezione (3).Inoltre la realizzazione di allestimentiutili all’uso del teatro, con materiali etecniche non compatibili con le superficirappresentano causa di degrado, comeper esempio le ossidazioni ferrose pre-senti in prossimità di montanti in ferrodegli apparecchi illuminanti (4).Nel corso di alcuni interventi di restau-ro sono state eseguite, su alcuni gradinidella zona inferiore, integrazioni con pie-trame e malta, e nell’orchestra puntualiconsolidamenti (5-6).
156
RISCHIO ANTROPICO
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
3 4
5 6
1
2
Con
osce
nza

157
ACCESSI
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e
INGRESSO ALL’AREA, RECINZIONI,SISTEMI DI PROTEZIONE
Il Parco monumentale della Neàpoliscomprende nel suo perimetro la mag-gior parte dei monumenti classici siracu-sani.Viale Paradiso divide il parco in due partidisuguali, l’area a sinistra contienel’Anfiteatro romano e l’Ara di Ierone,nella parte destra, molto più estesa, sitrovano il Teatro greco e diversi altrimonumenti tra i quali la Latomia delParadiso con l’Orecchio di Dionisio.Le due aree sono provviste di una recin-zione e un ingresso autonomi, con can-cellate provviste di tabelle segnaletiche.La biglietteria per l’ingresso al parco èunica ed è ubicata nella zona destra del-l’area.La recinzione del teatro è realizzata inmuratura e ringhiera metallica.

PERCORSI, AREE DI SOSTA, DISSUA-SORI, BARRIERE ARCHITETTONICHE
Ampi percorsi, provvisti di zone di sosta,attraversano il parco.Si può accedere alle latomie dellaNeapolis o attraverso le scale ubicateall’ingresso o con un percorso alternati-vo destinato soprattutto ai non abili.Sono presenti strutture in muraturadestinate al personale di custodia e allagestione della manutenzione.Per vietare l’accesso ai visitatori dissua-sori in legno sono posizionati agli ingres-si delle zone ad uso del personale dicustodia del parco.Non sono presenti barriere architettoni-che tali da impedire la fruizione dellestrutture archeologiche.
158
PERCORSI
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e

159
PIANTUMAZIONE
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e
SISTEMAZIONE A VERDE DELL’AREA
Il parco presenta una folta e ricca vege-tazione costituita da una ampia varietà dispecie arboree, arbustive ed erbacee.Nel complesso viene effettuata unamanutenzione ordinaria continua sututta la sistemazione a verde di pertinen-za dell’area fruita.

PANNELLI DIDATTICI E DIVULGATIVI
La divulgazione e comunicazione all’in-terno dell’area archeologica è garantitada singole tabelle segnaletiche.
160
SUPPORTI DIDATTICI
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e

161
IMPIANTISTICA
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e
Nelle zone limitrofe al teatro gli impian-ti idrici ed elettrici sono posti in operacon le canalizzazioni a vista.L’area è provvista di punti luce lungo ilpercorso d’accesso e di cabine telefoni-che.

L’edificio è sede di eventi culturali dirisonanza internazionale, come il Ciclodi Spettacoli Classici che si svolge ognidue anni tra maggio e giugno (dal 2000la manifestazione ha una cadenzaannuale) organizzato dall’Istituto Na-zionale del Dramma Antico.Nell’anno 2004 si è svolto il XL Ciclodegli Spettacoli Classici 14 maggio - 20giugno 2004.
162
ATTIVITÀ TEATRALI
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e
ALLESTIMENTO PALCOSCENICO
Il piano dell’orchestra, in opus sectile, èopportunamente protetto da uno stratodi argilla espansa su cui poggia una strut-tura metallica in elementi scatolari chiu-sa da un impalcato ligneo modulare.

163
FASI DI ALLESTIMEN-TO
DEL PALCOSCENICO
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e

164
ATTIVITÀ TEATRALI
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
Frui
zion
e
SISTEMI DI SEDUTA, SCALE DI ACCES-SO, PERCORSI DIVERSIFICATI
Nella cavea vengono installate strutturesmontabili per realizzare ulteriori posti asedere ad integrazione degli elementioriginari.Le scale di servizio anch’esse smontabilisono state progettate sia per la fruizionedella cavea durante gli eventi culturali,che per la fruizione turistica.

165
ATTIVITÀ TEATRALI
Teat
ro d
i Syr
acus
saiSTRUTTURE DI SERVIZIO
E IMPIANTISTICA
Il teatro viene dotato di un impianto diilluminazione e di un sistema di diffusio-ne acustica.È realizzata una struttura prefabbricatain legno adibite a biglietteria e ubicatapresso il cancello di ingresso al teatro.Strutture prefabbricate ad uso degliattori e del personale a servizio dell’or-ganizzazione degli spettacoli sono ubica-te in luoghi che non intercettano visualiprivilegiate del teatro.Punti di ristoro si trovano lungo il vialeParadiso.
Frui
zion
e

166
BIBLIOGRAFIAESSENZIALE
Teat
ro d
i Syr
acus
sai
- ANTI C., Teatri greci arcaici, da Minosse a Pericle, Padova, 1947, pp. 85-106- ANTI C., Il teatro greco trapezoidale ad ali convergenti, in Dioniso, Bollettino dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico, Siracusa,
lugl.-ott. 1948, pp. 152-162- ARIAS P.E., Il teatro greco fuori di Atene, Firenze, 1934, pp. 139-142- BERNABÒ BREA L., Studi sul teatro greco di Siracusa, in Palladio, gen.-dic. 1967, pp. 97-154- BERNABÒ BREA L., FALLICO A.M., Guida artistica, Firenze, 1970- CAVALLARI F.S., Relazione sullo stato delle antichità di Sicilia sulle scoperte e sui restauri dal 1860 al 1872, Roma, 1958- COARELLI F.,TORELLI M., Sicilia. Guida archeologica, Bari, Laterza, 2000, pp. 42-43- FIORI A., Siracusa greca, Roma, 1971, pp. 177-181- GENTILI G.V., Siracusa, in EAA, Roma, 1966, vol.VII, pp. 329-330, 333-334- ISLER H.P., Siracusa, in Teatri greci e romani, alle origini del linguaggio rappresentato censimento analitico, Roma, 1994,V. III, p. 35-37- Memoria del teatro.Teatri antichi di Sicilia, a cura di P. Ciancio Rossetto e G. Pisani Sartorio, Roma, 2002, pp. 31-33- MITENS K., Teatri greci e teatri ispirati all’architettura greca in Sicilia e nell’Italia meridionale, Roma, 1988, pp. 116-120- PACE B., Arte e civiltà della Sicilia antica, 1938, pp. 303-314
- POLACCO L., La posizione del teatro di Siracusa nel quadro dell’architettura teatrale greca in Sicilia, in Aparcai, Nuove ricerche estudi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias, Pisa, 1982, pp. 431-443
- ROMANI S., Città di tiranni e di spettacoli, in Archeo, n. 7, Luglio 2002, pp. 44-51- TRAVERSARI G., Tetimino e Colimbétra, ultime manifestazioni del teatro antico, in Dionisio, Bollettino dell’Istituto Nazionale del
Dramma Antico, Siracusa, gen.-apr. 1950, pp. 21-22- TULLIO A., Itinerari archeologici in Sicilia, Palermo, 2002
- Autori dei testi: CONOSCENZA - Anna Maria Daniela Coco; FRUIZIONE - Teresa Ferlisi