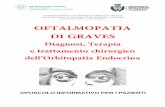Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale
Transcript of Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale
Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (SICMF) Presidenza 2009-2011,dott.PaoloRonchi
2011-2013,prof.GiuseppeFerronato
Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO)Presidenza 2009-2011,prof.LorenzoLoMuzio
2011-2013,prof.GiuseppinaCampisi
Raccomandazioni clinico-terapeutiche sull’osteonecrosi delle ossa mascellari
associata a bisfosfonati e sua prevenzione
AlbertoBedogniGiuseppinaCampisiVittorioFuscoAlessandroAgrillo
SocietàItalianadiPatologiaeMedicinaOrale
SocietàItalianadiChirurgiaMaxillo-Facciale
4
PubblicazionesupportatadalprogettoAIFA“Farmacianti-angiogeneticierischiodi osteonecrosi dei mascellari. Progetto multicentrico su dati retrospettivi,ottimizzazione della Farmacovigilanza e della prevenzione secondaria, studigenetici”(Capofila:AziendaOspedalieraUniversitaria“P.Giaccone”Palermo).
Conilpatrociniodi
Prima edizione: marzo 2013
ISBN 978 88 6787 000 4
© 2013 by SICMF - SIPMO
Cleup sc“Coop. Libraria Editrice Università di Padova”via G. Belzoni 118/3 – Padova (t. +39 049 8753496)www.cleup.itwww.facebook.com/cleup
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento,totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresele copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.
FNMOCeO-CAO
CollegiodeiDocentidiOdontoiatria
SocietàItalianadiOsteoncologia
SocietàItalianadiRadiologia
Impaginazione di Cristina Marcato.
In copertina: particolare del gruppo scultoreo di Fontana Pretoria a Palermo,opera di Francesco Camilliani.
5
Raccomandazioni clinico-terapeutiche sull’osteonecrosi delle ossa mascellari associata a bisfosfonati e sua prevenzione
Autori-Commissione di esperti SICMF-SIPMO
dott. Alberto Bedogni, U.O.C.diOdontoiatriaeChirurgiaMaxillo-FaccialeDipartimento di Chirurgia, AziendaOspedaliera Universitaria Integrata,Veronaprof. Giuseppina Campisi, Settore di Medicina Orale “V. Margiotta”,Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche,UniversitàdegliStudidiPalermodott. Alessandro Agrillo, Sezione di Chirurgia Maxillo-Facciale,Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Università Roma “LaSapienza”dott. Vittorio Fusco, Unità di Oncologia, Dipartimento di Oncologia eEmatologia,AziendaOspedalieradiAlessandria
Con la collaborazione diprof. Antonio Lo Casto , Sezione di Scienze Radiologiche, DipartimentodiBiopatologiaeBiotecnologieMedicheeForensi(DIBIMEF),UniversitàdegliStudidiPalermodott. Lucio Lo Russo ,SezionediScienzeStomatologiche,DipartimentodiScienzeChirurgiche,UniversitàdiFoggiaprof. Claudio Marchetti ,U.O.C.diChirurgiaMaxillo-Facciale,OspedaleS.Orsola-Malpighi,UniversitàdiBolognadott.ssa Giorgia Saia, U.O.C.diChirurgiaMaxillo-Facciale, Dipartimentodi Neuroscienze-NPSRR, Azienda Ospedaliera, Università degli Studi diPadovadott. Stefano Valsecchi , U.O.C. di ChirurgiaMaxillo-Facciale, Ospedale“S.Anna”,Como
prof. Paolo Vescovi , Sezione di Odontostomatologia, Dipartimento diScienzeOtorino-Odonto-OftalmologicheeCervicoFacciali,UniversitàdiParma
Si ringraziano per il supporto tecnico fornito
dott.ssa Giordana Bettini , U.O.C. di Chirurgia Maxillo-Facciale,Dipartimento di Neuroscienze-NPSRR, Azienda Ospedaliera, UniversitàdegliStudidiPadova
6
dott.ssa Olga Di Fede , Settore di Medicina Orale “V. Margiotta”,Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche,UniversitàdegliStudidiPalermodott.ssa Valeria Mercadante ,EastmanDentalInstitute,UniversityCollegeLondondott.ssa Anna Musciotto , Settore di Medicina Orale “V. Margiotta”,Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e StomatologicheUniversitàdegliStudidiPalermodott. Andrea Totola ,U.O.C.diOdontoiatriaeChirurgiaMaxillo-FaccialeDipartimento di Chirurgia, AziendaOspedaliera Universitaria Integrata,Verona
Citarequestapubblicazionecomesegue:Bedogni, Campisi, Fusco,Agrillo. “Raccomandazioni clinico-terapeutiche suosteonecrosidelleossamascellariassociataabisfosfonatiesuaprevenzione”(Versione1.1;Marzo2013)
7
Prefazione
L’osteonecrosi delle ossa mascellari associata ai bisfosfonati (Bisphosphonates Related Osteonecrosis of Jaws-BRONJ) è certamente la più severa tra le patologie odontoiatriche emergente: nel corso di 9 anni siamo passati da isolati reports a migliaia di casi descritti in Letteratura internazionale. La comunità scientifica ha riconosciuto sin da subito la gravità del problema, e con esso la necessità di definire delle regole di comportamento per la tutela del diritto alla salute del paziente, nell’interesse dell’intera collettività.
Con queste premesse, nel 2010 le Società Scientifiche Italiane SICMF e SIPMO, hanno deciso di investire professionalità e risorse in un progetto che prevedeva come atto conclusivo la stesura di Raccomandazioni clinico-terapeutiche per la prevenzione e la cura della BRONJ, attraverso una raccolta capillare e un’analisi organica e condivisa delle informazioni scientifiche disponibili. Con grande forza abbiamo voluto e sostenuto in questi due anni e mezzo d’intenso lavoro il gruppo di esperti delle nostre Società che hanno formato il panel di esperti sulla BRONJ, medici e odontoiatri selezionati esclusivamente sulla base delle loro riconosciute competenze cliniche e in base alla loro pregressa attività di ricerca nel campo della BRONJ. Siamo convinti della necessità di ridisegnare il percorso assistenziale di tale malattia e di raccomandare a ciascun professionista, coinvolto in questo percorso, un ruolo operativo ben definito.
Il primo grande obiettivo di questo panel, crediamo ampiamente raggiunto, è stato di cercare la sintesi del problema BRONJ, laddove oggi esiste ancora una grande frammentazione del pensiero che si traduce in approcci metodologici tortuosi e basati su esperienze personali. Partendo dall’enorme numero d’informazioni pubblicate nella letteratura scientifica sulla BRONJ, la Commissione SICMF-SIPMO ha cercato di ordinare tutte le esperienze in
8
base al principio della robustezza dell’informazione. Questo lungo e difficile percorso di rilettura critica li ha portati a riscrivere la storia della malattia, partendo dal concetto che la BRONJ è una malattia del tessuto osseo che interessa quasi esclusivamente le ossa mascellari, e che come tale va indagata, diagnosticata e infine trattata. Il secondo grande obiettivo delle nostre società scientifiche sarà quello di divulgare la monografia in modo capillare su tutto il territorio italiano, anche integrandola nel contesto di ulteriori attività esplicative, per offrire a Odontoiatri, Esperti di Medicina/Chirurgia Orale e Chirurghi Maxillo-Facciali uno strumento operativo di semplice consultazione per la gestione del soggetto a rischio, con BRONJ sospetta o conclamata. Queste obiettivi, unitamente all’impegno di seguire l’evoluzione delle conoscenze sulla BRONJ e aggiornare periodicamente l’opera, intercettano in pieno la missione delle nostre Società.
Vogliamo esprimere la nostra soddisfazione per il lavoro svolto, insieme all’auspicio che queste Raccomandazioni clinico-terapeutiche possano rappresentare un valido strumento per la comunità degli operatori sanitari coinvolti nella gestione del soggetto a rischio e nel trattamento del paziente affetto da BRONJ. Il nostro ringraziamento a tutti i colleghi che hanno collaborato alla stesura della monografia.
Lorenzo Lo Muzio
Past President SIPMO
Soc.ItalianadiPatologiaeMedicinaOrale
Paolo Ronchi
Past President SICMF
Soc.ItalianadiChirurgiaMaxillo-Facciale
9
Indice
CAPITOLOI.OSTEONECROSIDEIMASCELLARIDABISFOSFONATI(BRONJ)
Introduzione 11 Inquadramento storico della BRONJ 12 La tematica BRONJ 13
Bisfosfonatiemeccanismod’azione 14
EpidemiologiadellaBRONJ 18 Epidemiologia della BRONJ nei pazienti oncologici 19 Epidemiologia della BRONJ nei pazienti non oncologici 23
DefinizionedellaBRONJ 25
CriteridiagnosticidellaBRONJ 28 Criteri clinici 29 Criteri radiologici 32
Work-updiagnosticodellaBRONJ 40
StadiazionedellaBRONJ 42
CategorieefattoridirischiodiBRONJ 49 Categorie di rischio 49 Fattori di rischio farmaco-correlati e sistemici 49 Fattori di rischio locali 55
CAPITOLOII.LAGESTIONEODONTOIATRICADELPAZIENTECHEASSUMERÀOASSUMEAMINOBISFOSFONATI
Approcciopreventivo 75 Tipologia di bisfosfonato 76 Indicazione alla terapia con aminobisfosfonati 76 Timing dell’azione odontoiatrica 77
Sospensionedellaterapiaconaminobisfosfonatiprimadiprocedure terapeuticheoelettiveinvasive 82
Procedureodontoiatriche 84 Chirurgia dento-alveolare 86 Implantologia 89 Chirurgia parodontale e chirurgia endodontica 92
10
Conservativa ed Endodonzia 93 Terapia parodontale 94 Ortodonzia 95 Protesi 96
CAPITOLOIII.TRATTAMENTODELLABRONJ
Introduzione 107
Terapiamedica 108 Terapia antisettica 108 Terapia antibiotica 109 Terapia antidolorifica 113 Biostimolazione 115 Teriparatide 117 Sospensione del farmaco NBP 118 Ossigenoterapia iperbarica 119
Terapiachirurgica 122
Considerazioni generali 122 Considerazioni tecniche 129 Protocollo di trattamento SICMF-SIPMO 134
11
CAPITOLO I
OSTEONECROSI DEI MASCELLARI DA BISFOSFONATI (BRONJ)(redatto in collaborazione con Antonio Lo Casto-UNIPA)
Introduzione
L’osteonecrosidellamandibolaedelmascellaresuperioreassociataaltratta-mentoconbisfosfonati,comunementedettianchebifosfonatiodifosfonati,èuneventoavversofarmaco-correlatochepuòinfluenzareinlargamisuralaqualitàdivitadeipazientiaffetti.Inquestodocumentol’osteonecrosideimascellariassociataall’usodibisfo-sfonativerràsempreriferitacomeBRONJ(BisphosphonatesRelatedOsteo-NecrosisoftheJaw),dall’acronimoinglesepiùutilizzatoinletteratura.IlpresentedocumentoèstatosviluppatodaunaCommissionediespertiinChirurgiaMaxillo-Facciale,MedicinaePatologiaOrale,ChirurgiaOraleedOn-cologia,attivamenteimpegnatinellaricercaclinicaedibasesullamalattiainquestione,enellagestioneclinicadelpazienteaffettodaBRONJ.LaCommissioneèstataselezionatadaiDirettividellaSocietàItalianadiChi-rurgiaMaxillo-Facciale (SICMF)edellaSocietàItalianadiPatologiaeMedicinaOrale(SIPMO).QuestodocumentorappresentapertantolaposizionedelledueSocietàsulproblemaBRONJalmomentodelladivulgazione.Ildocumentosirivolgeaglispecialistidelledisciplineodontostomatologiche,allacomunitàdegliodontoiatriedeichirurghioro-maxillo-faccialicheopera-nosulterritorioitaliano.LaCommissionesièavvalsadellepiùrecenticonoscenzeriportateinlette-ratura internazionale sull’argomento, pur tenendo presente l’impossibilità,allostatoattuale,didefinirelineeguidabasatesull’evidenzascientifica,perlarecenteidentificazionedellamalattiaBRONJeperladifficoltànellarealizza-zionedistudiappropriati.Pertanto,sarebbeconsigliabileutilizzarequestodocumentocomestrumen-todiorientamentonelpercorsodiagnosticodellamalattia,lasciandoampiospazioalgiudizioclinicoinognisingolocasotrattatoeconsigliandol’aggior-namentocontinuo.
12
LaCommissionehaanalizzatoedutilizzatotutteleinformazionipertinentiecontenuteinarticoliaccettati/pubblicatiapartiredal2003(i.e.positionpa-pers,reportsdiseriecliniche,lettereededitoriali)finoadAgosto2012.Larevisionedella letteratura internazionaleattinenteèstataeffettuatauti-lizzandoimotoridiricercaMEDLINE,EMBASE,SciVerseScopus,eCochraneLibrary.Leparolechiave,inlinguainglese,sonostate:“osteonecrosis”,“ava-scular osteonecrosis”, “osteomyelitis”,ONJ, BRONJ, BONJ, BIONJ, “bisphos-phonate”,“diphosphonate”,“zoledronicacid”,“pamidronate”,“alendronate”,“ibandronate”, “risedronate”, “neridronate”, “mandible”, “maxilla”, “jaw”,“jaws”.
Gli obiettivi primaridelpresentedocumentosono:fornireunadefinizionediBRONJcoerenteconlostatodelleconoscen-•zeconsolidate;proporreunpercorsodiagnosticocheguidiilclinicoalsospettoedalla•correttadiagnosidiBRONJ;definireifattoridirischioeleclassidirischio;•fornire raccomandazioni per la gestione odontoiatrica del paziente•primadell’inizioedincorsoditerapiaconbisfosfonati;proporreprotocolliperlagestioneetrattamentodelpazienteaffetto•daBRONJ.
Inquadramento storico della BRONJ
L’esposizionediossonecroticoincavooraleinpazientioncologicièstatoas-sociatoperlaprimavoltaaltrattamentoconbisfosfonatidaMarxecoll.nel2003(Marx2003).Daallora,sonostatiriportatinelmondopiùdi2400casidiBRONJ(Filleul,Crompotetal.2010)tracasereportseserieclinicheretrospettive,esonostatianchepresentatisistemiclassificatividellapatologia(Ruggiero,Gralowetal.2006)consuccessivepropostediintegrazioneemodificazioneaseguitodellescopertescientificheariguardo(Bagan,Jimenezetal.2009;Ruggiero,Dodsonetal.2009).Inrealtà,ilnumerodicasiaccertatinellapraticaclinicasembrerebbedecisamentesuperioreaquantostimato(Ruggiero2009)anchesulterritorioitaliano(Sottosanti2009;Vescovi,Campisietal.2011)Contestualmente,èstatopubblicatounimponentenumerodireviews,posi-tionpapers,raccomandazionielineeguida,diarticolisuipotesipatogeneti-cheepotenzialimodellisperimentalidiBRONJsuanimali.
13
La tematica BRONJ
BRONJèuneventoavversofarmaco-correlatochepuòinfluenzarenegativa-mentelaqualitàdivitadeipazientiaffetti(MinisterodelLavoro2009;Miksad,Laietal.2011).Ibisfosfonatisonoungruppodi farmaci impiegatinel trattamentodipato-logie che coinvolgono il sistema scheletrico; in particolare, essi si sonodi-mostratiefficacinelridurrel’incidenzadieventischeletriciinpazientiaffettidapatologiaoncologicaedematologica(i.e.ipercalcemiamaligna,metastasiossee da tumori solidi di varia origine – carcinomamammario, prostatico,renale- emielomamultiplo)(Aapro,Monfardinietal.2009;Terpos,Sezeretal.2009).Ibisfosfonatisonolargamenteutilizzatiancheperiltrattamentodipatologieosteometabolichebenignecomel’osteoporosiedilmorbodiPa-get,condizionicaratterizzatedaun’elevatafragilitàscheletricaperl’alteratoturnoverosseo.Oggiibisfosfonatisonodiffusamenteprescrittialtresìperlaprevenzionedell‘osteoporosi(i.e.osteopeniapost-menopausale;osteopeniaiatrogenadafarmaci)(Alonso-Coello,Garcia-Francoetal.2008).Ibisfosfonatisonofarmacilargamenteimpiegati(milionidiprescrizioniognianno,nelmondo)(Abu-Id,Warnkeetal.2008)condifferentidosaggi,viedisomministrazione(principalmenteoraleoendovenosa,talvoltaintramusco-lare)edurata(spessoprolungataneglianni).Infine,direcentesonostatidescrittidiversicasidiosteonecrosidelleossama-scellariinpazientioncologiciintrattamentoconfarmaciacosiddettotargetbiologico(i.e.bevacizumab,sunitinib,sorafenib,inassociazioneomenoconbisfosfonati)(Sottosanti2009;Sottosanti2010)oancheconfarmacipoten-zialmentealternativiaibisfosfonati(i.e.denosumab)(Stopeck,Liptonetal.2010;Saad,Brownetal.2012;Smith,Saadetal.2012).UnadellepeculiaritàdellaBRONJèlalocalizzazionequasiesclusivaalleossamascellari.Lepossibilicausediquestofenomenononsonoancoradeltuttoconosciute,masonostateipotizzateadoggiunaseriedimotivazioni,comediseguitoriportate:
turnoverosseodeimascellarifisiologicamentepiùelevatorispettoal•restantescheletro(Buser,Dahlinetal.1994;Marx2003);vascolarizzazione terminale della mandibola (Bagan, Murillo et al.•2005);presenza di un esile rivestimentomuco-periosteo a protezione del•sottostantetessutoosseo,facilmentesoggettoatraumatismo(Marx2003);
14
peculiaremicroflora/biofilmdellacavitàorale (Eckert,Maureretal.•2007);caratteristicainterfacciadento-alveolarechepredisporrebbe,incaso•dimalattiadento-parodontale(i.e.lesionieascessiperiapicali,paro-dontopatia)ochirurgiaoro-dentale,all’esposizionedeltessutoosseosottostante(Baltensperger2009).
Bisfosfonati e meccanismo d’azione
Ibisfosfonati sonoanaloghideipirofosfatie legano fortemente lacompo-nentemineraledell’osso,l’idrossiapatite.Ibisfosfonatisonocostituitidaduecatenefosforichelegateadunanellocentralecostituitodaunatomodicar-bonioasuavoltalegatoaduecateneR1eR2,laprimaresponsabiledell’af-finitàdelfarmacoperl’idrossiapatite,lasecondaresponsabiledellapotenzadellostesso.Inbaseallapresenza/assenzanellacatenaR2diungruppoamminico, ibi-sfosfonativengonodistintiindueclassifarmacologiche,gliaminobisfosfonati(NBP), tracuisegnaliamoZoledronato,Pamidronato,Alendronato,Risedrona-to,Ibandronato,Neridronato,edinonaminobisfosfonati,comeClodronato,TiludronatoedEtidronato.GliNBPhannomaggioreaffinitàperl’osso,edunapotenzada10a1000voltemaggiorerispettoaibisfosfonatinoncontenentigruppiamminici.GliNBPsonoadoggil’unicacategoriatraibisfosfonatipercuisiastataiden-tificata un’associazione con lo sviluppo di BRONJ (Migliorati, Epstein et al.2011);lostessononpuòessereaffermatoperibisfosfonatinoncontenentigruppiamminici,adeccezionedisporadicicasereports(Montazeri,Erskineetal.2007;Crepin,Larocheetal.2010;Morgan,Daviesetal.2010).Perquestomotivo,nelpresentedocumentosifaràriferimentoaisoliNBP,interminidiattivitàdelfarmacocosìcomedaindicazioniministerialialloroutilizzo.Incommercioesistonoformulazioniorali(e.g.alendronato,risedronato,iban-dronato) e parenterali (e.g. pamidronato, ibandronato, acido zoledronico,neridronato)(Tabella1).L’iniezioneintramuscolaredibisfosfonatièlimitatainItaliaprincipalmentealclodronato,chenonèunNBP,einlimitaticasialneridronato.Secondoleindicazionidell’AgenziaItalianadelFarmaco(AIFA)(http://www.agenziafarmaco.gov.it),aoggilaprescrizionediNBPèautorizzatainItalia–conriferimentoalsolousoprolungatoenonperiltrattamentodellaipercal-cemiaacuta–perlacuradelleseguenticondizioni:
15
patologie onco-ematologiche1) (metastasi scheletriche da neoplasiesolideemielomamultiplo):
via endovenosa:pamidronato; ibandronato (fl6mg,ogni 4•settimane);acidozoledronico(fl4mg,ogni3-4settimane);viaorale:ibandronato(cp50mg,1cp/die);•
patologie osteometaboliche2) :per via orale: alendronato; risedronato; ibandronato (cp•150mg,ogni4settimane);perviaendovenosao intramuscolare:neridronato(2mg/kg•ogni3mesi);perviaendovenosa:acidozoledronico(fl5mg,ogni12mesi),•ibandronato(fl3mg,ogni3mesi).
GliNBPvengonocomunementeprescrittiperviaoraleancheinpaziention-cologici, inassenzadimetastasiossee,per laprevenzioneo il trattamentodellaosteoporosifarmaco-indotta(Hillner,Ingleetal.2003;Saad,Abrahams-sonetal.2009;Ito,Elkinetal.2010).L’utilizzodiNBPaldifuoridelleindicazioniministeriali(off-label),qualil’in-fusionedipamidronato(fl15-30-60-90mg)oacidozoledronico(fl4mg)inpazienticonpatologiaosteo-metabolica,èstatorecentementesegnalatoinletteratura(Cartsos,Zhuetal.2008)evisonoconfermeindiretteditalepra-ticaancheinItalia,dacasistichepubblicate(Sottosanti2009;Nocini,Saiaetal.2009).
16
Tabella 1. Aminobisfosfonati: principi attivi e specialità medicinali in commercio PRINCIPIO ATTIVO INDICAZIONI DESCRIZIONE
CLASSE SSN
FORMULAZIONE VIA SOMM
Acido alendronico (sale sodico) (alendronato)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale; Trattamento dell’osteoporosi negli uomini; Trattamento e prevenzione dell’osteoporosi indotta dai glicocorticoidi.
Acido Alendronico FG (FG) Acido Alendronico Fidia (Fidia) Acido Alendronico Sigma Tau (Welcome) Acido Alendronico Germed (Germed) Adronat (Neopharmed) Alendronato Alter (Alter) Alendronato Arrow (Arrow) Alendronato AHCL (Accord Healthcare) Alendronato Almus (Almus) Alendronato DOC (DOC Generici) Alendronato Eg (Eg) Alendronato Mylan (Mylan Generics) Alendronato Pensa (Pensa) Alendronato Ranbaxy (Ranbaxy) Alendronato Ratiopharm (Ratiopharm GmbH‐D) Alendronato Sandoz(Sandoz) Alendronato Teva(Teva Pharma) Alendros (Abiogen) Alenic (Eg) Aston(Biohealth Pharmaceuticals) Doryx (Bioethical) Dralenos(Caber) Dronal (Sigma‐Tau) Fosamax (Merck Sharp Dohme) Genalen (Gentili) Glamor (Agips) Loss (So.Se.Pharm) Nofrattil (SF Group) Porodron (Benedetti) Realen (Rende)
A79 cpr 70mg cpr 10mg
OS
Acido alendronico (alendronato) + colecalciferolo (Vit D)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale in pazienti che sono carenti di vitamina D e non assumono già terapia specifica.
Fosavance (Merck Sharp Dohme) Adrovance (Sigma Tau) Vantavo (Neopharmed)
A79 RR
cpr 70mg/5600 UI OS
Acido ibandronico(sale monosodico monoidrato) (ibandronato)
Prevenzione di eventi scheletrici in pazienti affetti da tumore della mammella e metastasi ossee;
Trattamento dell’ipercalcemia maligna. Bondronat (Roche)
H H
cpr 50mg fl 6mg/6ml
OS EV
Acido ibandronico (sale monosodico monoidrato) (ibandronato)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale in soggetti ad elevato rischio di frattura.
Bonviva (Roche) A79 H
cpr 1 cpr 150mg fl 3mg/3ml
OS EV
Acido neridronico (sale sodico) (neridronato)
Osteogenesi imperfetta Malattia ossea di Paget
Nerixia (Abiogen Pharma) A H
fl 25mg/2ml fl 100mg/8ml
EV/IM EV
Acido pamidronico (sale disodico) (pamidronato)
Prevenzione degli eventi scheletrici in pazienti affetti da tumore della mammella con metastasi ossee/mieloma multiplo con lesioni ossee;
Trattamento dell’ipercalcemia maligna.
Aredia (Novartis Farma) Pamidronato Bioindustria (Bioindustria) Pamidronato Disodico Hikma (Ebewe) Pamidronato Disodico Hospira (Hospira) Pamidronato Ratiopharm (Ratiopharm) Pamidronato Teva (Teva) Texpami (Pharmatex)
H
fl 15 mg/5ml fl 30 mg/10 ml fl 60 mg/10ml fl 90 mg/10 ml
EV
Acido risedronico (sale sodico) (risedronato)
Prevenzione degli eventi scheletrici nell’osteoporosi post‐menopausale; Trattamento dell’osteoporosi negli uomini ad elevato rischio di fratture; Mantenimento o aumento della massa ossea in terapia cortico‐steroidea
prolungata sistemica post‐menopausa.
Actonel (Procter Gamble) Avestra (Sanofi Aventis) Optinate (Sanofi Aventis)
A79 cpr 35mg cpr 5mg cpr 75mg
OS
Acido zoledronico(monoidrato) (zoledronato)
Prevenzione di eventi scheletrici in pazienti affetti da tumori con metastasi ossee;
Trattamento ipercalcemia neoplastica. Zometa (Novartis) H 1 flacone 4 mg/5 ml EV
Acido zoledronico (monoidrato) (zoledronato)
Trattamento dell'osteo‐porosi nelle donne in post‐menopausa, negli uomini ad aumentato rischio di fratture, compresi quelli con una recente frattura dell’anca da trauma lieve;
Trattamento del Morbo di Paget osseo.
Aclasta (Novartis) H flacone 5 mg/100 ml EV
Tabella 1. Aminobisfosfonati: principi attivi e specialità medicinali in commercio
17
Tabella 1. Aminobisfosfonati: principi attivi e specialità medicinali in commercio PRINCIPIO ATTIVO INDICAZIONI DESCRIZIONE
CLASSE SSN
FORMULAZIONE VIA SOMM
Acido alendronico (sale sodico) (alendronato)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale; Trattamento dell’osteoporosi negli uomini; Trattamento e prevenzione dell’osteoporosi indotta dai glicocorticoidi.
Acido Alendronico FG (FG) Acido Alendronico Fidia (Fidia) Acido Alendronico Sigma Tau (Welcome) Acido Alendronico Germed (Germed) Adronat (Neopharmed) Alendronato Alter (Alter) Alendronato Arrow (Arrow) Alendronato AHCL (Accord Healthcare) Alendronato Almus (Almus) Alendronato DOC (DOC Generici) Alendronato Eg (Eg) Alendronato Mylan (Mylan Generics) Alendronato Pensa (Pensa) Alendronato Ranbaxy (Ranbaxy) Alendronato Ratiopharm (Ratiopharm GmbH‐D) Alendronato Sandoz(Sandoz) Alendronato Teva(Teva Pharma) Alendros (Abiogen) Alenic (Eg) Aston(Biohealth Pharmaceuticals) Doryx (Bioethical) Dralenos(Caber) Dronal (Sigma‐Tau) Fosamax (Merck Sharp Dohme) Genalen (Gentili) Glamor (Agips) Loss (So.Se.Pharm) Nofrattil (SF Group) Porodron (Benedetti) Realen (Rende)
A79 cpr 70mg cpr 10mg
OS
Acido alendronico (alendronato) + colecalciferolo (Vit D)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale in pazienti che sono carenti di vitamina D e non assumono già terapia specifica.
Fosavance (Merck Sharp Dohme) Adrovance (Sigma Tau) Vantavo (Neopharmed)
A79 RR
cpr 70mg/5600 UI OS
Acido ibandronico(sale monosodico monoidrato) (ibandronato)
Prevenzione di eventi scheletrici in pazienti affetti da tumore della mammella e metastasi ossee;
Trattamento dell’ipercalcemia maligna. Bondronat (Roche)
H H
cpr 50mg fl 6mg/6ml
OS EV
Acido ibandronico (sale monosodico monoidrato) (ibandronato)
Trattamento dell’osteoporosi post‐menopausale in soggetti ad elevato rischio di frattura.
Bonviva (Roche) A79 H
cpr 1 cpr 150mg fl 3mg/3ml
OS EV
Acido neridronico (sale sodico) (neridronato)
Osteogenesi imperfetta Malattia ossea di Paget
Nerixia (Abiogen Pharma) A H
fl 25mg/2ml fl 100mg/8ml
EV/IM EV
Acido pamidronico (sale disodico) (pamidronato)
Prevenzione degli eventi scheletrici in pazienti affetti da tumore della mammella con metastasi ossee/mieloma multiplo con lesioni ossee;
Trattamento dell’ipercalcemia maligna.
Aredia (Novartis Farma) Pamidronato Bioindustria (Bioindustria) Pamidronato Disodico Hikma (Ebewe) Pamidronato Disodico Hospira (Hospira) Pamidronato Ratiopharm (Ratiopharm) Pamidronato Teva (Teva) Texpami (Pharmatex)
H
fl 15 mg/5ml fl 30 mg/10 ml fl 60 mg/10ml fl 90 mg/10 ml
EV
Acido risedronico (sale sodico) (risedronato)
Prevenzione degli eventi scheletrici nell’osteoporosi post‐menopausale; Trattamento dell’osteoporosi negli uomini ad elevato rischio di fratture; Mantenimento o aumento della massa ossea in terapia cortico‐steroidea
prolungata sistemica post‐menopausa.
Actonel (Procter Gamble) Avestra (Sanofi Aventis) Optinate (Sanofi Aventis)
A79 cpr 35mg cpr 5mg cpr 75mg
OS
Acido zoledronico(monoidrato) (zoledronato)
Prevenzione di eventi scheletrici in pazienti affetti da tumori con metastasi ossee;
Trattamento ipercalcemia neoplastica. Zometa (Novartis) H 1 flacone 4 mg/5 ml EV
Acido zoledronico (monoidrato) (zoledronato)
Trattamento dell'osteo‐porosi nelle donne in post‐menopausa, negli uomini ad aumentato rischio di fratture, compresi quelli con una recente frattura dell’anca da trauma lieve;
Trattamento del Morbo di Paget osseo.
Aclasta (Novartis) H flacone 5 mg/100 ml EV
18
Epidemiologia della BRONJ
SonostatidescritticasidiBRONJintuttelecategoriedipazientitrattaticonNBP,sebbeneconfrequenzediverse(Tennis,Rothmanetal.2012).SonodaritenersiquindiapotenzialerischiodiBRONJ:
pazienti oncologici ed ematologici trattati con somministrazionia)mensili di NBP ev (pamidronato, acido zoledronico, ibandrona-to)perlesionischeletriche:èquestalacategoriacuiappartieneilmaggiornumerodicasidiBRONJriportati(Migliorati,Epsteinetal.2011);pazientioncologicitrattaticonacidozoledronicoinassenzadilesio-b)ni scheletriche:attualmentesonostatidocumentatisolo incorsodistudisperimentali(Mauri,Valachisetal.2009;Coleman,Burkin-shawetal.2010);pazientioncologicitrattaticonbisfosfonatiorali:sonosegnalaticasic)sporadici;pazientinononcologicitrattaticonNBPorali(prevalentementeperd)osteopenia/osteoporosi): ilnumerodicasidocumentatiadoggièdimolto inferioreaquellodeipazientidel gruppoa); si tratta ingeneredipazientisottopostiatrattamentiprolungati(ingenere>2-3anni)econpossibilifattoridirischiolocalie/osistemiciconco-mitanti(Mavrokokki,Chengetal.2007; JeffcoatandWatts2008;Fedele,Kumaretal.2009;Bedogni,Bettinietal.2010).
Nota: esiste una categoria di pazienti non oncologici con patologia osteo-metabolica trattati con NBP per via endovenosa (es. ibandronato 3mg ogni 3 mesi o acido zoledronico 5mg ogni 12 mesi); non esistono al momento dati di follow-up sufficienti a stabilire quale sia il rischio dell’evento BRONJ in questi pazienti e con questi regimi terapeutici , anche se sono stati segnalati recen-temente casi sporadici (Otto, Sotlar et al. 2011).
NonsonoalmomentodisponibilidatiepidemiologicicertisullaBRONJ.L’inci-denzadellamalattiaèancoraignotaelestimedifrequenzadisponibilinellediversepopolazioniesottopopolazioniarischiopresentanounagrandevaria-bilità;tuttoramancanoinletteraturadatiprospetticidefinitivi.L’attualecarenzadidatiepidemiologicitraeoriginedadiversifattori,tracuiilrecentericonoscimentodellamalattiaelaridottaconsapevolezzadell’esi-stenzadellastessadapartedimoltioperatori;aquestifattori,inItalia,sièaggiuntalalimitatasegnalazionedicasiairegistridifarmacovigilanza.
19
Lamancanzadi codici specificinel sistema ICD-Oper la segnalazionedellaBRONJcomemalattiaaséstanteharappresentatoerappresentaancora illimiteprincipaleallaraccoltadidatiepidemiologici.NegliStatiUnitisonostatiintrodottidirecentecodicispecificidisegnalazioneICD-OperBRONJ(ICD-9-CM:733.45,necrosiasetticadeimascellari)dautiliz-zarealpostodeicodici733.1(fratturapatologica)e733.49(necrosiasetticadialtrisegmentischeletrici),daassociareacodicispecificiperilfarmacoBPelaviadisomministrazioneorale(E933.6)oendovenosa(E933.7);laddoveicasidiosteoradionecrosi(526.89)ediosteomielitedelleossamascellari(526.4e526.5)vengonosegnalaticonirispettivicodiciunivoci.In Italia, talicodicidisegnalazionespecificiper laBRONJadogginonsonostatiancorarecepitieresioperativi.Sonopochiidatiriguardantil’incidenza di BRONJ(numerodinuovicasi/annoinunadeterminatapopolazione)eman-canodeltuttostimediprevalenza(numerodicasipresentieosservati/annoinunapopolazione);piùnumerosi,sebbenepocouniformi,sonoidatiriguar-dantilafrequenza(intesacomelapercentualedipazientiaffettidaBRONJinunadeterminatapopolazionedipazienti“arischio”).Idatisarebbero,peral-tro,inficiatidalfattocheinmolticasièbendefinitoilsolonumeratore(casiriportatidiBRONJ),mentreèmaldefinitoildenominatore(totaledeipazientitrattaticonNBP).Moltistudidifrequenza,inoltre,nonspecificanonéiltiponéladuratadeitrattamenticonNBP,lamalattiadibase,ifattoridirischioedaltreimportantiinformazioni.Recentistudiepidemiologicivoltiallaricercadicasi“probabili”o“possibili”diBRONJsullabasedicodiciutilizzatiinschededidimissionee/odatabaseassicurativi (Lapi,Ciprianietal.2012;Solomon,Merceretal.2012;Tennis,Rothmanetal.2012)nonhanno fornitodatisicuridi incidenzanellevariesottopopolazioni, hanno comunque fornito dati suggestivi per la confermadelruolodeiBPnellapatogenesidellaBRONJ.Allalucediquesteconsiderazioni,idatiepidemiologicidisponibilidovrebberoesserelettieinterpretaticoncautela,sianelladirezionediunasottostimachediunasovrastimadelrischioperilsingolopaziente.
Epidemiologia della BRONJ nei pazienti oncologici
Con riferimentoatalipazienti,almomentononsonodisponibilistimed’in-cidenzadiBRONJ:neidiversiarticolipubblicati(studidicoorte;seriedicasi)èstatastimataunafrequenzadiBRONJchevariadamenodell’1%apiùdel12%deipazienti.
20
Sonopochissimiidatidiincidenzabasatisudatiraccoltisistematicamenteinpiùampiemisurecampionarie(Mavrokokki,Chengetal.2007;GliklichandWilson2009).AllalucedeidatidiletteraturasipuòvalutarecheilrischiomedianodiBRONJdopotrattamentoprolungatoconNBPendovenosoinpazientionco-ematolo-gicipossaoscillaretra1%e10%a2annidall’iniziodeltrattamento(Bamias,Kastritisetal.2005;Durie,Katzetal.2005;Woo,Hellsteinetal.2006),conleseguentiprecisazioni:
ilrischiorisultapiùelevatoquantopiùaltaèladosecumulativadifar-maco somministrato (Hoff, Tothet al. 2008;Vahtsevanos, Kyrgidis etal.2009);sonoriportatianchecasidiBRONJadesordioprecoce,dopopochesomministrazioni(Abu-Id,Warnkeetal.2008);nonènotoseediquantosiriducailrischiodisviluppareBRONJdoposospensionedellaterapia;inalcunicasidipazientilungosopravviventièstatoinfattisegnalatolosviluppotardivodiBRONJ(DelConte,Bernar-deschietal.2010);ilrischiosembrapiùalto,purinassenzadistudirandomizzati,perl’aci-do zoledronico rispettoal pamidronato,mentrenon sonodisponibilidatidefinitiviperl’ibandronatoendovena(Vahtsevanos,Kyrgidisetal.2009;Fusco,Loidorisetal.2010);ilrischiosembrapiùelevatoperipazientiaffettidamielomamultiplorispettoaquelli trattatipermetastasi osseeda carcinomaprostaticoe carcinomamammario (Del Conte, Bernardeschi et al. 2010; Fusco,Loidorisetal.2010);sono invecesporadici icasisegnalati inpazientiaffettidaaltritumori(e.g.polmone,rene,pancreas)(Woo,Hellsteinetal.2006;Smith,Kressleyetal.2009).
Inassenzadidatiepidemiologicisullapopolazioneitaliana,sipossonoestra-polare alcune informazioni dall’esperienza delle Regioni Piemonte e ValleD’Aostaneglianni2004-2008 (Campisi,Fedeleetal.2009;Colella,Campisietal.2009;Fusco,Baraldietal.2009;Fusco,Ortegaetal.2009); traipazienticontumoremetastaticoalleossaemielomamultiplo,osservatipressoiCen-trioncologiciedematologicidellaReteOncologicadiPiemonteeValled’Ao-sta(http://www.reteoncologica.it) etrattaticonNBP,sonostatiregistrati221casidiBRONJinunapopolazionegeneralediriferimentoparia4.3milionidiabitanti.LanumerositàdeicasidiBRONJriscontratiinquestaareageograficaèrisultatasuperioreall’atteso,inriferimentoaidatiriportatiinAustralia(114casi/20.3milionidiabitantitrail2003eil2005)(Mavrokokki,Chengetal.2007).
21
Assumendochenell’areaterritorialeitalianacitata,l’incidenzadicasidimie-lomaeditumorimetastaticiall’osso,iltassodiprescrizionediNBPendovenael’incidenzadipossibilifattoridirischiolocali(vediparagrafosuccessivo)sia-nosimiliaquellidell’interapopolazioneitaliana(circa58milioni),sipotrebbeformulareunaproiezione su basenazionale, secondo la quale in Italia nelperiodo2003-2008sisarebberodovutiosservaretrai2000ei3000casidiBRONJinpazientioncologiciedematologici.Un supporto indirettoa taleproiezioneèdatodalla segnalazionedipiùdi1000casidiBRONJosservatisulterritorioItalianoepresentatinelcorsodicongressinazionalitenutitrail2007eil2009,afrontediunnumerodicasidiBRONJregistratidalsistemanazionaledifarmacovigilanza(AIFA)nettamenteinferiore(425casialGiugno2009).Unalimitazionefondamentaledellostudiopiemontesesuindicatoèl’impos-sibilitàdifornireuntasso d’incidenzatraipazientiesposti,inquantomancaildenominatore(l’interapopolazionetrattataconNBPendovena),nonregi-stratouniformementeneidiversiambiti(regimediricovero,dayhospital,at-tivitàambulatoriali)neivariospedali;c’èdaricordarechenonesistenelsiste-maitalianoDRGuncodicespecificoperiltrattamentoconNBPendovena.Indettaglio, leosservazionidelnumerodeinuovicasinellapopolazionediPiemonteeValled’Aosta,inparticolarel’aumentodeinuovicasi/annotrail2003edil2006edilsuccessivodecrementoneglianni2007-2009,spingeadalcuneconsiderazionisuicambiamentitemporalidiincidenza.Lepossibilira-gionidell’elevataincidenzadiBRONJosservatanelprimotrienniorispettoalsecondopotrebberoesserelegatia:
un aumento della consapevolezza e della capacità di riconoscere i•possibilicasidiBRONJ:dal2004-2005centinaiadilavorisonoapparsinella letteraturamedica edodontoiatrica ed inoltre sono statimo-dificatifogliettiillustrativieschedetecnichedeifarmaci;pertantoèaumentatalaprobabilitàcheinuovicasidiBRONJsianostatiricono-sciuticometali,enonidentificatierroneamentecomemetastasialleossamascellari,localizzazionidimieloma,osteomieliti,comeaccade-vainizialmente(Marx2003;Ruggiero2009);unpossibileeffettodi“harvesting”,cioèl’inclusionedialcunicasipre-•valentitraicasiincidenti:inaltreparole,unapartedeipazientidia-gnosticaticonBRONJnelprimotriennio2003-2006sarebbestatoer-roneamenteinseritonellestatisticheepidemiologichediqueglianni,inquantol’insorgenzadellamalattiarisalirebbeaglianniprecedenti;inquestomodo,ilritardodiagnosticoavrebbeprodottounaumento
22
deicasiriportatineglianni2003-2006(pressocentridiriferimento,spessodopovarievisitedi specialistinonancoraallertati inmeritoallanuovapatologia)(Yarom,Yahalometal.2007);dalla sua introduzionenel2002 l’acidozoledronicoha rapidamente•sostituitoilpamidronatocomefarmacodiprimasceltaneltrattamen-todellelesionischeletrichedaneoplasiamalignaemielomamultiplo,siainNordAmericacheinEuropa;inoltre,unnumeroconsiderevoledi pazienti già in trattamento conpamidronato è stato dirottato inqueglianniall’acidozoledronico,per lepiùconfortevolimodalitàdisomministrazione;neiconfrontidelpamidronato,ilrischiodiBRONJdopotrattamento•conacidozoledronicorisultapiùelevato(Fusco,Loidorisetal.2010)el’esordioavvienedopounperiododitrattamentopiùbreve(12-24mesivs24-48mesi,nelleprincipalicasistiche),concasiisolatidiesor-diodopopochimesiditerapia;ilrischiodiBRONJaumentaperdosicumulativediNBPpiùaltee/o•perperiodiditrattamentopiùlunghi(Durie,Katzetal.2005;Dimo-poulos,Kastritisetal.2006;Hoff,Tothetal.2008). Almenofinoal2005-2006,ipazienticandidatialtrattamentovenivanosottopostiaregimiditerapiaconNBPlacuiduratanoneraregolamentatadallealloravigentilineeguida(Berenson,Hillneretal.2002;Hillner,Ingleetal.2003);inquestomodosiraggiungevanoaltedosicumulativeneipazientilungo-sopravviventi;riduzionedelleprescrizionidiBPdopo il2005 (inparticolaredi zo-•ledronato),anchesullabasedinuove lineeguidache raccomanda-notrattamentiacadenzamensilediduratapiùlimitata(1-2anni)edeventuale“tailoring”(terapiaindividualizzatasullabasedellecaratte-ristichedelpazienteedell’aggressivitàdellamalattiadibase):inge-neralesièassistitoinquestiultimianniadunariduzionedeipazientitrattatie/odelladosecumulativadifarmacopersingolopaziente;efficaciadelleraccomandazioniemanateperminimizzareilrischiodi•BRONJ(Berenson,Hillneretal.2002;Hillner,Ingleetal.2003;Lacy,Dispenzierietal.2006;Campisi,DiFedeetal.2007;Durie2007;Aa-pro,Abrahamssonetal.2008;Dimopoulos,Kastritisetal.2009;Mini-sterodelLavoro2009;Ripamonti,Maniezzoetal.2009;Terpos,Sezeretal.2009).
Sonostati recentemente riportaticasidiosteonecrosideimascellari inpa-zientioncologicitrattaticon:
23
farmacibiologiciabersagliomolecolare(inparticolareagentiantian-•giogeneticiqualibevacizumab,sunitinib,sorafenib),dasoliocongiun-tamenteaNBP(Brunello,Saiaetal.2009;Guarneri,Milesetal.2010;KyrgidisandToulis2010;Migliorati,Wooetal.2010;Yarom,Eladetal.2010;Agrillo,NastroSiniscalchietal.2012).denosumab, un farmaco inibente il riassorbimento osseo da parte•degliosteoclastiinibendounaproteinadettaRANKligando(RANKL)(KyrgidisandToulis2010;Stopeck,Liptonetal.2010;Fizazi,Carduccietal.2011;Henry,Costaetal.2011).
Allafinedel2010sonostateemessedall’AgenziaEuropea(EMEA),ediconse-guenzadall’AIFA,duealertsullanecessitàdistrettomonitoraggiodeipazientioncologicitrattaticonbevacizumabesunitinibperilrischiodiOsteonecrosi,indipendentementedalfattocheipazientiricevanoomenoNBP(AIFA2010-a;AIFA2010-b).Deltuttorecentemente,èstatointrodottoilconcettodiosteonecrosifarma-cocorrelata(DRONJ)intendendoconquestoterminel’insiemedituttiipro-cessiosteonecroticiassociabiliall’usodi farmaciadelevatotropismoosseo(Mignogna,Sadileetal.2012).È opinione di questa Commissione che le somiglianze, almeno apparenti, nella presentazione clinica di questi processi osteonecrotici non siano ancora ele-menti sufficienti per permettere di unificare concettualmente malattie poten-zialmente molto diverse per gravità e progressione.Pertanto, si è deciso di analizzare in questa trattazione esclusivamentel’osteonecrosiassociataaNBP,di cuioggi si iniziaadavereunquadropiùcompleto.
Epidemiologia della BRONJ nei pazienti non oncologici
IdatiepidemiologicideipazientinononcologicitrattaticonNBPperpatologieosteometaboliche(principalmenteosteoporosi)sonoquantomaicarenti(inItaliaancorpiùcheneglialtriPaesi), innanzituttoper ladifficoltàdirisalirealnumerocomplessivodipazientiintrattamento(acausadellamolteplicitàdeiprescrittoridiBPorali,di mancanzadi registrideipazientiedelle loropatologie,discarsacompliancenell’assunzioneregolaredeifarmaci).Nondimeno,ilnumerodinuovicasidiBRONJinpazienticheassumonoNBPoralipermalattiaosteometabolicapotrebbeessere inparte sottostimato (man-catoodifficilericonoscimentodicasidiBRONJ,spessomenoseverieasin-
24
tomatici;ridottoaccessoacentridiriferimentoodontoiatricoodi2°livello).Alcuneinizialivalutazionidiincidenza,ottenuterapportandoilnumerodicasidiBRONJpubblicati(oriportatidalleAgenzieregolatorienazionali)inpazientinononcologicitrattaticonNBPorali(numeratore)conleprescrizionidiNBPorali(denominatore)indicavanofrequenzedell’ordinedi1casoogni10.000-100.000persone-annodiesposizione(AdvisoryTaskForceonBisphosphona-te-RelatedOstenonecrosisoftheJaws2007;Khosla,Burretal.2007).Nel2006,l’incidenzadiBRONJinunapopolazionedipazientinononcologicièstatastimatanello0.00038%(Felsenberg2006). Unapiùprecisamaanco-raparzialevalutazioneaustraliana(Mavrokokki,Chengetal.2007)indicavastimetra lo0.01%elo0.04%,chediventavanotra lo0.09%elo0.34%neipazientisottopostiadestrazione.LaprevalenzastimatadiBRONJneipazientinononcologicivariatra0.02%e1%.(Felsenberg2006;Khosla,Burretal.2007;Mavrokokki,Chengetal.2007;Ault2008;KingandUmland2008;Rizzoli,Burletetal.2008;RuggieroandMehrotra2009;SilvermanandLandesberg2009;Lo,O’Ryanetal.2010). Un’analisisu13,946assistitidiunaassicurazionehafornitounaprevalenzadello0.10%(1casocertoogni952pazientiarischio)limitandosiaicasisicu-ramenteaccertati(Lo,O’Ryanetal.2010). Inunostudiosu13,000soggetti,laprevalenzadiBRONJinpazienticheassumevanoBPinmanieracronicafuriportataesseredello0.06%(1:1,700)(Ault2008).Unostudioamericano,seppureconlimitazioninellaselezionedeipazienti(9casidiBRONJtra208pazienti,parial4.3%,trattaticonalendronato,osservatituttipressouncentrodiriferimentouniversitarioperproblemiodontoiatricidivariogenere),hafattoprospettarerischidecisamentesuperiori(Sedghiza-deh,Stanleyetal.2009).Idatidifrequenzaneipazientiosteometabolicinonsonospessodirettamentefruibili inquantolamaggiorpartedellecasistichesonomisteconpazientioncologici: inuno studiomulticentricoè stato riportatauna frequenzadel7.1%diBRONJinpazientitrattaticonBPper osrispettoaltotale (Otto,Abu-Idetal.2011).Inunoaltrostudio,condottoinduecentridiriferimentoisrae-liani,èstataosservatainpazientiosteometaboliciinterapiaoraleconBPlafrequenzadel8.9%diBRONJrispettoalcampionetotale(Yarom,Yahalometal.2007).Autorigiapponesi(Yamazaki,Yamorietal.2012)hannorecentementeidenti-ficatounrischio<1%diosteomielitein4,129pazientiinterapiaoraleconBP,sottolineandochel’usodiBPpotrebbeincrementareilrischiodiosteomielitepiùdialtrifarmaciperlacuradell’osteoporosi.
25
Altriautori(Diniz-Freitas,Lopez-Cedrunetal.2012)hannorecentementede-scrittountotaledi310pazienticonBRONJdaBPper os,dopounarevisionediseriedicasiconalmeno10soggetti,eseguitasuPub-Med.L’alendronato,il farmaco largamenteutilizzato fra i BPper os, è anchequello inmaggiormisuraimplicatoneicasidiBRONJ:ReidandCornish(ReidandCornish2012)hannodescritto261casidiBRONJinsoggettiinterapiaper osconBP,lamag-gioranzadeiqualiconalendronato.
Definizione della BRONJ
La definizione di osteonecrosi da bisfosfonati è stata formulata per la pri-mavoltanel2007dall’AmericanAssociationforOral&MaxillofacialSurgery(AdvisoryTaskForceonBisphosphonate-RelatedOstenonecrosisoftheJaws2007),come“presenza di osso necrotico esposto in cavo orale per più di 8 settimane in un paziente in terapia con bisfosfonati e mai sottoposto a radio-terapia dei mascellari (testa-collo)”.La definizione adottata dalle principali società scientifiche internazionali[AmericanSocietyofBoneandMineralResearch–ASBMR(Khosla,Burretal.2007), CanadianAssociationforMaxillofacialSurgery–CAOMS(Khan,Sandoretal.2008), CommissioneCHMPdellaAgenziaEuropeaperilfarmaco–EMA(EMEA2009),AlliedCommitteeoftheJapaneseSocietyforBoneandMineralResearch, JapanOsteoporosis Society, Japanese Society of Periodontology,JapaneseSocietyforOralandMaxillofacialRadiology,andJapaneseSocietyofOralandMaxillofacialSurgeons(Yoneda,Haginoetal.2010),FrenchExpertPanelAnalysis(Tubiana-Hulin,Spielmannetal.2009)]èrimastaadoggipres-sochéimmodificata.Lastessa definizioneèstatarecepita nel2009anchedalMinisterodellaSalu-teItalianonella“Raccomandazioneperlaprevenzionedell’osteonecrosidellamascella/mandiboladabifosfonati”(MinisterodelLavoro2009).Inpratica,taledefinizionediBRONJvienepresentatainunaformapuramentedescrittiva,cheidentificalapiùtipicamanifestazioneclinicadellamalattiainsoggetticonsideratiarischio,ovverol’ossoespostoincavoorale.Pertantoladiagnosidimalattiarimaneancoraoggiquasiesclusivamentebasatasull’os-servazioneclinicaditalesegnonelcavoorale.Èparerediffusotrairicercatorieiclinici,edancheopinionediquestaCom-missione,cheladefinizionediBRONJcosìcomeformulatadall’AAOMS,ancheallalucedelleattualiconoscenzeraggiunte,siadifattocarenteedilimitata
26
efficacia(Colella,Campisietal.2009;Yarom,Fedeleetal.2010;Bedogni,Fu-scoetal.2012;Bedogni,Saiaetal.2012).Inoltre,conl’introduzionediunnuovostadiodimalattianelleraccomanda-zioniAAOMS2009(Ruggiero,Dodsonetal.2009),chiamatostadio“0”,sièpostoinessereunproblemainterpretativodidifficilesoluzione.Lostadio“0”(vedi paragrafo “Stadiazione BRONJ”) include pazienti con segni e sintomioraliassimilabiliallaBRONJ,purinassenzadiesposizioneosseaclinicamenteobiettivabile.CiòèinnettocontrastoconladefinizionestessadiBRONJcheprevedecomecondizionenecessariaperladiagnosilapresenzadiossoespo-stoincavoorale.Nonèchiaro,quindi,comesiapossibileperilclinicoinclu-derenellostadio“0”dimalattiapazientiinterapiaconNBPchepresentinosegniclinicieradiologicisuggestividiBRONJ,senzacheaquestipossaesserediagnosticataformalmentelamalattia(Colella,Campisietal.2009).LaCommissione haanalizzato ladefinizionedimalattiaalla lucedellepiùrecenticonoscenzesull’argomento(Bedogni,Fuscoetal.2012),identificandoleseguenticriticità:
lapresenzadi“ossonecroticoespostoincavoorale”èsolounadelle•possibilimanifestazioniclinichedellamalattia;pertanto,considerarecomesoggettiaffettidaBRONJ solo ipazientichepresentanoossoespostoincavoorale impedisceladiagnosidiBRONJinunnumeroimprecisatodipazienti(Bagan,Jimenezetal.2009;Yarom,Fedeleetal.2010).L’introduzionedellostadio“0”rappresenterebbequindi iltentativodi limitare ilnumerodipotenziali falsinegativi,cioè ilnu-merodipazientipotenzialmenteesclusidalladiagnosidiBRONJperl’assenzadiossoespostoincavoorale;lapresenzadi“ossonecroticoespostoincavoorale”èspessounse-•gnotardivodimalattia;lanecessariapresenzadiquestosegnoclinicoascopodiagnosticosarebbecausadiunritardodiagnostico.Recentiesperienzesembranoconfermarecheunelevatonumerodisoggettirientrerebbenellaattualecategoria“stadio0”diBRONJ (anchepiùdellametàdeipazientiosservatiinalcunecasistiche)(JunqueraandGallego2008;Lazarovici,Yahalometal.2009;Mawardi,Treisteretal.2009), echeunapercentualerilevantediquestipazientipresentereb-beunaprogressioneversostadipiùavanzatidimalattiaconiltempo,sinoall’esposizioneossea.
Lanecessitàdiaccertarelapersistenzadell’ossonecroticoperalmeno8setti-manecomporterebbeancheunaccessotardivoalleterapienecessarie,limi-tandoinmodoconsiderevolelaloropotenzialeefficacia.L’attesadi8settima-
27
ne perunadiagnosidicertezza(AdvisoryTaskForceonBisphosphonate-Re-latedOstenonecrosisoftheJaws2007;Khosla,Burretal.2007;Khan,Sandoretal.2008) ovverodi6settimanesecondoaltriautori(Bagan,Jimenezetal.2006),èstataadottataperpermettereladiagnosidifferenzialecontuttelepossibilimanifestazioniclinichedi ritardodiagnosticoconseguentiaproce-durechirurgicheorali.Infatti,dopo8settimanedaun’estrazioneoqualsiasiprocedura chirurgicadento-alveolare la guarigionedellemucosedovrebbeesserecompletata,inassenzadiesposizioneossea(Khosla,Burretal.2007).Èpurverochel’attesadi8settimanepresentaimportantiestoricheanalogieconladiagnosidimalattieinfettivecronichedeimascellari(i.e.osteomielite)(Baltensperger2009).Nonèchiaropertantosenellasuaattualedefinizionesisiavolutoprivilegiareilcaratterecronicodelprocessoosteonecrotico,sullabasediunadeterminataipotesipatogenetica,ovverocercaredidefinireunquadroclinicodicertezza,inmododalimitareilnumerodeifalsipositiviinunafase incui leconoscenzesull’argomentoancorascarseggiavano.Lade-finizionediBRONJcomeadoggiaccreditatadefinisceunquadrocronicodimalattia,senzachesiastataindividuataunasuapossibileformainizialeacutao subacuta, così comenel casodellemalattie infiammatorie/infettivedelleossamascellari.LaCommissioneharilevatol’esigenzadiproporreunadefinizionerivistadiBRONJsolosullabasedelle informazionisicuramenteconosciute,senza in-cludereinessaalcunaconnotazionelimitativacircalapossibilepresentazioneoduratadeisegniesintomi.Questanuovadefinizionedimalattiadovrebbepermettereunadiagnosipiùprecoce,consentirel’inclusionedisoggettisinoadogginoninquadrabilinell’accezione“ossoespostoincavoorale”e,comeprimoeffetto,anticiparel’iniziodelleterapie.LadefinizionediBRONJproposta(Bedogni,Fuscoetal.2012)rispecchia lesopracitateconsiderazionievieneespressacomesegue:“l’osteonecrosi dei mascellari associata a bisfosfonati (BRONJ) è una reazione avversa farmaco-correlata, caratterizzata dalla progressiva distruzione e necrosi dell’osso man-dibolare e/o mascellare di soggetti esposti al trattamento con amino-bisfosfo-nati, in assenza di un precedente trattamento radiante”.Sirimandaaltestoperladescrizionedellediverseformeclinichedipresenta-zionedellamalattia.LaCommissiones’impegnaaridiscutereedaggiornarelapresentedefinizio-nesullabasedellefutureevidenzedellaletteratura;essahapoicercatodidefinireunpercorsodiagnosticochiaroeriproducibile,sullabasedellecono-scenzedisponibili,chepossaguidareilcliniconellaformulazionedelsospettodiagnosticoeportarealladiagnosiprecocediBRONJ.
28
Almomentodellastesuradiquestodocumento,èopinionecomunecheladiagnosidiBRONJpossabasarsiesclusivamente sudaticlinici e radiologici(Khosla,Burretal.2007;Khan,Sandoretal.2008;Ruggiero,Dodsonetal.2009).Infatti,l’esecuzionedibiopsieosseeascopodiagnosticoèfortementesconsigliata inpazienticon sospettaBRONJ,per il rischiodi favorire lo svi-luppoe/olaprogressionedelprocessoosteonecrotico(Ruggiero,Gralowetal.2006).Moltodiscussaè l’utilitàstessadellabiopsia,quandoeseguita incorrispondenzadiossonecroticoesposto incavoorale,vistoche ilquadroistologicononsembrerebbeadoggiaggiungerenullaaquelloclinico(Phal,Myalletal.2007).Secondo gli attuali orientamenti, in definitiva, l’accertamento bioptico an-drebbeeseguitosoloperdirimereilsospettodimetastasiinsedemandibola-re/mascellare(Campisi,DiFedeetal.2007).Va comunque segnalata la possibilità che in un prossimo futuro la biopsiaosseadento-alveolarepossadiventareuntassello importantenelladiagno-siprecocediBRONJ,soprattuttoneisoggettiadaltorischiodisvilupparelamalattiaoincolorochenonpresentinosegniclinico-radiograficiesaustivi.Èstatorecentementeillustratoilvalorepredittivodell’esameistologicodell’os-sodento-alveolareversolosviluppodiBRONJinpazientiarischio(Saia,Blan-damuraetal.2010).ComesievincedalladefinizionediBRONJpropostadagliautori,l’assunzionepregressaoinattodiNBPèunacondizionenecessariaperpoteridentificaresoggettiarischioepotenzialmenteaffettidallamalattia(Appendice I).Talecondizione,purtuttavia,nonèmaisufficienteaporredasolaunadiagnosiconclusivadiBRONJ.Sonodescritte formediosteonecrosi diversedaquellaassociataall’usodiNBP(i.e.osteonecrosida farmacibiologici). Incasodicompresenzadialtriagenticausalioltreall’usodiNBPnellastoriadiunsoggettoconosteonecrosideimascellari,nonsiritienepossibilealmomentodellastesuradiquestodo-cumentoporreunadiagnosidiBRONJpropriamentedetta.Lapregressaesecuzionediradioterapiadeimascellaririmanealmomentol’uni-cocriteriodiesclusioneaccettabileperladiagnosidiBRONJ(Appendice1)
Criteri diagnostici della BRONJ
LaCommissioneharilevatolanecessitàdiimplementareladiagnosidimalat-tiaconunaseriedicriteridiagnostici,siaclinicicheradiologici,diversidalla
29
sempliceosservazionediossonecroticoespostoincavoorale.TalenecessitàderivadalfattocheunnumeroconsistentedipazientiintrattamentoconNBPechesviluppaBRONJ,presentasegniesintomi,almenoinfaseiniziale,diver-sidall’esposizioneossea (Yarom,Fedeleetal.2010).Pur riconoscendochel’esposizionediossonecroticorimaneancoraoggiilpiùsicuroindicatorediBRONJ(Ruggiero,Dodsonetal.2009),altrisegniesintomidiperséaspecifici,possonoedevonoportarequantomenoalsospettoprecocediBRONJ,ancheinpresenzadiunacausadento-parodontalericonosciuta(JunqueraandGal-lego2008;Mawardi,Treisteretal.2009). Unrecentestudiocondottosu110pazientiaffettidaBRONJhaevidenziatocome lamalattiasiacaratterizzatadaesposizioneosseasolonel55.4%deipazienti(Elad,Gomorietal.2009);similmente, inunlavoromulticentricoèstatasegnalataunapercentualedicasisenzaesposizioneosseaparial28.8%,inunapopolazionedi334pazientiaffettidaBRONJ(Fedele,Porteretal.2010).
Criteri Clinici
Apartel’esposizioneossea,riconosciutacomesegnoclinicomaggioreequin-ditaledasoddisfareladiagnosidiBRONJinpresenzadianamnesifarmacolo-gicapositivaperNBP,cisiproponediutilizzareascopodiagnosticoanchel’in-siemedeisegnicliniciminoriedeisintomiattualmenteimpiegatiperdefinirelostadio0dimalattiasecondol’AOOMS.Tuttiquestisegnisonoampiamentecondivisi dalle principali commissioni internazionali di studio sulla BRONJ.Vengonoelencatidiseguito,inordinealfabetico,unaseriedisegniclinicimi-noriesintomichedasoli,oinassociazionetraloro,devonofarporrequantomenoilsospettodimalattiaolasuadiagnosidifferenziale(Tabella2).
30
Tabella 2. Criteri clinici non specifici per la diagnosi di BRONJ
Segno clinico maggiore
Esposizionediossonecroticoincavoorale
Segni clinici minori e sintomi (inordinealfabetico)
AlitosiAscessoodontogenoAsimmetriamandibolareDoloredioriginedentaleeosseoFistolamucosaFistolaextra-oraleMancatariparazionemucosaalveolarepost-estrattivaMobilitàdentalearapidainsorgenzaMobilitàpreternaturaledellamandibola,conosenzaocclusioneconservataParestesia/disestesiadellelabbra(segnodiVincent)*FuoriuscitadiliquididalnasoSecrezionepurulentaSequestrospontaneodiframmentiosseiTrismaTumefazionetessutimolli
*dairritazionedelnervoalveolareinferiore/nervoinfraorbitario
Lapresenzadiunoopiùsegnicliniciminoriosintomiinunpazienteintrat-tamentoconNBP,anchequandoimputabiliadunacausadento-parodontaledocumentata,dovrebbefarporreilsospettodimalattiaeindurrel’operatorearichiedereaccertamentiradiologiciperconfermareoescludereilsospettodimalattia(vediparagrafosuwork-updiagnostico).Conriferimentoaisintomi,ildoloreèunsintomodifrequenteriscontroneipazienticonBRONJ(Miksad,Laietal.2011).Ciononostante,inunnumeroele-vatodipazientiildolorenonsembraesserepresenteagliesordidellamalattia(Ruggiero,Mehrotraetal.2004;Ruggiero,Fantasiaetal.2006).Ildolore,sullacuinaturasonostateavanzatediverseipotesi(i.e.doloreneuropatico,infetti-vo,infiammatorio,miogeno),puòpresentarsisecondovariemodalità:
odontalgia, non spiegabile con una patologia dento-parodontale in•atto;
31
dolore“osseo”ditipogravativo,bendelimitabilenellasede(piùfre-•quentealcorpomandibolare);doloreirradiatoallamuscolaturamasticatoriaecervicale,chepuòri-•cordarequellodapatologiadell’articolazionetemporo-mandibolare(doloremiogeno);doloresinusitico;•iperestesiaodoloreditipotrigeminale(cheinteressaselettivamente•labrancanellasededimanifestazionediBRONJ).
Ildoloreèconsideratounfattoreaggravantelaprognosidellamalattia,perchéspessomalcontrollatoeintalunicasirefrattarioallaterapiamedica.Perque-stomotivo ilsintomodoloreèconsideratoelementodiscriminantedall’AA-OMS(Ruggiero,Dodsonetal.2009),inpresenzadiossoespostoincavoorale,perdefinireilpassaggioadunostadiodimalattiapiùavanzato.LaCommissione,verificatocheaogginonesistealcunaevidenzasecondocuilapresenzaolacomparsadidoloreinunsoggettoaffettodaBRONJsiassociadunquadroavanzatodimalattia,ritieneopportunoutilizzareilsintomodo-loreperdistinguerecondizioniclinichediversenell’ambitodellostessostadio,piuttostocheperdefinirestadidiversidimalattia(vediparagrafo“StadiazionedellaBRONJ”). IldoloreècertamenteilsintomochepiùaffliggeilpazienteaffettodaBRONJ,quandopresente.Ildoloreèspessodielevataintensità,an-chenotturno,edarrivaalimitareinmodosignificativolavitadirelazionedelpaziente(MinisterodelLavoro2009).Ildoloreèspessopresenteinpazientiaffettidaneoplasiedisseminate,chegiàfannousodifarmacioppioidiperlagestionedeldolorescheletricometastatico,senzaperaltroottenereunbene-ficiodirettosullasintomatologiadolorosaassociataallaBRONJ.IltrattamentodelsintomodoloreèunpuntocriticodellaterapiadellaBRONJ.Essendo ildoloreunsintomosoggettivocheinfluenzaspessolasceltadeitrattamentiolalorosuccessivaripetizione,vistalanecessitàdimonitorarel’evoluzionedeldoloreneltempoafrontedellediverseterapiemesseinatto,laCommissioneproponechevengadiprassieseguitaunamisurazionesoggettivadeldolo-re riferitomediante l’utilizzo di una scala analogica visiva graduata (Visual Analogue Scale-VAS),dasottoporrealpazientealprimoincontroeadognisuccessivavisitadicontrollo,permonitorarel’andamentodellamalattiael’ef-ficaciadeitrattamentinonsolodalpuntodivistadell’operatore,maanchedelpaziente(Saia,Blandamuraetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011;Miksad,Laietal.2011).
32
Criteri radiologici
Ladiagnosi radiologicadiBRONJèmoltocomplessa,per l’assenzadi segnipeculiaridimalattiaintutteleprincipalimetodichediindagineconosciute.ViètuttaviaunacrescenteevidenzachealcunetecnicheradiologichepossanoaiutarenelladiagnosidiBRONJ,permettendodi identificareareedicoinvol-gimentoprecoceanche inassenzadiesposizioneosseae,successivamente,diindagarel’estensionedell’areanecroticaelapresenzadilesionimultifocali(Morag,Morag-Hezronietal.2009).Diconseguenza i radiologisvolgonounruoloimportantenellaidentificazionedeipazientiarischiodiBRONJedèvero-similecheinfuturopossanoassumereunruolosemprepiùcentrale.L’Ameri-canDentistryAssociation(ADA)elaCanadianAssociationforMaxillofacialSur-gery(CAOMS) affermanogiustamentecomenonsiapossibileeffettuareunadiagnosidiBRONJattraversoisoliesamiradiologici, iqualisonoingradodirilevaresolamenterepertiaspecifici(Khan,Sandoretal.2008).PostochenonesisteancoraunesameradiologicoidealeperladiagnosidiBRONJ,l’AmericanSocietyofBoneandMineralResearchaffermachesebbeneognitecnicara-diologicaabbiadeilimiti,lacombinazionedidifferentitecnicheradiologichepotrebbefornireelementiutilialladiagnosi(Khosla,Burretal.2007).Inletteraturasonostatiidentificatiunaseriedisegniradiologicidipossibilepresentazionedellamalattia.Èdasottolinearecomunqueilfattochenonèstatoancorapossibiledifferenziareconcertezzadeisegniradiologicidiesor-dioperlaBRONJ.L’unicosegnoriportatoinletteraturacomepotenzialmentespecificodiBRONJconsisterebbeinunispessimentodellamembranadiSch-neiderdelsenomascellarevisibileallaTomografiaComputerizzata (TC), le-gatoadunaeccessivaosteogenesi(Bianchi,Scolettaetal.2007).Tuttavia,èopinionedi moltiautoriediquestastessaCommissionechequestosegnosia semplicemente espressionedi unaneo-apposizioneosseaperiostale dicomune riscontro inprocessi flogistici cronicizzatidei senimascellari (Cho,Kimetal.2007).Inognicaso,questosarebbeunsegnoavanzatodiBRONJ,considerandochelamalattiaoriginaquasisempreinsededento-alveolareeinteressasolosecondariamenteilsenomascellare.Il limitedi rappresentazionedelle tecnicheadisposizioneper lo studio ra-diologicodellaBRONJpotrebbedareunaparzialespiegazionedell’assenzadispecificitàradiologichedellamalattia(Morag,Morag-Hezronietal.2009);èinoltreriportatainletteraturalapossibilitàcheall’esordiolamalattiasipre-senticonunaseriedisegniclinici,ancheinassenzadisegniradiologicispeci-fici(Mawardi,Treisteretal.2009).
33
Le indagini radiologichepiùutilizzateadogginelladiagnosidiBRONJsonocertamentel’Ortopantomografia(OPT)(Sanna,Predaetal.2006;Mawardi,Treisteretal.2009), leradiografieendorali,e laTC(Chiandussi,Biasottoetal.2006;Bianchi,Scolettaetal.2007).Illoroampioutilizzodipendedaunaseriedifattori:
miglioredefinizionedellestrutturescheletricherispettoallealtreme-•todicheconosciute;accessofacilitatoall’indagineperlagrandedisponibilitàdellatecno-•logiasulterritorio;costilimitati;•maggioreconoscenzadelletecnichedapartedelmedicoedell’odon-•toiatraprescrittore;maggiorepossibilitàdiconfrontotraspecialisti.•
L’Ortopantomografia, o radiografia panoramica delle arcate dentarie (OPT), permettediacquisireinformazionigeneraliriguardolostatusdellamandibolaedelmascellare,utilesoprattuttonell’identificazionedieventualisequestriosseieareeosteolitichecombinateadareediosteosclerosi.Tuttavia, l’OPTnonpermettedidifferenziarelanaturadellelesioniosteolitichedaeventualimetastasiossee,soprattuttoseisolate.Larisoluzionedicontrastodell’OPTèbassaerichiedeunasignificativaperditaminerale(superioreal30-50%)pri-machesiapossibileidentificareunalesioneosteolitica(StoreandGranstrom1999;Chiandussi,Biasottoetal.2006). InoltrelaOPTèunazonografia,cioèunatomografiaastratospessoconlapossibilesovrapposizionesulleimmagi-nidistrutturechesitrovanosupianidiversimanellostessostratoradiografa-to.Leimmaginipossonoessereinficiatedaartefattidaposizionamentodelpaziente,ombreditrascinamento,etc.Lavisualizzazionedeisettoricentralièspessocarente(TerrosiVagnoliP1994).Diconseguenza,lelesionidellaBRONJpossonoesserefrequentementemi-sconosciuteall’OPTenonèpossibiledistingueretratessutopatologicoetes-sutoosseosano.Ciononostanteesisteancoraoggiunlargoconsensoall’uti-lizzodell’OPTcomeprimostrumentodiapproccioalpazienteconsospettaBRONJ.La Tomografia Computerizzata (TC), inparticolarenellaversioneTCspirale,haunarisoluzionedicontrastomaggiorerispettoallaradiografiaconvenzio-naleefornisceinformazionidettagliatesulnumeroesullanaturadieventualilesioniosteoliticheedosteosclerotichepresenti (Chiandussi,Biasottoetal.2006;Bianchi,Scolettaetal.2007);permetteinoltrediindagareconprecisio-nesial’ossocorticalechel’ossotrabecolare.LaTCpermettedidiscriminare
34
conbuonaapprossimazionetratessutoosseosanoepatologicoinmolticasi,fornendoinformazioniutilisull’estensionedelprocesso. Il limiterealedellaTCpotrebberivelarsiinfuturonellostudiodellemodificazioniosseeprecocidellaBRONJ,dovelasuaefficacianonèancorabendocumentata.Allalucediquantoesposto, la Commissione ritiene che l’OPT e la TC siano da considerarsi le tecniche di indagine di primo e secondo livello rispettivamente più utili per la definizione di un percorso diagnostico routinario.Ipiùsignifi-cativipatternradiologici(perOPTeTC)compatibiliconladiagnosidiBRONJsonoriportatiinTabella3.Alcuni autori hanno cercato di suddividere i segni radiologici di BRONJ siaperl’OPTchelaTCinprecocietardivi(Bianchi,Scolettaetal.2007;Krishnan,Arslanogluetal.2009).Questadistinzione,chevienemantenutanelpresentedocumento(Tabella3),hacomunqueinséunaseriedicriticitàchelaCom-missionehaidentificatoneiseguentipunti:
nessunsegnoradiologicoèpeculiaredellaBRONJedeveesseresem-•precorrelatoadunoopiùcritericliniciperpoteravanzareilsospettodimalattiaegiungereadunadiagnosiconclusiva;lapersistenzadell’alveolopost-estrattivoel’ispessimentodellalamina•duradopoestrazionedentalesonoconsideratiunpossibilesegnopre-cocediBRONJall’OPT;ciononostante,visonoalcunistudichesegnala-nolapersistenzadell’alveolopost-estrattivoadunannodall’estrazioneinpazientichenonmostranosegniclinicidiBRONJ(Saia,Blandamuraetal.2010).L’assenzadiriparazionedell’alveolosarebbelegatasecon-dogli autori all’attivazione localedelNBP che inibirebbe il rimodel-lamentoosseoinsedediestrazione,mantenendonelastrutturaperdiversi anni anche in assenzadi segni clinici dimalattia.Pertanto lapersistenzadiunoopiùalveolipost-estrattiviall’OPTnonèdacon-siderare sempreun segnodimalattia, tantomenonecessariamenteprecoce;all’OPTisegnidiunaalterazionestrutturaleinizialedell’ossosonodif-•ficilmenteidentificabiliperlanaturastessadellatecnica,soprattuttoinconfrontoallaTC.PertantolaTCèl’indaginechemegliopermettediidentificarealterazioniinizialidellastrutturamidollarecompatibiliconBRONJ(Chiandussi,Biasottoetal.2006;Bianchi,Scolettaetal.2007;Bedogni,Blandamuraetal.2008;Morag,Morag-Hezronietal.2009;Saia,Blandamuraetal.2010). IsegnitardividiBRONJ,inparticolareilsequestroosseo,l’osteosclerosidiffusa,lareazioneperiostaleelefrat-turepatologichesonougualmentericonoscibiliall’OPTedallaTC,con
35
unamaggioresensibilitàdiquest’ultimaneldefinire l’estensionedelprocessosoprattuttoperquel che riguarda l’identificazionedieven-tualitragittifistolosi(Phal,Myalletal.2007;Morag,Morag-Hezronietal.2009);isegniTCcomunementeassociatiallaBRONJ(Tabella3)delineanoin•largamisuracondizionitardivedimalattia.SoloisegniTCchedefini-sconoilgradodiprogressivoaddensamentodellamatriceossea(i.e.ispessimento trabecolare, sclerosimidollare focale edosteosclerosi)sembranocaratterizzarelefasiinizialidimalattia,equindisarebberoquellidaricercareperunadiagnosiprecoce(Carneiro,Vibhuteetal.2006;Bisdas,ChambronPinhoetal.2008;Hutchinson,O’Ryanetal.2010);ilgradodiaddensamentoosseoprogressivodelsegmentoscheletrico•coinvoltoosospettoperBRONJè identificabileattraverso lacompa-razioneconladensitàosseadeisegmentischeletricilimitrofinormali(Hutchinson,O’Ryanetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011)(Tabella3).
36
Tabe
lla 3
. Cri
teri
radi
olog
ici p
er la
dia
gnos
i di B
RON
J - O
PT e
TC
Segn
i rad
iolo
gici
non
spe
cific
i di B
RON
J (inordinealfabe
tico)
Prec
oci
Tard
ivi
OPT
Ispe
ssim
entocrestaalveolareelaminadu
ra
Persistenzaalveolopo
st-estrattivo
Sequ
estro
Slargamen
tospa
ziopa
rodo
ntale
Fratt
urapa
tologica
Ispe
ssim
entocan
alede
lnervoalveo
lareinferiore
Osteo
sclerosidiffusa
Ra
diop
acità
sen
omascellare
Re
azione
periostale
TC
Erosione
corticale
Ispe
ssim
entocrestaalveolareelaminadu
ra
Ispe
ssim
entotrab
ecolare
Osteo
sclerosim
idollarefo
cale*
Pe
rsistenzaalveolopo
st-estrattivo
Sequ
estro
Slargamen
tospa
ziopa
rodo
ntale
Fistolaoro-an
trale,oro-nasale,m
uco-cutane
a
Fratt
urapa
tologica
Ispe
ssim
entocan
alede
lnervoalveo
lareinferiore
Osteo
lisiestesaalsen
omascellare
Osteo
sclerosidiffusa
Osteo
sclerosidizigom
oe/opa
latoduro
Re
azione
periostale
Sinu
site
*Sclerosim
idollarefo
calecon
disorganizzazione
trab
ecolareescarsadifferen
ziazione
cortico-m
idollare
37
LaScintigrafia ossea total-body con TC99è l’esamefunzionalepiùutilizzatoper la diagnosi di localizzazioni scheletriche di neoplasie solide, ed è am-piamenteusatoperilloromonitoraggio(Bombardieri,Aktolunetal.2003;Ghanem,Uhletal.2005).EssendolaBRONJmoltopiùfrequenteneipazientiportatoridimalattiascheletricametastaticaemielomamultiplo,edessendoquestipazienti comunemente inpossessodi esami scintigrafici total-bodyeseguitiprimaoinvicinanzadellacomparsadeisintomidiosteonecrosi,leinformazioniderivantidallascintigrafiapotrebberofornireunvalidosuppor-toperlaformulazionedelsospettodiagnosticodiBRONJ(Bertoldo,Santinietal.2007).LapresenteCommissioneritienelascintigrafiaosseatotal-bodyunutilesupportodiagnostico,quandogiàeseguitoperaltreragioni,manonneconsiglial’esecuzioneperfinalitàdiagnostichespecifiche.Perannilascin-tigrafiaconTC99èstataconsiderataesamedielezioneperladiagnosidellediverselocalizzazionidiosteonecrosisubaseischemica.Lametodica,peral-tro,è ingradodi individuareun incremento focaledellavascolarizzazioneall’internodiunsegmentoscheletrico,piùcheun’areadinecrosiischemica(Dore,Filippietal.2009). L’accertamentodiun’ipercaptazionesospettaditracciantealivellodeimascellari,seppurnonspecificainquantorilevabileinqualsiasiprocessoflogisticodeimascellari,puòorientareesupportareilclinicoversounadiagnosidiBRONJgiànelleprimefasi,inpresenzadisegniesintomiclinicidiBRONJ(O’Ryan,Khouryetal.2009).Nonsivuoleinque-staoccasioneequiparareTCescintigrafiadaunpuntodivistadellequalitàequantitàdiinformazionifornite,vistalanettasuperioritàdellaTC,masottoli-nearelanecessitàdapartedell’odontoiatraedelchirurgomaxillo-faccialediricercareeutilizzareesamistrumentalispessogiàeseguitiperaltremotiva-zionimachepossonorivelarsimoltoutilinelladiagnosiinizialeeperstabilirelastorianaturaleoevoluzionetemporaledellamalattia.ÈaltresìchiarochenelsospettodiunaBRONJinunpazientearischiointerapiaconNBP,chenonsiagiàinpossessodiunaScintigrafiatotal-body,l’esamedisecondoli-vellodarichiederesaràcertamentelaTC.Unaserieditecnicheradiologichesupplementari,chechiameremoditerzolivello,sonoutilineicasididubbiainterpretazioneoquandosianecessariostabilireconmaggioreaccuratezzal’estensionedelprocessoosteonecroticoascopoterapeutico.Questetecniche,tracuilaRisonanzaMagnetica(Bedogni,Blandamuraetal.2008;Bisdas,ChambronPinhoetal.2008;Garcia-Ferrer,Baganetal.2008),laTomografiaComputerizzataafascioconico(Barragan-Adjemian,Laustenetal.2008),laScintigrafiaconLeucocitimarcati(Vittorini,DelGiudiceetal.2005;Catalano,DelVecchioetal.2007) laTC-PET(Dore,
38
Tabella 4. Criteri radiologici per la diagnosi di BRONJ - RM metodica
Segni radiologici non specifici di BRONJ
Metodica Sequenza Osso normale Infiammazione Necrosi ossea
RM
T1T2STIRT1Gadolinioesoppressione grasso
isointensoisointensoipointensoenhancement
ipointensoiperintensoiperintensoenhancement
ipointensoipointensoipointensoenhancementorlettoipercaptante
Filippietal.2009),e le tecnichedi imaging integratetrovanouncrescenteconsensoanchenelladiagnosticadellaBRONJ.Pur tuttavia, essi hannounlimitediutilizzolegatoalladifficoltàdiaccessoall’esameeaicostielevati.La Risonanza Magnetica (RM)èindicataperlostudiodell’estensionedelpro-cesso osteonecrotico (Bedogni, Blandamura et al. 2008; Bisdas, ChambronPinhoetal.2008).Èormaichiaritoche l’ossoesposto incavoorale,quan-dopresente,rappresentalapuntadell’icebergdelprocessomorboso,chesiestendealdisottodellamucosaintegra.Inparticolare,moltiautoriconside-ranolaRMindaginediscelta,alparidellaTC,perlostudiopreoperatoriodeicasirefrattari,inquantopermetterebbediidentificaresiailgradodicoinvol-gimentoosseochedeitessutimolliadiacenti(presenzadiascessi,flemmoniefistolemuco-cutanee)(Bedogni,Blandamuraetal.2008;Bisdas,ChambronPinhoetal.2008;Garcia-Ferrer,Baganetal.2008;Bedogni,Saiaetal.2011).Direcente,èstatoosservatochelaRMèingradodivalutareilgradodiede-madelmidolloosseoelezonediischemiachecorrispondonorispettivamen-tealleareediosteomieliteediosteonecrosi,cherappresentanoleduepiùtipicheformedipresentazionedellamalattia,quasisemprecoesistenti(Be-dogni,Blandamuraetal.2008)(Tabella4).
La Tomografia Computerizzata a Fascio Conico (CBCT):èunatecnicarelati-vamentenuovachesottoponeilpazienteadunadoseinferiorediradiazionirispettoallaTC,masuperioreall’OPT,datenereinconsiderazioneperilgran-denumerodiinformazionichefornisce(Ludlow,Davies-Ludlowetal.2003).L’indagine ha un’alta risoluzione spaziale e consente di avere informazioni
39
dettagliatecircaladensitàdell’osso(e.g.sottigliezza,integritàdellacorticaleedelmidolloosseo).TuttavialaminorerisoluzionedicontrastorispettoallaTCnonpermettedivalutareitessutimolli.LealterazioniosseedellaBRONJindividuabiliconunaCBCTsonoalmomentolestesserivelabiliconunaTCspiralemultistrato(Tabella3).Questoesamepotrebbesostituireinunpros-simofuturosial’OPTchelaTC(TreisterandWoo2006;Barragan-Adjemian,Laustenetal.2008)La Scintigrafia con leucociti marcati con 99mTc (99mTc-HMPAO LeukocyteScintigraphy)èunesamemetabolicoingradodidiscriminarelapresenzadiunprocessoinfettivorispettoadunoinfiammatorio.Lametodicaconsistenelmarcareconuntraccianteigranulocitineutrofilidelpazientedopoprelievoematicoe,unavoltareinfusi,diseguireneltempolalorolocalizzazioneneidiversitessutidell’organismo, incluso l’osso.Questametodicaèstatautiliz-zatainassociazioneallaTCpervalutareinunostudiosperimentaleirisultatideltrattamentochirurgicodellaBRONJsullarecidivadiinfezione(Jadu,Leeetal.2007).L’esameèinoltreconsideratodiqualcheutilità inassociazioneallaTC,quandolapresenzadimaterialeprotesicocontroindichil’esecuzionedi unaRMper la possibilità di artefattimetallici, permeglio caratterizzarel’estensionedell’infezioneosseaprimadiuntrattamentochirurgico(Vittorini,DelGiudiceetal.2005).La Tomografia ad emissione di positroni (PET) èunesamefunzionale, ingradodidefinireareedialteratometabolismoosseo. Il limitedi risoluzionedellametodicaècomunquebassoedèperquestoconsiderataindaginepocoutileperdiagnosidiBRONJ.RecentementeungruppodiricercatorihainvestigatolasensibilitàdiduetracciantiutilizzaticonlaPETperladiagnosidiBRONJeperlamisuradell’estensionedelprocessoosteonecrotico(Wilde,Steinhoffetal.2009),mailnumerolimitatodipazientistudiatiimpedisceadoggiunsuoutilizzopiùampio.Secondol’EMEA,laPETtroverebbeunapotenzialeapplica-zioneincasidubbidiBRONJsenzaesposizioneossea(EMEA2009).LaTomografia ad emissione di singolo fotone (SPECT),dasolao inassocia-zioneallaTC(HibrydSPECT/TC),dovrebbeessereingradodidistingueretraunaridottacaptazionedell’ossonecrotico(sequestro)edilcircostanteossocaratterizzatodaiperattivitàcellulare(Chiandussi,Biasottoetal.2006;Dore,Filippietal.2009);nonècomunquechiarosel’ipercaptazionedeltraccianteavvengaall’internodellareazioneosteonecroticaoppurenellezonereattivecircostanti(Estilo,VanPoznaketal.2008).ConsideratocheilcaricomediodiradiazioneperesamiPET,TC/PET,SPECTeSPECT/TCèelevato,neèconsigliabile l’esecuzionesolo incondizionimoltoparticolari.
40
Work-up diagnostico della BRONJ
La Commissione ha ritenuto opportuno proporre un percorso diagnostico,sullabasediquantosinoraaffermato (Bedogni, Fuscoetal.2012).Questowork-updiagnosticodovrebbeconsentirealclinicodiporreunadiagnosidisospetto(Step 1)e,attraversol’esclusionedipatologiesimili-diagnosidiffe-renziale(Step 2),giungereadunadiagnosiconclusiva(Step 3)conunbuonmarginedisuccessoedintempibrevi(vediSchema1).
Sospetto diagnostico
STEP 1
Diagnosi differenziale
STEP 2
Diagnosi conclusiva
STEP 3Imaging 2 Livello
Tomografia computerizzata
Imaging 1 livello
Ortopantomografia (OPT) o radiografie endorali
Esame obiettivo
Identificazione segni clinici Valutazione dolore (scala VAS)
Medica Odontoiatrica Farmacologica
Fattori rischio sistemiciFattori rischio
localiTipo
DurataVia di somministrazione
Dose cumulativa
Anamnesi
Schema 1. Work ‐ up diagnostico di BRONJ
Step 1. IlsospettodiBRONJdovrebbeesserepostoogniqualvoltaunpazienteintrattamento(inattoopregesso)conNBPpresentideisegniedeisintomiincavooralediversidall’esposizioneossea(vediTabella2),anchequandoim-
41
putabiliadunacausadento-parodontaledocumentata.Lapresenzadiquestisegnideveindurrel’operatorearichiedereaccertamentiradiologicipercon-fermareo escludere il sospettodimalattia. L’identificazioneprecocedi uncasodiBRONJconsentirebbedisicurounaccessopiùrapidoaitrattamentiedunamaggioreprobabilitàdisuccessodeglistessi.L’odontoiatraèlafigurapiùimportantenelpercorsodiagnosticoiniziale,per-chéèilprofessionistadirettamentecoinvoltonelloscreeningdelpazientearischioequindichiperprimoèingradodisospettarelamalattia.UgualmenteimportantiaifinidiunadiagnosiprecocediBRONJsonoilpazienteintratta-mentoconNBPed ilmedicoprescrittoredel farmaco(oncologoespeciali-stadell’osteoporosi,medicodimedicinagenerale,ortopedico,reumatologo,ematologo).Èpossibilesintetizzareilruolodiciascunodeisoggetticoinvoltinelprocessodiagnosticoiniziale,comesegue:ilmedicoprescrittoredelNBPhailruolofondamentalediistruireilpazienteaffinchéessosiaconsapevoledelrischiodisvilupparelamalattianelcorsodeltrattamento,ealcontempopossaessere indirizzatoadunavisitaodontoiatrica; l’odontoiatracheha incuraunpazientechestaperiniziareoègiàinterapiaconNBPhailcompitodiinstauraredellemisurepreventiveattearidurreilrischiodimalattia,ediistruire ilpazientesullediversemodalitàdipresentazioneclinicadellama-lattia(vediCapitolo2).Lasensibilizzazionedelpazienteallepossibilimani-festazioniclinichedellaBRONJfasìcheilpazientearischiopongamaggioreattenzioneallacomparsadidisturbiincavooralecollegabiliallamalattiaesirivolgaprecocementealproprioodontoiatraincasodidubbio.Step 2.Ladiagnosidifferenzialedeveconsideraretuttequellecondizionipa-tologichedelcavooralechepresentinosegniditipoclinicoeradiologicoe/osintomisovrapponibiliallefasiinizialidiBRONJecheinalcunicasipossonorappresentareessestessefattoreprecipitantelaBRONJ.Traquesteincludia-mo principalmente l’osteite alveolare condensante, l’ascesso parodontale,l’ascessoendodontico,lelesioniendo-parodontali,laparodontopatiacronica,lamucositeperimplantareelaperimplantite.Inpresenzadisintomatologiadolorosadevonoesserepresiinconsiderazioneancheidisordinidell’artico-lazionetemporo-mandibolare.Ancheinquestafasel’odontoiatrasvolgeunruoloessenziale.Èinfattil’operatorecheesegueunaprimadiagnosidifferen-ziale,individuandolapresenzadeifattoridirischiodimalattiaincavoorale(vediparagrafo“CategorieefattoridirischiodiBRONJ”)elapresenzadipos-sibilifattoriscatenanti;coluicheinpresenzadiunsospettofondatodimalat-tiadovrebbeinviareconsolerziailpazientepressocentrispecializzati.Step 3.Affidataacentridisecondoeterzolivello(MedicinaePatologiaOra-
42
le,ChirurgiaMaxillo-Facciale),prevedel’esecuzionediindaginiradiologicheestrumentalipiùspecificheelarivalutazioneconclusiva(analisideglistep).È opinione della Commissione che a oggi non esiste alcun esame sierologico che si sia dimostrato di significativo ausilio nella diagnosi di BRONJ o nell’identifi-cazione del rischio di BRONJ.
Stadiazione della BRONJ
Inquestocampo,siassisteadunarapidaevoluzionedelleconoscenzescien-tifichecherendenecessarioilcostanteaggiornamentodelleinformazionigiàacquisite.LeprimaclassificazioneinstadidiBRONJ,propostanel2007dal-laAAOMS(AdvisoryTaskForceonBisphosphonate-RelatedOstenonecrosisoftheJaws2007),èstatarecentementemodificata(Ruggiero,Dodsonetal.2009),perchénonpiùsufficientementerappresentativadellacomplessitàdeiquadricliniciemersi(McMahon,Bouquotetal.2007).LastadiazionediBRONJinorigineprevedevachesolopazientichepresentas-seroossoespostoincavoorale,comedadefinizionedimalattia,potesseroessereclassificatiinunodei3stadi,inbaseallapresenzadisegnidiinfezione,dolore,o complicanze (i.e.fistole cervicali, fratturepatologiche) (Ruggiero,Fantasiaetal.2006);lastessaclassificazioneprevedevainoltrel’esistenzadiuna categoriadi soggettia rischio,o STADIO “X”, che includevapazienti intrattamentoattivoopregressoconbisfosfonatisenzaesposizionediossone-croticoincavoorale.LastessaAOOMShaprodottonel2009unamodificasostanzialedellaclas-sificazionediBRONJ,eliminandolostadio“X”edinserendolostadio“0”dimalattia(Ruggiero,Dodsonetal.2009).Lostadio“0”sarebbecostituitodapazientiintrattamentoconNBPchepresentanosegnicliniciaspecificidima-lattiainassenzadiesposizioneosseaediunaaccertatacausadento-parodon-tale.Anchel’EuropeanMedicinesAgency(EMEA)èconcordenelconsiderarelapresenzadiunostadioprecocedellacondizione,duranteilqualeipazientimostranosintominonspecificicomeodontalgiaedoloreosseo,mainassen-zadiesposizioneossea(EMEA2009).LaCommissioneha identificato inquesto sistemaclassificativouna seriedicriticitàchenelimitanoinmodoconsistentelavaliditàel’applicazioneclinica:
recentiesperienze sembrerebbero affermare che i segni radiologici•(TC)dimalattiapossonoprecederel’esposizioneossea(Saia,Blanda-muraetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011);pertantoassegnareun
43
paziente ad uno stadio dimalattia in base a criteri esclusivamentecliniciapparefrancamentelimitativo;sebbeneall’aumentaredell’esposizioneosseasiosserviunconcomi-•tanteaumentodell’estensioneTCdimalattia,nonc’èassociazionetraestensioneTCestadiinizialidimalattiaAAOMS(stadio0,1);inoltre,neglistadipiùavanzati(stadio2,3)sonoinclusipazienticonesten-sioneradiologicadeltuttosimiletraloropercuidaunpuntodivistaradiologicoquestiduestadicorrispondono.Nelcomplesso,all’inter-nodiognistadiodimalattiaAAOMS(stadio0-3)esistonopazienticoncaratteristichecinichesimilimaconestensioniradiologichedimalat-tiadeltuttodiverse.Sonopertantocategoriedisomogeneechenondescrivonorealisticamentequadridistintidimalattia(Tronchet,Bet-tinietal.2011);isoggettiappartenentiallostadio“0”secondoAAOMShannoun’ele-•vataprobabilitàdiprogredireversol’esposizioneossea(Bettini,Totolaetal.2011);èstatosegnalatochepazienticonsegniesintomicliniciassimilabili•allostadio“0”presentanoalterazioniradiologicheevidentisoprattut-toallaTC;inoltrepazientiinstadio0presentanospessoquadriradio-logicidimalattiaavanzataedeltuttocomparabiliaquellidipazienticonesposizioneossea(Bedogni,Saiaetal.2011).
Sullabasediquesteconsiderazioni,la Commissione propone un nuovo schema classificativo della BRONJ in cui i pazienti vengono suddivisi in categorie sulla base di criteri clinici e radiologici (Tabella5).Lafinalitàdiquestaclassificazioneclinico-radiologicaèquelladidistinguerestadidimalattiasicuramentediversitraloro,maomogeneiperquantopossibileallorointerno.Rispettoallaclassi-ficazioneAAOMS2009,esistonoimportantidifferenzetracuiinordine:
lamancanzadellostadio“0”,conlaconseguentericollocazionedei•casidiBRONJsenzaesposizioneossea;la distinzione in staditiene in considerazione il coinvolgimento ra-•diologicodelmascellareaffetto,utilizzandolaTCcomeriferimento;ancora,ilsintomodolore,variabileindipendentedall’estensionedelprocessoosteonecrotico(Tronchet,Bettinietal.2011),nonvienepiùutilizzatocomecriteriodifferenziativotrastadidiversi,masoloperdistinguereformesintomaticheenonsintomaticheall’internodiunostessostadio; lostessoconcettovieneapplicatoallasuppurazione,checontribuisceadefinireleformesintomatiche;ladistinzioneinformesintomaticheenondeglistadi1e2dimalattia•
44
secondolaclassificazioneSICMF-SIPMOquipresentataevitailcon-tinuopassaggiodistadio(dallostadio1al2eviceversa)deipazienticonBRONJ,cuisiassisteinconseguenzadelleciclicheriacutizzazionidelprocessoinfettivoedeldoloreadessoassociato;il sequestro osseo, inteso come distacco completo e conseguente•espulsione(siaspontaneacheindottadallospecialistaconmanovrenon invasive)di frammentooporzionedi tessutoosseonecrotico,nonvienepiùconsideratacomesegnoclinicopeggiorativo,comenelcasodellostadio“3”dellaAAOMS.Èesperienzacomune,infatti,cheilsequestrodiossoportanellamaggiorpartedeicasiaddiritturaadunmiglioramentodelquadroclinico,consuccessivariepitelizzazionemucosadellasedecoinvolta(Ferlito,Puzzoetal.2011).
Questanuovastadiazioneèfruttodiun’attentaanalisiinterpretativadeidatidisponibiliinletteratura,edèinpartefruttodell’esperienzadeicomponentilaCommissionenellagestionedeipazientiaffettidaBRONJ.LaCommissio-neritienecomunquequestaclassificazionenondefinitivamenteesaustivaecredepossaesseresuscettibiledisostanzialimodifichenelprossimofuturo,inparticolareperchéinessanonsitieneancorainadeguataconsiderazionel’estensioneradiologicadimalattia;quest’ultima,allalucedirecentisegnala-zioni,potrebbedivenirelostrumentopiùrealisticoperdefinirel’appartenen-zaastadidimalattiaprogressivi(Tronchet,Bettinietal.2011).IlprincipalevantaggiodelsistemaclassificativoquipropostoèsenzadubbioquellodiallocareinmodoomogeneolediverseformediBRONJ,adesempiofacendorientrareinunostadiodimalattiafocale(stadio“1”)buonapartedel-leformediosteonecrosiassociataall’utilizzodiNBPoralioe.v.permalattieosteometaboliche,cheperesperienzacomunesonospessocaratterizzatedauncoinvolgimentoosseoselettivodelprocessodento-alveolare.Nellostadio“1”rientrerebberoancheformeprecocidiBRONJdaNBPe.v.inpaziention-cologici(Fig.1).Nellostadio2verrebberoinveceinclusetutteleformecon-clamatediBRONJassociataadNBPe.v.inpazientioncologiciedalcuneformeavanzatedaNBPorali(Fig.2).Infine,nellostadio3rientranotutteleformediBRONJcomplicate(Fig.3).L’ulterioresuddivisionedeglistadi1e2inasintomatico(a)esintomatico(b)permetterebbedidefiniremegliolenecessitàterapeutichedeipazienti.Inol-tre,ilcostantesuccedersidiperiodidiriacutizzazionedelprocessoinfettivo,cheètipicodeipazienticonBRONJ,nonsarebbepiùessostessocausadiuncontinuopassaggiodallostadio1al2eviceversa,comesiosservaquandosiutilizzalastadiazioneAAOMS,inpresenzaditrattamentoantibiotico.
45
Tabella 5. Stadiazione clinico-radiologica della BRONJ (SICMF-SIPMO)
Stadiazione clinico-radiologica BRONJ
Stadio 1
BRONJ FOCALE: in presenza di almeno1 segno clinicominore e con unaddensamento osseo alla TC limitato al solo processo dento-alveolare*dellamandibolaodelmascellare,conosenzaaltrisegniradiologiciprecoci.
Segni clinici minori e sintomi: alitosi, ascesso odontogeno, asimmetriamandibolare,doloredioriginedentaleeosseo,esposizioneossea,fistolamucosa, mancata riparazione mucosa alveolare post-estrattiva, mobilitàdentalearapidainsorgenza,parestesia/disestesiadellelabbra,secrezionepurulenta, sequestro spontaneodi frammentiossei, trisma, tumefazionedeitessutimolli.
Segni TC: ispessimento trabecolare, osteosclerosi midollare focale, cono senza ispessimentocrestaalveolaree laminadura,persistenzaalveolopost-estrattivo,slargamentospazioparodontale.
asintomatica a. sintomatica b. (presenzadidoloree/osuppurazione)
Stadio 2
BRONJ DIFFUSA: in presenza di almeno 1 segno clinico minore e conun addensamento osseo alla TC esteso anche al processo basale dellamandibolaodelmascellare,conosenzasegniradiologicitardivi.
Segni clinici minori e sintomi: comeperstadio1.Segni TC:osteosclerosi diffusa,conosenzafistolaoro-antraleeoro-nasale,ispessimentodelcanalealveolare,reazioneperiostale,sequestro,sinusite.
asintomaticaa. sintomaticab. (presenzadidoloree/osuppurazione)
Stadio 3
BRONJ COMPLICATA: come in stadio 2, in presenza di uno o più deiseguenti:
Segni clinici minori: fistolaextra-orale,fuoriuscitadiliquididalnaso,mobilitàpreternaturaledellamandibolaconosenzaocclusioneconservata.Segni TC:fistolamuco-cutanea,fratturapatologica,osteolisiestesaalsenomascellare,osteosclerosidizigomoe/opalatoduro
*siintendeperregionedento-alveolarequellastrutturaosseaanatomicachecostituisceilsupportoscheletricoaglielementidentari.Perdefinizione,ilprocessodento-alveolareterminainsensocranio-caudalesubitoaldisottodellaradicedeglielementidentari
46
Fig1.STADIO1oFOCALE(SICMF-SIPMO).Pazienteinterapiaconaminobisfosfonatioraliiniziatadapiùditreanniinseguitoariscontrodiosteoporosi.Clinica:presenzadifisto-lamucosaconsondaggioosseo inesitidiestrazionesemplicedielemento36, (freccianera).Radiologia:allaTCdellamandibola inproiezioneassialesiapprezza lapresenzadiaddensamentoosseo(osteosclerosimidollarefocale)(frecciabiancainalto)acaricodellaregionemolare-premolaresin,chenellaproiezionecoronaleèconfinataalprocessodento-alveolare(frecciabiancainbasso).
47
FIG.2.STADIO2oDIFFUSO(SICMF-SIPMO).Stadio 2a. Paziente in terapia con aminobisfosfonati endovena in seguito a riscontrodimetastasiosseedacarcinomaprostatico.Clinica:presenzadifistolamucosa insedecrestalesinistra(freccianera),inassenzadisuppurazione,esitoadistanzadiestrazionesemplicedielemento3.6perproblemidiinfezionedento-parodontale.Radiologia:allaTCinproiezioneassialesievidenziaosteosclerosimidollarediffusa,coninteressamentodell’emimandiboladestrafinoallaregionecaninacontrolaterale,associataallapresenzadipiccolelacuneosteolitiche,inizialereazioneperiostalesulversantelingualeepiccoleinterruzionicorticalidallatosinistro.Stadio2b.Pazienteinterapiaconaminobisfosfonatiendovenainseguitoariscontrodimetastasiosseedacarcinomamammario.Clinica:presenzadiesposizioneosseainregio-nemolaresuperioresinconevidenzadisuppurazione;quadropost-estrattivo.Radiolo-gia:allaTCinproiezioneassialesievidenziaosteosclerosimidollarediffusacheinteressailmascellaresinistrodalla regionecaninaalla laminapterigoidea;concomitanoalcuneinterruzioni corticali adelimitareun’areadi iniziale sequestrazioneosseadelprocessodento-alveolare.
48
FIG3.STADIO3oCOMPLICATO(SICMF-SIPMO).Paziente in terapia conaminobisfosfonatiendovena in seguitoa riscontrodiMielomaMultiplo.Clinica:presenzadimultiplefistolecutaneesottomentali(freccenere), inas-senzadi francasuppurazione.Radiologia:allaTC inproiezionecoronale siapprezzanoosteosclerosi midollare diffusa con interessamento a tutto spessore della mandibolabilateralmente(frecciabianca); inproiezioneassialesinota lacompresenzadi fratturascomposta del corpomandibolare sinistro (freccia bianca in grassetto) ed ampia areadisequestrazionedelprocessodento-alveolareomolaterale(freccianera ingrassetto).Unsecondosequestroosseoèvisibileinregionesinfisariaunitamenteadispessimentoperiostalecheinteressatuttal’emimandibolasinistra.
49
Categorie e fattori di rischio per BRONJ
Categorie di rischio
LaCommissionehatenuto inconsiderazione,nellastesuradeldocumento,dellecategoriespecifichedisoggettiarischio,inparticolareipazientionco-ematologici trattaticonsomministrazionimensilidiNBPe.v. (pamidronato,zoledronato,ibandronato)eipazientinononcologicitrattaticonNBP(preva-lentementeperosteopenia/osteoporosi).Taledecisionenascedallaconside-razionechelesuindicatecategoriesonoquelleamaggiorimpattoepidemio-logicoequindidipiùfacileriscontronellapraticaclinica.
Fattori di rischio farmaco-correlati e sistemici
In una patologia multifattoriale e relativamente poco frequente come laBRONJ, sarebbeutile identificare fattoridi rischiodimalattiacheaiutinoadistinguerepazientiadaltoebassorischio,conconseguentiricadutesia interminidiprevenzionechedidiagnosiprecoce.Perotteneredatistatistica-menterilevantioccorrerebbeavere(inalternativa):
datidicoortesucampioninumerosidipazientitrattaticonNBP,affetti- enondaBRONJ,dicuistudiare(conanalisimultivariata)lecaratteri-sticheinoggetto;
- studicaso-controllostatisticamenteadeguati,diconfrontotracasidiBRONJe“controlli”selezionati;
- confrontodicaratteristichetragruppidipazienticonBRONJ(es.regi-stridicasi)ecasistichedipopolazionitrattate(es.pazientiseguitidasistemi assicurativi; dati epidemiologici sulla popolazione generale;ecc.).
Purtroppononesistonoalmomentodatidefinitivisuifattoridirischio(Assa-el2009).Infatti,l’esiguitàel’eterogeneitàdellecoortidiBRONJpubblicate,(Bamias,Kastritisetal.2005;Dimopoulos,Kastritisetal.2006;Hoff,Tothetal.2008;Vahtsevanos,Kyrgidisetal.2009),l’esiguitànumericadeglistudica-so-controllo(Kyrgidis,Vahtsevanosetal.2008;Wessel,Dodsonetal.2008),nonchélascarsitàdidatabasesufficientementeampi(Khamaisi,Regevetal.2006;Jung,Hoffmannetal.2010)fannosìchenonsiapossibiletrarreconsi-derazioniconclusive.Pertanto,laCommissionehaschematizzatoinTabella6
50
ifattoridirischiofarmaco-correlatiesistemicisinorasegnalatiinletteratura,identificandoperciascunounlivellodi“robustezza”senzaentrarenelmeritodellivellodievidenzascientificaodelgradodiraccomandazione.
Tabella 6. Fattori di rischio farmaco-correlati e sistemici
FattoreLivello di robustezza
Farmaco (NBP)Molecola(zoledronatoversusaltri)Viadisomministrazione(endovenaversusorale)DosecumulativaDuratadeltrattamento
Patologia di base (per cui indicata terapia con NBP)TumorisolidiMielomamultiploPatologianononcologica(dismetabolica)
Terapie di supportoChemioterapiaSteroidineipazientioncologiciSteroidineipazienticonmalattianononcologica(dismetabolici)AntiangiogeneticineipazientioncologiciTalidomideFattoridistimolazioneeritropoietica
Stili di vitaFumoAlcoolObesità
Caratteristiche anagraficheSessoEtàFattorigenetici
Patologie concomitanti (comorbidità)DiabeteArtriteReumatoideIpocalcemia,iperparatiroidismoOsteomalacia,ipovitaminosiDInsufficienzarenaleindialisiAnemia
+++++
++++++
+++++/-
-/+-/++
+++/-+/-
+/--/++/-
+/-+/-+/-
+/-+++++/-
Legenda:+++datipositivi robustiedunivoci; ++datipositivipresentinellamaggiorpartedeglistudi; +datipositivi in alcuni studi (da confermare); +/-datipositivi enegativinei singoli studi(datiinsufficientiperunanettapositività);-/+datiprevalentementenonpositiviodingenerenonconfermatineglistudipiùampi.
51
Analizziamoindettaglioifattoridirischiofarmaco-correlati:Molecola: neipazientioncologiciedematologici,l’acidozoledronico(somministratoagranpartedeipazienticonBRONJmaancheilfar-macopiùutilizzato,almenodopoil2002)sembracomportarecomun-queunrischiostatisticamentemaggiorediBRONJ(Bamias,Kastritisetal.2005;Hoff,Tothetal.2008;Wessel,Dodsonetal.2008;Vahtse-vanos,Kyrgidisetal.2009;Fusco,Loidorisetal.2010)rispettoalpa-midronato,purinassenzadistudirandomizzati;datiinsufficientinonpermettonounconfrontodefinitivoconl’ibandronato,anchesesem-brachequest’ultimocomportiunrischiominore(Kyrgidis2010).Neipazientinononcologicinonesistonoalmomentodatidiconfrontotraalendronatoerisedronato(iduefarmacipiùlargamenteutilizzati).
Via di somministrazione (endovena vs orale) :ilrischioapparenetta-mentemaggioreperiNBPsomministratiperviaendovenosa,maciòèstrettamentelegatoalloroprevalenteutilizzoneipazientioncologi-ci(Woo,Hellsteinetal.2006;Wessel,Dodsonetal.2008;Migliorati,Wooetal.2010).
Dose cumulativa (dosaggio totale somministrato) di NBP endovena :visonodatisostanzialmenteunivocinell’indicareunaumentodelri-schioconl’incrementodelladosetotalediNBPendovenasommini-stratoaipazientioncologiciedematologici,siaperlozoledronatosiaperilpamidronato(Bamias,Kastritisetal.2005;Hoff,Tothetal.2008;EMEA2009;Vahtsevanos,Kyrgidisetal.2009).
(Comeriportatoinprecedenza,nonesistonodatidifollow-upsuffi-cientiperzoledronatoedibandronatoendovenaasomministrazioniogni3-12mesineipazientinononcologici).
Durata del trattamento con NBP endovena: mediamente i pazienticonBRONJ sono stati trattatiper periodi più lunghi di quelli senzaBRONJ.IneffettiladuratadeltrattamentoconNBPendovenaapparecorrelabile con il dosaggio totaledi farmaco somministrato,dato iltipodisomministrazionemensile,continuativaeindefinitaneltempoconsigliatadalleprincipalilineeguidafinoal2007(Bamias,Kastritisetal.2005;Badros,Weikeletal.2006;Dimopoulos,Kastritisetal.2006).Inunarecenterevisionedellaletteratura(Palaska,Cartsosetal.2009)iltempomedioequellominimoperlacomparsadiBRONJrisultòes-sererispettivamentedi1.8annie10mesiperlozoledronato,2.8anni
52
e1.5anniperilpamidronato.Infine,purinassenzadistudicheana-lizzinoseparatamenteil fattore“tempodisopravvivenza”daquello“duratadeitrattamenticonNBP”,l’aumentodellasopravvivenzaneipazientioncologiciedematologici,intesacometempointercorsotraladiagnosiditumoreel’exitus,potrebberappresentareinfuturounfattoredirischioaggiuntivo,inquantoresponsabilediunaprolungataesposizioneaglialtri fattoridirischiogiàconosciuti(Badros,Weikeletal.2006)(Dimopoulos,Kastritisetal.2006;Hoff,Tothetal.2008;Jung,Hoffmannetal.2010).
Dose cumulativa e durata del trattamento con NBP orale: lamaggiorpartedeicasidiBRONJèstataosservatainpazientitrattatiperanni(ingenerepiùdi2-3anni)conunamediadi4.6annisecondolarevi-sionesopracitata(Palaska,Cartsosetal.2009).
Traifattoridirischiosistemiciriconosciuticomepotenzialmentepromuo-ventil’insorgenzadiBRONJsonostatiindividuatiiseguenti:
Patologia di base: i pazientiaffettidapatologianeoplastica vengo-noingeneredefinitiapiùaltorischio,ancheseciòsembraderivaredaldiversotipoditrattamentoconNBP(Woo,Hellsteinetal.2006).Traipazientioncologiciedematologici,sembradedursicheipazientiaffettidamielomamultiplosianomaggiormentearischiodiBRONJrispettoaquelli affettidaneoplasiamammariaoprostatica in fasemetastatica;ciòsarebbededucibilesiasullabasedeipiùelevatidatidifrequenza/incidenzamedi(6-12%versus1-5%)siasullabasedel-la relativa minore frequenza assoluta della patologia mielomatosa(Jung,Hoffmannetal.2010;Migliorati,Wooetal.2010);tuttaviaal-cuniautorinonhannoconfermatotalemaggiorerischioetendonoaspiegarelefrequenzepiùalteconunamaggioreesposizionemediaaiNBP(Bamias,Kastritisetal.2005).
Trattamenti chemioterapici :nonesistonodatistatisticamenterobusticheassocianounmaggiorrischiodiBRONJalla“chemioterapia”oasingolifarmacichemioterapici(Jadu,Leeetal.2007;Wessel,Dodsonetal.2008)maquestiaspettinonsonostatiadeguatamentestudiati.
Trattamenti steroidei: alteebassedosidisteroidinonsonorisultatifattoridirischioneipazientioncologiciinunostudio(Wessel,Dodsonetal.2008)mentredatipositivisonostatiregistratineipazienticon
53
mieloma(Jadu,Leeetal.2007).L’usoprolungatodisteroidiassociatoaNBPoralipotrebbeessereunco-fattorenell’insorgenzadiBRONJ(Abu-Id,Aciletal.2006;Chiu,Chiangetal.2010).
Trattamenti antiangiogenetici: l’utilizzodifarmacibiologicidiultimagenerazione,confunzioneantiangiogenetica(e.g.bevacizumab,suni-tinib,sorafenib)inassociazioneconNBPneipazienticonmetastasios-seedatumorisolidisembrerebbeincrementarel’incidenzadiBRONJ(Christodoulou,Pervenaetal.2009;Migliorati,Wooetal.2010;Ya-rom,Eladetal.2010;Fusco,Galassietal.2011)manonvisonodatisucasistichesufficientementeampie,conl’eccezioneparzialedelbe-vacizumab(Guarneri,Milesetal.2010).Daticontrastantisonostatipubblicatisulruolodellatalidomideneipazienticonmielomamulti-plo,perdifficoltàmetodologichedeiprimistudieprobabilmenteperl’utilizzoquasi sistematicodel farmaco (nelle varie lineedi terapia)negliultimianni (Bamias,Kastritisetal.2005;Zervas,Verrouetal.2006;Pozzi,Marchesellietal.2007;Wessel,Dodsonetal.2008).
Fattori eritropoietici: riportaticomefattoredirischioinunostudiosupazienticonmieloma(Jadu,Leeetal.2007).
Fumo: valorepredittivoasseritodaalcuniautori(Wessel,Dodsonetal.2008;Mucke,Haarmannetal.2009;Katz,Gongetal.2011),manegatoinaltristudi(Kyrgidis,Vahtsevanosetal.2008;Vahtsevanos,Kyrgidisetal.2009).
Alcool: citatospessocomepossibilefattoredirischio,masenzadatistatisticiafavore.
Obesità: risultato significativo inuno studio (Wessel,Dodsonet al.2008).
Sesso: nonesistono almomentodatiunivoci versounapreferenzanelsessomaschileoinquellofemminile(casistichespessosbilanciatesullabasedellapatologiadibase).
Età: ancheseinalcunecasistichevisonodatiafavorediunacorre-lazionetraetàerischiodiBRONJ(Badros,Weikeletal.2006;Jadu,Leeetal.2007;Sarasquete,Garcia-Sanzetal.2008),lamaggiorepre-valenzadicasinellefascedietàpiùavanzatesembraprobabilmentelegataallanormaledistribuzioneperetàdeipazientioncologicime-tastatici.
54
Fattori genetici :inunprimostudioalcunevariantidelgeneCYP2C8eranopredittivediBRONJinpazienticonmieloma(Sarasquete,Gar-cia-Sanz et al. 2008),ma tali risultati non sono stati confermati inpazienticoncarcinomaprostatico (English,Baumetal.2010)né inunaltro lavorosupazienticonmieloma(Katz,Gongetal.2011) Inquest’ultimostudio,tuttavia,altredeterminazionigenichesonorisul-tatepredittivediBRONJ(Katz,Gongetal.2011).Inunostudioitaliano(Marini,Tonellietal.2011),variantidiunaltrogene(FDPS)sembranocorrelareconilrischiodiBRONJ.Lafarmacogeneticaèpertantouncampodiricercatuttoraaperto.
Patologie concomitanti
Diabete:- sostenutodaalcuniautori(Urade2009)manonconfer-matodaaltri(Wilkinson,Kuoetal.2007;Lazarovici,Mesilaty-Grossetal.2010;Katz,Gongetal.2011).
Artrite reumatoide:- ipazienticonartritereumatoide, trattaticonsteroidi oltre che con farmaci immunologici, sembranoavereunpiùalto rischiodiBRONJdaNBPorali (SawatariandMarx2007;Junquera,Gallegoetal.2009;Chiu,Chiangetal.2010;Conte-Neto,Bastosetal.2012).
Ipocalcemia ed iperparatiroidismo- :unsingolostudiosembraposi-tivo(Ardine,Generalietal.2006)edèinattesadiconferme.
Osteomalacia ed Ipovitaminosi D- : di recente pubblicazione studicheipotizzanounpossibileruolodell’osteomalacia(Bedogni,Saiaetal.2012)edell’ipovitaminosiDcomefattoripredisponentiallosviluppodiBRONJinpazientigiàintrattamentoconNBP(Hokugo2012),ruoloperaltrogiàdimostratonelmodelloanimale(Hokugo,Christensenetal.2010).
Dialisi- : inunsingolostudiofuregistrataassociazionepositivatradialisieBRONJ(Jadu,Leeetal.2007).
Anemia- :bassilivellidiemoglobinasiericasonostatisegnalatinellostessostudiocanadese(Jadu,Leeetal.2007).
Altre condizioni (e.g.immunodepressione,ipertensione,vasculopatie,dislipidemie, sindromeda iperviscosità) sono state ipotizzate come
55
possibilifattoridirischiosullabasedellaipotesietiopatogeneticadiunanecrosi ischemica della BRONJ e/oper similitudine alla necro-si femorale (Woo,Hellsteinetal.2006;RustemeyerandBremerich2010),manonesistonoalmomentodatiaconfermaosmentitaditaleipotesi.
Fattori di rischio locali
Iprincipalifattoridirischiolocaliriportatiinletteratura(Ruggiero,Mehrotraetal.2004;Ficarra,Beninatietal.2005;Marx,Sawatarietal.2005;Badros,Weikel et al. 2006; Jeffcoat2006;Hoff, Tothet al. 2008;Wutzl, Pohl et al.2012)vengonoriportatidiseguitoinordinediimportanza(vediTabella7).La Commissione ritiene utile rilevare che al momento della stesura di questo documento la maggior parte dei dati disponibili in letteratura sui fattori di rischio per lo sviluppo di BRONJ fa riferimento a soggetti affetti da malattia oncologica/ematologica e solo in minima parte a pazienti osteoporotici o af-fetti da malattie osteometaboliche. AllalucedelladiversafrequenzadellaBRONJnelleduecategoriedisoggetti,èpertantopossibilecheunospecificofattoredirischioinfluiscainmododiver-sosullosviluppodimalattianeipazientioncologiciedosteoporotici.Questospiegaperchésirendononecessariesceltestrategichediprevenzioneecom-portamentiodontoiatricidifferenziatiper leduecategoriedi soggetti (vediCapitolo2).Siconsideranoiseguentifattoridirischiolocali:
Chirurgia dento-alveolare
Larelazioneesistentetral’esecuzionediprocedurechirurgicheincavoora-le(e.g.avulsionedidente inarcataodente incluso,chirurgiaendodontica,chirurgiaparodontaleepreimplantare)el’insorgenzadiBRONJinsoggettiinterapiaconNBPècertamentequellapiùstudiata,sebbeneancoranonsup-portatadaevidenzescientifichedefinitive.TralemigliaiadicasidiBRONJadoggisegnalatiinletteratura,l’evento“procedurachirurgicadento-alveolare”èstatoriportatocomeilpiùfrequentefattoretemporalmenteassociatoallaBRONJ,conunrischiod’insorgenzafinoa44voltemaggiore(Hoff,Tothetal.2008)rispettoaipazientinonsottopostiadalcunaprocedurachirurgica.Ri-portiamounconsensogenerale,anchetradiversesocietàscientificheitalianequalil’AIOM(AssociazioneItalianadiOncologiaMedica-http://www.aiom.it),
56
laSIF(SocietàItalianadiFarmacologia-http://www.sifweb.org/),laSIOMMMS(SocietàItalianadell’Osteoporosi,delMetabolismoMineraleedelleMalattiedelloScheletro-http://www.siommms.it)nelconsiderarelachirurgiadento-alveolareunimportantefattoredirischiolocaleperlosviluppodiBRONJ,senonilpiùrilevante,ancheinsoggettiintrattamento(concomitanteopregres-so)conNBPperosteoporosi.Ilrangedifrequenzadellaprocedurachirurgicadento-alveolarequalefattoredirischiolocalediBRONJvariadal50al100%(Marx,Sawatarietal.2005)(Marx,Cilloetal.2007)(AguiarBujanda,BohnSarmientoetal.2007)(Walter,Al-Nawasetal.2008)(Fehm,Becketal.2009)(Lazarovici,Yahalometal.2009)(Yarom,Eladetal.2010).
Implantologia osteointegrata
Ilposizionamentodi impiantiosteointegratièconsideratoadoggiunama-novrachirurgicapotenzialmentearischio(Shabestari,Shayestehetal.2010;Yip,Borrelletal.2012),alparidelleprocedurechirurgichedento-alveolari,soprattuttoneipazientiinterapiaconNBPe.v.permalattieoncologiche.Nonènotoquale sia il rischio realediBRONJ conseguentea implantologianeipazientioncologici incorsodi terapia,maèopportunoconsiderare il fattochetra inumerosicasidiosteonecrosipubblicati,moltisisonoverificatiincorrispondenzadisitiimplantaririabilitatiprimadell’iniziodellaterapiaconNBP (Ruggiero,Mehrotraetal. 2004;Marx, Sawatarietal. 2005;Bedogni,Blandamuraetal.2008;Lazarovici,Yahalometal.2010).Lamaggioranza degli studi che hanno valutato in anni recenti il rischio diBRONJ legatoall’inserimentodi impianti, sono stati condottisu soggetti intrattamentoconNBPperosteoporosi(Fugazzotto,Lightfootetal.2007;Gra-low2010).Inquestisoggetti,ilrischiodisviluppareBRONJèrisultatobassoedinpartelegatoalladosediaccumuloedalladuratadellaterapiaconNBP.Cer-tamentetalerischioèrisultatodimoltoinferiorerispettoallestesseprocedu-reimplantaricondotteinsoggettioncologiciintrattamentoconNBPe.v.È opinione di questa Commissione che l’implantologia rappresenti un impor-tante fattore di rischio per lo sviluppo di BRONJ nel paziente oncologico in corso di terapia con NBP (pregressa o in atto), al pari di tutte le procedure chirurgiche invasive dento-alveolari; diversamente, non è dimostrato che lo stesso possa valere per il paziente osteoporotico, almeno per i primi anni di terapia con NBP. Aldi làdelrischioper laprocedurachirurgica insé,bisognapoiconsidera-rechenegliannisuccessivialsuoposizionamento,l’impiantoosteointegrato
57
saràespostoadunrischiocrescentedisviluppareBRONJincasodiperi-im-plantite,perlacompresenzadiunapatologiainfiammatoriaedilgradualeau-mentodellaconcentrazionedelfarmaconeltessutoosseoperi-implantare.DaicasidiBRONJinsortasusediimplantariinpazientiosteoporoticiincorsoditerapiaconNBPsegnalatiinletteraturasievincecheiltempointercorsotral’inserimentodegliimpiantielosviluppodiBRONJvariadapochimesiadiver-sianni(Lazarovici,Yahalometal.2010).Questosembrerebbeconfermarechenonsolo laprocedurachirurgica insè inizierebbe ilprocessomorboso,maancheepiùspessoilverificarsidiripetutifenomenid’infiammazioneperim-plantarelegatiallaformazionediunbiofilmsudiun’areaabassaresistenzacomeilcollettomucosoperimplantare.Leridottedifeseimmunitariedell’ossolegateallaterapiacronicaconNBPel’assenza di un effettobarriera all’interfaccia osso-impianto promuovono ilrischiodiperimplantiteeiltrasferimentod’infezioniall’ossocircostantevei-colatodallastrutturaimplantare.Questa Commissione ritiene che la programmazione di un intervento di im-plantologia debba essere discussa e condivisa con il paziente non oncologico in trattamento con NBP più per il rischio incrementale di sviluppare BRONJ negli anni successivi alla procedura in caso di terapia continuativa con NBP che per la procedura chirurgica in sé.Pertanto,leprocedured’implantoprotesidevonoesseresoggetteall’acquisi-zionediunampioedettagliatoconsensoinformato.
Patologia infiammatoria dento-parodontale e peri-implantare
Lapresenzadiunapatologiainfiammatoriadento-parodontalee/operi-im-plantare (i.e. parodontopatia cronica, infezioni odontogene, lesione endo-periodontale, perimplantite, scarsa igiene orale) causata da una scadentegestionedellasaluteoraleedaunscarsocontrollodiplaccainunsoggettointerapiaconNBPaumentanodecisamenteilrischiodisviluppareBRONJincorsoditrattamentoerappresentanounsicurofattorediaggravamentodelquadroclinicoincasodiBRONJgiàdiagnosticata(Ficarra,Beninatietal.2005;Sarathy,Bourgeoisetal.2005;Migliorati2006;Palomo,Bissadaetal.2006;Dodson2009).Lamalattiaparodontaleinfattièstatadiagnosticatanell’84%deicasiinunnumerosocampionedipazientiaffettidaBRONJ(Marx,Sawa-tarietal.2005).Ipazienticonunastoriadipatologiainfiammatoriadentale,ascessiparodontaliedentali,seespostiaNBPe.v.adaltodosaggio,sono7voltepiùarischiodisviluppareBRONJrispettoadindividuiconimedesimi
58
problemidento-parodontalimanonintrattamentoconNBP(Hoff,Tothetal.2008).Alparidellamalattiaparodontale,laperi-implantitesulpianoteoricoaumentailrischiod’insorgenzadiBRONJ.
Protesi rimovibili incongrue
I dispositivi protesici rimovibili sono ritenuti fattori di rischioper lo svilup-podiBRONJperché,senonbenadattatiallasuperficiegengivale,possonodanneggiarelabarrierameccanicadellamucosaoralefavorendol’ingressodimicrobineitessutisottostanti.Èstatadocumentataunacorrelazionesignifi-cativatral’usodiprotesirimovibilielosviluppoBRONJinunapopolazionedisoggettiaffettidaneoplasiametastaticaintrattamentoconNBPe.v.adaltodosaggio(Kyrgidis,Vahtsevanosetal.2008;Vahtsevanos,Kyrgidisetal.2009),unrisultatoperaltrononconfermatodaaltristudi.Malocclusionidentarieeforzemasticatorienonsembranoaumentareinveceilrischiod’insorgenzadiBRONJ.
Condizioni anatomiche
Lapresenzad’irregolaritàanatomiche(e.g.torimandibolarie/opalatali,eso-stosi,crestamilojoideaparticolarmentepronunciata)puòrappresentareunfattoredirischioperlosviluppodiBRONJ,soprattuttoinpazientiportatoridiprotesirimovibilitotalidelmascellaresuperioreeparziali/totalidellamandi-bola(Ruggiero,Dodsonetal.2009).In conclusione, l’estrazionedentalee leprotesi rimovibili incongrue sono ifattoridirischiolocaliriportatipiùfrequentementedallaletteraturainterna-zionale (Kyrgidis, Vahtsevanos et al. 2008; Filleul, Crompot et al. 2010); dicontro, condizioni anatomiche, procedure implanto-protesiche e chirurgiadento-alveolareelettivasonomenosegnalate,verosimilmenteacausadellascarsanumerositàcampionariadelleseriesinorapubblicate.
59
Tabella 7. Fattori di rischio locali
FattoreLivello di
robustezza
Chirurgia dento-alveolare
EstrazionedentaleChirurgiaosseaChirurgiaendodonticaChirurgiaparodontaleChirurgiapreimplantare
Implantologia osteointegrata
Patologia infiammatoria dento-parodontale o peri-implantare
ParodontopatiacronicaInfezioniodontogene
Ascessoparodontaleo Ascessoendodonticoo
Lesioneendo-periodontalePerimplantiteScarsaigieneorale
Protesi rimovibili incongrue
Condizioni anatomiche
ToruspalatinoTorilingualiEsostosiCrestamiloioideapronunciata
+++
++
++
+++
+/-
Legenda:+++datipositivirobustiedunivoci;++datipositivipresentinellamaggiorpartedeglistudi;+datipositiviinalcunistudi(daconfermare);+/-datipositivienegativineisingolistudi(datiinsufficientiperunanettapositività).
60
Bibliografia
Aapro,M.,Abrahamsson,P.A.,etal.(2008):Guidanceontheuseofbisphosphonatesinsolidtumours:recommendationsofaninternationalexpertpanel.AnnOncol19(3):420-432.
Aapro,M.,Monfardini,S.,etal. (2009):Managementofprimaryandadvancedbreastcancerinolderunfitpatients(medicaltreatment).CancerTreatRev35(6):503-508.
Abu-Id,M. H., Acil, Y., et al. (2006): [Bisphosphonate-associated osteonecrosis of thejaw].MundKieferGesichtschir10(2):73-81.
Abu-Id,M.H.,Warnke,P.H.,etal.(2008):“Bis-phossyjaws”-Highandlowriskfactorsforbisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaw.JCraniomaxillofacSurg36(2):95-103.
Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Ostenonecrosis of the Jaws, A.(2007):AmericanAssociationofOralandMaxillofacialSurgeonspositionpaperonbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.JOralMaxillofacSurg65(3):369-376.
Agrillo, A., Nastro Siniscalchi, E., et al. (2012): Osteonecrosis of the jaws in patientsassumingbisphosphonatesandsunitinib:twocasereports.EurRevMedPharmacolSci16(7):952-957.
AguiarBujanda,D.,BohnSarmiento,U.,etal.(2007):Assessmentofrenaltoxicityandosteonecrosisofthejawsinpatientsreceivingzoledronicacidforbonemetastasis.AnnOncol18(3):556-560.
AIFA(2010-a):Nota informativa importantesuAvastin(bevacizumab)del30/11/2010.http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-informativa-importante-su-avastin-bevacizumab-del-30112010
AIFA(2010-b):NotainformativaimportantesulSunitinib(Sutent)del30/11/2010.http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/nota-informativa-importante-sul-sunitinib-sutent-del-30112010.
Alonso-Coello,P.,Garcia-Franco,A.L.,etal.(2008):Drugsforpre-osteoporosis:preventionordiseasemongering?Bmj336(7636):126-129.
Ardine,M., Generali, D., et al. (2006): Could the long-termpersistence of low serumcalcium levelsandhighserumparathyroidhormone levelsduringbisphosphonatetreatmentpredisposemetastaticbreastcancerpatientstoundergoosteonecrosisofthejaw?AnnOncol17(8):1336-1337.
Assael, L. A. (2009): Oral bisphosphonates as a cause of bisphosphonate-relatedosteonecrosis of the jaws: clinical findings, assessment of risks, and preventivestrategies.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):35-43.
Ault,A.(2008):Jawnecrosisaffects1in1,700onoralbisphosphonates.InternalMedicineNews41(August1):23.
Badros, A., Weikel, D., et al. (2006): Osteonecrosis of the jaw in multiple myelomapatients:clinicalfeaturesandriskfactors.JClinOncol24(6):945-952.
61
Bagan, J. V., Jimenez, Y., et al. (2009): Osteonecrosis of the jaws in intravenousbisphosphonateuse: Proposal for amodificationof the clinical classification.OralOncol45(7):645-646.
Bagan,J.V.,Jimenez,Y.,etal.(2006):Jawosteonecrosisassociatedwithbisphosphonates:multipleexposedareasanditsrelationshiptoteethextractions.Studyof20cases.OralOncol42(3):327-329.
Bagan, J. V.,Murillo, J., et al. (2005): Avascular jaw osteonecrosis in associationwithcancerchemotherapy:seriesof10cases.JOralPatholMed34(2):120-123.
Baltensperger,M., (2009):Osteomyelitisof the jaws. Springer (Eds)2009; chapter225-36.
Bamias,A.,Kastritis,E.,etal.(2005):Osteonecrosisofthejawincanceraftertreatmentwithbisphosphonates:incidenceandriskfactors.JClinOncol23(34):8580-8587.
Barragan-Adjemian,C.,Lausten,L.,etal.(2008):Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisoftheJaw:ModelandDiagnosiswithConeBeamComputerizedTomography.CellsTissuesOrgans189:284-288.
Bedogni,A.,Bettini,G.,etal. (2010):Oralbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawafterimplantsurgery:acasereportandliteraturereview.JOralMaxillofacSurg68(7):1662-1666.
Bedogni, A., Blandamura, S., et al. (2008): Bisphosphonate-associated jawboneosteonecrosis:acorrelationbetween imagingtechniquesandhistopathology.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod105(3):358-364.
Bedogni, A., Fusco, V., et al. (2012). Learning from experience. Proposal of a refineddefinitionandstagingsystemforbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthe jaw(BRONJ).OralDis18(6):621-623.
Bedogni,A.,Saia,G.,etal.(2011):Long-termoutcomesofsurgicalresectionofthejawsincancerpatientswithbisphosphonate-relatedosteonecrosis.OralOncol47(5):420-4.
Bedogni,A.,Saia,G.,etal.(2012):Osteomalacia:themissinglinkinthepathogenesisofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws?Oncologist17(8):1114-1119.
Berenson,J.R.,Hillner,B.E.,etal.(2002):AmericanSocietyofClinicalOncologyclinicalpracticeguidelines:theroleofbisphosphonatesinmultiplemyeloma.JClinOncol 20(17):3719-3736.
Bertoldo,F.,Santini,D.,etal. (2007):Bisphosphonatesandosteomyelitisofthe jaw:apathogenicpuzzle.NatClinPractOncol4(12):711-721.
BettiniG.,Totola,A.,etal. (2011):Osteonecrosideimascellariassociataabisfosfonatisenzaesposizioneosseaeprogressionedistadi.AttidelXVIICongressoNazionaledellaSocietàItalianadiChirurgiaMaxillo-Facciale(SICMF),Como.
Bianchi, S. D., Scoletta, M., et al. (2007): Computerized tomographic findings inbisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw in patientswith cancer. OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod104(2):249-258.
Bisdas,S.,ChambronPinho,N.,etal. (2008):Biphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaws:CTandMRIspectrumoffindingsin32patients.ClinRadiol63(1):71-77.
62
Bombardieri,E.,Aktolun,C.,etal. (2003):Bonescintigraphy:procedureguidelines fortumourimaging.EurJNuclMedMolImaging30(12):BP99-106.
Brunello,A.,Saia,G.,etal.(2009):Worseningofosteonecrosisofthejawduringtreatmentwith sunitinib in a patientwithmetastatic renal cell carcinoma. Bone 44(1): 173-175.
Buser, E., Dahlin C., et al. (1994): Guided bone regeneration in implant dentistry.QuintessencePublishingCo.,Chicago(1994):49-100.
Campisi,G.,DiFede,O.,etal.(2007):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw(BRONJ): run dental management designs and issues in diagnosis. Ann Oncol 18Suppl6:vi168-172.
Campisi, G., Fedele, S., et al. (2009): Canadian consensus practice guidelines forbisphosphonateassociatedosteonecrosisof the jaw. JRheumatol36(2): 451-453;authorreply453.
Carneiro, E., Vibhute, P., et al. (2006): Bisphosphonate-associated mandibularosteonecrosis.AJNRAmJNeuroradiol27(5):1096-1097.
Cartsos,V.M., Zhu, S., et al. (2008): Bisphosphonateuse and the risk of adverse jawoutcomes:amedicalclaimsstudyof714,217people.JAmDentAssoc139(1):23-30.
Catalano, L., Del Vecchio, S., et al. (2007): Sestamibi and FDG-PET scans to supportdiagnosisofjawosteonecrosis.AnnHematol86(6):415-423.
Chiandussi,S.,Biasotto,M.,etal.(2006):Clinicalanddiagnosticimagingofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaws.DentomaxillofacRadiol35(4):236-243.
Chiu,C.T.,Chiang,W.F.,etal. (2010):Resolutionoforalbisphosphonateandsteroid-relatedosteonecrosisofthejaw--aserialcaseanalysis.JOralMaxillofacSurg68(5):1055-1063.
Cho,S.H.,.Kim,S.Y,etal.(2007):Newboneformationinunilateralrhinosinusitis.AmJRhinol21(1):37-39.
Christodoulou, C., Pervena, A., et al. (2009): Combination of bisphosphonates andantiangiogenic factors induces osteonecrosis of the jaw more frequently thanbisphosphonatesalone.Oncology76(3):209-211.
Colella, G., Campisi, G., et al. (2009): American Association of Oral andMaxillofacialSurgeonspositionpaper:Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisof the Jaws-2009update:theneedtorefinetheBRONJdefinition.JOralMaxillofacSurg67(12):2698-2699.
Coleman,R.,Burkinshaw,R.,etal.(2010):Zoledronicacid.ExpertOpinDrugSaf10(1):133-145.
Conte-Neto,N.,Bastos,A.S.,etal.(2012):Epidemiologicalaspectsofrheumatoidarthritispatients affected by oral bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws.HeadFaceMed8:5.
63
Crepin,S.,Laroche,M.L.,etal.(2010):Osteonecrosisofthejawinducedbyclodronate,analkylbiphosphonate:casereportandliteraturereview.EurJClinPharmacol66(6):547-554.
Del Conte, A., Bernardeschi, P., et al. (2010): Bisphosphonate-induced osteonecrosisof the jaw32monthsafter interruptionof zoledronate in apatientwithmultiplemyeloma.JOralMaxillofacSurg68(5):1179-1182.
Dimopoulos,M.A.,Kastritis,E.,etal.(2006):Osteonecrosisofthejawinpatientswithmultiplemyeloma treatedwith bisphosphonates: evidenceof increased risk aftertreatmentwithzoledronicacid.Haematologica91(7):968-971.
Dimopoulos,M.A.,Kastritis,E.,etal.(2009):Reductionofosteonecrosisofthejaw(ONJ)after implementation of preventivemeasures in patients with multiple myelomatreatedwithzoledronicacid.AnnOncol20(1):117-120.
Diniz-Freitas, M., Lopez-Cedrun, J. L., et al. (2012): Oral bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:Clinicalcharacteristicsofaseriesof20casesinSpain.MedOralPatolOralCirBucal.17(5):e751-758.
Dodson,T.B.(2009):Intravenousbisphosphonatetherapyandbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):44-52.
Dore, F., Filippi, L., et al. (2009): Bone Scintigraphy and SPECT/CTof Bisphosphonate-InducedOsteonecrosisoftheJaw.JNuclMed50(1):30-35.
Durie,B.G. (2007):Useofbisphosphonates inmultiplemyeloma: IMWGresponse toMayoClinicconsensusstatement.MayoClinProc82(4):516-517;authorreply517-518.
Durie,B.G.,Katz,M.,etal.(2005):Osteonecrosisofthejawandbisphosphonates.NEnglJMed353(1):99-102;discussion199-102.
Eckert, A.W.,Maurer, P., et al. (2007): Bisphosphonate-related jaw necrosis - SeverecomplicationinMaxillofacialsurgery.CancerTreatRev33(1):58-63.
Elad,S.,Gomori,M.J.,etal.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:clinicalcorrelationswithcomputerizedtomographypresentation.ClinOralInvestig 14(1):43-50.
EMEA (2009):CHMPassessment reportonbisphosphonatesandosteonecrosisof thejaw. http://www.ema.europa.eu/docs/en_gb/document_library/report/2010/01/wc500051428.pdf:london,24september2009-emea/chmp/291125/292009.
English, B. C., Baum, C. E., et al. (2010): A SNP in CYP2C8 is not associatedwith thedevelopment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in men withcastrate-resistantprostatecancer.TherClinRiskManag6:579-583.
Estilo,C.L.,VanPoznak,C.H.,etal.(2008):Osteonecrosisofthemaxillaandmandibleinpatientswithadvancedcancertreatedwithbisphosphonatetherapy.Oncologist 13(8):911-920.
Fedele, S., Kumar, N., et al. (2009): Dental management of patients at risk ofosteochemonecrosisofthejaws:acriticalreview.OralDis15(8):527-537.
64
Fedele,S.,Porter,S.R.,etal.(2010):Nonexposedvariantofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:acaseseries.AmJMed123(11):1060-1064.
Fehm, T., Beck, V., et al. (2009): Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw(ONJ): Incidenceand risk factors inpatientswithbreast cancer andgynecologicalmalignancies.GynecolOncol;112(3):605-609.
Felsenberg, D. (2006): Osteonecrosis of the jaw--a potential adverse effect ofbisphosphonatetreatment.NatClinPractEndocrinolMetab2(12):662-663.
Ferlito,S.,Puzzo,S.,etal. (2011):PreventiveProtocolforToothExtractionsinPatientsTreatedWithZoledronate:ACaseSeries.YJOMS:1-4.
Ficarra,G.,Beninati,F.,etal.(2005):Osteonecrosisofthejawsinperiodontalpatientswithahistoryofbisphosphonatestreatment.JClinPeriodontol32(11):1123-1128.
Filleul,O.,Crompot,E.,etal.(2010):Bisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaw:areviewof2,400patientcases.JCancerResClinOncol136(8):1117-1124.
Fizazi,K.,Carducci,M.,etal. (2011):Denosumabversuszoledronicacid for treatmentofbonemetastasesinmenwithcastration-resistantprostatecancer:arandomised,double-blindstudy.Lancet377(9768):813-822.
Fugazzotto, P. A., Lightfoot, W. S., et al. (2007): Implant placement with or withoutsimultaneoustoothextractioninpatientstakingoralbisphosphonates:postoperativehealing,earlyfollow-up,andtheincidenceofcomplicationsintwoprivatepractices.JPeriodontol78(9):1664-1669.
Fusco, V., Baraldi, A., et al. (2009): Jaw osteonecrosis associated with intravenousbisphosphonate:isincidencereducedafteradoptionofdentalpreventivemeasures?JOralMaxillofacSurg67(8):1775.
Fusco,V.,Galassi,C., etal. (2011):Osteonecrosisof the jawafter zoledronicacidanddenosumabtreatment.JClinOncol29(17):e521-522;authorreplye523-524.
Fusco,V.,Loidoris,A.,etal.(2010):Osteonecrosisofthejaw(ONJ)riskinbreastcancerpatientsafter zoledronicacid treatment.Breast19(5):432-433;author reply433-434.
Fusco, V., Ortega, C., et al. (2009): Increase and decrease of jaw osteonecrosis (ONJ)in patients treated with intravenous bisphosphonates (BP): impact of preventivemeasuresand reducedprescriptions in theexperienceof the“ReteOncologicadiPiemonteeValled’Aosta”ONJstudygroup.Disponibleon:http://ex2.excerptamedica.com/CIW09ecco/index.cfm?fuseaction=CIS2002&hoofdnav=Abstracts&content=abs.details&what=AUTHOR&searchtext=fusco&topicselected=*&selection=ABSTRACT&qryStartRowDetail=1-EuropeanJournalofCancerSupplements.7(2):201.AbstractP-3088.
Garcia-Ferrer,L.,Bagan,J.V.,etal.(2008):MRIofmandibularosteonecrosissecondarytobisphosphonates.AJRAmJRoentgenol190(4):949-955.
Ghanem,N.,Uhl,M.,etal.(2005):DiagnosticvalueofMRIincomparisontoscintigraphy,PET,MS-CTandPET/CTforthedetectionofmetastasesofbone.EurJRadiol55(1):41-55.
65
Gliklich,R.andWilson,J.(2009):Epidemiologyofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:theutilityofanationalregistry.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):71-74.
Gralow,J.R. (2010):Bisphosphonaterisksandbenefits:findingabalance.JClinOncol 28(33):4873-4876.
Guarneri,V.,Miles,D.,etal.(2010):Bevacizumabandosteonecrosisofthejaw:incidenceand association with bisphosphonate therapy in three large prospective trials inadvancedbreastcancer.BreastCancerResTreat122(1):181-188.
Henry,D.H.,Costa,L.,etal.(2011):Randomized,double-blindstudyofdenosumabversuszoledronicAcidinthetreatmentofbonemetastasesinpatientswithadvancedcancer(excludingbreastandprostatecancer)ormultiplemyeloma.JClinOncol29(9):1125-1132.
Hillner,B.E.,Ingle,J.N.,etal.(2003):AmericanSocietyofClinicalOncology2003updateontheroleofbisphosphonatesandbonehealthissuesinwomenwithbreastcancer.JClinOncol21(21):4042-4057.
Hoff,A.O.,Toth,B.B.,etal.(2008):Frequencyandriskfactorsassociatedwithosteonecrosisofthejawincancerpatientstreatedwithintravenousbisphosphonates.JBoneMinerRes23(6):826-836.
Hokugo, A. (2012): [Vitamin D and bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw(BRONJ)].ClinCalcium22(1):83-90.
Hokugo,A.,Christensen,R.,etal.(2010):Increasedprevalenceofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawwithvitaminDdeficiencyinrats.JBoneMinerRes25(6):1337-1349.
Hutchinson,M.,O’Ryan,F.,etal.(2010);Radiographicfindingsinbisphosphonate-treatedpatientswithstage0diseaseintheabsenceofboneexposure.JOralMaxillofacSurg 68(9):2232-2240.
Ito,K.,Elkin,E.B.,etal. (2010):Cost-effectivenessof fractureprevention inmenwhoreceiveandrogendeprivationtherapyforlocalizedprostatecancer.AnnInternMed 152(10):621-629.
Jadu,F.,Lee,L.,etal.(2007):Aretrospectivestudyassessingtheincidence,riskfactorsandcomorbiditiesofpamidronate-relatednecrosisofthejawsinmultiplemyelomapatients.AnnOncol18(12):2015-2019.
Jeffcoat,M.andWatts,N.B.(2008):Osteonecrosisofthejaw:balancingthebenefitsandrisksoforal bisphosphonate treatment forosteoporosis.GenDent56(1): 96-102;quiz103-104,111-102.
Jeffcoat,M. K. (2006): Safety of oral bisphosphonates: controlled studies on alveolarbone.IntJOralMaxillofacImplants21(3):349-353.
Jung,T.I.,Hoffmann,F.,etal.(2010):Disease-specificriskforanosteonecrosisofthejawunderbisphosphonatetherapy.JCancerResClinOncol136(3):363-370.
Junquera,L.andGallego,L.(2008):Nonexposedbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:anotherclinicalvariant?JOralMaxillofacSurg66(7):1516-1517.
66
Junquera,L.,Gallego,L.,etal.(2009):Clinicalexperienceswithbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaws:analysisof21cases.AmJOtolaryngol30(6):390-395.
Katz,J.,Gong,Y.,etal.(2011):Geneticpolymorphismsandotherriskfactorsassociatedwith bisphosphonate induced osteonecrosis of the jaw. Int JOralMaxillofac Surg 40(6):605-611.
Khamaisi, M., Regev, E., et al. (2006): Possible Association Between Diabetes andBisphosphonate-Related JawOsteonecrosis. J Clin EndocrinolMetab 92(3): 1172–1175.
Khan, A. A., Sandor, G. K., et al. (2008): Canadian Consensus Practice Guidelines forBisphosphonate Associated Osteonecrosis of the Jaw. J Rheumatol 35(7): 1391-1397.
Khosla,S.,Burr,D.,etal.(2007):Bisphosphonate-AssociatedOsteonecrosisoftheJaw:ReportofaTaskForceoftheAmericanSocietyforBoneandMineralResearch.JBoneMinerRes22:1479-1491.
King, A. E. and Umland, E.M. (2008): Osteonecrosis of the jaw in patients receivingintravenousororalbisphosphonates.Pharmacotherapy.28:667-677.
Krishnan, A., Arslanoglu, A., et al. (2009): Imaging findings of bisphosphonate-relatedosteonecrosis of the jaw with emphasis on early magnetic resonance imagingfindings.JComputAssistTomogr33(2):298-304.
Kyrgidis, A. (2010): Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw in randomizedclinicaltrials.BreastCancerResTreat119(1):253-254.
Kyrgidis, A. and Toulis, K. A. (2010): Denosumab-related osteonecrosis of the jaws.OsteoporosInt22(1):369-370.
Kyrgidis,A.,Vahtsevanos,K.,etal.(2008):Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisoftheJaws:ACase-ControlStudyofRiskFactors inBreastCancerPatients. JClinOncol.26(28):4634-4638.
Lacy,M.Q.,Dispenzieri,A.,etal.(2006):Mayoclinicconsensusstatementfortheuseofbisphosphonatesinmultiplemyeloma.MayoClinProc81(8):1047-1053.
Lapi,F.,Cipriani,F.,etal. (2012):Assessingtheriskofosteonecrosisofthejawduetobisphosphonate therapy in the secondary prevention of osteoporotic fractures.OsteoporosInt24(2):697-705.
Lazarovici,T.S.,Mesilaty-Gross,S.,etal. (2010):Serologicbonemarkersforpredictingdevelopmentofosteonecrosisof the jaw inpatients receivingbisphosphonates. JOralMaxillofacSurg68(9):2241-2247.
Lazarovici,T.S.,Yahalom,R.,etal.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:asingle-centerstudyof101patients.JOralMaxillofacSurg67(4):850-855.
Lazarovici,T.S.,Yahalom,R.,etal.(2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawassociatedwithdentalimplants.JOralMaxillofacSurg68(4):790-796.
Lo,J.C.,O’Ryan,F.S.,etal.(2009):Prevalenceofosteonecrosisofthejawinpatientswithoralbisphosphonateexposure.JOralMaxillofacSurg68(2):243-253.
67
Ludlow,J.B.,Davies-Ludlow,L.E.,etal.(2003):Dosimetryoftwoextraoraldirectdigitalimagingdevices:NewTomconebeamCTandOrthophosPlusDSpanoramicunit.DentomaxillofacRadiol32(4):229-234.
Marini, F., Tonelli, P., et al. (2011): Pharmacogenetics of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.FrontBiosci(EliteEd)3:364-370.
Marx,R.E. (2003):Pamidronate (Aredia)and zoledronate (Zometa) inducedavascularnecrosisofthejaws:agrowingepidemic.JOralMaxillofacSurg61(9):1115-1117.
Marx,R.E.,Cillo,J.E.Jr.,etal.(2007):Oralbisphosphonate-inducedosteonecrosis:riskfactors,predictionofriskusingserumCTXtesting,prevention,andtreatment.JOralMaxillofacSurg65(12):2397-2410.
Marx, R. E., Sawatari, Y., et al. (2005): Bisphosphonate-induced exposed bone(osteonecrosis/osteopetrosis)ofthejaws:riskfactors,recognition,prevention,andtreatment.JOralMaxillofacSurg63(11):1567-1575.
Mauri,D.,Valachis,A.,etal.(2009):Osteonecrosisofthejawanduseofbisphosphonatesinadjuvantbreastcancertreatment:ameta-analysis.BreastCancerResTreat116(3):433-439.
Mavrokokki, T., Cheng, A., et al. (2007): Nature and frequency of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawsinAustralia.JOralMaxillofacSurg65(3):415-423.
Mawardi, H., Treister N., et al. (2009): Sinus tracts--an early sign of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaws?JOralMaxillofacSurg67(3):593-601.
McMahon,R.E.,Bouquot,J.E.,etal.(2007):Stagingbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawshouldincludeearlystagesofdisease.JOralMaxillofacSurg65(9):1899-1900.
Migliorati,C.A.(2006):Bisphosphonatesareassociatedwiththedevelopmentofexposedbone(osteonecrosis/osteopetrosis) intheoralcavity.JEvidBasedDentPract6(4):283-284.
Migliorati,C.A.,Epstein,J.B.,etal.(2011):Osteonecrosisofthejawandbisphosphonatesincancer:anarrativereview.NatRevEndocrinol7(1):34-42.
Migliorati, C. A., Woo, S. B., et al. (2010): A systematic review of bisphosphonateosteonecrosis(BON)incancer.SupportCareCancer18(8):1099-1106.
Mignogna, M. D., Sadile, G., et al. (2012): Drug-related osteonecrosis of the jaws:“Exposure,ornotexposure: that is thequestion”.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiol113(5):704-705.
Miksad, R. A., Lai, K. C., et al. (2011): Quality of life implications of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.Oncologist16(1):121-132.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (settembre 2009):Raccomandazioneperlaprevenzionedell’osteonecrosidellamascella/mandiboladabifosfonati.Raccomandazionen.10.
Montazeri,A.H.,Erskine,J.G.,etal.(2007):Oralsodiumclodronateinducedosteonecrosisofthejawinapatientwithmyeloma.EurJHaematol79(1):69-71.
68
Morag,Y.,Morag-Hezroni,M.,etal.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:apictorialreview.Radiographics29(7):1971-1984.
Morgan, G. J., Davies, F. E., et al. (2010): First-line treatmentwith zoledronic acid ascomparedwithclodronicacidinmultiplemyeloma(MRCMyelomaIX):arandomisedcontrolledtrial.Lancet376(9757):1989-1999.
Mucke,T.,Haarmann,S.,etal.(2009):Bisphosphonaterelatedosteonecrosisofthejawstreatedbysurgicalresectionandimmediateosseousmicrovascularreconstruction.JCraniomaxillofacSurg37(5):291-297.
Nocini,P.F.,Saia,G.,etal.(2009):Vascularizedfibulaflapreconstructionofthemandibleinbisphosphonate-relatedosteonecrosis.EurJSurgOncol35(4):373-379.
O’Ryan,F.S.,Khoury,S.,etal.(2009):Intravenousbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:bonescintigraphyasanearlyindicator.JOralMaxillofacSurg67(7):1363-1372.
Otto, S., Abu-Id, M. H., et al. (2011): Osteoporosis and bisphosphonates-relatedosteonecrosis of the jaw: not just a sporadic coincidence--amulti-centre study. JCraniomaxillofacSurg39(4):272-277.
Otto,S.,Sotlar,K.,etal.(2011):Osteonecrosisofthejawasapossibleraresideeffectofannualbisphosphonateadministrationforosteoporosis:Acasereport.JMedCaseRep5:477.
Palaska, P. K., Cartsos, V., et al. (2009): Bisphosphonates and time to osteonecrosisdevelopment.Oncologist14(11):1154-1166.
Palomo,L.,Bissada,N.,etal.(2006):Bisphosphonatetherapyforbonelossinpatientswithosteoporosisandperiodontaldisease:clinicalperspectivesandreviewof theliterature.QuintessenceInt37(2):103-107.
Phal, P.M.,Myall, R.W., et al. (2007): Imagingfindingsofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaws.AJNRAmJNeuroradiol28(6):1139-1145.
Pozzi,S.,Marcheselli,R.,etal.(2007):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:a reviewof35casesandanevaluationof its frequency inmultiplemyelomapatients.LeukLymphoma48(1):56-64.
Reid,I.R.andCornish,J.(2012):Epidemiologyandpathogenesisofosteonecrosisofthejaw.NatRevRheumatol8(2):90-96.
Ripamonti,C.I.,Maniezzo,M.,etal.(2009):Decreasedoccurrenceofosteonecrosisofthejawafterimplementationofdentalpreventivemeasuresinsolidtumourpatientswithbonemetastasestreatedwithbisphosphonates.TheexperienceoftheNationalCancerInstituteofMilan.AnnOncol20(1):137-145.
Rizzoli,R.,Burlet,N.,etal.(2008):Osteonecrosisofthejawandbisphosphonatetreatmentforosteoporosis.Bone42(5):841-847.
Ruggiero,S.,J.Gralow,etal.(2006).“Practicalguidelinesfortheprevention,diagnosis,andtreatmentofosteonecrosisofthejawinpatientswithcancer.”JOncolPract2(1):7-14.
69
Ruggiero,S.L.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw(BRONJ):initialdiscoveryandsubsequentdevelopment.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):13-18.
Ruggiero,S.L.,Dodson,T.B.,etal.(2009):AmericanAssociationofOralandMaxillofacialSurgeonspositionpaperonbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws--2009update.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):2-12.
Ruggiero,S. L., Fantasia, J.,etal. (2006):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisof thejaw:backgroundandguidelinesfordiagnosis,stagingandmanagement.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod102(4):433-441.
Ruggiero,S. L.andMehrotra,B. (2009):Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisof theJaw:Diagnosis,Prevention,andManagement.AnnuRevMed60:85-96.
Ruggiero,S.L.,Mehrotra,B.,etal.(2004):Osteonecrosisofthejawsassociatedwiththeuseofbisphosphonates:areviewof63cases.JOralMaxillofacSurg62(5):527-534.
Rustemeyer, J. and Bremerich, A. (2010): Bisphosphonate-associated osteonecrosis ofthe jaw:whatdowe currently know?A surveyof knowledge given in the recentliterature.ClinOralInvestig14(1):59-64.
Saad,F.,Brown.J.E.,etal.(2012):Incidence,riskfactors,andoutcomesofosteonecrosisofthejaw:integratedanalysisfromthreeblindedactive-controlledphaseIIItrialsincancerpatientswithbonemetastases.AnnOncol23(5):1341-7.
Saad, F., Abrahamsson, P. A., et al. (2009): Preserving bone health in patients withhormone-sensitiveprostate cancer: the roleof bisphosphonates. BJU Int 104(11):1573-1579.
Saia,G.,Blandamura,S.,etal.(2010):Occurrenceofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawaftersurgicaltoothextraction.JOralMaxillofacSurg68(4):797-804.
Sanna,G., Preda, L., et al. (2006):Bisphosphonatesand jawosteonecrosis inpatientswithadvancedbreastcancer.AnnOncol17(10):1512-1516.
Sarasquete,M.E.,Garcia-Sanz,R.,etal. (2008):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisof the jaw is associatedwith polymorphisms of the cytochrome P450 CYP2C8 inmultiplemyeloma:agenome-widesinglenucleotidepolymorphismanalysis.Blood 112(7):2709-2712.
Sarathy,A.P.,Bourgeois,S.L.Jr.,etal.(2005):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawsandendodontictreatment:twocasereports.JEndod31(10):759-763.
Sawatari, Y. and Marx, R. E. (2007): Bisphosphonates and bisphosphonate inducedosteonecrosis.OralMaxillofacSurgClinNorthAm19(4):487-498,v-vi.
Sedghizadeh,P.P.,Stanley,K.,etal.(2009):Oralbisphosphonateuseandtheprevalenceofosteonecrosisofthejaw:aninstitutionalinquiry.JAmDentAssoc140(1):61-66.
Shabestari,G.O.,.Shayesteh,Y.S,etal.(2010):Implantplacementinpatientswithoralbisphosphonatetherapy:acaseseries.ClinImplantDentRelatRes12(3):175-180.
Silverman, S. L. and Landesberg, R. (2009):Osteonecrosis of the Jaw and theRole ofBisphosphonates:ACriticalReview.AJM122:S33-S45.
70
Smith, A., Kressley, A., et al. (2009): Oral osteonecrosis associated with the use ofzoledronicacid:first caseof apatientwithadvancedpancreatic cancerandbonemetastases.JOP10(2):212-214.
Smith,M. R., Saad, F. C., et al. (2012):Denosumab and bone-metastasis-free survivalinmenwithcastration-resistantprostatecancer:resultsofaphase3,randomised,placebo-controlledtrial.Lancet379(9810):39-46.
Solomon,D.H.,Mercer,E.,etal.(2012):Definingtheepidemiologyofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:priorworkandcurrentchallenges.OsteoporosInt24(1):237-244.
Sottosanti,L.(2009):LESEGNALAZIONIALL’AIFA.IdatidellaReteNazionalediFarmaco-vigilanza (RNF) sui Bifosfonati e ONJ.http://www.reteoncologica.it/images/stories/ONJ/Osteonecrosi_mascellari_2009/0204%20Sottosanti%20Laura.pdf CongressoAlessandria,23giugno2009.
Sottosanti, L. (2010): DatiAIFA ed EMEA: update 2010. http://www.reteoncologica.it/index.php?option=com_content&view=article&id=185%3Aosteonecrosi-deimascel-lari-onj-prevenzione-diagnosi-trattamento-update-2010&catid=41&Itemid=85
CongressoONJ,Alessandria5giugno2010.
Stopeck,A.T.,Lipton,A.,etal.(2010):Denosumabcomparedwithzoledronicacidforthetreatmentofbonemetastasesinpatientswithadvancedbreastcancer:arandom-ized,double-blindstudy.JClinOncol28(35):5132-5139.
Store,G.,andGranstrom,G.(1999):Osteoradionecrosisofthemandible:amicroradio-graphic studyof cortical bone. Scand J PlastReconstr SurgHandSurg33(3): 307-314.
Tennis,P.,Rothman,K.J.,etal.(2012):Incidenceofosteonecrosisofthejawamongusersofbisphosphonateswithselectedcancersorosteoporosis.PharmacoepidemiolDrugSaf21(8):810-817.
Terpos,E.,Sezer,O.,etal.(2009):Theuseofbisphosphonatesinmultiplemyeloma:rec-ommendationsofanexpertpanelonbehalfoftheEuropeanMyelomaNetwork.Ann Oncol20(8):1303-1317.
TerrosiVagnoli,P.,C.P.,Centra,M.A.(1994):Ortopantomografia.CardinaleAE,DiGu-glielmoL,ed.Radiologiastomatologicaemaxillo-facciale.Napoli,Idelson:43-51.
Treister,N.andWoo,S.B.(2006);Imagesinclinicalmedicine.Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.NEnglJMed355(22):2348.
Tronchet,A.,Bettini,G.,etal(2011):Studiodell’estensioneclinico-radiologicadell’osteo-necrosideimascellariassociataabisfosfonati.AttidelXVIICongressoNazionaledellaSocietàItalianadiChirurgiaMaxillo-Facciale(SICMF),Como.
Tubiana-Hulin,M., Spielmann,M., et al. (2009): Physiopathology andmanagementofosteonecrosis of the jaws related to bisphosphonate therapy formalignant bonelesions.AFrenchexpertpanelanalysis.CritRevOncolHematol71(1):12-21.
Urade, M. (2009): [New development in bisphosphonate treatment. Bisphosphonatetherapyandosteonecrosisofthejaws].ClinCalcium19(1):100-108.
71
Vahtsevanos, K., Kyrgidis,A., et al. (2009): Longitudinal cohort studyof risk factors incancer patients of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw. J Clin Oncol 27(32):5356-5362.
Vescovi, P., Campisi, G., et al. (2011): Surgery-triggered and non surgery-triggeredBisphosphonate-relatedOsteonecrosisoftheJaws(BRONJ):Aretrospectiveanalysisof567casesinanItalianmulticenterstudy.OralOncol47(3):191-194.
Vittorini,E.,DelGiudice,E.,etal.(2005):MRIversusscintigraphywith99mTc-HMPAO-labelled granulocytes in thediagnosis of bone infection. RadiolMed109(4): 395-403.
Walter,C.,Al-Nawas,B.,etal. (2008):PrevalenceandRiskFactorsofBisphosphonate-Associated Osteonecrosis of the Jaw in Prostate Cancer Patients with AdvancedDiseaseTreatedwithZoledronate.EurUrol54(5):1066-1072.
Wessel,J.H.,.Dodson,T.B,etal.(2008):Zoledronate,smoking,andobesityarestrongriskfactorsforosteonecrosisofthejaw:acase-controlstudy.JOralMaxillofacSurg 66(4):625-631.
Wilde, F., Steinhoff, K., et al. (2009): Positron-emission tomography imaging in thediagnosisofbisphosphonate-relatedosteonecrosisof the jaw.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod107(3):412-419.
Wilkinson, G. S., Kuo, Y. F., et al. (2007): Intravenous bisphosphonate therapy andinflammatoryconditionsorsurgeryofthe jaw:apopulation-basedanalysis. JNatlCancerInst99(13):1016-1024.
Woo,S.B.,Hellstein,J.W.,etal.(2006):Narrative[corrected]review:bisphosphonatesandosteonecrosisofthejaws.AnnInternMed144(10):753-761.
Wutzl,A.,Pohl,S.,etal.(2012):Factorsinfluencingsurgicaltreatmentofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.HeadNeck 34(2):194-200.
Yamazaki,T.,Yamori,M.,etal.(2012):Riskofosteomyelitisofthejawinducedbyoralbisphosphonates inpatientstakingmedicationsforosteoporosis:Ahospital-basedcohortstudyinJapan.Bone51(5):882-887.
Yarom,N.,Elad,S.,etal.(2010):Osteonecrosisofthejawsinducedbydrugsotherthanbisphosphonates-acalltoupdateterminologyinlightofnewdata.OralOncol46(1):e1.
Yarom,N.,Fedele,S.,etal.(2010):Isexposureofthejawbonemandatoryforestablishingthediagnosisofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw?JOralMaxillofacSurg68(3):705.
Yarom, N., Yahalom, R., et al. (2007): Osteonecrosis of the jaw induced by orallyadministeredbisphosphonates:incidence,clinicalfeatures,predisposingfactorsandtreatmentoutcome.OsteoporosInt18(10):1363-1370.
Yip,J.K.,Borrell,L.N.,etal.(2012):Associationbetweenoralbisphosphonateuseanddental implant failure amongmiddle-agedwomen. J Clin Periodontol 39(4): 408-414.
72
Yoneda,T.,Hagino,H.,etal. (2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisof the jaw:positionpaperfromtheAlliedTaskForceCommitteeofJapaneseSocietyforBoneandMineralResearch,JapanOsteoporosisSociety,JapaneseSocietyofPeriodontology,JapaneseSocietyforOralandMaxillofacialRadiology,andJapaneseSocietyofOralandMaxillofacialSurgeons.JBoneMinerMetab28(4):365-383.
Zervas,K.,Verrou,E.,etal.(2006):Incidence,riskfactorsandmanagementofosteonecrosisof the jaw in patients withmultiplemyeloma: a single-centre experience in 303patients.BrJHaematol134(6):620-623.
73
Appendice 1. Criteri diagnostici
Criterio di inclusione
TerapiaconNBP(orali/endovenosi)inattoopregressa *
Criterio di esclusione
Pregressaradioterapiadeldistrettotesta-collo,interessanteilmascellareelamandibola§
Diagnosi dubbia
Co-presenzadineoplasiaosseaprimitivadeimascellari $
Co-presenzadimetastasiosseeacaricodeimascellari $
*Non è ancora definito quanto tempo debba trascorrere prima che il rischio di sviluppare BRONJ si annulli, anche in considerazione delle caratteristiche farmaco-cinetiche e farmaco-dinamiche dell’NBP. Pertanto, questa Commissione ritiene opportuno ad oggi considerare a rischio tutti i pazienti in trattamento con NBP EV per motivi oncologici, anche qualora sia terminata la terapia; invece, nei pazienti in trattamento con NBP per malattia osteometabolica è verosimile che l’effetto del farmaco sia più limitato nel tempo e per questi ultimi è consigliabile una valutazione caso- specifica.
§La co-presenza di “pregressa radioterapia del settore testa-collo” e “assunzione di NBP” all’anamnesi, identifica un paziente che, pur non potendo essere inquadrato per definizione nella BRONJ, è verosimilmente esposto ad un rischio molto elevato di sviluppare un processo osteonecrotico, per il danno osseo tissutale indotto sia dalla radioterapia che da NBP.
$L’associazione di neoplasia ossea primitiva o metastatica dei mascellari rappresenta un elemento potenzialmente peggiorativo della condizione clinica di base, ma non permette la diagnosi di BRONJ.
75
Approccio preventivo
Laprevenzionerimanel’approcciopiùsignificativoalfineditutelarelasaluteoraledelpazientechenecessitadell’assunzionediamino-bisfosfonati(NBP).Tuttavia, l’incompletaconoscenzadellebasieziopatogenetichedellaBRONJlimitalapossibilitàel’efficaciadell’approcciopreventivoalcontrollodeifatto-ridirischio.Traquestiultimi,comeènoto,ipiùsignificativisonoleprocedurechirurgichechecoinvolgonoleossamascellari(e.g.l’estrazionedentaria),leinfezionidento-parodontaliedimanufattiprotesicirimovibiliincongrui.Appare evidente come tali fattori siano di assoluta competenza degli ope-ratoridel settoreodontoiatrico,per iquali si configura,quindi,un ruolodiprimopianonellestrategiediprevenzionedellaBRONJ.Ciòimponelosforzodicolmarelelacunenellaconoscenzaegestionedelproblemadapartedelmedicoprescrittoreedell’odontoiatra(Lopez-Jornet,Camacho-Alonsoetal.2010),nonchélecarenzenell’informazionedelpaziente(Migliorati,Mattosetal.2010)cherendonoindubbiamentemoltodifficilel’isolamentodeifattoriedei pazientia rischioedi conseguenza complicanononpoco l’approcciopreventivoelasuaefficacia.Atalproposito, in letteraturasonostateriportatediverseraccomandazioniperglioperatoridelsettoreodontoiatrico,mala loroefficacianelridurreilrischiodiBRONJèspessocontroversaecomunqueprivadievidenzescienti-ficheadeguate(lamaggiorpartesonofondate,infatti,suopinionidiespertioseriedicasi).Tenuto conto delle raccomandazioni correnti, la Commissione presenta inquestasezioneunvademecumperlagestioneodontoiatricadelpazientepri-ma,duranteedopoiltrattamentoconNBP,intesocomestrumentodisempli-ceconsultazioneed’immediataapplicabilitàclinica.
CAPITOLO II
LA GESTIONE ODONTOIATRICA DEL PAZIENTE CHE ASSUMERÀ
O ASSUME AMINOBISFOSFONATI(redatto in collaborazione con Lucio Lo Russo-UNIFG e Paolo Vescovi-UNIPR)
76
Unapprocciopreventivoragionatodevetenereinconsiderazioneiseguentiparametri:
Tipologia di bisfosfonato• (BP): aminobisfosfonati (NBP)versus non aminobisfosfonati;Indicazione alla terapia con aminobisfosfonato (NBP)• : patologiaon-cologicaversus patologiaosteometabolica;Timing dell’azione odontoiatrica• (subitoprimaversusdurantetera-piaconNBP);
Tipologia di bisfosfonato
Aminobisfosfonati.Gliaminobisfosfonati(NBP)sono,adoggi, l’unicaclassedi bisfosfonatiper cui sia stata identificataun’associazione con lo sviluppodi BRONJ;pertanto, solo adessi si applicano le raccomandazioni seguenti,tese,perquantopossibileeneilimitidelleattualievidenze,allariduzionedelrischiodiinsorgenzadiBRONJ.Non aminobisfosfonati.Adoggi,peribisfosfonatinoncontenentigruppiam-minici,nonèstataevidenziataalcunaassociazioneconlaBRONJ,senoninsingoliesporadicicasereport;pertanto,ilrilievoanamnesticorelativoall’as-sunzioneditaleclassedifarmacinonmodificailcomportamentodell’odon-toiatraedinormaliprotocollidigestionedellasaluteorale(Ruggiero,Dodsonetal.2009).
Indicazione alla terapia con NBP
Per patologia oncologica
I dati epidemiologici disponibili indicano un’associazione tra insorgenza diBRONJeNBPadelevatapotenzasomministratiperviaendovenosanelpa-zienteoncologico(Bamias,Kastritisetal.2005).Secondo il parere di questa Commissione, il paziente oncologico che necessiti di NBP richiede un approccio preventivo rispetto alla BRONJ che inizia ancor prima dell’inizio della somministrazione di NBP e prosegue regolarmente per tutta la durata del trattamento e anche al termine di esso, attraverso l’azione coordinata di diverse figure professionali tra cui l’odontoiatra (gestione delle problematiche orali e loro prevenzione), l’oncologo (gestione della patologia
77
oncologica) ed il medico curante e/o altri specialisti (gestione delle comorbi-dità).
Per patologia osteometabolicaL’analisidellaletteraturaevidenziaunarelazionemenorobustatraBRONJeNBPsomministratiper os (Ruggiero,Dodsonetal.2009)perindicazionire-lativeallaprevenzionee/otrattamentodiproblematicheosteometaboliche(e.g.osteopenia,osteoporosi).Inquestisoggetti,l’incidenzadiBRONJrisultaesseremoltobassaedèstatostimatointornoa0,7/100.000persone-annodiesposizione(Ruggiero,Dodsonetal.2009).Questidati,ottenutidividen-doilnumerodicasidiBRONJriportatiperilnumerodisomministrazionidialendronatoapartiredallasuadatadiimmissioneincommercio,potrebberopotenzialmentesottostimareilproblema;infatti,datiderivantidastudicliniciindicherebberoun’incidenzadiBRONJinpazienticheassumonosettimanal-mentealendronatoper osparia0,01-0,04%(Mavrokokki,Chengetal.2007).Nelcomplesso,adoggiilrischiosembrerebbeclinicamentebassoe,comun-que,nontaledagiustificareilrifiutodapartedell’odontoiatradisottoporreilpazienteincuraconNBPatrattamentiodontoiatrici,inassenzadialtrecon-troindicazionispecifiche.Anzi, ilmancatotrattamentopotrebbeprolungareoprecipitarecondizioniinfiammatorie/infettivechepotrebberoaumentareilrischiodiBRONJ.Secondo il parere di questa Commissione, il paziente non oncologico che deb-ba iniziare terapia con NBP necessita di un approccio preventivo rispetto alla BRONJ meno vincolante ed urgente rispetto alla precedente categoria, che consista nella diagnosi e cura delle patologie dento-parodontali, al pari del-la popolazione generale di pari età e sesso. Tale approccio dovrebbe iniziare entro 6 mesi dalla prima somministrazione di NBP e proseguire regolarmen-te per tutta la durata del trattamento e anche al termine di esso, attraverso l’azione coordinata di diverse figure professionali tra cui l’odontoiatra (gestio-ne delle problematiche orali e loro prevenzione) ed il medico curante e/o altri specialisti (gestione delle comorbidità).
Timing dell’azione odontoiatrica (subito prima o durante la terapia con NBP)
L’attività di prevenzioneprimaria della BRONJ, per quanto limitata al sem-plicecontrollodeifattoridirischioadogginoti,ècondottainpazientiche
78
hanno lanecessitàdi iniziare l’assunzionediNBPocheassumonogiàNBP,manonhannoavutoeventiavversialcavoorale.Inentrambiicasil’obiettivodell’attivitàdiprevenzioneèquellodimanteneree/orispristinarelostatodisalutedento-parodontaledelpazienteinmododaridurrelapossibilitàchesirealizzinoeventiinfiammatori/infettiviesirendano,perciò,necessarieproce-dureinvasive(Ruggiero,Dodsonetal.2009),che,insieme,sonoiprincipalifattoridirischiolocaliperlaBRONJ.Inaggiunta,ilpaziente,inentrambelesituazioni,deveessereinformatodelrischiodiBRONJeresoedottodellesuemanifestazioniinmododapoterallertaretempestivamenteilmedico/odon-toiatracuranteeconsentire,così,unadiagnosiprecoce(Khan,Sándoretal.2008).Piùinparticolare,diseguitosonoriportatiicomportamenticonsigliatinelledueevenienze.
Somministrazione di aminobisfosfonati pianificata, ma non ancora iniziataNeipazientichedevonoiniziarel’assunzionediNBP,deveessereattentamen-te valutato lo status dento-parodontale, nonché le pregresse riabilitazioniprotesiche,siaattraversol’esameclinicodapartediunodontoiatrachetra-mitevalutazioneradiografica,inmodocheeventualiproblematicheinessereocondizionidi incertezza (e.g.denticonprognosidubbia),possanoessereprontamenteedopportunamenterisolte,possibilmenteprimadell’iniziodel-la terapia conNBP, soprattutto sequesta richiedaNBPendovenaper indi-cazionioncologiche;l’iniziodellaterapiadovrebbeessereprocrastinatafinoallacompletaguarigionebiologicadeitessutiorali(Dimopoulos,Kastritisetal.2009;Ripamonti,Maniezzoetal.2009),compatibilmentecon lapatolo-gia di base che determina l’indicazione alla somministrazione diNBP ed ilgiudiziocriticodelclinicoche liprescrive. Inaltreparole, inaccordocon leRaccomandazioniMinisteriali (MinisterodelLavorodellaSaluteedellePo-litichesociali,settembre2010),primadiiniziarelasomministrazionediNBPperpatologieoncologiche,ilpazientedeveessereriferitoadunodontoiatra;quest’ultimo,provvedeallavalutazione (secondo lapresenteCommissioneancheconl’ausiliodiimagingradiologico)dellasaluteorale,altrattamentodipatologielocaliedall’istituzionediunadeguatoprogrammadiprevenzioneemantenimentodellasaluteorale.Inpresenzadipatologienononcologiche, leRaccomandazioniMinisterialinonfornisconoindicazioni, l’EuropeanMe-dicensAgency(EMEA)haraccomandatonel2009,perquestipazienti,cheilprescrittorediNBPliriferiscaall’odontoiatraseillorostatusdentalerisultassescarso.L’EMEA,però,nonspecificasecondoqualiparametrioprocedure il
79
prescrittorediBPpossagiungereadunaopinioneatalriguardo;atalpro-posito la Società Italianadi Patologia eMedicinaOrale (SIPMO)hapropo-stonel2011(www.sipmo.it)unmodopersuperaretaledifficoltà,medianteunquestionario(vediSchema2)dasomministrarealpazientedapartedelprescrittorediNBP,cosìchemedianterisposteadomandechiusesipossa-no intercettare pazienti con patologie dento-parodontali in atto da riferireall’odontoiatraprimadell’assunzionediNBP.È opinione di questa Commissione che nel paziente oncologico la visita odon-toiatrica debba essere eseguita prima dell’assunzione di NBP e che tale com-portamento sia auspicabile anche prima della somministrazione di NBP per indicazioni non oncologiche; in tal caso la valutazione odontoiatrica e l’even-tuale riabilitazione potrebbe essere condotta, in regime di elezione, anche nei primi mesi successivi alla somministrazione di NBP (entro 6 mesi), tenuto con-to che la durata del trattamento con NBP pare essere uno dei fattori di rischio per BRONJ.
Somministrazione di aminobisfosfonati in atto o conclusaIpazientichegiàassumonoNBPdevonoessereinseritiinunidoneoprogram-madiprevenzionedento-parodontalee/o terapiaparodontaledi supportoinmododaminimizzareilrischiodiinsorgenzadipatologiedentarieopro-blematicheparodontali/perimplantari,econtrollareefficacementequelleinatto.Atalproposito,ipazientidevonoeseguirecontrolliperiodiciconunafre-quenzanoninferioreaquellanormalmenteusataneiprogrammidipreven-zioneoraleemantenimentoparodontalenellapopolazionegenerale,ilche,asecondadellostatusdento-parodontaleedell’etàdelpaziente,comportal’effettuazionedellarivalutazionedelpazienteogniquattrooseimesi(Ame-ricanAcademyofPeriodontology1996and2000;Renvert,Persson2004;Te-zal,Wactawski-Wendeetal.2005).Leriabilitazioniprotesichevannoinseritemetodicamentenellerivalutazioniperiodiche;inparticolare,quelleditipori-movibiledevonoesseremonitoratealfinediverificareerimuovereeventualitraumisullamucosa(inparticolarenellaregionelingualeeposterioredellamandibola).OccorretenerepresentecheèstatadocumentatainletteraturaunacorrelazionepositivatraduratadiesposizioneagliNBPerischiodiBRONJ(Bamias,Kastritisetal.2005).Ataleriguardoèstatoevidenziatoche,periNBPper os,ilrischioaumentasensibilmentequandoladuratadell’esposizio-nesuperaitreanni(Ruggiero,Dodsonetal.2009).
80
IltermineolasospensionedellasomministrazionediNBPèprudenzialmen-teassimilabile, in terminidi condottaclinicaaifinidellaprevenzionedellaBRONJ, alla somministrazione in atto per un tempo non ancora definibile.Infatti, l’emivitapiuttosto lungadellemolecolediNBPcomportauneffettod’inibizionesullafunzioneosteoclasticadiduratanonprevedibile.GlieffettidegliNBPalivelloosseopossonoesseremoltoprolungatineltempo,anchedopounasingolasomministrazione.Èstatadimostratalapresenzanell’ossodiquestemolecoleanchedopomoltiannidalterminedellaloroassunzione,maappareintuitivochequantopiùèprolungatoiltempocheintercorretrailterminedell’esposizionealfarmacoelaterapiaodontoiatricainvasiva,tantomaggiorisarannolepotenzialitàdirecuperometabolicoevascolaredell’ossoedeitessutidirivestimento(CorradoandCantatore2005;Allegra,Aloncietal.2010),conpotenzialeriduzionedelrischio.
81
Schema 2. Questionario ad uso del medico prescrittore di amino-bisfosfonati per stimare lo status dentale e la necessità di visita/cure odontoiatriche *
SI NOSi sottopone a visita odontoiatrica almeno 2 volte all’anno? Esegue con regolarità sedute di igiene orale professionale?Lavaidenticonlospazzolinoalmeno3voltealgiorno?Usaaltripresidiperl’igieneorale?(e.g.collutori,gel)
Utilizzailfilointerdentale?
Le sue gengive sanguinano spesso spontaneamente e/o al minimo traumatismo?Ha mai avuto gonfiore o dolore in sede gengivale? (e.g. ascesso parodontale, ascesso periapicale)Hamaisoffertodiinfezionideidenti?(e.g.facciagonfia,pus)Hamaiavutoulcereorali?(ricorrentioassociateapatologiesistemiche)Hamaisoffertodimaldidenti?Hamaiosservatoun’alterazionedelcolorediqualchedente?
Hamaiavutodeitraumadentalioalleossamascellari?
Dovrà sottoporsi ad estrazioni dentarie o interventi di chirurgia orale (eg. impianti endossei, chirurgia parodontale, chirurgia periapicale) nei prossimi mesi?Porta protesi dentarie? Sesi,dichetipo?Specificare(fissoorimovibile,totaleoparziale)……………………………………………………………………………………………………………Soffre di qualche malattia? Sesi,quale/i?Specificare(e.g.diabete,insufficienzarenale,coagulopatie,osteoporosi,tumori,malattiecardiovascolari)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Assume cortisone in modo continuativo ? Sesi,chetipo?Specificaretipoedose………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Assume cortisone o farmaci antiangiogenetici? Se sì, di che tipo? Specificare tipo e dose ……………………………………………
Fuma?Sesi,specificarenumerodisigarette/die……………………………………………
Bevealcolici?Sesi,specificarenumerodibicchieri/die……………………………………………
*In grassetto, le domandechiave:inpresenzadialmenounarispostachefasospettareunoscarsostatooro-dentale,il/lapazientedovrebbeessereriferitoall’odontoiatra
82
Sospensione della terapia con aminobisfosfonati prima di procedure terapeutiche o elettive invasive
Alcuniautori segnalano lapossibilitàdi sospendere la somministrazionediNBPcirca3mesiprimadiunaproceduraterapeuticaoelettivainvasiva,com-patibilmenteconlapatologiadibaseeprevioaccordoconilmedicocurante(cosiddetta“drugholiday”),perpoiriprenderlaunavoltaterminatoilproces-sobiologicodiguarigionedeitessuti.NonesisteevidenzascientificachesupportilavaliditàdellasospensionedellaterapiacongliNBP,siaendovenosaoorale,primadelleproceduredichirur-giadento-alveolare.L’emivitapiuttosto lungadiquestemolecolecomportauneffettod’inibizionesullafunzioneosteoclasticadiduratanonprevedibile.GlieffettideiBPalivelloosseopossonoesseremoltoprolungatineltempo,anchedopounasingolasomministrazione.S’ipotizzachelasospensionedellaterapiapotrebbeessereassociataadunariduzionedell’effettoanti-angioge-neticoesercitatodagliNBPsulperiostioeitessutimollicontribuendo,poten-zialmente,amigliorarelavascolarizzazioneeacondurreunaguarigionepiùrapida dopo lemanovre chirurgiche. Altri autori ipotizzano la sospensionedelfarmacoilmesesuccessivoall’estrazionenelcasoditerapiaconNBPen-dovenainpazientioncologici,perridurrel’accumulodiNBPinsededitrau-maestrattivo,dovel’accumulodiNBPsarebbeaumentatoperiltropismodelfarmacoper sitiadelevato rimodellamentoosseo (Saia,Blandamuraetal.2010).Comunque,l’eventualedecisionesullasospensionedellaterapiadeveesseresemprepresainaccordoconl’oncologool’internistadopoun’attentavalu-tazionedeirischiedellacondizionedibasedelpaziente.Neipazientionco-logicicheassumonoNBPperviaendovenosa,lasospensionerappresentainognicasounaproceduraadelevatorischioperlaprogressionedellapatologiadibaseoperilmancatocontrollodeglieventiosseicorrelati.Lelineeguidadell’ASBMR(AmericanSocietyofBoneandMineralResearch)edell’AAOMS(AmericanAssociationofOralandMaxillofacialSurgeons)raccomandanolasospensionediNBPunicamente se le condizioni sistemiche lopermettono(Khosla,Burretal.2007;Ruggiero,Dodsonetal.2009).LaMFA(MyelomaFoundation of Australia) raccomanda la cessazione diNBP per almeno tremesiincasodicomparsadiBRONJsalvoincasodiipercalcemianoncontrol-labile.Laripresadellaterapiadipendedalrischioindividualedieventische-letrici (SRE)e sarebbecomunqueconsigliata solodopo la risoluzionedellaBRONJ(Dickinson,Princeetal.2009).
83
Latemporaneainterruzionedellaterapia,neipazienticheassumonoNBPperviaorale,puòessereconsiderataduranteilpianoditrattamentoodontoiatri-co,neicasiincuilastessanonprovochidegliimportantiscompensidell’equi-librioosseo,ilchepuòesserestabilitoconlacollaborazionedelmedicopre-scrittorediNBP.NelcasodiunpazientecandidatoaltrattamentoendovenosoconNBPchedeveesseresottopostoadinterventochirurgicoalcavoorale,selecondizio-nigeneralilopermettono,laterapiamedicadeveessererimandatafinoallacompletariepitelizzazionedelsitoestrattivo.Èpiuttostodiscutibileinveceilbilanciorischio-beneficionelcasodellasospensionediNBPinunpazientegiàinterapia:alcuniautorineconsiglianolasospensionefinoaunmesedopol’intervento,manonesistonostudicaso-controllochenepossanoconferma-relarealeutilità.Pertuttiipazienti interapiaconNBPperviaoraledapiùdi treanni,odamenodi tre anni se inpresenzadi co-fattori di rischio addizionali, le lineeguidastilatedall’AAOMSsuggerisconodiinterromperelasomministrazionediNBPtremesiprimadegliinterventichirurgici,selecondizionisistemichedelpazienteloconsentono,ediriprenderelaterapiadopolacompletachiusuradelsitochirurgico.Quest’atteggiamento,peraltro,sibasapuramentesulpa-rerediespertienonèstatoinalcunmodovalidatoinletteratura.PoichésononotiglieffettibeneficidegliNBPsulcontrollodellamalattiadibaseesullere-lativecomplicanze,mentresonodubbiirisultatidellalorosospensioneaifinidiridurreilrischiodiBRONJ,sidevesempreinformareilpazientesullascarsapredicibilitàdell’effettosospensivo(Borromeo,Tsaoetal.2011)esulpossibi-lerischioconnessoalpeggioramentodelcompensometabolicodell’osso.La Commissione considera che ad oggi non esiste alcuna evidenza scientifica a sostegno della reale utilità della “drug holiday”. Diseguito,sarannodescrittelediverseprocedureodontoiatricheconlerela-tiveraccomandazioniclinicheperlagestionedelpaziente.Ledifferentiprocedureterapeutichesarannoconsideratenelleduecategoriedirischio:ipazientiinterapiaconNBPperindicazionioncologicheequelliperpatologieosteometaboliche.Lesingoleproceduresarannoanalizzateinduedifferentifasi:primadell’inizioedurantel’assunzionedegliNBP.Aquest’ulti-mafasevieneassimilataanchel’evenienzaincuiilpazienteabbiaterminatootemporaneamentesospesolaterapiaconNBP.
84
Procedure odontoiatriche
II termine“dentalprocedures”,comunementeusatonelleraccomandazioniclinico-terapeuticheinternazionali(tradottoinlinguaitaliana“terapieodon-toiatriche”)identificaunaserieditrattamentianchemoltodiversitraloro.Persemplificarelatrattazionedellenumeroseprocedureodontoiatrichein-vasiveonon,insoggettipotenzialmentearischiodisviluppareBRONJ,abbia-moritenutoopportunodistinguerleintrecategorietralorodistinte:
Procedure di prevenzione: • insiemeditrattamentichemiranoapreser-varelostatodisaluteorale;Procedure terapeutiche: • trattamentoinvasivoonon-invasivodipatolo-giedento-parodontaliinatto;Procedure d’elezione: • trattamentiinvasivionon-invasivi,finalizzatialripristinodellefunzionidell’apparatostomatognatico.
RispettoallecondizionidisaluteoralediunpazientechedeveiniziareogiàassumeterapiaconNBP,possonorealizzarsiduepossibiliscenari:
Salute orale mantenuta• ,percuisirendononecessariesoloprocedurediprevenzionedento-parodontaleoproceduredielezione.Presenza di patologie dento-parodontali o perimplantari e/o lesioni •mucose,perlequalisirendenecessariaun’opportunaprocedurate-rapeutica.
Salute orale mantenuta:cheiltrattamentoconNBPsiaincorsooprogram-mato, l’obiettivoprimariosaràmantenere lo statodi saluteorale inessereattraversolenormaliprocedure di prevenzione(controlliperiodici,fluoropro-filassi topica,mantenimento igienico e/o terapia parodontale di supporto,screeningperlesionimucose)perridurreilrischiodiBRONJconnessoafeno-meniinfiammatori/infettiviodontogenieallerelativeprocedurechirurgiche.Eventualiprocedure di elezione (protesi, ortodonzia) saranno comunque pos-sibili, mentre procedure di elezione invasive(e.g.chirurgiaimplantare,chirur-gia ossea preimplantare, chirurgiamucogengivale) andranno attentamenteconsiderateinfunzionedellamalattiadibase,deltipoedellaquantitàdiNBPassuntoneltempo.Inparticolare,selasomministrazionediNBPnonèanco-rainiziata,leterapiedielezionepotranno,inlineateorica,essereeffettuatesecondo i comuniprotocollie, sedicarattere invasivo,andrannoportateatermineprimadell’iniziodellaterapiaconNBP,fermorestandolaconsidera-zioneragionatadellarealeutilitàdellaproceduraperilpazienteedellesuepriorità,specieperilpazienteoncologico;nelcasopoi incui laterapiacon
85
NBPperindicazionioncologichesiagiàiniziata,leterapiedielezioneinvasivesonocontroindicateedandrebberoevitate.Per questo motivo, la Commissione conferma che nel paziente oncologico sono da ritenersi sempre controindicate le procedure terapeutiche elettive (chirur-gia ossea pre-implantare, implantologia o chirurgia mucogengivale), sia che il trattamento con NBP sia già in corso oppure programmato a breve.Taleapproccioèmenostringentenelcasodi terapiaconNBPpermalattieosteometaboliche,incorsodellaqualeleprocedureinvasivedielezione(chi-rurgia implantare, chirurgia ossea preimplantare, chirurgiamucogengivale)possonoessereportateatermineselaterapiaèiniziatadamenoditreannienonsianopresentialtrifattoridirischio;qualorainvecesianopresentifattoridi rischiospecificie/o il trattamentoconNBPsisiaprotrattoperpiùdi treanni,leprocedureandrebberovalutatecasopercaso.Presenza di patologie dento-parodontali o perimplantari e/o lesioni mucose di natura traumatica:essevannogestiteerisolteprimadell’iniziodeltratta-mentoconNBP,compatibilmenteconl’urgenzaconcuièritenutanecessarialasomministrazionediNBP.QualoralasomministrazionediNBPsiagiàiniziata,comecriteriodiorientamentogenerale,bisogneràevitarediprocrastinarel’eli-minazionedeifocolaiinfiammatori/infettivi.Le procedure terapeutiche finaliz-zateal trattamentodiprocessipatologici infiammatori/infettivi inattosonosempreindicate,medianteapplicazionediprotocollispecifici,overichiesti.Eventualiproceduredielezione,ancheesoprattuttoinvasive(e.g.chirurgiaimplantare,chirurgiaosseapreimplantare,chirurgiamucogengivale),andran-noattentamenteconsiderateesarannopossibili,ovenoncontroindicate,solounavoltarisoltiiprocessipatologiciinfiammatori/infettivi.Saranno forniti,ovepossibile, i livellidi rischioe la fattibilitàomenodellediverseprocedureodontoiatriche.Pertanto,nelpresentecapitolo,sarannoutilizzatiiseguentitermini:
Rischiobasso :BRONJèevenienzaimprobabile;Rischioalto :probabilitàdiBRONJèsensibilmenteconcreta;Rischio non definibile : non esistono evidenze che permettano diquantificare,ancheinmodoapprossimativo,ilrischiodiBRONJasso-ciatoadunaprocedurae/oallepossibilicomplicanzedellaprocedurastessa,potendoquesteultimerealizzarsiancheadistanzaditempodalmomentodiesecuzionedellaprocedura, incondizioniquindidiaumentatocaricodiNBPaimascellari.
Afronteditaleconnotazionedelrischio, leprocedureodontoiatrichesonostateclassificatecome:
86
Indicate :rischioassenteobasso,e/oesistelanecessitàdieseguireleprocedurestesseinquantoilbeneficiochederivadaessesorpassadigranlungal’eventualerischiodiBRONJ;Possibili : rischio tendenzialmente basso, se presente, in assenza diuna controindicazione specifica; tuttavia, non esiste la necessità diesecuzionechecaratterizzaleprocedure“indicate”;Controindicate :ilrischiodiBRONJconseguentealleprocedureèalto,e/oibeneficisonoinconsistenti.
Chirurgia dento-alveolare
Ingenerale,primadell’iniziodellaterapiaconNBP(siapermalattieoncologi-checheosteometaboliche),leterapiechirurgichedento-alveolari(procedureterapeuticheinvasive)sonoindicatealfinedieliminarefocolaiinfiammatoriedinfettivi,oeventualielementidentariconunaprognosidubbianonmodi-ficabile.QualoralaterapiaconNBPsiagiàiniziata,neipazientiintrattamentoper ma-lattie osteometaboliche leprocedure terapeutiche invasive (estrazioniden-tarie)nonsonogeneralmentecontroindicate(Ruggiero,Dodsonetal.2009);invece,peripazientitrattaticonNBPendovenaperindicazioni oncologicheilrischiodisviluppareBRONJaseguitodiavulsionidentarieèaumentatofinoa53volte(Kyrgidis,Vahtsevanosetal.2008).Pertalemotivo,nellamaggiorpartedellepubblicazionidegliultimiannileproceduredichirurgiaoralein-teressanti l’osso e in particolarmodo le estrazioni dentarie erano ritenutecontroindicateintalipazienti.Tuttavia,atalpropositovannofattealcunecon-siderazioni:vistalapartecipazionedeimeccanismiinfiammatori-infettivinel-lagenesidellaBRONJ,allalucedelsignificativocalod’incidenzadellaBRONJosservatodopol’introduzionedispecificiprotocollidiprevenzioneoraleneipazientiinterapiaconNBP(Dimopoulos,Kastritisetal.2009),lamancataef-fettuazionediprocedureterapeuticheinvasivequandoquesterappresentinolasoluzionedefinitivaaprocessiinfiammatori/infettiviinattonelleossama-scellari(e.g.quelliassociatiadelementidentaricompromessiononrecupe-rabili),mantenendoquestiprocessiattivi,aumenterebbeilrischiodiBRONJpiùchel’esecuzionedelleterapiestesse.Èstatoevidenziato,infatti,cheaseguitodiestrazionidentarielaBRONJsima-nifestainqueicasiincuiiltessutoosseoalveolaresiagiàinteressatodaalte-razioni osteomieliticheevidenziate istologicamente (Saia, Blandamuraet al.
87
2010),verosimilmenteinnescateconilcontributodeiprocessiinfiammatori/infettivichepongonol’indicazioneall’estrazione.Pertanto,lachirurgianonsolononcostituirebbe,persé,unfattoredirischio,anzipotrebberidurreilrischiodiBRONJattraversol’eliminazioneprecocedifocolaiinfiammatori/infettivi.Intalsenso,recentementesonostatiriportatirisultatiincoraggiantiasegui-todi procedure terapeutiche invasive inpazientioncologici in trattamentoconNBPendovena,nell’ambitodiopportuniprotocollidiprofilassiantibiotica(Saia,Blandamuraetal.2010;Montefusco,Gayetal.2008;Lodi,Sardellaetal.2010;Ferlito,Puzzoetal.2011;Scoletta,Arduinoetal.2011).Taliproto-colliprevedonolasomministrazionediantibioticisistemiciedantisetticioralipre-e/opost-chirurgia,l’esecuzionediprocedureestrattiveatraumatichee,datocomuneatuttiiprotocolli,lamobilizzazionedilembimucoperiosteiperlachiusuraprimariadelsitochirurgico.Perquantoriguardailtipodiantibioticoe laduratadellasuasomministra-zione i diversi protocolli non sonounivoci. In generale, sono statiutilizzatiantibioticiadampiospettro,inparticolareamoxicillina(1g,3volte/die)conosenzaacidoclavulanico,ancheinassociazioneametronidazolo(500mg,2volte/die)o,incasodiallergiaallepenicilline,eritromicina(600mg,3volte/die)clindamicina(600mg,2volte/die)ociprofloxacina(500mg,2volte/die).Inrelazionealladuratadellasomministrazionepreoperatoria,alcunireportsindicanomiglioririsultatiincasoditerapieantibiotichepreoperatorieprolun-gate (3-4settimane) (HoefertandEufinger2011),mentrealtrievidenzianobuonirisultaticonterapieantibiotichepreoperatoriebrevi(iniziatetregiorni(Lodi,Sardellaetal.2010),o1giorno(Scoletta,Arduinoetal.2011)primadell’estrazione) o con terapie iniziate il giorno stesso dell’estrazione (Saia,Blandamuraetal.2010).L’esecuzionediprocedurediigieneoraleprofessio-naleeseguitedueotresettimaneprimadell’interventoedassociateall’usoquotidianodicollutorioallaclorexidinasembranoaumentareulteriormenteillivellodiefficaciadelleprocedureterapeuticheinvasive(Lodi,Sardellaetal.2010;Scoletta,Arduinoetal.2011).Laprosecuzionepostoperatoriadellaterapiaantibioticaneiprotocollicitatièstatariportatainunrangeda5giorni(Ferlito,Puzzoetal.2011;Scoletta,Arduinoetal.2011)a17giorni(Lodi,Sardellaetal.2010).Atalproposito,nonsipuòesprimereungiudiziocircalasceltaottimalechevieneindefinitivarimessaalgiudiziodelclinicorelativamentealcasospecifico,dalmomentocheiprotocolliriportatinonsonocomparabilielaloroefficaciaèbasataalmomentosuevidenzescientificheinsufficienti.Alcuniprotocolliproposticonsiglianodieseguireleestrazioniconminimain-
88
vasivitàsull’osso(Lodi,Sardellaetal.2010),perridurrelaqualeèstatopro-postoanchel’ausiliodiapparecchiaturechirurgicheultrasonicheperl’esecu-zionedieventualiosteotomie/osteoplastiche(Scoletta,Arduinoetal.2011).Iprotocollidiestrazionechirurgicaproposticonl’usodistrumentiodontoia-triciconvenzionali(Saia,Blandamuraetal.2010;Ferlito,Puzzoetal.2011),afrontedimaggioreinvasivitànonsembranoperaltroaccrescereilrischiodiBRONJrispettoall’usodistrumentiultrasonici,almenosullabasedelleattualievidenze.Larimozionedeltessutodigranulazioneall’internodell’alveoloelachiusuraprimariadelsitoestrattivoottenutaconlamobilizzazionedilembimucope-riostei sonoconsigliati in tutti iprincipaliprotocollipubblicatie rappresen-tanoprobabilmente il fattoredecisivoper lariduzionedelrischiodiBRONJdopoestrazionedentaria.Il ruolo di fattori potenzialmente capaci di migliorare la guarigione osseacome i fattori di crescitadi derivazionepiastrinica (Scoletta,Arduinoet al.2011)deveessereancoravalidato.È opinione di questa Commissione che la chirurgia dento-alveolare sia indi-cata ed eseguibile senza modifiche dei normali protocolli prima di iniziare la somministrazione di NBP non solo in soggetti affetti da patologie osteometa-boliche, ma anche oncologiche a patto che, soprattutto in quest’ultimo caso, sia possibile attendere la completa guarigione biologica del sito estrattivo (normalmente 4-6 settimane). In caso contrario, le tecniche estrattive devono essere assimilabili a quelle consigliate in corso di terapia con NBP. SelaterapiaconNBPèiniziata,nelcasodiNBPper osdiduratainferioreai3anniperpatologieosteometaboliche,ilrischiodiBRONJaseguitodipro-cedureestrattiverisultaesseremoltobasso,percuipossonoessereeseguiteestrazionidentalisecondoinormaliprotocolliodontoiatrici,perchéilbilanciorischio-beneficièatotalevantaggiodeibeneficiottenibiliconl’eliminazionedellepatologiechepongonol’indicazioneallachirurgia.SeinvecelaterapiaconNBPperpatologieosteometabolicheèiniziatadapiùdi3anni,oinpre-senzadialtrifattoridirischio,sidovrebbevalutarelapossibilitàdiutilizzareprotocolli di chirurgia estrattiva cheprevedano la rimozionedel tessutodigranulazioneall’internodell’alveoloelachiusuraprimariadelsitoestrattivoottenuta con lamobilizzazionedi lembimucoperiostei. È invecealtamenteconsigliabile ed indicato l’usodel suddettoprotocolloestrattivo inpazientioncologicigiàinterapiaconNBPendovena.Comegiàaccennatoinpreceden-za,puòessereutileinquestisoggettiunasospensionetemporaneadiNBPdalmomentodell’estrazionesinoallacompletaguarigionedelsitoestrattivo(4-6
89
settimane),selecondizionidelpazienteloconsentonoeselasospensionenonhaeffettideleterisulcompensodellapatologiadibase.È opinione di questa Commissione che la chirurgia pre-implantare e la chi-rurgia mucogengivale siano controindicate nel paziente oncologico che abbia iniziato il trattamento con NBP o sia in procinto di farlo. Èinvecepossibilel’esecuzionediterapiedielezioneinvasive(chirurgiapre-implantareechirurgiamucogengivale)nelsoggettoaffettodamalattiaoste-ometabolica,siachedebbaancorainiziare(oabbiainiziatoda<3anni)l’as-sunzionediNBP,siachelaterapiasiainiziatadapiùdi3anniovveroinpre-senzadialtrifattoridirischio.Sirilevaperaltrol’importanzadiun’adeguatainformazionealpazientesulrischio,purbasso,disviluppareBRONJnegliannisuccessivialcompletamentoditaliprocedurefinalizzateallacostruzionediimplanto-protesi,nelcasolaterapiaconNBPdovesseperdurare,comeève-rosimilechesia.
Implantologia
Ilrapportotraimplantologiadentaleel’usodiNBPèpiuttostocomplessoecontroverso:sedaunlatosistaancoracercandodidefinireilrischiodiBRONJperuninterventodiimplantologiadentaleinunpazienteincuraconquestifarmaci,inpassatoibisfosfonatisonostatitestatialloscopodimigliorareilprocessodiosteointegrazione. Ilnumerodeglistudiretrospettivicheripor-tano gli effettidell’inserimentodi impiantiendossei nei pazienti in terapiaconNBPècresciutonegliultimi4anni.Lamaggioranzadeglistudisiècon-centratasulladefinizionedelsuccessoimplantareneipazientiintrattamentoconNBP(inparticolarepazienticonpatologienononcologiche);certamentemenoattenzioneharicevutoladefinizionedelrischiodiinsorgenzadiBRONJconseguenteadunaproceduraimplantare.Èancoradifficilestabilirese l’intervento implantologico insée/o laprotesisupportatadaimpianti,possanorappresentareaprioriunrischioeffettivodiBRONJ.Ildubbioèchelecondizionilocaliosistemichedelpaziente(soprat-tuttooncologico) possano favorire l’insorgenzadi unaperimplantite, facileviadidiffusionedelprocessoinfettivoall’osso,edunquecostituireilfattoreprecipitantelaBRONJ.Le raccomandazioni cliniche sono concordi nel definire che l’assunzione di NBP per via endovenosa per motivi oncologici rappresenta una controindicazio-ne assoluta all’implantologia in corso di terapia, e la presente Commissione
90
concorda in pieno su questo punto. Tale controindicazione deve considerarsi valida anche dopo cessazione della terapia con NBP, anche se per un periodo di tempo ancora non meglio definito.LasomministrazionediNBPperviaendovenosaconposologiedifferentiedindicazionidiversedaquelleoncologicheèancoratroppolimitataerecenteperfornirepreciseindicazioni.Unatematicadimaggiorediscussioneèrappresentatadallaterapiaoraleoparenteraleneipazientiaffettidamalattieosteometaboliche,per il larghis-simo numero dei soggetti compresi e per l’indicazione all’implantoprotesitipicaproprio delle fascedi età interessateda tali patologie. AlcuniAutoriavevanoinizialmenteipotizzatocheibisfosfonatirappresentanoinognicasounacontroindicazioneallachirurgiaimplantareinquantomodificanoinma-nieranonpreventivabilelarispostadell’osso,delperiostioedeitessutimolliall’eventotraumatico(Soileau2006;Wang,Weberetal.2007;Scully,Kumaretal.2010).Altri,alparidiJeffcoatcheriportairisultatidiunostudiosuglieffettidell’alendronatoversusplacebosulriassorbimentodell’ossoalveolaree sulmantenimentodegli impianti in335pazientiaffettidamalattiaparo-dontalemoderataeseveraesu50pazientitrattaticonchirurgiaimplantare(Jeffcoat2006),nondescrivononessuncasodiBRONJalfollow-upedilsuc-cessodellaterapiaimplantoprotesicaèstatodel99%sianelgruppotrattatoconalendronatocheinquellotrattatoconilplacebomentresièosservatounminoreriassorbimentoosseoneipazientiespostialfarmaco.Fugazzotto,inunostudiosuimpiantipost-estrattiviconcaricoimmediatoin61pazientiinterapiaconNBPper osperunperiodomediodi3,3anni,rife-risceilmantenimentodegliimpiantieassenzadiBRONJintuttiisoggettiperunfollow-upda12a24mesi(Fugazzotto,Lightfootetal.2007).Koka(Koka,Babuetal.2010)riportairisultatidiunostudioeffettuatocaso-controllosu137donneinpost-menopausa,dicui55intrattamentoconNBP.Nessuncasodiosteonecrosisieraverificatoneiduegruppielasopravviven-zadegliimpiantinellepazientiinterapiaenoninterapiaerasovrapponibile(98.19%vs99.17%rispettivamente).Nessunapazienteavevasospesol’assun-zionedeifarmaciinoccasionedell’intervento.Leonida(Leonida,Vescovietal.2010)riferisce9casidipazientiinterapiaconaminobisfosfonatioralisottoposticonsuccessoadimpiantipost-estrattiviconcaricoimmediatodiprotesifullarchconappoggiosuseiimpianti.Nessunpa-zientehamanifestatosegniditumefazionedeitessutimollinédiBRONJperl’interoperiododifollow-up.Dopodueannidicaricotuttigliimpiantisonorisultatistabiliesenzaalcunsegnodiflogosioinfezioneconunaglobaleso-
91
pravvivenzaclinicadel100%.Lasoluzionediunaprotesiadesclusivoappog-gioimplantareverrebbeaminimizzaretotalmenteilrischioditraumiedecu-bitiprotesicichecostituisconofattoridirischioperl’insorgenzadiBRONJ.Grant (Grant,Amenedoetal.2008)nonriportaalcuncasodiosteonecrosiin468impiantiapplicatiin115pazientiinterapiaconbisfosfonatiorali.Unarevisionedellaletteraturadal1995afebbraio2010(JavedandAlmas2010)identifica89articolisull’argomentoestabiliscechelaterapiaconbisfosfonatioralinoninfluiscesull’osteointegrazioneesullafunzionalitàdegliimpianti.Tuttaviaalcuniautorihannoriferitosingolicasidi fallimentodi impiantiedinsorgenza di BRONJ in pazienti trattati con bisfosfonati orali, (Savoldelli,LePageetal.2007;Bedogni,Bettinietal.2010; Lazarovici,Yahalometal.2010).IcasidiBRONJpost-implantareincorsoditerapiaconNBPpermalattieosteometabolicheattualmenteriportatiinletteraturasonocircaunadozzina.Cheng (Cheng, Daly et al. 2009) stima un rischio di perdita di impianti inpazientisottopostiaNBPoraledicircal’0,88%.Se i risultati di questi studi sembrano suggerire che la terapia con NBPnei pazienti non oncologici non rappresenterebbe una controindicazioneall’implantologia dentale, viene dagli stessi studi riportata la necessitàdi considerare sempre cautamente i singoli casi, specie in relazione aglieventualifattoridirischioaggiuntivi.Infatti,èriportatocheperipazienticheassumonoibisfosfonatioralidaoltretreanniechesonosottotrattamentocon steroidi il rischio aumenta e potrebbero essere considerate terapiealternative(Flichy-Fernandez,Balaguer-Martinezetal.2009).Inaggiunta,vasottolineatoche ilnumerodeicasi studiatiprospetticamentenonèancorastatisticamente adeguato per addivenire a conclusioni definitive e d’altrocantolepotenzialicomplicazionidicaratterebiologicoacaricodellaterapiaimplantare(i.e.perimplantite)sipossonoconfigurarecomefattoredirischioperlaBRONJ.Talicomplicanzepossonoinsorgereancheadistanzaditempoedintalcasoilloroeffettodovrebbeesserevalutatononsingolarmentemainassociazioneall’aumentatorischioprodottodalcumulototalediNBP.Ciò,inaltritermini,potrebbesignificarechenonlaproceduraimplantareinsé,malesuepotenzialicomplicanzepotrebberoesporreadunrischioincrementaledi BRONJ. Pertanto, l’implantologia nel paziente non oncologico dovrebbeprudenzialmenteessereancoraconsideratauntrattamentoarischio,sebbeneconleevidenzeattualitalerischiononsiadefinibile.È opinione della Commissione che sia oppurtuno che l’operatore (Odonto-iatra o Chirurgo Maxillo-Facciale) informi il paziente in terapia con NBP per malattie osteometaboliche durante la pianificazione di riabilitazioni implan-
92
toprotesiche che esiste un potenziale e non quantificabile rischio di sviluppa-re BRONJ sul sito implantare, legato al protrarsi negli anni della terapia con NBP ed all’eventuale insorgenza di fenomeni di perimplantite; il che si rende ovviamente più probabile in caso di insufficiente controllo delle condizioni di salute orale e perimplantare, sia anche esso legato ad una scarsa aderenza del paziente ai controlli. Si afferma, quindi, l’importanza di discutere e condi-videre con il paziente la scelta dell’implantologia e l’indispensabile adesione da parte del paziente a uno stretto programma di igiene orale domiciliare e professionale.
Chirurgia parodontale e chirurgia endodontica
Leprocedureterapeuticheinvasive(chirurgiaparodontale/endodonticacheabbiano come finalità l’eliminazione di significativi processi infiammatori-infettiviinattonelleossamascellari)sonoindicateinentrambelecategorie(oncologicienon)ancheduranteiltrattamento.Andrebbero,tuttavia,semprepreferiteopzionietecnichechirurgichecheminimizzanolamanipolazioneos-sea,tenendoinconsiderazioneiprotocollidiprofilassiantibioticaindicatiapropositodellachirurgiadento-alveolare.Nelcasoleprocedureterapeuticheinvasivesianopredisposteprimadell’iniziodellaterapiaconNBP,lacommis-sioneritienenecessaria l’attesadellaguarigionebiologicadei tessutiprimadell’iniziodellaterapiafarmacologica(4-6settimane).Sel’iniziodellaterapiaNBPnon fosseprocrastinabile,èconsigliabilevalutaresoluzionialternativeconlachirurgiaestrattiva.È opinione di questa Commissione che le procedure di elezione invasive (chi-rurgia estetica muco-gengivale) siano da ritenersi controindicate nei pazienti oncologici prima, durante e dopo il trattamento con NBP. Per quanto riguarda i pazienti non oncologici le procedure di chirurgia parodontale elettiva do-vrebbero essere eseguite minimizzando la chirurgia ossea. Inoltre,daunpuntodivistaspeculativo,l’effettoantiangiogeneticodegliNBPpotrebbeavereuneffettonegativo,ocomunquenonpredicibile,suproce-dure di rigenerazione ossea o rigenerazionetissutale guidata, sebbene ciòrichieda ancora prove sperimentali. Se il piano di trattamento richiede uncoinvolgimentodell’ossoe/odelperiostioinsestantidifferentialcuniautorihannoconsigliatoditrattareprimaunsestanteounsingolodente(i.e.sextantapproach).Sedopolaterapia,durantei2mesidifollow-up,nonsievidenzial’insorgenzadisegniosintomidiBRONJil trattamentopuòessereragione-
93
volmenteeseguitoanchenegli altri sestanti.Sevièun successocompletonelprimosestante(assenzadiareeinfiammate,irritateoeritematose)sipuòprendereinconsiderazioneunapprocciochirurgicoconcoinvolgimentocon-temporaneodipiùsestanti. Il“sextantapproach”afinipreventiviperlaBRONJhacomunqueunbassolivellodievidenza(Fedele,Kumaretal.2009).È opinione di questa Commissione che le procedure terapeutiche (chirurgia parodontale/endodontica che abbia come finalità l’eliminazione di rilevanti processi infiammatori-infettivi in atto nelle ossa mascellari) in pazienti con malattia osteometabolica siano sempre indicate; le procedure di elezione in-vasive (chirurgia parodontale con finalità estetiche), pur se gravate da un ri-schio tendenzialmente basso, sono possibili anche dopo i 3 anni di terapia ed in presenza di fattori di rischio aggiuntivi. La Commissione rileva l’importanza di un’attenta valutazione del singolo caso e di un’adeguata informativa al pa-ziente sul rischio, pur basso, di sviluppare BRONJ.
Conservativa ed Endodonzia
Leterapieconservativedidentimoltocompromessi,sepredicibili,sonocon-sigliateinentrambelecategoriedipazienti(oncologicienon)interapiaconNBP,perovviarealleestrazionidentarie(Pemberton2010).Bisogna,infatti,considerarecheattualmente i casidiosteonecrosi insorti incoincidenzaditerapiacanalaresonopochissimiedidubbia interpretazione(Sarathy,Bou-rgeoisetal.2005;FugazzottoandLightfoot2006);tuttavia,ilrischiodiBRONJpotrebbeesserepiùelevatoaseguitodicomplicanzeoerroriproceduralidu-rante l’esecuzionedella terapiaendodontica inun soggetto in trattamentoconNBP (Ozmeric2002;Dumlu,Yalcinkayaetal.2007;WaltersandRawal2007).Viene,pertanto,incoraggiatointutteleraccomandazioniiltrattamen-toendodonticoortogradoinvecedimanovrechirurgicheinvasive,identifican-doquindiinquestasoluzioneterapeuticaun’azionepreventivaneiconfrontidell’insorgenzadiosteonecrosi(Kyrgidis,Aroraetal.2010;McLeod,Pateletal.2010).L’unicodubbioèrappresentatodaipazientioncologicidefedati,af-fettidamielomamultiploometastasiosseealrachide:l’estremadifficoltàdimantenerelaposizionesedutaodecliveperlungotempoel’impedimentoadapplicareladigaperlapresenzadinauseaevomitorappresentanounagravelimitazioneallacorrettaproceduraendodontica.Sonopoisegnalatedifferenzedi“sensibilità”nelconsiderarelapotenzialitàdelrecuperodell’elementodentariotraglispecialistiinendodonziaedichi-rurghiorali(Ehrmann2010).
94
Recentementeèstatoipotizzatocheunfattoredirischioperl’insorgenzadiosteonecrosi possaessere rappresentatodall’applicazionedell’uncinodelladigadigommadurante lecureconservativeoendodontiche (Gallego, Jun-queraetal.2011).Iltraumaesercitatosullemucoseesull’ossoalveolarepo-trebberappresentareunfenomenoscatenanteilprocessoosteonecrotico.Leraccomandazionicircal’opportunitàdilimitarel’esecuzionedellecurecon-servativepreventivamente alla somministrazionediNBP appaiono comun-quemoltodeboliinentrambelecategoriedipazienti;infatti,nonc’èevidenzaalcunacheleterapieconservativeoendodontichecomportinounsostanzialeaumentodirischiodiBRONJinnessunacategoriadipazienti(oncologicionononcologici)incorsoditerapiaconNBPoppureunavoltasospesal’assunzioneditalifarmaci.È opinione di questa Commissione che le terapie conservative ed endodontiche possano essere eseguite senza limitazione alcuna anche du-rante la terapia con NBP.
Terapia parodontale (Igiene e terapia causale)
Laparodontopatia è considerata la principale comorbidità riscontrabile sianeipazientioncologici chenononcologici sottopostia terapia conNBP. Ladiffusionedibatteriattraversolatascaparodontalerappresentailprincipalefattoredidiffusionedi infezioneallacompagineossea(Ruggiero,Mehrotraetal.2004;Ruggiero,Gralowetal.2006;Woo,Hellsteinetal.2006;Yone-da,Hagino et al. 2010) e come tale è da considerarsi un fattoredi rischiorilevante. Pertanto, un adeguato protocollo di igiene orale professionale edomiciliarerappresentailpre-requisitoallasomministrazionediNBPsianeipazientioncologicicheneipazienticonpatologieosteometaboliche;è,inol-tre,indispensabilemantenereunostrettocontrollodellecondizionidiigiene/saluteoraleconrichiamiperiodicidaeseguirsiogniquattromesineisoggettioncologiciedogniseimesineinononcologici(Campisi,DiFedeetal.2007),ocomunqueconunafrequenzaperiodicachenondovràmaiessereinferioreaquellanormalmenteusataneiprogrammidiprevenzioneoraleemante-nimentoparodontale richiestidallo statusdento-parodontaleedall’etàdelpaziente(Teja,Perssonetal.1992;Persson,Alvesetal.1995;Sims,Lernmarketal. 2001;Persson,Matulieneetal. 2003;Tezal,Wactawski-Wendeetal.2005;Bertoldo,Santinietal.2007).IltrattamentodelleparodontopatieneipazienticonmalattiaoncologicaoosteometabolicacheassumonoohannoassuntoNBPdevefondarsisuun’accurataterapiacausale(nonchirurgica)e
95
un’altrettantaaccuratarivalutazioneperiodica;sedaquest’ultimadovesseroemergereproblematiche residuee/o altrenecessità edobiettivi terapeuti-ci,aifinidellastabilizzazionedellecondizioniparodontaliedell’eliminazionedifocolaiinfiammatori-infettivi,etaliobiettiviterapeuticisonoraggiungibilisoloattraversoprocedurechirurgiche,questedevonoesserepraticate,purconparticolaricautele.
Ortodonzia
Dall’anno2007sonoiniziateacomparireinletteraturadelleraccomandazio-niperquantoconcernel’ortodonzia(Zahrowski2007;Goss2008).Anchesenonesistonostudichepossanoattribuireaquestogeneredi terapiaunri-schiospecificodiincrementodiosteonecrosinèsonodescritticasiclinicidiBRONJ insorte su siti trattatiortodonticamente, bisogna considerare che ilmovimentoortodonticodeterminaunaumentosensibiledelturnoverosseoconunconseguenteaccumulo localedifarmaco. Ildecrementodell’attivitàosteoclasticainquestipazientisitradurràintuitivamenteinunadifficoltàallospostamentodeidentiedunplausibilerischiodiparodontopatia,traumaoc-clusale,accumulodiplaccaetartaroconflogosigengivale(Fujimura,Kitauraetal.2009;Zahrowski2009).QuestipossonoindubbiamenterappresentarepossibilifattoridirischioriconosciutiperleBRONJ.Siraccomanda,dunque,diconsiderareconcautelailtrattamentoortodonticoneipazientisottopostiadaltedosiedaterapieprolungate,specialmenteperviaendovenosa.Ipa-zientiinterapiaconbisfosfonatiperviaoralesonodaconsiderare,comeperlealtre terapieodontoiatrichenon invasive, abasso rischio. Il trattamentoortodonticodovràesserepianificatoperridurrealminimoiltraumaeserci-tatosuidentiesullemucose,utilizzandoforzedeboliescegliendoancoraggidentarimultipliedevitandoquantopossibilecollaterali terapiechirurgiche(Zaoui2009;Ghoneima,Allametal.2010).Correzionichirurgichedianomaliemucoseemuscolari(frenulievestiboloplastiche)chenonprevedanoilcoin-volgimentodellebasiosseeedeidentisonodapreferirerispettoad inter-ventipiùinvasivi.Sussiste,comunque,dapartedell’ortodontistailcompitodiseguireconattenzioneilpazienteinterapiaconNBP,siadaunpuntodivistaclinico che radiografico, per poter intercettare e opportunamente trattareforme inizialidipatologiadento-parodontale, taloraasintomatiche,avendoescluso lapossibilitàchesi trattidisegniprecocidiosteonecrosi.Anche inquestocasoèstatasuggeritaprecauzionalmentelasospensionediNBPdu-
96
ranteiltrattamentoortodontico;valgono,tuttavia,leperplessitàcircalasuautilità.È opinione della Commissione che non sussistono evidenze cliniche che controindichino la terapia ortodontica in nessuna delle categorie di pazienti, oncologici e non, ed in nessuna delle fasi di somministrazione degli NBP. Esi-stonoinoltreesperienzeclinichecheraccomandanol’estrusioneortodonticadiradiciodentiirrecuperabilifinoallalorogradualeesfoliazioneperovviareallapiùtraumaticaestrazionedentaria(Regev,Lustmannetal.2008).Ladu-ratadiquestaproceduradipendedallamorfologiadiognisingolaradice,dallostatodeitessutiparodontali,dall’anatomialocaleedallacollaborazionedelpaziente.Vienepropostaquestasoluzionecometrattamentodisceltaquan-do l’estrazioneènecessaria inunpazientechenonpuò sospendere l’NBP.Questatecnicarisultatuttaviadifficiledaadattareneipazientianzianiedon-cologicichemostranounascarsacomplianceperlefrequentivisiteeseduteodontoiatricheediventainattuabileincasodiedentulismoparzialenelleareelimitrofeall’elementodaestrarreperl’ovviaimpossibilitàdiapplicareletra-zioniortodontiche(VescoviandNammour2010).
Protesi
Indipendentementedalla categoriadi pazientioncologici onononcologici,l’attenzionevapostasulpotenzialetraumasullemucoseoralicausatodallacompressionedellebasiprotesiche,nelcasodi riabilitazioniditiporimovi-bile.Ilruolodell’odontoiatraedell’igienistadentaleappaionofondamentalinellaprevenzioneenell’intercettazionedi lesionimucosechedeterminanoesposizioneosseaechespessosonoasintomaticheopaucisintomatiche(Kyr-gidis,Teleioudisetal.2010).Spessotalimanifestazionisono interpretateegestitedalpazientecomebanalidecubitialternandol’impiegodellaprotesiconlatemporanearimozioneperalleviareildoloreinducendocosìunacro-nicizzazioneedunaggravamentodelprocesso.È opinione della Commissione che non sussistono evidenze cliniche che controindichino la terapia protesica in alcuna delle categorie di pazienti, oncologici e non, o in alcuna delle fasi di somministrazione di un NBP. Esistono delle precauzioni da tenere in debita considerazione. Leprotesifissedevonoessereposteconmargini sopragengivali facilmentecontrollabiliedetergibili:lecoroneprotesichedevonoessereallestiteinma-nieradaesercitareilminordannopossibilesuitessutiparodontalimarginali.Leprotesirimovibilinondevonoesercitaredecubitisoprattuttonelleareea
97
Tabe
lla 8
. Pro
cedu
re o
dont
oiat
rich
e in
paz
ienti
che
ass
umer
anno
o a
ssum
ono
amin
obis
fosf
onati
Pato
logi
e on
colo
gich
ePa
tolo
gie
oste
omet
abol
iche
Tera
pia
con
NBP
da
iniz
iare
Tera
pia
con
NBP
iniz
iata
Tera
pia
con
NBP
da
iniz
iare
, o <
3 a
nni
Tera
pia
con
NBP
iniz
iata
> 3
an
ni, o
< 3
ann
i con
fatt
ori
sist
emic
i di r
isch
io p
er B
RON
J
Chir
urgi
a de
nto-
alve
olar
e- P
roce
dure
es
tratti
veIn
dica
ta: e
strazion
esemplice1
Atten
dere
la
gu
arig
ione
m
ucos
a pr
ima
di in
izio
tera
pia
con
NBP
(4-6
setti
man
e)
Indi
cata
: estrazion
echirurgica
2
È co
nsig
liabi
le l
a so
spen
sion
e di
N
BP
dal
mom
ento
de
ll’es
traz
ione
alla
gua
rigio
ne
dei t
essu
ti (4
-6 s
ettim
ane)
Indi
cata
: estrazion
esemplice
Indi
cata
: estrazion
echirurgica
2
- Chi
rurg
ia
prei
mpl
anta
reCo
ntro
indi
cata
Cont
roin
dica
taPo
ssib
ilePo
ssib
ile4
Impl
anto
logi
aCo
ntro
indi
cata
Cont
roin
dica
taPo
ssib
ile3
Poss
ibile
3,4
Chir
urgi
a pa
rodo
ntal
e- T
erap
euti
caIn
dica
ta2,
5
Atten
dere
gua
rigio
ne m
ucos
a pr
ima
di in
izia
re t
erap
ia c
on
NBP
(4-6
setti
man
e)
Indi
cata
2,5
È co
nsig
liabi
le l
a so
spen
sion
e di
N
BP
dal
mom
ento
de
ll’in
terv
ento
alla
gua
rigio
ne
dei t
essu
ti (4
-6 s
ettim
ane)
Indi
cata
Indi
cata
2
- Ele
ttiva
Cont
roin
dica
taCo
ntro
indi
cata
Poss
ibile
Poss
ibile
Chir
urgi
a en
dodo
ntica
Indi
cata
2,5
Indi
cata
2,5
Indi
cata
Indi
cata
2
Tera
pia
paro
dont
ale
(Igi
ene
e te
rapi
a ca
usal
e)In
dica
taIn
dica
ta (o
gni 4
mes
i)In
dica
taIn
dica
ta (o
gni 4
-6 m
esi)
Cons
erva
tiva
Indi
cata
Indi
cata
Indi
cata
Indi
cata
Endo
donz
iaIn
dica
taIn
dica
taIn
dica
taIn
dica
ta
Ort
odon
zia
Poss
ibile
Poss
ibile
È co
nsig
liabi
le l’
impi
ego
di fo
rze
debo
li
Poss
ibile
Poss
ibile
Prot
esi fi
ssa
Poss
ibile
Poss
ibile
6Po
ssib
ilePo
ssib
ile6
Prot
esi r
imov
ibile
Poss
ibile
Poss
ibile
Evita
re t
raum
atism
o e
decu
biti;
ev
entu
ale
ribas
atur
a m
orbi
da
(con
trol
lo d
ei m
anuf
atti o
gni
4 m
esi)
Poss
ibile
Poss
ibile
Evita
re tr
aum
atism
o e
decu
biti;
eve
ntua
le ri
basa
tura
m
orbi
da (c
ontr
ollo
dei
m
anuf
atti o
gni 4
-6m
esi)
1 Seiniziote
rapiaconNBP
non
èprocrastin
abile,scegliereestrazion
echirurgica
2 Usarelembo
mucop
eriosteo
perlachiusuraprim
ariadelsito
chirurgico
3 Co
nsen
soin
form
atope
rrischiono
nde
finibilediB
RONJa
lung
oterm
ine
4Co
nsen
soin
form
atope
rrischiono
nde
finibilediB
RONJa
brevete
rmine
5So
losefin
alizzataaltrattam
entodisignificati
viprocessiinfi
ammatori-infetti
viin
attoeno
naltrim
enticontrollabiliconmetod
iche
non
invasive
6 Rispett
ode
ll’am
piezzabiologica(con
trollodellachiusuracervicale–even
tualechiusurasop
rageng
ivale)
98
rischio(marginelingualedellamandibola,porzionemedianadelpalatoever-santevestibolaredellecresteedentulemascellari).Lacompressionemecca-nicaesercitatadaprotesirimovibiliincongrueolapresenzadistruttureana-tomichefacilmentetraumatizzabili(esostosi,torimandibolariomascellari)èriferitacomeresponsabilediinsorgenzadiosteonecrosi.Vaconsiderata,soprattuttoperipazientichehannosviluppatoBRONJochehannosubitointerventichirurgici,l’opportunitàdieseguireribasaturemorbi-deperminimizzareiltraumasullecrestealveolari.Quandoèpossibileilrecu-peroendodonticodeglielementidentariresidui,laprogettazionediun’over-denture(eventualmenteconl’ausiliodicoronetelescopicheinconometria)consentediridurrel’appoggiomucosoedidistribuireilcaricomasticatoriosuimonconiradicolarie,conferendomaggiorstabilitàall’apparecchio,riduceimovimentidiconfricazioneequindiilrischiodidecubito(Gollner,Holstetal.2010).Ipazientiparzialmenteototalmenteedentulidevonoessereinformaticircailrischiorappresentatodaiprocessiflogisticiacaricodellemucosesottopro-tesiche,chenepossonocompromettere l’integritàepromuovereeventua-lideiscenzeconesposizioniossee,edessereistruitiall’igieneedalcorrettomantenimentodelmanufattoprotesico. È generalmente consigliabile la ri-mozionedelleprotesiduranteleorenotturne; infine,nonc’èevidenzachemalocclusioniealterazionidelle forzemasticatoriepossanocomportareunaumentodirischiodiBRONJ(MeloandObeid2005).Perunasintesideipercorsi terapeuticiattuabiliprimadell’iniziodel tratta-mentoconNBPoincorsoditerapia,sifacciariferimentoallaTabella8omni-comprensiva,all’Appendice2peripazientioncologiciedall’Appendice3peripazienticonpatologiaosteometabolica.
99
Bibliografia
Allegra, A., Alonci, A., et al. (2010): Bisphosphonates induce apoptosis of circulatingendothelialcellsinmultiplemyelomapatientsandinsubjectswithbisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaws.ActaHaematol124(2):79-85.
AmericanAcademyofPeriodontology(1996):Positionpaper:epidemiologyofperiodontaldiseases.JPeriodontol67(9):935-945.
AmericanAcademyofPeriodontology(2000):Parameteronperiodontalmaintenance.JPeriodontol71(5Suppl):849-850.
Bamias,A.,Kastritis,E.,etal.(2005):Osteonecrosisofthejawincanceraftertreatmentwithbisphosphonates:incidenceandriskfactors.JClinOncol23(34):8580-8587.
Bedogni,A.,Bettini,G.,etal. (2010):Oralbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawafterimplantsurgery:acasereportandliteraturereview.JOralMaxillofacSurg68(7):1662-1666.
Bertoldo,F.,Santini,D.,etal. (2007):Bisphosphonatesandosteomyelitisofthe jaw:apathogenicpuzzle.NatClinPractOncol4(12):711-721.
Borromeo,G.,Tsao,C.,etal.(2011):Areviewoftheclinicalimplicationsofbisphosphonatesindentistry.AustDentJ56(1):2-9.
Campisi,G.,DiFede,O.,etal.(2007):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw(BRONJ): run dental management designs and issues in diagnosis. Ann Oncol 18Suppl6:vi168-172.
Cheng,A.,Daly,C.G.,etal.(2009):Alveolarboneandthebisphosphonates.AustDentJ 54Suppl1:S51-61.
Corrado, A. and Cantatore, F. P. (2005): I bisfosfonati: caratteristiche chimiche, effettibiologici scheletrici ed effetti extra-scheletrici. The bisphosponates: chemicalcharacteristics, skeletal biological effects and extra-skeletal effects. Reumatismo 57(3):142-153.
Dickinson, M., Prince, H. M., et al. (2009): Osteonecrosis of the jaw complicatingbisphosphonatetreatmentforbonediseaseinmultiplemyeloma:anoverviewwithrecommendationsforpreventionandtreatment.InternMedJ39(5):304-316.
Dimopoulos,M.A.,Kastritis,E.,etal.(2009):Reductionofosteonecrosisofthejaw(ONJ)after implementation of preventivemeasures in patients with multiple myelomatreatedwithzoledronicacid.AnnOncol20(1):117-120.
Dumlu,A.,Yalcinkaya,S.,etal.(2007):Osteomyelitisduetoarsenictrioxideusefortoothdevitalization.IntEndodJ40(4):317-322.
Ehrmann,E.H.(2010):Lettertotheeditor.AustEndodJ36(2):96.
Fedele, S., Kumar, N., et al. (2009): Dental management of patients at risk ofosteochemonecrosisofthejaws:acriticalreview.OralDis15(8):527-537.
Ferlito,S.,Puzzo,S.,etal. (2011):PreventiveProtocolforToothExtractionsinPatientsTreatedWithZoledronate:ACaseSeries.YJOMS:1-4.
100
Flichy-Fernandez,A.J.,Balaguer-Martinez,J.,etal.(2009):Bisphosphonatesanddentalimplants:currentproblems.MedOralPatolOralCirBucal14(7):E355-360.
Fugazzotto,P.A.andLightfoot,S.(2006):Bisphosphonateassociatedosteonecrosisofthejawsandendodontictreatment:twocasereports.JMassDentSoc55(2):5.
Fugazzotto, P. A., Lightfoot, W. S., et al. (2007): Implant placement with or withoutsimultaneoustoothextractioninpatientstakingoralbisphosphonates:postoperativehealing,earlyfollow-up,andtheincidenceofcomplicationsintwoprivatepractices.JPeriodontol78(9):1664-1669.
Fujimura,Y.,Kitaura,H.,etal.(2009):Influenceofbisphosphonatesonorthodontictoothmovementinmice.EurJOrthod31(6):572-577.
Gallego, L., Junquera, L., et al. (2011):RubberDamClampTraumaDuringEndodonticTreatment:ARiskFactorofBisphosphonate-RelatedOsteonecrosisoftheJaw?JOralMaxillofacSurg69(6):e93-5.
Ghoneima,A.A.,Allam,E.S.,etal.(2010):Bisphosphonatestreatmentandorthodonticconsiderations.OrthodCraniofacRes13(1):1-10.
Gollner, M., Holst, S., et al. (2010): Prosthodontic treatment of a patient withbisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaw using a removable dentalprosthesiswithaheat-polymerizedresilientliner:aclinicalreport.JProsthetDent 103(4):196-201.
Goss,A.N.(2008):Bisphosphonatesandorthodontics.AustOrthodJ24(1):56-57.
Grant,B.T.,Amenedo,C.,etal.(2008):Outcomesofplacingdentalimplantsinpatientstakingoralbisphosphonates:areviewof115cases.JOralMaxillofacSurg66(2):223-230.
Hoefert, S. and Eufinger, H. (2011): Relevance of a prolonged preoperative antibioticregimeinthetreatmentofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw.JOralMaxillofacSurg69(2):362-380.
Javed,F.andAlmas,K.(2010):Osseointegrationofdentalimplantsinpatientsundergoingbisphosphonatetreatment:aliteraturereview.JPeriodontol81(4):479-484.
Jeffcoat,M. K. (2006): Safety of oral bisphosphonates: controlled studies on alveolarbone.IntJOralMaxillofacImplants21(3):349-353.
Khan,A.A.,Sándor,G.K.B.,etal. (2008):Canadianconsensuspracticeguidelines forbisphosphonateassociatedosteonecrosisofthejaw.JRheumatol35:1391-1397.
Khosla,S.,Burr,D.,etal. (2007):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisof the jaw:reportofataskforceoftheAmericanSocietyforBoneandMineralResearch.JBoneMinerRes22(10):1479-1491.
Koka, S., Babu, N. M., et al. (2010): Survival of dental implants in post-menopausalbisphosphonateusers.JProsthodontRes54(3):108-111.
Kyrgidis,A.,Arora,A.,etal.(2010):Rootcanaltherapyforthepreventionofosteonecrosisofthejaws:anevidence-basedclinicalupdate.AustEndodJ36(3):130-133.
101
Kyrgidis,A.,Teleioudis,Z.,etal.(2010):Theroleofdentalhygienistinthepreventionofosteonecrosisofthejawinpatientswearingdentures.IntJDentHyg8(2):154.
Kyrgidis,A.,Vahtsevanos,K.,etal.(2008):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:acase-controlstudyofriskfactorsinbreastcancerpatients.JClinOncol26(28):4634-4638.
Lazarovici,T.S.,Yahalom,R.,etal.(2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawassociatedwithdentalimplants.JOralMaxillofacSurg68(4):790-796.
Leonida,A.,Vescovi,P.,etal.(2010):Immediateloadingofdentalimplantsinmandiblefull-arch:pilotstudyinpatientswithosteoporosistreatedwithbassooniststherapy.JOralImplantol38(1):85-94.
Lodi, G., Sardella, A., et al. (2010): Tooth extraction in patients taking intravenousbisphosphonates:apreventiveprotocolandcaseseries.JOralMaxillofacSurg68(1):107-110.
Lopez-Jornet, P., Camacho-Alonso, F., et al. (2010): Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.Knowledgeandattitudesofdentistsanddentalstudents:apreliminarystudy.JEvalClinPract16(5):878-882.
Mavrokokki, T., Cheng, A., et al. (2007): Nature and frequency of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawsinAustralia.JOralMaxillofacSurg65(3):415-423.
McLeod, N. M., Patel, V., et al. (2010): Bisphosphonate osteonecrosis of the jaw: aliteraturereviewofUKpoliciesversusinternationalpoliciesonthemanagementofbisphosphonateosteonecrosisofthejaw.BrJOralMaxillofacSurg49(5):335-42.
Melo,M.D.andObeid,G.(2005):Osteonecrosisofthejawsinpatientswithahistoryofreceivingbisphosphonatetherapy:strategiesforpreventionandearlyrecognition.JAmDentAssoc136(12):1675-1681.
Migliorati,C.A.,Mattos,K.,etal. (2010):Howpatients’ lackofknowledgeaboutoralbisphosphonatescaninterferewithmedicalanddentalcare.JAmDentAssoc141(5):562-566.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (settembre 2009):Raccomandazioneperlaprevenzionedell’osteonecrosidellamascella/mandiboladabifosfonati.Raccomandazionen.10.
Montefusco,V.,Gay,F.,etal.(2008):Antibioticprophylaxisbeforedentalproceduresmayreducetheincidenceofosteonecrosisofthejawinpatientswithmultiplemyelomatreatedwithbisphosphonates.LeukLymphoma49(11):2156-2162.
Ozmeric,N. (2002): Localizedalveolarbonenecrosis following theuseofanarsenicalpaste:acasereport.IntEndodJ35(3):295-299.
Pemberton,M.N.(2010):Osteonecrosisofthejaw.Noteondentalprocedures.BMJ340:c1317.
Persson, G. R., Alves,M. E., et al. (1995): Amulticenter clinical trial of PerioGard indistinguishing between diseased and healthy periodontal sites. (I). Study design,methodologyandtherapeuticoutcome.JClinPeriodontol22(10):794-803.
102
Persson,G.R.,Matuliene,G.,etal.(2003):Influenceofinterleukin-1genepolymorphismon the outcome of supportive periodontal therapy explored by a multi-factorialperiodontalriskassessmentmodel(PRA).OralHealthPrevDent1(1):17-27.
Regev, E., Lustmann, J., et al. (2008): Atraumatic teeth extraction in bisphosphonate-treatedpatients.JOralMaxillofacSurg66(6):1157-1161.
Renvert,S.andPersson,G.R.(2004):Supportiveperiodontaltherapy.Periodontol200036:179-195.
Ripamonti,C.I.,Maniezzo,M.,etal.(2009):Decreasedoccurrenceofosteonecrosisofthejawafterimplementationofdentalpreventivemeasuresinsolidtumourpatientswithbonemetastasestreatedwithbisphosphonates.TheexperienceoftheNationalCancerInstituteofMilan.AnnOncol20(1):137-145.
Ruggiero,S.,Gralow,J.,etal.(2006):Practicalguidelinesfortheprevention,diagnosis,andtreatmentofosteonecrosisofthejawinpatientswithcancer.JOncolPract2(1):7-14.
Ruggiero,S.L.,Dodson,T.B.,etal.(2009):AmericanAssociationofOralandMaxillofacialSurgeonspositionpaperonbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws--2009update.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):2-12.
Ruggiero,S.L.,Mehrotra,B.,etal.(2004):Osteonecrosisofthejawsassociatedwiththeuseofbisphosphonates:areviewof63cases.JOralMaxillofacSurg62(5):527-534.
Saia,G.,Blandamura,S.,etal.(2010):Occurrenceofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawaftersurgicaltoothextraction.JOralMaxillofacSurg68(4):797-804.
Sarathy,A.P.,Bourgeois,S.L.Jr.,etal.(2005):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawsandendodontictreatment:twocasereports.JEndod31(10):759-763.
Savoldelli, C., Le Page, F., et al. (2007): [Maxillar osteonecrosis associated withbisphosphonate treatment and dental implants.]. Rev Stomatol Chir Maxillofac 108(6):555-8.
Scoletta,M., Arduino, P. G., et al. (2011): Initial experience on the outcome of teethextractions in intravenous bisphosphonate-treated patients: a cautionary report.69(2):456-462.
Scully,C.,Kumar,N.,etal.(2010):Hottopicsinspecialcaredentistry:9.Bisphosphonates.DentUpdate37(1):63.
Soileau, K.M. (2006):Oral post-surgical complications following theadministrationofbisphosphonates given for osteopenia related tomalignancy. J Periodontol 77(4):738-743.
Teja, Z., Persson, R., et al. (1992): Periodontal status of teeth adjacent to nongraftedunilateralalveolarclefts.CleftPalateCraniofacJ29(4):357-362.
Tezal,M.,Wactawski-Wende,J.,etal.(2005):Periodontaldiseaseandtheincidenceoftoothlossinpostmenopausalwomen.JPeriodontol76(7):1123-1128.
Vescovi,P.andNammour,S.(2010):Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisoftheJaw(BRONJ)therapy.Acriticalreview.MinervaStomatol59(4):181-203,204-213.
103
Walters, J. D. and Rawal, S. Y. (2007): Severe periodontal damage by an ultrasonicendodonticdevice:acasereport.DentTraumatol23(2):123-127.
Wang,H.L.,Weber,D.,etal.(2007):Effectoflong-termoralbisphosphonatesonimplantwoundhealing:literaturereviewandacasereport.JPeriodontol78(3):584-594.
Woo,S.B.,Hellstein,J.W.,etal.(2006):Narrative[corrected]review:bisphosphonatesandosteonecrosisofthejaws.AnnInternMed144(10):753-761.
Yoneda,T.,Hagino,H.,etal. (2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisof the jaw:positionpaperfromtheAlliedTaskForceCommitteeofJapaneseSocietyforBoneandMineralResearch,JapanOsteoporosisSociety,JapaneseSocietyofPeriodontology,JapaneseSocietyforOralandMaxillofacialRadiology,andJapaneseSocietyofOralandMaxillofacialSurgeons.JBoneMinerMetab28(4):365-383.
Zahrowski,J.J.(2007):Bisphosphonatetreatment:anorthodonticconcerncallingforaproactiveapproach.AmJOrthodDentofacialOrthop131(3):311-320.
Zahrowski,J.J.(2009):Optimizingorthodontictreatmentinpatientstakingbisphosphonatesforosteoporosis.AmJOrthodDentofacialOrthop135(3):361-374.
Zaoui,F.(2009):[Lightforcesandorthodonticdisplacement:acriticalreview].IntOrthod7(1):3-13.
104
Appendice 2. Percorsi terapeutici raccomandabili prima e dopo l’inizio del trattamento con NBP in caso di malattia oncologica
105
Appendice 3. Percorsi terapeutici raccomandabili prima e dopo l’inizio del trattamento con NBP in caso di malattia osteometabolica
107
Introduzione
AdoggiesistononumerosiprotocolliditrattamentodellaBRONJpubblicatieadottatidadiversesocietàscientifiche,tutticomunquebasatisull’esperienzaclinicamaturataneiprimicinqueannidallascopertadellamalattia(AAOMS2007;Khosla,Burretal.2007;Khan,Sandoretal.2008;Ruggiero,Dodsonetal.2009;Tubiana-Hulin,Spielmannetal.2009;Yoneda,Haginoetal.2010).Inlineagenerale,duesonogliapproccipossibilineltrattamentodellaBRONJ:unoconservativo,basatosull’utilizzodifarmaciperilcontrollodell’infezioneedeldolore,lacuifinalitàprincipaleèdistabilizzareilquadroclinicoimpe-dendolaprogressionedimalattia.Essoèstatoilprimopropostoeancoraoggiilpiùseguito,prevedeunusomoltolimitatodellachirurgia,dariservaresoloalleformerefrattarieedavanzatediBRONJ.Ilsecondoapproccio,piùrecente,èinveceorientatoallachirurgia,sempreinassociazioneaterapiemediche,anchee soprattuttonelle fasi inizialidimalattia,con l’intentoprincipalediarrestare laprogressionedimalattia ilpiùprecocementeedefficacementepossibile.Daunarevisioneapprofonditadellaletteraturasinoal2010(Kuhl,Walteretal.2012)sievincecheunatteggiamentoconservativopuòportareallariso-luzionedelproblemasoloneglistadiinizialidiBRONJ(stadioIsecondoAA-OMS),mentresarebbescarsamenteefficaceneglistadipiùavanzatidimalat-tia.Lachirurgiasembrerebbeinlineageneralepiùefficaceneglistadiavanzati(Greenberg2004;Migliorati2005;Badros,Weikeletal.2006;Woo,Hellsteinetal.2006;Mucke,Haarmannetal.2009;Ruggiero,Dodsonetal.2009),masolonegliultimiannisiètenutapositivamenteinconsiderazioneanchene-glistadiinizialidiBRONJ(CarlsonandBasile2009;Stockmann,Vairaktarisetal.2010;Williamson2010;Wilde,Heufelderetal.2011;Graziani,Vescoviet
CAPITOLO III
TRATTAMENTO DELLA BRONJ(redatto in collaborazione con Antonio Lo Casto-UNIPA, Claudio Marchetti-UNIBO, Giorgia Saia-UNIPD, Stefano Valsecchi-Osp. S.Anna Como, Paolo Vescovi-UNIPR)
108
al.2012;Kuhl,Walteretal.2012;Vescovi,Manfredietal.2012;Voss,JoshiOsheroetal.2012).Ancheinconsiderazionediun’accresciutaconoscenzadelproblemaBRONJ,èipotizzabilechelachirurgiainassociazioneallaterapiaconservativapossadi-ventarenelfuturolaprincipalestrategiaterapeuticaperlacuradellaBRONJ.LapresenteCommissionesiproponedidescrivereinquestocapitololeprin-cipaliopzioniterapeuticheconosciute,medicheechirurgiche,edidefinirnel’ambitodiutilizzo,inbasealleevidenzedellaletteratura.Saràinoltrepropo-stounnuovoprotocolloditrattamentodellaBRONJ,basatosullastadiazioneclinico-radiologicaSICMF-SIPMOpresentata inquestodocumento (vediTa-bella5).
Terapia medica
Terapia antisettica
L’usodi collutori a basedi clorexidina (e.g. 0.12% soluzionenon alcoolica,0.2%soluzionealcoolica)èlargamenteconsigliatoperladisinfezionedelcavooraleinpresenzadisoluzionidicontinuodellamucosaorale,sianoessecon-seguentiatraumatismospontaneooaprocedureodontoiatriche-chirurgicheinvasive.L’usodeicollutoriabasediclorexidinainodontoiatriaèsolitamentelimitatoallafasediguarigionedelleferite(2-3settimane),penalapossibileprogressivacomparsadieffettisecondariqualipigmentazionidellemucoseedisgeusia,masoprattuttoperlapossibileinsorgenzadiresistenzebatteriche.L’utilizzo continuato e prolungato dei collutori a base di clorexidina vieneconsigliatoancoraoggi in letteraturacomeadiuvanteneltrattamentodellaBRONJ (vedi Tabella9) (AAOMS2007;Khosla,Burret al. 2007;Khan, San-doretal.2008;Ruggiero,Dodsonetal.2009;Tubiana-Hulin,Spielmannetal.2009;Yoneda,Haginoetal.2010)poichélamalattiahaandamentocronico,caratterizzatodall’alternarsidiperiodidi relativa stabilitàa fasidi recrude-scenzacondoloreesuppurazione.È opinione di questa Commissione che alla luce delle attuali conoscenze sia da preferire un utilizzo “transitorio” della clorexidina, limitatoallefasidiriacutiz-zazionediunasovrainfezioneonelperioperatoriodopointerventichirurgicipiùomenoinvasiviincavoorale.In questa situazione, è consigliabile l’utilizzo di clorexidina alcoolica allo 0.2%.
109
È altresì consigliabile l’istituzione di un protocollo antisettico di mantenimento con clorexidina 0.12% non alcoolica (2 sciacqui/die, 1 settimana/mese) in sog-getti affetti da BRONJ che non possano essere sottoposti a protocolli terapeu-tici ad intento curativo per motivi di comorbidità o terapie antineoplastiche non differibili,sìdalimitarel’insorgenzadiresistenzebattericheeglieffettiindesideratidellaterapiacronicaconclorexidina.Inalternativaoinaggiuntaallaterapiaciclicaconclorexidina,puòfornireunbeneficioalpazientel’usodisciacquiconacquamiscelataabicarbonato(2cucchiaini/litro)(Khan,Sándoretal.2008)o,verosimilmente,anchel’usodialtridisinfettantioralisullacuispecificaefficacianonvisonoadoggidatidellaletteratura.
Terapia antibiotica
Laterapiaantibioticaèconsiderataunostrumentodigrandeutilitàneltratta-mentodellaBRONJ.Diversesonoleragionichemotivanol’usodegliantibiotici,in primisilfattochel’infezioneècomunqueunacondizionecheaccompagna,
Tabella 9. Indicazioni all’uso di collutori a base di clorexidina.
Clorexidina Concentrazione DurataStadio
AAOMSMarxRE,etal.JOralMaxillofacSurg2007(AAOMSPP*)
si ns# indefinita 1,2,3
KoslaS,etal.JBoneMinerRes2007(ASBMRPP*)
si 0.12 ns# ns#
KhanAA,etal.JRheumatol2008(CanadianPP*)
ns# ns# ns# 2
RuggieroSL,etal.JOralMaxillofacSurg2009(AAOMSPP*)
si 0.12% indefinita 1,2,3
Tubiana-HulinM,etal.CritRevOncolHematol2009(FrenchPP*)
si 0.12% ns# 1,2,3
YonedaT,etal.JBoneMinerMetab2010(JapanesePP*)
ns# ns# ns# 2
PP*:positionpaperns#:nonspecificata
110
senondetermina,lemanifestazioniclinichedellamalattia,equindilaterapiaantibioticarivesteunruolodecisivonellagestionedeisintomicorrelati.Duesonoleprincipaliipotesipatogeneticheaccreditatesulruolopotenzialedellacolonizzazionebattericanell’origineenellaprogressionedellaBRONJ:1) l’infezione come evento iniziale (primario) nelmeccanismo patogeneti-co(Aspenberg2006;Hansen,Kunkeletal.2006;Sedghizadeh,Kumaretal.2008;Kos,Luczak2009;Lesclous,AbiNajmetal.2009;Reid2009;Sedghiza-deh,Kumaretal.2009;Kumar,Goruretal.2010;Aghaloo,Kangetal.2011;Abtahi,Agholmeetal.2012;Wei,Pushalkaretal.2012);2)l’infezionecomeevento secondario all’instaurarsi dell’osteonecrosi (Marx, Sawatari et al.2005;Migliorati,Schubertetal.2005;AAOMS2007;RuggieroandMehrotra2009;Ruggiero,Dodsonetal.2009;Otto,Hafneretal.2010;MarxandTursun2012).Nellaprimaipotesi,ilprocessopatologicosarebbeassimilabileadun’osteo-mieliteconunaspiccatatendenzaallacronicizzazione,legataalmenoinparteall’inibizionedeiprocessiriparativiossei(Allen,Kubeketal.2011)edell’attivi-tàcellularenonossea(Landesberg,Cozinetal.2008;Kobayashi,Hiragaetal.2010;Cornish,Bavaetal.2011;Ravosa,Ningetal.2011)indottidalfarmaco.Inparticolare, l’interruzionedell’integritàmucosadellegengivecausatadafattoritraumaticilocalideterminerebbeilpassaggiodigermiresidentiincavooraleall’internodellastrutturaossea,lacuiattivitàriparativaèampiamentecompromessadall’azionediNBP.Afavorediquestateoriailfattochel’ossoincorsoditerapiaconNBPsembrerebbedaunpuntodivistaistologicodeltuttoparagonabileaquellodisoggettidellastessaetànonintrattamentoconNBP(Bedogni,Blandamuraetal.2008;Totola,Bettinietal.2010).LarecentescopertadiuneffettoinibitorioesercitatodagliNBPsullecelluledeltarespon-sabilidellarispostaimmunitariadell’ossososterrebbequestateoria(Roelofs,Jauhiainenetal.2009).Lasecondaipotesiconsiderainvecel’infezionecomeuneventosecondario,cioè successivo alla formazionedi ossonecrotico e alla sua esposizione incavoorale.Inparticolare,l’effettoinibitoriodelbisfosfonatosulrimaneggia-mentoosseocauserebbe l’accumulodi tessutoosseononvitalealdi sottodellegengive,apparentementeintegre,consuccessivaesposizioneesuperin-fezione.Recentementequestateoriaèstatamessaindiscussione,inseguitoall’identificazionediunnumeroelevatodisoggettichepresentavanosegniclinicieradiologicidiinfezionedelleossamascellariinassenzadiossoespo-stoincavoorale,oggiinclusinellostadio0secondoAAOMS(Colella,Campisi
111
etal.2009;Ruggiero,Dodsonetal.2009;Fedele,Porteretal.2010;Bedogni,Fuscoetal.2012).Vacomunqueconsideratochel’osteonecrosiingeneraleèunprocessoisto-patologicocheiniziaalivellomicroscopico,percuil’assenzadiossoespostoincavooralenonsignificanecessariamenteassenzadialterazioniistologichedell’osso in sensonecrotico;un’osteonecrosi in fasemolto iniziale,quandoancoranonidentificabiledaunpuntodivistaclinicoeradiologico,potrebbeaveregiàcausatounaridottaresistenzameccanicaestrutturaledell’ossoalleinfezioni,incasodiinterruzionedellabarrieramuco-gengivale(Hansen,Kir-kpatricketal.2006;Hansen,Kunkeletal.2006).Inassenzadiconoscenzesufficientisulruolodell’infezionenellapatogenesidellaBRONJnonèchiaroselaterapiaantibioticapossaavereancheunruoloprimarioo“eziologico”nellacuradell’osteonecrosi.GliantibioticiutilizzatinellaterapiadellaBRONJsononumerosi(i.e.penicilli-ne,cefalosporine,metronidazolo,chinolonici,clindamicinaelincomicina,ci-profloxacina,doxiciclina,eritromicina,spiromicina);purtuttavia,nonesisto-noadoggiprovediefficaciaperspecifichemolecole,ancheinassociazionetraloro,nelcontrollodellacomponenteinfettivadellaBRONJedeisintomiadessacorrelati.Lapressochécompletaassenzadistudisperimentalirandomizzaticontrollati(RCT)sultrattamentoantibioticoneipazientiaffettidaBRONJnonpermettedidefinireconsicurezzal’efficaciadellesingolemolecoleneltrattamentodiquestamalattia.Nonostantediversistudiabbianodescrittol’usodiantibioticipiùomenopro-lungatoneltrattamentodellaBRONJ,essivengonosempreassociatiadaltriinterventimediciochirurgici,percuièimpossibileestrapolareinformazionisullarealeefficaciadellestessemolecole(i.e.utilizzodiposologiediverse,inpopolazionieterogenee,instadidimalattiadiversiedinassenzadigruppidicontrollo)(Khan,Sandoretal.2008;Bedogni,Saiaetal.2011;HoefertandEufinger2011;Moretti,Pelliccionietal.2011).Pertanto,laterapiaantibioticadellaBRONJèoggibasatapiùsull’esperienzaclinicachenonsull’evidenza,siaperquantoriguardalemolecoledautilizza-re,chelaviadisomministrazione(i.e.peros,e.v.,i.m.,topica)elaschedaditrattamento.Unapproccioterapeuticoindividualizzatopotrebberappresentareunasolu-zioneperilfuturo,ogginonancorapercorribileperlenotedifficoltàtecnichenell’isolamentodigermipatogenidacampioniditessutoosseoattraversole
112
convenzionaliproceduremicrobiologiche(NaikandRusso2009)eperlacon-troindicazioneabiopsieosseeneipazientiaffettidaBRONJ(Ruggiero,Fanta-siaetal.2006;Campisi,DiFedeetal.2007).Questa Commissione riconosce alla terapia antibiotica un ruolo importante nel trattamento dell’infezione e della componente algica ad essa correlato, pur tenendo conto delle limitate conoscenze dell’efficacia delle singole mole-cole.Partendodalprincipiodell’esperienzaclinica,è opinione di questa Commissio-ne che in linea generale l’uso degli antibiotici debba essere sempre associato ad altri trattamenti, quando l’obiettivo terapeutico sia la risoluzione comple-ta della BRONJ.Èriconosciuta,infatti,larefrattarietàdellemalattieinfettivedell’ossoadandamentocronico,quandogestitesoloconantibioticoterapia(LewandWaldvogel2004). L’utilizzodell’antibioticocomeprincipaleouni-co presidio terapeuticodovrebbe essere limitato alla gestionedelle fasi diriacutizzazionedelprocessoinfettivotipichedellamalattiaeneipazientide-fedatiincuinonsiapossibileuntrattamentopiùaggressivo.LacomponenteinfettivadeldoloreinsoggettiaffettidaBRONJrispondebenealtrattamentoantibioticonellefasiinizialidimalattia,matendeconiltempoaperderediefficacia(Hoff,Tothetal.2008;Williamson2010).È opinione di questa Commissione che l’antibiotico debba essere prescritto, in assenza di evidenza clinica di suppurazione, solo in caso di dolore franco, al fine di evitare farmaco-resistenze; a tal proposito, l’uso di scale di misura-zione del dolore (e.g. Visual analogue scale 0-10) renderebbe più razionale lo schema di somministrazione della terapia antibiotica. Inoltre, la terapia anti-biotica, a dosaggio pieno, dovrebbe avere una durata non superiore ai 10-14 giorni, ripetibile nel tempo.L’associazione antibiotica è da prediligere ogni qualvolta possibile, allo scopo di aumentare lo spettro di efficacia riducendo le complicanze farmaco-corre-late; la via di somministrazione consigliabile è quella per os, limitando la via parenterale alle forme più gravi o in concomitanza di trattamenti chirurgici invasivi (vediCapitoloIII,Paragrafo“Terapiachirurgica”).L’utilizzodiantibioticiperusotopico,seppurdescrittoinletteratura(Ruggiero,Dodsonetal.2009;VescoviandNammour2010),nonhaadoggidimostratoalcunvantaggiorispettoaiprotocollinormalmenteutilizzatineltrattamentodellaBRONJ.Questa Commissione,presoattodell’eterogeneitàdeiprotocolliproposti inletteraturaetenutocontodell’esperienzaclinica,ha identificato uno schema
113
generale di utilizzo degli antibiotici (vediAppendice4“ProtocolloTerapeuti-co”), basato sui seguenti principi:
utilizzo di associazioni antibiotiche di penicillineo (attivecontroGram-negativieGram-positiviβ-lattamasiresistenti) e metronidazolo (atti-vocontroanaerobi,particolarmenteBacteroides spp.ecocchigram-positivi),comeprimascelta;durata della terapia da un minimo di 7 ad un massimo di 14 giorni, a o dosaggio pieno;via di somministrazione per os nel paziente non ospedalizzato; prefe-o ribile somministrazione e.v. in caso di ospedalizzazione per complican-ze infettive o interventi chirurgici associati;molecole alternative (i.e. eritromicina, clindamicina o ciprofloxacina) o da utilizzarsi in caso di allergie a penicilline/cefalosporine, di compro-vata inefficacia del trattamento standard, di disturbi legati all’assun-zione o di problemi di funzionalità renale.
Terapia antidolorifica
IldoloreèunsintomodifrequenteriscontroneipazienticonBRONJ(Miksad,Laietal.2011).Ildolore,sullacuinaturasonostateavanzatediverseipotesi(i.e.doloreneuropatico, infettivo, infiammatorioomiogeno) (BouquotandMcMahon2000;Ruggiero,Fantasiaetal.2006;Greenberg2008),èconside-ratounfattoreaggravantelastoriaclinicadellamalattia,perchéspessomalcontrollatoeintalunicasirefrattarioallaterapiamedica.Perquestomotivoilsintomodoloreèconsideratoelementodiscriminantedall’AOOMS(Ruggiero,Dodsonetal.2009),inpresenzadiossoespostoincavoorale,perdefinireilpassaggioadunostadiodimalattiapiùavanzato.AnchelapresenteCommis-sioneSICMF-SIPMO,stabilitocheaogginonesistealcunaevidenzasecondocuilapresenzaolacomparsadidoloreinunsoggettoaffettodaBRONJsias-sociadunquadroavanzatodimalattia,ritieneopportunoutilizzareilsintomodoloreperdistinguerecondizioniclinichemanell’ambitodellostessostadio,piuttostocheperdefinirestadidiversidimalattia(vediCapitoloI,Paragrafo“StadiazionedellaBRONJ”). Ildolore,quandopresenteècertamente ilsin-tomochepiùaffliggeilpazienteaffettodaBRONJ;essoèspessodielevataintensità,anchenotturno,edarrivaalimitareinmodosignificativolavitadirelazionedelpaziente(MinisterodelLavorodellaSaluteedellePoliticheso-
114
ciali,settembre2010).Ildoloreègeneralmentepresenteinpazientiaffettidaneoplasiedisseminate,chegiàfannousodifarmacioppioidiperlagestionedeldolorescheletricometastatico,senzaperaltroottenereunbeneficiodiret-tosullasintomatologiadolorosaassociataallaBRONJ.IltrattamentodelsintomodoloreèunpuntocriticodellaterapiadellaBRONJ.Essendoildoloreunsintomocheinfluenzaspessolasceltadeitrattamentiola lorosuccessiva ripetizione, la Commissione consiglia che venga di prassi eseguita una misurazione soggettiva del dolore riferito mediante l’utilizzo di una scala analogica visiva graduata (Visual Analogue Scale-VAS), da sotto-porre al paziente al primo incontro e ad ogni successiva visita di controllo, per monitorare l’andamento della malattia e l’efficacia dei trattamenti,nonsolodalpuntodivistadell’operatore,maanchedelpaziente(Saia,Blandamuraetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011;Miksad,Laietal.2011).VistalanaturamultimodaledeldolorenellaBRONJ,èverosimilechesiane-cessariounapproccioterapeuticoparimentimultimodale,dovefarmacidi-versiagisconosucomponentiseparatedeldolore.Fattaeccezioneperlacomponentealgica“acuta”legataallariacutizzazionedelprocessoinfettivo,lacuigestioneècompetenzadell’Odontoiatra/Chirur-goorale-maxillo-faccialeattraversolaprescrizionediterapiespecifiche(vediparagrafi“Terapiaantisettica”e“Terapiaantibiotica”),lacomplessitàdelpro-blemaètaledarenderenecessarioilcoinvolgimentodialtrispecialisti.L’utilizzodiFANS,oppiodi,ketamina(Jackson,Ashbyetal.2011;Mercandan-te,Villarietal.2003),neuroletticioaltroperiltrattamentodeldolorecroniconeuropaticoinsoggetticonBRONJdovrebbeesseregestitointeramentedaspecialistiinterapiaantalgica,perevitarediincorrereinfenomenidiintossi-cazione(i.e.oppiodi)oridottaefficacianeltempo.In conclusione,è opinione di questa Commissione che la componente neu-ropatica del dolore cronico debba essere gestita da specialisti in terapia del dolore. Diversamente, la componente infettiva del dolore dovrebbe essere trattata dall’Odontoiatra/Chirurgo oro-maxillo-facciale che ha in carico il pa-ziente, applicando i protocolli esistenti (vedi paragrafo ”Terapia antibiotica”), riservandosi di riferire il paziente a specialisti di malattie infettive in situazioni complesse che richiedano terapia endovenosa e ospedalizzazione (e.g. forme di BRONJ refrattarie).
115
Biostimolazione
OzonoterapiaAncheseiltrattamentochirurgicocombinatoallaterapiaantibioticarientraneiprincipaliprotocolliterapeutici,lasuaefficacianonsembrasoddisfaretut-tiicasidiBRONJ.AlcuniAutoririportanochel’ausiliodisistemidibiostimo-lazionecomelaozonoterapiapuòmigliorarelarispostalocaledeifisiologicimeccanismiriparativiinpazientiaffettidaBRONJ(Agrillo,Petruccietal.2006;Agrillo,Ungarietal.2007;Ripamonti,Cislaghietal.2011).Lepiùimportanticaratteristichedell’ozonosono:
- ilpotereantimicrobico,controbatteriaerobieanaerobi,miceti,virus(Dayas,Boughtonetal.1983;Muller,Guggenheimetal.2007);
- lastimolazionedelsistemacircolatorio,conincrementodeltassodiemoglobinaedeiglobulirossiemiglioramentodell’ossigenazionetis-sutale(BocciandPaulesu1990);
- lamodulazionedicellule immunitarie,agendocomeunacitochina,conaumentodellafagocitosiediapedesideifagociti(Bocci1996);
- lariduzionedeldolore(Bocci2004).L’applicazionedell’ozonoterapianelleBRONJsiavvaledidiversipresidieme-todi.Èstatosomministratoozonotopicamentemediante insufflazioni ripe-tute(Agrillo,Ungarietal.2007)ocomeolioozonizzato(Ripamonti,Cislaghietal.2011),cosìcomeriportatoneilavorisinquipubblicati,cheipotizzanouneffettostimolante laneoangiogenesied ilsistemaimmunitario,confor-mazioneditessutodigranulazioneadelimitareleareediossonecrotico.Lasuccessivaespulsionedel sequestroosseo lascerebbespazioaduntessutoepitelialeinmaturazione,chepuòportareallacompletacoperturadell’ossovitalesottostante,senzalanecessitàdiulterioriinterventichirurgicidichiusu-radeitessuti(Agrillo,Ungarietal.2007;Ripamonti,Cislaghietal.2011).Altriautoriperaltrohannoosservatochel’eventosequestropuòavvenirecondiscretafrequenzaanchesenzal’utilizzodiozonoterapia(Filleul,Crompotetal.2010;Marangoni,Bettinietal.2011;Ferlito,Puzzoetal.2012). I futuristudidovrannoessererivoltiastabilireirealimeccanismid’azionedell’OzonosulleBRONJinmododacorrelaregliincoraggiantirisultaticliniciottenuticonl’ausiliodiquestosistemadibiostimolazione.È opinione di questa Commissione che, in attesa di una sua validazione defi-nitiva, l’ozonoterapia possa essere utilizzata come trattamento di supporto in particolari situazioni cliniche (impossibilità al trattamento chirurgico o rifiuto
116
dello stesso, in caso di incompleta/assente guarigione dopo applicazione dei protocolli standard) (Appendice 4 “Trattamenti”).
Laser-terapiaL’applicazionedilaserabassaintensità(LowLevelLaserTherapy–LLLT)èsta-tariportataconsuccessonellagestionedelleBRONJ.L’effettobiostimolantedinumeroselunghezzed’ondamiglioraiprocessiriparativi,aumentalama-triceosseainorganicael’indicemitoticodegliosteoblastinonchéstimolalacrescitadeivasisanguignielinfatici(Angiero,Sanninoetal.2009;Stubinger,Dissmannetal.2009;Scoletta,Arduinoetal.2010;Romeo,Galanakisetal.2011;Vescovi,Merigoetal.2012).Glieffettidell’applicazionedidifferentilunghezzed’ondalaserabassainten-sitàsultropismodellacuteodellamucosaesullastimolazionedelflussosan-guignosonostatidescrittidanumerosiAutoriequesteosservazionirappre-sentanounsupportoalpossibileimpiegodellabiostimolazionelaserneltrat-tamentodelleBRONJ.MoltistudirelativiallaguarigionedelleferitemucoseriferivanoglieffettidellaLLLTsullacrescitadeifibroblasti,sullalocomozioneesullaproduzionedicollagene(Posten,Wroneetal.2005).ÈstatoriportatoinoltrechelaLLLTmiglioralaguarigioneosseaneisititrau-matizzatiedaumentalamineralizzazioneduranteiprocessirigeneratividopoilposizionamentodiimpiantistimolandol’attivitàeladifferenziazionedegliosteoblasti(Guzzardella,Finietal.2002).MoltiautorihannoriportatounsuccessocliniconeltrattamentodelleBRONJmedianteLLLTpraticatacondiverselunghezzed’ondaedifferentiparametri:laserNd:YAG(1064nm),adiodi(GaAs-904nm),(GaAs-650,904-910nm)(Romeo,Galanakisetal.2011).Èriportataingeneraleunaconsistenteriduzionedeldolore,dell’edema,delledimensionidell’esposizioneossea,delpus,dellefistoleedell’alitosiedinuncertonumerodicasilaguarigionecompletadellemucoseadistanza(Scolet-ta,Arduinoetal.2010).Allalucedelleprecedenticonsiderazionilabiostimolazionelaser,praticabilecondiverse lunghezzed’onda,potrebberappresentarenelprossimofuturounaterapiadiausilioneltrattamentodelleforme“iniziali”diBRONJ,essendounatecnicasicura,scarsamenteinvasiva,ebentollerata(Vescovi,Merigoetal.2006).Èquindiconsigliabilequandosirendaopportunountrattamentononinva-sivodellelesioniosseesiainpazientioncologicichenon(Vescovi,Merigoetal.2008).
117
È opinione di questa Commissione che, in attesa di una sua validazione de-finitiva, la biostimolazione laser possa essere utilizzata come trattamento di supporto in determinate situazioni cliniche (i.e. impossibilità al trattamento chirurgico o rifiuto dello stesso o per pochi o nessun risultato da protocolli standard) (vediAppendice4“ProtocolloTerapeutico”).
Teriparatide
Ilteriparatide[recombinanthumanPTH-(1-34)],molecoladerivatadalpara-tormone,èutilizzatoneltrattamentodellaosteoporosiseveradaormaiunadecinadianni(Neer,Arnaudetal.2001).Ilsuomeccanismod’azioneconsistenellastimolazionedellaproduzioneosseadapartedegliosteoblasti.Haquin-diuneffettoanabolicodirettosull’osso,aumentandolamassaelaresistenzadell’ossostesso,diversamentedaibisfosfonatichecontrastanolaperditadimassaosseabloccandoilrimaneggiamentoosteoclasto-mediato(Bashutski,Eberetal.2010;Gray2010).Èoggi ipotizzatoche l’utilizzodel teriparatide incondizionipatologichedeimascellariassociateadalterazionidelmetabolismoosseopossaprodurreef-fettibeneficisiainterminidiriduzioneorisoluzionedellaperditaossea,siadicontrollodeisegniclinicidimalattia.Aconfermadiciò,recentementeèstatodimostratocheilteriparatidemiglioral’efficaciadellachirurgiadento-alveola-renellaparadentitesevera,rispettoalplacebo(Bashutski,Eberetal.2010).Inoltre,unpossibilespazioterapeuticoperilteriparatideèstatoipotizzatosumodelloanimaleneltrattamentodellefratturemandibolari (Rowshan,Par-hametal.2010).Alcunesegnalazioniinletteraturariportanorisultatipositiviancheneltratta-mentodellaBRONJrefrattariaallaterapiaantibioticaedantisetticacomune-menteutilizzata,conunnettomiglioramentodelquadroclinicoeradiograficodopoterapiaconteriparatide(HarperandFung2007;LauandAdachi2009;CheungandSeeman2010;Narongroeknawin,Danilaetal.2010;Tsai,Huangetal.2010;Lee,Chengetal.2011).Al contrario,è recente la segnalazionedelmancatoeffetto terapeuticodelteriparatide inuncasodiBRONJ inpazienteosteoporoticodopo8mesiditrattamento(Narvaez,Narvaezetal.2012).L’usodelteriparatidealmomentoèsconsigliatoneipazientioncologiciconmetastasiosseeperilrischiodipeggiorareoindurrelanuovaformazionedimetastasi(Gray2010);pertanto,ilteriparatidepotrebbetrovareindicazione
118
nel trattamentodellaBRONJ solo inpazientinon-oncologici. Vista l’attualeinferioreincidenzadiBRONJstimatainsoggettinononcologiciintrattamentoconNBP,lacostruzioneditrialscliniciperlostudiodell’efficaciadelteripara-tideècertamenteadoggipocopraticabile.Siprecisachelaterapiaconteriparatidenonpuòessereprotrattaoltreidueanni per il rischio di indurre la crescita di osteosarcomi (Vahle, Sato et al.2002).Inconclusione,nonostanteglieffettipositivistudiatisulleossamascellariingenereelesegnalazionidiefficacianellaBRONJ,ilteriparatidenonrappre-sentaoggiunaopzionecertaeriproducibileperiltrattamentodellaBRONJ.EsistecomunquelanecessitànelprossimofuturodiimplementarelaricercasuimodellipatogeneticisperimentalidellaBRONJperverificareunsuopossi-bilefuturoruolo(Subramanian,Cohenetal.2011).È opinione di questa Commissione che la scelta di utilizzare teriparatide per il trattamento della BRONJ in pazienti non oncologici deve essere valutata caso per caso, l’eventuale indicazione deve essere condivisa con l’esperto in osteo-porosi o lo specialista in Medicina Interna, e l’inizio della terapia è subordina-ta alla certificata consapevolezza da parte del paziente circa l’assenza di una indicazione ministeriale specifica al suo utilizzo per la BRONJ (acquisizione del consenso a terapia off-label).
Sospensione del farmaco NBP
Lasospensionedella terapiaconNBP inseguitoalladiagnosidiBRONJ,di-versadalladrugholidayprofilattica(vediCapitoloII,Paragrafo“Lagestioneodontoiatricadelpazientecheassumeràoassumeaminobisfosfonati”)èunasituazionedifrequenteriscontro,purnonadeguatamentestudiataneglief-fetti.Nonesistealmomentoun’opinionecondivisainmeritoallasospensionete-rapeuticadiNBP,esistendoduelineeoppostedipensiero.Inparticolare,unapartedellacomunitàscientificaritieneche lasospensioneprolungatadellaterapiaconNBP,ancorchéresapossibiledallarelativastabilitàdellamalattiadibase,possadeterminareunvantaggionellagestionedeisintomicorrela-tiallaBRONJenellastabilizzazionedelprocessoosteonecrotico(Magopou-los,Karakinarisetal.2007;CremersandFarooki2011).AnchealcuneSocietàMedico-ScientifichehannoapertamenteconsigliatolasospensionediNBPin
119
caso di insorgenza di BRONJ, subordinando la ripresa dello stesso ai primisegnidiprogressionedellamalattiadibase(Terpos,Sezeretal.2009).Pur-troppoadogginonesistonostudidiefficaciachesupportinolasospensionedelfarmaco.Alcontrario,unapartepiùcospicuadellacomunitàscientificaritienechelasospensionediNBP,farmacochevieneassuntoperdiversianni(almenosinoadoggi)conunconsiderevoleeffettodiaccumulonelleossa,nonpossamodi-ficareinmodosignificativolostatoclinicodellaBRONJ(Marx,Cilloetal.2007;VandenWyngaert2009;Wilde2011).Glieffettiinibitorisulrimodellamentoosseoindottidalfarmacosarebberoresidurevolidalfattocheilfarmacosiaccumulainformanonattivanelleossaetalepuòrimanerefinoachelasededi accumulo non venga coinvolta in un processo di rimodellamento osseoanomalo (e.g.metastasi ossea, fratture da osteoporosi, traumi) (Migliorati2005;RuggieroandWoo2008;Otto,Hafneretal.2010).Aquestosiaggiungal’elevataemivitadegliNBP(Ebetino,Hoganetal.2011)e,così,lasospensionedibreveduratapotrebbenonaverealcuneffettopositivo,privandoinoltreilsoggettodeglieffettibeneficidell’NBPsullamalattiaoncologicaodismetabo-licapercuieraindicatoiltrattamento(Ruggiero,Dodsonetal.2009;Migliora-ti,Epsteinetal.2011;Brozoski,Trainaetal.2012;Holzinger2012).Questioneaparterivestelasospensionetemporaneadelfarmacoinconco-mitanzaditerapiechirurgicheperiltrattamentodellaBRONJ(vediCapitoloIII,Paragrafo“Terapiachirurgica”).È parere di questa Commissione che in presenza di BRONJ la sospensione della terapia con NBP rappresenti un atto medico con potenziali ricadute sulla salu-te del paziente, e che quindi debba essere decisa dallo specialista prescrittore del farmaco, in accordo con l’odontoiatra/chirurgo oro-maxillo-facciale.
Ossigenoterapia iperbarica
L’ossigenoterapiaiperbarica(OTI)èunaterapiaincruenta,attuatamedianterespirazionediO2puroapressionesuperioreaquellaambientale,incamereiperbarichepressurizzateadaria.llprincipiofondamentaledell’ossigenotera-piaiperbaricaconsistenell’incrementarelaquotadiO2discioltonelplasmaepermetterneladiffusioneneivariliquidietessuti.AcausadelraggiungimentodiPpO2sovrafisiologicheinregimeiperbaricol’OTIagiscecomeunfarmaco.Ilperiododi iperossialimitatoallasedutaiperbaricainnescaunacascatadieventi,checontinuanotralevariesedute(HopfandHolm2008).
120
L’OTIèunaproceduraterapeuticavoltaadassicurareilripristinodicondizioninormossicheneitessutiche,percausepatogenetichelepiùsvariate,vadanoincontroadunostatodisofferenzapercarenzadiossigeno.Traglieffettipositividell’OTIdimostratisui tessutiumani,di interessespe-cifico sono il più rapidoedefficace controllo delle infezioni, l’aumentodelpotenzialedi cicatrizzazionedelle ferite (replicazionedeifibroblastiedelladeposizionedicollagene, lostimoloall’epitelizzazione), lostimoloallaneo-vascolarizzazionedeitessuti, lapiùrapidademarcazionedeltessutonecro-ticodaquelloischemicomarecuperabile,lariduzionedell’infiammazioneedell’edematessutalee,nonultimo,lostimoloosteogenetico(mediatodallamobilizzazionedellecellulestaminaliendotelialidalmidolloosseoedallain-duzionedifattoridicrescitaedeirecettoriperifattoridicrescita).Pertuttiquestimotivi,l’OTIhatrovatoampiaapplicazioneancheneltratta-mentodelleinfezionicronichedelleossamascellari,qualiosteoradionecrosieosteomieliti(Epstein,vanderMeijetal.1997;Feldmeier2004).L’ideadell’utilizzomedicodell’OTIneltrattamentodellaBRONJnascesubitodopo la segnalazionedeiprimicasidiBRONJ, tra il2003ed il2006,quan-dosiipotizzòchelanecrosiosseadeimascellaridipendesseinlargamisuradall’ischemiaindottadalfarmaco.LaBRONJalloravennedefinitacomeunaformadi necrosi avascolare dell’osso causata dall’effetto antiangiogeneticodelfarmaco,insomiglianzaallaosteonecrosipost-attinica(Dimitrakopoulos,Magopoulosetal.2006).Inrealtà, lapatogenesie imeccanismibiologiciattraversocuigliNBPsonoresponsabilidellacompromissionedelrimodellamentoosseoedell’angioge-nesinelleossamascellaririmangonotuttoraincertiequindidifficilmentecon-frontabili conquellipiùdelineatidell’osteoradionecrosiedelleosteomieliticronicherefrattarie(RuggieroandDrew2007).Lamaggiorpartedeidatiattualmentedisponibilisull’utilitàdell’OTIneltrat-tamentodellaBRONJderivadaserieclinichedipazienti(Freiberger,Padilla-Burgosetal.2007;Magopoulos,Karakinarisetal.2007;Kumar,Meruetal.2008;Yamazaki,Kitagawaetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011).Sedaunlatolapressioned’infusionedell’ossigenoutilizzatainquesteserieclinicheèsimiletraidiversiprotocolli(2-3ATA),ilnumeroeladuratadellese-dutedescrittevariarispettivamenteda10a40eda60a120minuticiascuna.L’ossigeno-terapia è stata utilizzata in sicurezza anche in soggettiaffettidamalattiaoncologicametastatica,inquantononèstatodimostratonegliannialcuneffettofavorentelaprogressionedeltumoreolosviluppodinuoveme-tastasi(Feldmeier,Carletal.2003).
121
Nellaquasitotalitàdeicasiriportatil’OTIèinoltreassociataaduntrattamen-to chirurgico, ad una terapia antibiotica e, quasi sempre, alla sospensionedell’assunzionedelNBP(Freiberger2009;Chiu,Chiangetal.2010;Bedogni,Saiaetal.2011).Ciòharesoinpraticaimpossibileidentificareunivocamenteipossibilieffettipositividell’OTIsull’osteonecrosiinconfrontoaglialtritrat-tamenticoncomitanti.IrisultatipositiviraggiuntinelcontrollodellaBRONJedescrittidadiversiprotocollicheutilizzanoOTIdevonopertantoessereintesicomeeffettodelprotocollonelsuocomplesso.Percercareunapiùchiaradefinizionedelruolodell’OTIneltrattamentodel-la BRONJ, da alcuni anni è in corso uno studio randomizzato controllato, icuirisultatidefinitivisu46pazientisonostatipubblicatidapochesettimane(Freiberger,Padilla-Burgosetal.2012). Inquesto studio l’OTIeraassociataallachirurgiaconservativaedallaantibioticoterapiacomedaprotocolloAA-OMS(AAOMS2007).NelgruppodipazientisottopostiancheadOTIèstatoregistratounmiglioramentodellasintomatologianeltempo,mailcampioneèrisultatoampiamenteinsufficientepertrarreconclusionidefinitive.Diversamente,dairisultatidiunostudioosservazionalecondottosuduecortiprospettichedipazientiaffettidaBRONJ,èemersocheassociareunciclodiOTI(30sedute)all’antibioticoterapiaedallaconcomitantesospensionedelfarmacononproduceunmiglioramentosignificativodellasintomatologiaenon arresta la progressione dell’osteonecrosi radiologicamentemonitorataadunannodifollow-up.L’OTIinoltrenonmigliorerebbeilcontrollodeldo-lore,esercitandosolounmodestoeffettosuglieventidiriacutizzazionedelprocessopatologiconelbrevetermine(Marangoni,Bettinietal.2011).Inmancanzadirisultaticonclusivinonèpossibilealmomentoparlaredieffi-caciadell’OTInellacuradellaBRONJ,ancheinconsiderazionedelfattocheiltrattamentoiperbaricononsiconfigurerebbeinunaterapiaeziopatogeneticadellaBRONJ.È opinione di questa Commissione che l’ossigenoterapia iperbarica debba es-sere intesa ad oggi come un trattamento sintomatico e quindi dovrebbe esse-re offerto ai pazienti, dopo attenta valutazione dei vantaggi e degli svantaggi legati ad una terapia alquanto impegnativa per il soggetto coinvolto, solo in associazione ad altri trattamenti che offrono maggiori garanzie di controllo della malattia (i.e. antibiotico-terapia e chirurgia).
122
Terapia chirurgica
Considerazioni generali
L’approcciochirurgicoallaBRONJèunodegliargomentipiùdibattutiinlet-teratura.Molteplicisonolemotivazioniportateafavoreoasfavoredell’in-terventochirurgico,maancorpiùsono ledifferenzediopinionesultipodiinterventodautilizzareequando.Ilpuntodiriferimentointernazionaleperladefinizione,ladiagnosieiltrattamentodellaBRONJèstatosinoadoggilapo-sizioneufficialedell’AmericanAssociationofOral&MaxillofacialSurgery(AA-OMS)conisuoirelatividocumenti(2007-2009),incuiitrattamentisonostaticollocatiinbaseadunastadiazioneclinicadellamalattia.Per l’AAOMS,pertutteleSocietàesingoleIstituzionichehannocomplessivamenteaderitoaiprincipiespressineipositionpapersdel2007edel2009(AAOMS2007;Rug-giero,Dodsonetal.2009),lachirurgiahaunruoloassolutamentemarginaleo“palliativo”nellaterapiadellaBRONJ,perl’impossibilitàdiottenereunagua-rigionecompleta(Cheng,Mavrokokkietal.2005;Tubiana-Hulin,Spielmannetal.2009;PatelS,ChoyeeSetal2012;McLeod,Brennanetal.2012).Questa impostazione si baserebbe su due principi fondanti: 1) lo spiccatofarmaco-tropismodeimascellari,legatoall’elevatoturn-overosseodiquestasede,chefasìchelamalattiainteressituttalastrutturascheletrica(Bertoldo,Santinietal.2007;Marx,Cilloetal.2007;Allen2008;Wen,Otto,Hafneretal.2010)e2)lalimitataspettanzadivitadigranpartedeipazienticonBRONJ(Wilde,Heufelderetal.2011;Voss,JoshiOsheroetal.2012),inlargamisuraaffettidatumorisolidimetastaticiomielomamultiplo.Entrambequestemo-tivazionisonooggettodigrandediscussioneenonsembrerebberopiùsuffi-cientiagiustificareilrifiutoaprioridellachirurgiacomeparteintegrantedeltrattamentodellaBRONJ.Infatti, che il turn-over osseo dento-alveolare sia più elevato rispetto allamaggiorpartedei restantidistrettischeletricigiustificasolamenteunmag-gioraccumulodiNBPaimascellarienonchelaBRONJsiaunamalattiachesidistribuisceaimascellarinellalorointerezza(Ikebe2012).Èstatorecente-menteriscontrato,infatti,chelaBRONJèunamalattiafocaledell’ossoecometalepuòesserecurataattraversolarimozionedell’ossocoinvolto;inoltre,conun’adeguataselezionedelpaziente, lachirurgia inunostudiorecente,nonsembrerebbemodificare inmodosostanziale le curvedi sopravvivenzadeisoggettitrattati(Bedogni,Saiaetal.2011).
123
Ancormenosostenibileèoggil’ideasecondocuil’altotassodimortalitàpre-suntadeipazienticonBRONJnongiustifica interventichirurgicidebilitanti.Esistono sporadici studiprospetticidi sopravvivenza in soggetticon tumorimetastaticiomielomamultiploincuilasopravvivenzageneraleadistanzadi2-3annidalladiagnosidiBRONJèancorasuperioreal70%(Badros,Terposetal.2008;Urade,Tanakaetal.2011).Seèverochequestistudinonanalizzano inmodospecificoglieffettidellachirurgia della BRONJ sulla sopravvivenza in generale, quando indagata, lasopravvivenzaa2annidopochirurgiademolitivainsoggettionco-ematologiciaffettidaBRONJèrisultataesseresuperioreall’80%.In conclusione, appare importante ridefinire il ruolo della chirurgia nel tratta-mento della BRONJ e stabilire quali interventi sia utile adottare nelle diverse fasi della malattia.
Finalità chirurgicaL’intentoprimariodellaterapiachirurgianellaBRONJdovrebbeesseresem-precurativo.Loèingenerepertuttelepatologiedelloscheletrofaccialeadeziologiainfettivaacutaecronica(i.e.alveolite,sinusite,osteomielite)eperleformediosteonecrosi(osteoradionecrosi)edè opinione di questa Commis-sione che debba esserlo anche per l’osteonecrosi dei mascellari associata agli NBP.L’intentocurativodiunaprocedurachirurgicas’identificamaterialmen-tenell’asportazionecompletadeltessutomacroscopicamentecoinvoltodallamalattiaenelraggiungimentodiuntessutosanochepermettaunaguarigio-nestabileneltempo.Uninterventochirurgicosaràcertamentemenoinvasivoeavràunmarginemaggioredisuccessose lamalattiadatrattareavràun’estensione limitata;pertantoilriservarelachirurgiaallefasipiùavanzatedimalattiacomesinoraoggi sostenuto (McLeod, Brennanet al 2012) non sarebbepiù una sceltasuggeribile,soprattuttoallalucedegliscarsirisultatiottenuticonitrattamenticonservativi,ancheinstadidimalattiainiziali(Kuhl,Walteretal.2012).Permegliocomprendere l’intentocurativodellachirurgiachequestaCom-missioneintendeproporre,ènecessariodefinire1)qualeèiltessutocoinvol-todallamalattiaeoggettodellachirurgia;2)cosasiintendepertessutosanoecomeèpossibileidentificarloconragionevolecertezzaprimaoinsedediinterventochirurgico;3)cosasiintendeperguarigionestabile.SappiamooggicheiltessutointeressatodirettamentedallaBRONJsindallesuefasiinizialièl’osso.GliNBPhannounelevatotropismoosseoe,inbase
124
allaviadisomministrazioneutilizzata,siaccumulanoinmaggiore(e.v.)omi-nore(per os)concentrazionenelcompartoosseogiàpocheoredopol’assun-zione; lapartenonfissatanello scheletroviene rapidamenteeliminatadaireni(Miller2011).Pertanto,glieffettinegatividelfarmacovengonoesercitatiprimariamentesullacomponenteossea.I tessutimucosi gengivali, lamucosaorale ingenere, imuscoli ed i tessuticutaneiesottocutaneidelvoltosonocoinvoltipiùcomeconseguenzadellaBRONJchenonperazionedirettadelfarmaco.Un’ipotesididannogengivaledirettofarmaco-indottoèstataavanzatasullabasedeirisultatidistudiinvitroesuanimale(Landesberg,Cozinetal.2008;Pabst,Ziebartetal.2012),manonhatrovato,almenosinoadoggi,unaconfermanellarealtàclinica.ÈstatodimostratodastudidiRisonanzaMagneticacondottiinpazientiaffettidaBRONJcheitessutimollifaccialipresentanosegnidiinfiammazione/infe-zione,chesonoingenerelimitatiallezoneadiacentiallasedeosseadimalat-tia(Bedogni,Blandamuraetal.2008;Bisdas,ChambronPinhoetal.2008).SarebbequindilaBRONJadeterminareisegniedisintomiclinicilegatiall’in-fiammazione/infezionesecondariadeitessutimolli(i.e.edema,fistole,mu-coseecutanee,raccoltepurulente,trisma).Perquestomotivo,l’eliminazio-necompletadeltessutoosseocoinvoltodovrebbeportarearisoluzionedelquadroclinico,rendendoinpraticasuperflual’asportazionedeitessutimollicoinvolti(Nocini,Saiaetal.2009),contrariamenteaquantoriportatodaalcu-niautoriinletteratura(Marx2009).Basterebbelapresenzaditessutoosseoistologicamentenormalealmarginediresezioneosseaperottenereunagua-rigionecompletaestabileneltempo(Bedogni,Saiaetal.2011).Questa Commissione ritiene che l’atto chirurgico debba essere mirato alla completa rimozione del tessuto osseo sede di BRONJ.
Valutazione del coinvolgimento osseoPerlacompletaasportazionedeltessutoosseopatologicosirendenecessarioidentificareconunbuonmarginedi sicurezza il tessutosanocircostante lalesione.Sel’esameistologicoeseguitosubiopsieosseerappresentaidealmenteilme-tododiagnosticopiùefficaceperqualunqueformadiosteonecrosi/osteomie-litedeimascellari,questononè certamente l’esamepiùutileper studiarel’estensionedelprocessopatologicoincasodiBRONJ.Ilproblemaprincipalerimanequindiquellodipoteridentificareconprecisio-neillimitetraossocoinvoltodallamalattiaetessutosano,perprogrammareuninterventorealmentecurativo.Nellapraticaclinicaattualeesistonodueorientamenti:ilprimosibasaesclu-
125
sivamente sulla determinazione intraoperatoria deimargini di resezione, ilsecondoinvecesiponecomeobiettivol’identificazionedellarealeestensionedeltessutopatologicoprimadell’interventochirurgico,attraversol’impiegodimetodicheradiologiche(Wilde,Heufelderetal.2011;Voss,JoshiOsheroetal.2012;Holzinger,Seemannetal2013).Lavalutazionedelsanguinamentoosseorappresentaancoraoggiilmezzopiùconsideratoper l’identificazione intraoperatoriadeimargini chirurgicinellaBRONJ (CarlsonandBasile2009;Mucke,Haarmannet al. 2009; Lemound,Eckardtetal. 2012;Wilde,Heufelderetal. 2011;Voss, JoshiOsheroetal.2012).Ilraggiungimentodiossosanguinanteperconfrontoconlaparteos-seanecroticaè interpretatocome il conseguimentodi tessutoosseosano.Tuttigliinterventimiratiall’asportazionedelsolotessutoosseonecrotico(i.e.sequestrectomiaecurettage) si fondanoancorasuquestoprincipio,ecosìspessoancheinterventipiùestesiincuil’ossovieneresecatocompletamen-te.Unarecenteesperienzaclinicasembrerebbeindividuarenellamarcaturadell’osso con tetracicline un utile strumento per la definizione deimarginiintraoperatori(Pautke,Baueretal.2011).Ilprincipiosibasasullospiccatotropismoosseo,sullacapacitàdifissazioneall’ossovitaleesullafluorescenzadiquestemolecole(i.e.doxiciclina).Durante l’interventochirurgico, l’utiliz-zodiunalampadaafluorescenzapermetterebbeilriconoscimentodell’ossofrancamentenecroticodaquelloancoravitale.Illimitediquestaesperienzasarebberappresentatoprincipalmentedalperiododiosservazionepost-ope-ratoriadiunsolomese,quandoèriconosciutochelerecidivepost-chirurgichediBRONJsirealizzanoinmassimaparteentrol’annosuccessivo.Pertanto,lasemplicevalutazioneintraoperatoriaesponealrischiodisottosti-marelarealeestensionedelprocessopatologico,permettendodidelimitaremacroscopicamentelacomponentenecroticamanondidistinguere“nell’os-sosanguinante” laquotadiossonormaledallacomponente infiammatoriache, inmisuramaggioreominore,è semprepresenteaibordidel tessutonecrotico(Bedogni,Blandamuraetal.2008;Mücke,Koschinskietal2011).Èimportantericordarechelapersistenzaditessutoosteomieliticodopointer-ventoèassociatoadunaelevataprobabilitàdirecidivadellamalattia,ancheinsedicontigue(Bedogni,Saiaetal.2011).Lavalutazioneintraoperatoriadelpuntodisanguinamentoavrebbe,dicontro,maggioreprobabilitàdisuccessose utilizzata nel trattamento chirurgico delle forme iniziali di osteonecrosi,dovel’entitàdellacomponenteosteomieliticaassociataèpotenzialmentepiùridottarispettoalleformeavanzate.Tuttavia,perriconoscereformeinizialidiBRONJèsemprepiùevidentelanecessitàdiun’accuratavalutazioneradiolo-
126
gica,comegiàdiscussoinprecedenza(CapitoloI,Paragrafi“CriteridiagnosticidiBRONJ”e“StadiazionedellaBRONJ”).La Commissione SICMF-SIPMO, dopo avere sottolineato il ruolo fondamenta-le dell’imaging ed in particolare della Tomografia computerizzata (TC) per la diagnosi clinico-radiologica di BRONJ, ritiene che la TC debba essere utilizzata anche nella valutazione preoperatoria dell’estensione della malattia, in asso-ciazione alla Risonanza Magnetica (RM) ove applicabile. Sedaunlato,infatti,laTCperlostudiodell’ossoconsenteunadettagliataiden-tificazionedellelesioniosteolitiche,deisequestriedellealterazionididensitàdelmidolloquandoevidenti,essaècertamenteinferioreallaRMnelvalutareilgradodiinfiammazioneediischemiadelmidolloosseochecorrispondonorispettivamentealleareediosteomieliteediosteonecrosi,quasisempreco-esistentinellaBRONJ(Bisdas,ChambronPinhoetal.2008).L’addensamentoosseodeglispazimidollari incorsodi infiammazione/infezionecronicapuòesseredifficilmentedifferenziabileallaTCdallapresenzadiosteosclerositar-diva(unasortadi“cicatrice”irreversibiledell’osso)inquadrabilecome“esitodimalattia” a remissione completa dei sintomi.Questo è soprattutto veronelleformepaucisintomaticheetardivediBRONJsenzaesposizioneossea,doveildatoradiologicoTCèdifficilmenteinterpretabile.PostochelaclinicaèdiaiutoneldifferenziareleformeattivediBRONJdaquelleinremissione,laRMècertamentel’esamedielezioneinognisituazionedubbiaallaTC.LaRMpermettediidentificareancheilgradodicoinvolgimentodeitessutimolliadiacenti(e.g.presenzadiascessi,flemmoni,interessamentodeglispazima-sticatori)(Garcia-Ferrer,Baganetal.2008).IcostiinferioridellatecnologiaTCrispettoallaRM,lasuamaggiorefruibili-tàsulterritoriocontrobilancianoillimiteprincipaledellametodicacostituitodalladosediirradiazione,oggicomunquedecisamenteridottarispettoalpas-sato.Questa Commissione ritiene essenziale la diagnosi radiologica dell’estensione della malattia prima di un intervento chirurgico che abbia finalità curative. Tra tutte le tecniche radiologiche, la TC e la RM forniscono le informazioni preoperatorie più utili e precise e pertanto dovrebbero essere considerate di elezione per lo studio preoperatorio della BRONJ, anche se non sono presenti ancora in letteratura elementi predittivi certi dell’ estensione di malattia.
Valutazione dei risultatiPervalutareglieffettidiunoopiùtrattamentisull’andamentodiunamalattia,ènecessarioutilizzaredeicriteridivalutazionestandard,chesianoapplicabili
127
aprescinderedallaterapiaadottata.Questoèilprincipiofondantecheregolalaconfrontabilitàdeitrattamentielasceltadiquellipiùefficacinellediversesituazionicliniche.In letteratura esiste ancora oggi una notevole disparità nella valutazionedell’efficaciadeitrattamentiperlaBRONJ,cheoriginadaunalacunosadefini-zionedeicriteridivalutazione.CiòèparticolarmenteveroperladefinizionediguarigionedellaBRONJpiùutilizzata,basataquasiesclusivamentesucritericlinici(CarlsonandBasile2009;Mücke,Koschinskietal2011;Wilde,Heufel-deretal.2011).Perguarigiones’intende,infatti,ilsemplicemantenimentodelsigillodellegengive/mucosaoraleinassenzadisintomi(Wilde,Heufelderetal2011).Questadefinizioneèlargamenteincompleta,mancandodeltuttolavaluta-zionedell’osso,cheèlasedeincuilamalattiasisviluppaepuòrecidivareneltempo,aprescinderedallapersistenzadelsigillomucososovrastante.Unsecondoimportanteaspettononchiaritoèiltempochedevetrascorre-redopountrattamentoperconsiderareunpazienteeffettivamenteguaritodallaBRONJ.Infatti,lastabilitàneltempodeglieffettidiuntrattamentoèilrequisitoessenzialechepermettedivalutarneilgradodiefficacia,inmodoparticolareperleterapiechirurgiche.Laduratadelfollow-up,lacadenzadellevisitedicontrolloedegliesamiradiologicidipendedalladefinizionetempo-ralediguarigione.Da una revisione della letteratura disponibile sulla terapia chirurgica dellaBRONJ(Gennaio2004-Luglio2012)abbiamoverificatochelamaggiorpartedellerecidiveclinichedimalattia(almenodiquelledocumentate)simanife-staentroi6mesi,maunnumerosignificativodirecidivesirivelaanchenei6mesisuccessiviecomunqueentrol’anno,qualunquesialaterapiachirurgicaadottata(CarlsonandBasile2009;Bedogni,Saiaetal.2011;Wilde,Heufelderetal.2011;Voss,JoshiOsheroetal.2012;Jabbour,El-Hakimetal2012;Hol-zinger,Seemann,etal2013).Lamaggiorpartedelleesperienzeclinichepubblicateanchedirecentevalu-tairisultatidellachirurgiasullabasedifollow-upmediinferioriougualia6mesi(Pautke,Baueretal.2011;Wutzl,Pohletal.2012;Ferlito,Puzzoetal.2012;MarxandTursun2012).Inoltre,ècomuneadiversistudiilfattocheunaparteancherilevantedeisoggettitrattatiabbiaunfollow-upinferioreai6mesi(Markose,Mackenzieetal.2009).Ladirettaconseguenzadiciòèlasovrastimadell’effettodei trattamentiadottati,dovutaallamancatasegna-lazionedellerecidivediBRONJtrai6ei12mesidifollow-up.Inoltre,siten-deaconfondereilconcettodirecidivaconquellodi“nuovalocalizzazionedi
128
malattia”giàneiprimi6mesidiosservazione,checaratterizzalacomparsadiesposizioneosseaodisegniclinicidimalattiasvincolatadallamanifestazionepregressa(CarlsonandBasile2009).QuestaCommissionesottolinea l’importanzadi istituireun limite tempora-leminimoper il follow-updeipazienticonBRONJ sottopostia trattamentichirurgici;suggeriscediconsiderarecomeelementicriticiperlavalutazionedell’efficaciadiqualsiasinuovaterapiachirurgicalacorrettadefinizionedelri-sultatoatteso,dellemisureutilizzatepervalutarlo,eladuratadelfollow-up.In conclusione, questa Commissione intende promuovere il concetto di gua-rigione clinico-radiologica della BRONJ, intendendo con essa la documentata assenza, per ciascun paziente trattato, di sintomi e segni clinici di BRONJ as-sociata all’assenza di segni radiologici di malattia per un periodo non inferiore ai 12 mesi.Neconseguechelaricomparsadimanifestazioniclinicheeradiologicheas-sociatenei12mesisuccessiviallaterapiachirurgicasiadaconsiderarsiunarecidivaenonunanuovalocalizzazionediBRONJanchequandosirealizziinareecontigueaquelletrattate(vediTabella10).
Definizione
GuarigioneAssenza di sintomi e segni clinici maggiori e minori, esegni radiologici di malattia alla TC o RM, ad 1 anno dalcompletamentodeltrattamento
RemissioneScomparsa dei sintomi (dolore) e dei segni clinici associatiallamalattia,inpresenzadistabilitàradiologicaallaTCoRM
RecidivaComparsa di BRONJ (clinico-radiologica) nella stessa sedetrattatao inuna sedecontiguaentrounannodal terminedeltrattamento
Nuova localizzazione
ComparsadiBRONJ(clinico-radiologica)inunasedediversadaquellaidentificatainprecedenza.Perfarediagnosidinuovalocalizzazioneinsedicontigueadareegiàtrattate,deveesseretrascorsounanno inassenzadi segni clinico-radiologici di malattia dal precedentetrattamento
Tabella 10. Parametri di prognosi della BRONJ
129
Considerazioni tecniche
L’assenzadiprotocollichirurgicicondivisiestandardizzatineltrattamentodel-laBRONJharesoinpraticaimpossibileconfrontarnel’efficacia.È quindi intenzione della Commissione fornire un elenco descrittivo degli inter-venti più utilizzati nel trattamento della BRONJ, in modo da favorire la scelta dell’operatore nelle diverse fasi della malattia.
Osteplastica di superficie Per “osteoplastica di superficie” (cfr: surface bone smoothening, bone re-surfacing) è da intendersi unaprocedura chirurgica minimamente invasiva condotta con frese rotanti e senza l’ausilio di anestesia locale,alloscopodieliminarepiccoleasperitànelcontestodiareediossoespostoincavoorale.Questaproceduranonrichiedeloscolpimentodilembimuco-periosteinédisutura.Èutilizzatainparticolarepereliminareconflittiinzonediossoesposto(i.e.lineaobliquainternadellamandibola,tuber)cheproduconotraumadasfre-gamentosullalinguaodifficoltàacalzarelaprotesi.L’osteoplasticadisuperficieèuntrattamentomeramentepalliativo,edèri-servatoai casigiudicatinonoperabili, inassociazionealle terapiemedicheperilcontrollodeldoloreedell’infezione.
Curettage dento-alveolare Per “curettage osseo” (cfr.debridment,bonecurettage) s’intende l’asportazio-ne chirurgica del tessuto osseo necrotico sino all’identificazione di una super-ficie ossea sanguinante, seguito dalla chiusura completa del difetto mediante mobilizzazione di un lembo muco-periosteo.Questointerventoècondottoinanestesialoco-regionaleoinnarcosi,inrelazioneall’estensionedelprocesso,alle condizioni cliniche ed alla compliance del paziente. L’osso è asportato per strati mediante uso di frese rotanti e, ove disponibili, strumenti a minore invasività (strumenti ad ultrasuoni). Questo intervento prevede che l’osso necrotico non sia ancora separatodall’ossovitalecircostante,altrimentisitratterebbediunasequestrectomia.L’utilizzodi strumenti scarsamente invasivioffreun teoricovantaggionellamanipolazionedeltessutoosseoadiacentealleareenecrotiche.L’intervento“curettagedento-alveolare”prevedesempreinaggiuntaun’oste-oplasticadella superficieosseapereliminarepossibiliasperità residuee lachiusura completadeldifettomediantemobilizzazionedi un lembomuco-
130
periosteo.Lachiusurainsingoloomultiplostratodeveavvenireinassenzaditensione.
SequestrectomiaIl sequestroosseoconsiste inunaporzionediossonecrotico, includenteono elementidentali, che si distacca progressivamente dall’osso circostantechemantieneinvececaratteristichedivitalità.Ilsequestroosseoètipicodeiprocessiosteonecroticiedosteomieliticicroniciedèuneventofrequentean-chenellaBRONJ(Ferlito,Puzzoetal.2012).IlsequestroèstatoconsideratoalungounsegnotardivodiBRONJ(stadioIIIsecondoAAOMS),puressendotipicamenteunsegnoprecocenell’osteomieliteacutadeimascellari.Datire-centisembrerebberodimostrarecheilsequestronellaBRONJinrealtànonhaunaspecificacollocazionetemporale,potendorealizzarsiinqualunquefasedellamalattia.Infatti,ilprocessodisequestrazionenellaBRONJrichiedeuntempovariabilechedipendedamolteplicifattori,tracuicertamentelacapa-citàresiduadirimodellamentodell’ossoinfunzionedelladuratadellaterapiaconNBP.Il processo di sequestrazione può portare all’espulsione spontanea del se-questroquandolaporzionenecroticasiaseparatacompletamentedall’ossovitalecircostantemedianteinterposizioneditessutodigranulazionebenva-scolarizzato.Inquestecondizioni,l’eliminazionedelsequestroavvienesenzalanecessitàdianestesiaointerventochirurgico.Coniltermine“sequestrectomia” s’intende pertanto la rimozione chirurgica, eseguita in anestesia locale o generale, di un sequestro osseo generalmente interessante il processo alveolare dei mascellari e ancora solidale ai tessuti circostanti.Questointerventoècondottoinanestesialoco-regionaleoinnar-cosi, inrelazioneall’estensionedelprocesso,allecondizioniclinicheedallacompliancedelpaziente.L’intervento chirurgico di sequestrectomia prevede sempre in aggiuntaun’osteoplasticadellasuperficieosseaadiacentepereliminarepossibiliaspe-ritàresidue,elachiusuramucosaperprimaintenzionedeldifetto,mediantemobilizzazionediunlembomuco-periosteo(Wilde,Heufelderetal.2011).
Chirurgia resettivaCon il termine di “chirurgia resettiva” s’intende l’asportazione in blocco dell’osso patologico sino ad arrivare a tessuto verosimilmente normale. L’intervento chirurgico resettivo nella BRONJ deve sempre prevedere in
131
aggiunta un’osteoplastica dei margini di resezione per eliminare possibiliasperità residue,eassicurare la chiusuramucosaperprima intenzionedeldifetto,mediantemobilizzazionediunlembomuco-periosteo.Diversamentedallachirurgiaoncologica,imarginidiresezioneosseanell’oste-onecrosiassociataaNBP,comeintutteleformediosteonecrosieosteomie-litedeimascellari,nonsonocodificati.Perdefinizione,unmarginediresezionedovrebbecaderenell’areaditessutonormaledaunpuntodivistaclinicoeradiologico,subitoantistante, retro-stantee/osottostanteiltrattodiossopatologicodaasportare,taledaassicu-rareunaguarigionestabileneltempo.NellaBRONJ,lavalutazionepreopera-toriaconTCeRMdeimarginidiresezionepermettediidentificareconbuonaprecisione il tessutoosseonormaleadiacente che,qualoranonpatologicoall’esameistologico(Bedogni,Blandamuraetal.2008),assicuraunaguarigio-necompletaestabileneltempo(Bedogni,Saiaetal.2011).Lachirurgiaresettivasidistinguenettamentesiadalcurettagedento-alveola-resiadallasequestrectomia,neiqualiiltessutoèasportatoperstratisucces-sivi,senzaunachiaradefinizionedeimarginid’intervento.Sidistinguonodueformedichirurgiaresettiva:quellamarginale e quella seg-mentale (a tutto spessore).La chirurgia resettiva marginale consiste nell’asportazione in blocco del tes-suto patologico, senza interruzione della continuità anatomica del segmento scheletrico interessato (altrimentidetta“asportazioneacassetto”,terminolo-giadifrequenteriscontronellaletteraturascientificaitaliana).L’interventopuòessereeseguitoinanestesialoco-regionale(regimeambula-toriale)oinanestesiageneralepreviaospedalizzazione,inrelazioneall’esten-sionedelprocesso,allecondizioniclinicheedallacompliancedelpaziente.La resezione marginale interessa di regola i processi dento-alveolari dellamandibolaedelmascellare,limitandosiallesolebasischeletricheinrarecir-costanze (CarlsonandBasile2009). Il concettodichirurgia resettivamargi-nale è facilmente intuibile a livellomandibolare, dove l’asportazionedi uncassettoosseodento-alveolarenonintaccalacontinuitàbasaledell’osso.Inquesto caso, il canale osseodel nervo alveolare inferiore rappresenta il li-mite naturale della resezione dento-alveolare. Al contrario, nelmascellaresuperioreladistinzionetrachirurgiamarginaleesegmentaleèmenonetta,poichél’asportazionedelprocessodento-alveolarecomportatipicamentelacreazionediunacomunicazioneoro-nasalee/ooro-antraleequindidiunadiscontinuitàossea.Daunpuntodivistaanatomico,infatti,laporzionebasale
132
delmascellaresuperioreèpressochévirtuale,coincidendoconlospazioesi-stentetral’ossodento-alveolare(contenenteleradicideglielementidentari)eiseninaso-paranasali.Questa Commissione ritiene opportuno per il futuro classificare la procedura chirurgica resettiva al mascellare come segmentale piuttosto che marginale.Per chirurgia resettiva segmentale s’intende l’asportazione in blocco (a tut-to spessore) di un segmento scheletrico con interruzione della sua continuità anatomica.L’interventoèeseguitoinanestesiagenerale,inregimediospedalizzazione.Essodevesempreprevedereinaggiuntaun’osteoplasticadeimarginidirese-zionepereliminarepossibiliasperitàresidueelachiusuramucosaperprimaintenzionedeldifetto(meglioseindoppiostrato),mediantemobilizzazionediunlembomuco-periosteo,ovenonindicataaltraformadiricostruzione.Lachirurgiaresettivasegmentaleportainséilconcettodiamputazione,ovve-rodiinterruzionedellacontinuitàosseadiunsegmentoscheletrico.L’interventoresettivostandardperlamandibolaèlamandibulectomia.Essacausasemprelaperditadellasimmetriadelterzoinferioredelvoltoedell’oc-clusione.Perquestomotivoèlargamentecondivisoilfattochelacreazionediundifettomandibolareatuttospessore,ovenonspecificamentecontroin-dicato, impone la ricostruzione immediatadella continuità osseaper ripri-stinarelamorfologiadelvolto,assicurareunrecuperofunzionaleilmigliorepossibile (e.g. fonazione,deglutizioneemasticazione) e favorireun rapidoreinserimentosociale.Laricostruzionedell’integritàmandibolaredopomandibulectomiapuòesse-reottenutaconplaccheda ricostruzione intitanio in sostituzionedell’ossoasportatoo,inalternativa,conlembiosseivascolarizzati.Entrambelemeto-dichesonoampiamentedescritteinletteraturaperiltrattamentodeglistadiavanzatidellaBRONJ(Kademani,Kokaetal.2006;Mucke,Haarmannetal.2009;Nocini,Saiaetal.2009;Seth,Futranetal2010).Sedaun lato la ricostruzioneconsistemidiosteosintesi intitaniohadellespecificheindicazioni,essendoapplicabilesolonelcasodidifettimandibolarilateralichenonsuperinolalineamedianaeconilcondilopreservatoperunadimensioneadeguata(Cannon,Strubetal.2012),laricostruzioneconossovascolarizzatopuòessereimpiegataperpressochéqualsiasidifettomandibo-lare(Engroff,Kim,2007;Seth,Futranetal2010).Èaltresìverocheladuratadell’interventoedirischid’insuccessolegatiallaprocedurasonodiversi,essendoingeneralemoltosuperioriperlaricostru-zioneconossovascolarizzato.Itempidiospedalizzazione,laripresadell’ali-
133
mentazione,elaripresadellenormalifunzioniècertamentepiùrapidaquan-dolamandibolaèricostruitaconplaccheintitaniochenonconlembiosseivascolarizzati(Bedogni,Saiaetal.2011).Il vantaggioprincipaledella ricostruzionemandibolareconossovascolariz-zatoèlapossibilitàdiriabilitareprotesicamentel’arcatainunsecondomo-mento,alcontrariodellaricostruzioneconplaccaintitanio,chenonpermettealcunaformadiprotesizzazione(Ferrari,Bianchietal.2008).Inrealtà,essendolargamentecondivisochel’implantologiaosteointegrataècontroindicataneipazientioncologiciespostialtrattamentoconNBP(AAOMS2007;Khosla,Burretal.2007),lepossibilitàdiunariabilitazioneprotesicasuossovascolarizzatonelpazienteconBRONJsonodrasticamenteridotte.Inultimaanalisi, ladecisionesull’interventoricostruttivodautilizzaredopomandibulectomiadovrebbeesserevalutatacasopercasoecondivisaconilpazientesecondounalogicacautelativa,chetengasoprattuttocontodelrea-levantaggiodellatecnicautilizzataedellecondizionigeneralidelpaziente.Alla luce di queste considerazioni, è parere della presente Commissione che i sistemi in titanio da ricostruzione mandibolare siano da preferire ai lembi vascolarizzati per difetti mandibolari laterali, mentre i secondi rappresentino l’unica scelta accettabile in caso di difetti estesi controlateralmente.Traipossibilisitidiprelievodiossovascolarizzato,lafibula,lacrestailiacaelascapolasonocertamenteipiùusati(Eckardt,Fokas2003).Lafibulaèunsitomoltorarodimetastasiossea(Rajan,Warneretal.1999),mentrelacrestailiacaelascapola,essendoriccheinossospongioso,sonofrequentementesededimetastasi(Mundy2002).Neconseguechenelpa-zienteconBRONJ,solitamenteaffettodaneoplasiemalignemetastatichealleossaomielomamultiplo, lasceltadell’ossovascolarizzatodovrebbecaderepreferenzialmentesullafibula,nonsolo invirtùdellesuecaratteristichein-trinsecheedellalunghezza,masoprattuttoperlasuaelevataresistenzaall’in-filtrazioneneoplastica.L’intervento resettivo segmentaleper ilmascellare superioreè lamaxillec-tomia,chevienesolitamenteclassificata inbaseall’estensioneverticaleedorizzontaledel difetto che viene creatoper asportare il tessutopatologico(Brown,Shaw2010;Bidra,Jacobetal.2012).Sidistinguonomaxillectomieparzialietotali,laprimacaratterizzatadall’aspor-tazionedelsoloprocessodento-alveolare,conosenzaconservazionedelpa-lato;lasecondaècontraddistintainvecedall’asportazioneinbloccodituttelepareti,inclusoilpavimentoorbitario.È opinione di questa Commissione che la maxillectomia parziale (mono o bi-
134
laterale) con conservazione del palato rappresenti l’intervento resettivo più opportuno nel trattamento della BRONJ.Laricostruzioneosseadelmascellaresuperioredopomaxillectomiaparzialenonèquasimainecessaria,èpuòesserepertantotemporaneamentediffe-ritaocompletamenteomessa,apattochenonvengamenoilsostegnoallestruttureorbitarieenasali.Deveesseresempreecomunquegarantitalaseparazionetralefossenasaliedisenimascellaridaunlatoelacavitàoraledall’altro,utilizzandodiprefe-renzatessutilocaliperottenereunachiusuraindoppiostrato.Atalescopo,lapreservazionedellamucosapalataleedigranpartedellegengivepermettediottenereunachiusuramucosasuperficialemolto stabile,quandoconte-stualmenteassociata alla separazione inprofonditàdelle cavità sino-nasaliconunlembopeduncolatodibolladiBichat(Gallego,Junqueraetal2012)odimuscolotemporale.Lamaggiorpartedeidifetticonseguentiamaxillectomiaparzialepuòesserecorrettaconquestametodica, senzanecessitàdiutilizzare lembi cutaneiomuscolari(Bedogni,Saiaetal.2011).Infine,incasodinecessitàdiricostruzionedellastrutturascheletricadelma-scellare, è indicato l’utilizzo di osso vascolarizzato, seguendo lemedesimeindicazionidescritteinprecedenzaperlariabilitazioneosseadopomandibu-lectomia.
Protocollo di trattamento SICMF-SIPMO
Inletteraturanonsisonoraggiuntiaoggilivellidivalidazioneclinicasufficien-tiperdefinirelasuperioritàdellaterapiachirurgicarispettoaquellamedicaquandoutilizzateseparatamente,inconsiderazionedelfattochegliinterventichirurgicisonoinpraticasempreprecedutioseguitidaterapiemediche(e.g.disinfettanti,antibiotici,OTI(Freiberger,Padilla-Burgosetal.2012),ozonote-rapia(Agrillo,Ungarietal.2007;Ripamonti,Cislaghietal.2011),biostimola-zione laser (Vescovi,Manfredietal.2010), sospensione farmaco (Bedogni,Saiaetal.2011;Wutzl,Pohletal.2012).Ma,nell’ambitodellachirurgia,sievincedallaletturadellarecenteletteratura,unapotenzialesuperioritàdelleprocedurechirurgicheresettivenelcontrollodellamalattiarispettoallachi-rurgiamenoinvasiva(Abu-Id,Warnkeetal.2008;Hoff,Tothetal.2008;Wut-zl,Biedermannetal.2008;CarlsonandBasile2009;Lazarovici,Yahalometal.2009;Stockmann,Vairaktarisetal.2010;Williamson2010;Wilde,Heufelder
135
etal.2011;Graziani,Vescovietal.2012;),puressendolaprimatipicamenteapplicatanellostadio3diBRONJsecondoAAOMS,mentrelasecondaneipiùfrequentistadi2.Sipotrebbeipotizzarechel’inferioritàpresuntadellachirur-gia scarsamente invasiva rispettoalla chirurgia resettiva siaprimariamentedovutaadunerrorediselezionedeipazienti,basatosuun’imprecisadefini-zionedeglistadidimalattia.IlfattochelaBRONJsiastatasinoraclassificatainbaseacriteriquasiesclu-sivamenteclinici(Ruggiero,Dodsonetal.2009)hadeterminatochepazienticonestensioneclinico-radiologicadimalattiamoltodiversatraloroconfluis-seroneglistessistadiericevesseropertantoimedesimitrattamenti,ovvia-menteconrisultatimoltodiversi.È opinione di questa Commissione che non tanto i trattamenti in sé, quan-to l’erronea assegnazione degli stessi ai pazienti, avvenuta sulla base di una classificazione di stadio basata in larga misura sul dolore ed i segni di infezio-ne, sia da considerarsi la principale responsabile del fallimento della chirurgia nella terapia della BRONJ.Quandoapplicatasecondounprincipiodiassegnazioneprogressivoincuil’in-vasivitàdellaprocedurachirurgicadipendedall’effettivogradodiestensionedellamalattiaalivelloscheletrico,lachirurgiadovrebbepermettere,sulpianoteorico,diottenererisultatisovrapponibiliaquelliottenutineltrattamentodiformediversediosteonecrosi/osteomielite.Daquantosinoraespresso,emergechiaroilfattochenonesisteuninterventoperlacuradellaBRONJmiglioredeglialtriinassoluto,maunaserieditera-piechirurgicheprogressivamentepiùinvasive,chedevonoessereadottateinbaseadunprecisostadiodiprogressionedellamalattia.La Commissione SICMF-SIPMO, dopo avere analizzato tutte le possibili tera-pie mediche e chirurgiche adottabili singolarmente o in combinazione tra loro per il trattamento della BRONJ, propone uno schema terapeutico graduato sull’estensione clinico-radiologica della malattia (vedi Capitolo I, Paragrafo “Stadiazione della BRONJ”).Questoprotocollo(Tab.11)èbasato–ovepossibile–sullaterapiachirurgica,daapplicareinognistadiodellamalattiainassociazioneallaterapiamedica.LaterapiachirurgicapropostaèlapiùsemplicepossibileperrenderefruibileilprotocolloatuttiicentrichesioccupanodidiagnosietrattamentodellaBRONJsulterritorionazionale.Glistrumentiabassainvasività,qualilasereultrasuoni,sonoaltamenteconsigliabiliovedisponibili,manonrappresenta-noadoggiunelementoimprescindibileperilraggiungimentodelrisultato.Loschemapropostoprevedel’assegnazionediuntrattamentoindicato(i.e.
136
Tabella 11. Trattamenti raccomandati per la cura dell’osteonecrosi dei mascellari associata a bisfosfonati (BRONJ)
Protocollo standard Protocollo alternativo
TERAPIA MEDICO-CHIRURGICA COMBINATA
TERAPIA MEDICA NON CHIRURGICA
Stadio 1(BRONJ focale)
Chirurgia dento-alveolare*,# :1. Curettage dento-alveolare,
con/senzasequestrectomiaefistolectomia
2. Chirurgia resettiva marginale, in caso di recidiva dopo curettage
Terapia antisettica topica Terapia antibiotica sistemica
perioperatoria Sospensione NBP sinoaguarigione
biologicadeitessuti(4-6settimane)
Terapia antisettica topicaTerapia antibiotica sistemicaalbisogno
con/senza:Biostimolazione(Ozonoterapia,laser)OssigenoterapiaiperbaricaTeriparatide(pazienteosteoporotico)
Finalità:
controllodella1.sintomatologia(palliazione);autosequestrazione2.remissione3.
Consigliabilequandocontroindicatol’utilizzodelprotocollostandardodoporifiutodellachirurgiadapartedelpaziente
Stadio 2(BRONJ diffusa)
Chirurgia resettiva*,# :1. Marginale: consigliabile solo per
BRONJ mandibolare in pazienti osteoporotici
2. Segmentale: in pazienti oncologici o in caso di recidiva dopo resezione marginale
Terapia antibiotica sistemicaperioperatoria
Terapia antisettica topica Sospensione NBP sinoaguarigione
biologicadeitessuti(4-6settimane)Stadio 3(BRONJ complicata)
Chirurgia resettiva segmentale*,# (conosenzaricostruzione)
Terapia antibiotica sistemicaperioperatoria
Terapia antisettica topica Sospensione NBP sinoaguarigione
biologicadeitessuti(4-6settimane)
*Consigliabilel’impiegodipiezochirurgiaechirurgialaser-assistitaperridurreiltraumati-smoosseo# Monitoraggio post-operatorio:visitadicontrolloa1-3-6-12mesi.EsameTCdicontrolloa6e12mesi.Incasodiguarigionea12mesidaltrattamento,ilpazienterientranelfollow-updiprevenzionedellaBRONJ
137
protocollostandard),ediunoopiù trattamenti“alternativi”nonchirurgici(i.e.protocolloalternativo),nelcasoincuilecondizioniclinichegeneralidelpaziente controindichino la scelta chirurgica (vediAppendice4 “ProtocolloterapeuticodellaBRONJ”).
Bibliografia
Advisory Task Force on Bisphosphonate-Related Ostenonecrosis of the Jaws (2007):American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper onbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.JOralMaxillofacSurg65(3):369-376.
Abtahi,J.,Agholme,F.,etal.(2012):Bisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejawinaratmodelarisesfirstafterthebonehasbecomeexposed.Noprimarynecrosisinunexposedbone.JOralPatholMed41(6):494-499.
Abu-Id,M.H.,Warnke,P.H.,etal. (2008):“Bis-phossy jaws”-Highand lowriskfactorsforbisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaw.JCraniomaxillofacSurg36(2):95-103.
Aghaloo,T.L.,Kang,B., etal. (2011):Periodontaldiseaseandbisphosphonates induceosteonecrosisofthejawsintherat.JBoneMinerRes26(8):1871-1882.
Agrillo,A.,Petrucci,M.T.,etal. (2006):NewTherapeuticProtocol in theTreatmentofAvascularNecrosisoftheJaws.JCraniofacSurg17(6):1080-1083.
Agrillo, A., Ungari, C., et al. (2007) Ozone therapy in the treatment of avascularbisphosphonate-relatedjawosteonecrosis.JCraniofacSurg18(5):1071-1075.
Allen, M.R. (2008): Skeletal accumulation of bisphosphonates: implications forosteoporosistreatment.ExpertOpinDrugMetabToxicol4(11):1371-1378.
Allen,M.R.,Kubek,D.J.,etal.(2011):Compromisedosseoushealingofdentalextractionsitesinzoledronicacid-treateddogs.OsteoporosInt22(2):693-702.
Angiero,F.,Sannino,C.,etal.(2009):Osteonecrosisofthejawscausedbybisphosphonates:evaluation of a new therapeutic approach using the Er:YAG laser. LasersMed Sci 24(6):849-856.
Aspenberg,P.(2006):Osteonecrosis:whatdoesitmean?Oneconditionpartlycausedbybisphosphonates-oranotherone,preferablytreatedwiththem?ActaOrthop77(5):693-694.
Badros,A.,Terpos,E.,etal.(2008):Naturalhistoryofosteonecrosisofthejawinpatientswithmultiplemyeloma.JClinOncol26(36):5904-5909.
Badros, A., Weikel, D., et al. (2006): Osteonecrosis of the jaw in multiple myelomapatients:clinicalfeaturesandriskfactors.JClinOncol24(6):945-952.
Bashutski,J.D.,Eber,R.M.,etal.(2010):Teriparatideandosseousregenerationintheoralcavity.NEnglJMed363(25):2396-2405.
138
Bedogni, A., Blandamura, S., et al. (2008): Bisphosphonate-associated jawboneosteonecrosis:acorrelationbetween imagingtechniquesandhistopathology.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod105(3):358-364.
Bedogni, A., Fusco, V., et al. (2012): Learning from experience. Proposal of a refineddefinitionandstagingsystemforbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthe jaw(BRONJ).OralDis18(6):621-623.
Bedogni,A.,Saia,G.,etal.(2011):Long-termoutcomesofsurgicalresectionofthejawsin cancer patients with bisphosphonate-related osteonecrosis. Oral Oncol 47(5):420-424.
Bertoldo,F.,Santini,D.,etal. (2007):Bisphosphonatesandosteomyelitisofthe jaw:apathogenicpuzzle.NatClinPractOncol4(12):711-721.
Bidra,A.S.,JacobR.F.,etal.(2012):Classificationofmaxillectomydefects:asystematicreviewandcriterianecessaryforauniversaldescription.”ProsthetDent107(4):261-70.
Bisdas,S.,ChambronPinho,N.,etal. (2008):Biphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaws:CTandMRIspectrumoffindingsin32patients.ClinRadiol63(1):71-77.
Bocci,V.(1996):Ozoneasbioregulator:Pharmacologyandtoxicologyofozone-therapytoday.JBiolRegulHomeostAgent10:31-53.
Bocci,V.(2004):OzoneasJanus.MediatorsofInflammation13(1):3-11.
Bocci,V.andPaulesu,L.(1990):Studiesonthebiologicaleffectsofozone1.Inductionofinterferongammaonhumanleucocytes.Haematologica75(6):510-515.
Bouquot,J.E.andMcMahon,R.E.(2000):Neuropathicpaininmaxillofacialosteonecrosis.JOralMaxillofacSurg58(9):1003-1020.
Brozoski,M.A.,Traina,A.A.,etal. (2012):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw.RevBrasReumatol52(2):265-270.
Brown,J.S.andShaw,R.J.(2010):Reconstructionofthemaxillaandmidface:introducinganewclassification.LancetOncol11(10):1001-8.
Campisi,G.,DiFede,O.,etal.(2007):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw(BRONJ): run dental management designs and issues in diagnosis. Ann Oncol 18Suppl6:vi168-172.
CannonT.Y.,StrubG.M.,etal(2012):Oromandibularreconstruction.ClinAnat25(1):108-19.
Carlson,E.R.andBasile,J.D.(2009):Theroleofsurgicalresectioninthemanagementofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):85-95.
Cheng,A.,Mavrokokki,A.,etal.(2005):Thedentalimplicationsofbisphosphonatesandbonedisease.AustDentJ50(4Suppl2):S4-13.
Cheung, A. and Seeman, E. (2010): Teriparatide therapy for alendronate-associatedosteonecrosisofthejaw.NEnglJMed363(25):2473-2474.
139
Chiu, C.T., Chiang,W.F., et al. (2010): Resolution of oral bisphosphonate and steroid-relatedosteonecrosisofthejaw-aserialcaseanalysis.JOralMaxillofacSurg68(5):1055-1063.
Colella, G., Campisi, G., et al. (2009): American Association of Oral andMaxillofacialSurgeonspositionpaper:Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisof the Jaws-2009update:theneedtorefinetheBRONJdefinition.JOralMaxillofacSurg67(12):2698-2699.
Cornish,J.,Bava,U.,etal.(2011):Bone-boundbisphosphonateinhibitsgrowthofadjacentnon-bonecells.Bone49(4):710-716.
Cremers,S.andFarooki,A.(2011):Biochemicalmarkersofboneturnoverinosteonecrosisof the jaw inpatientswithosteoporosisandadvancedcancer involving thebone.AnnNYAcadSci1218:80-87.
Dayas,A.,Boughton,B.J,etal.(1983):Ozonekillingactionagainstbacterialandfungalspecies;microbiologicaltestingofadomesticozonegenerator.JClinPathol36:1102-1104.
Dimitrakopoulos, I., Magopoulos, C., et al. (2006): Bisphosphonate-induced avascularosteonecrosis of the jaws: a clinical report of 11 cases. Int JOralMaxillofac Surg 35(7):588-593.
Ebetino, F.H.,Hogan,A.M.,et al. (2011): The relationshipbetween the chemistryandbiologicalactivityofthebisphosphonates.Bone49(1):20-33.
Eckardt, A. and Fokas, K. (2003): Microsurgical reconstruction in the head and neckregion:an18-yearexperiencewith500consecutivecases.JCranioMaxillofacSurg31:197–201.
Engroff,S.L.andKim,D.D.(2007)“Treatingbisphosphonateosteonecrosisofthe jaws:istherearoleforresectionandvascularizedreconstruction?”JOralMaxillofacSurg65(11):2374-85.
Epstein,J.,vanderMeij,E.,etal.(1997):Postradiationosteonecrosisofthemandible:along-termfollow-upstudy.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod83(6):657-662.
Fedele,S.,Porter,S.R,etal. (2010):Nonexposedvariantofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:acaseseries.AmJMed123(11):1060-1064.
Feldmeier,J.J.(2004):HyperbaricOxygenfordelayedradiationinjuries.UnderseaHyperMed31(1):133-145.
Feldmeier, J.J., Carl, U., et al. (2003): Hyperbaric oxygen: does it promote growth orrecurrenceofmalignancy?.UnderseaHyperMed30(1):1-18.
Ferlito,S.,Puzzo,S.,etal.(2012):Treatmentofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:presentationofaprotocolandanobservational longitudinalstudyofanItalianseriesofcases.BrJOralMaxillofacSurg50(5):425-429.
Ferrari, S., Bianchi, B., et al. (2008): Fibula free flap with endosseous implants forreconstructing a resected mandible in bisphosphonate osteonecrosis. J OralMaxillofacSurg66(5):999-1003.
140
Filleul,O.,Crompot,E.,etal.(2010):Bisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaw:areviewof2,400patientcases.JCancerResClinOncol136(8):1117-1124.
Freiberger, J.J. (2009): Utility of hyperbaric oxygen in treatment of bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):96-106.
Freiberger, J.J., Padilla-Burgos, R., et al. (2007): Hyperbaric oxygen treatment andbisphosphonate-inducedosteonecrosisof the jaw:a case series. JOralMaxillofacSurg65(7):1321-1327.
Freiberger,J.J.,Padilla-Burgos,R.,etal.(2012):Whatistheroleofhyperbaricoxygeninthemanagementofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:arandomizedcontrolledtrialofhyperbaricoxygenasanadjuncttosurgeryandantibiotics.JOralMaxillofacSurg70(7):1573-83.
Gallego,L.,Junquera,L.,etal.(2012):Theuseofpedicledbuccalfatpadcombinedwithsequestrectomy inbisphosphonate-relatedosteonecrosisof themaxilla.MedOralPatolOralCirBucal17(2):e236-41.
Garcia-Ferrer,L.,Bagan,J.V.,etal.(2008):MRIofmandibularosteonecrosissecondarytobisphosphonates.AJRAmJRoentgenol190(4):949-955.
Gray,A.(2010):Teriparatideforbonelossinthejaw.NEnglJMed363(25):2458-2459.
Graziani, F., Vescovi, P., et al. (2012): Resective Surgical Approach Shows a HighPerformance in the Management of Advanced Cases of Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisof the Jaws:ARetrospectiveSurveyof347Cases. JOralMaxillofacSurg70(11):2501-2507.
Greenberg,M.(2008):Burket’sOralMedicine-11thEd.Burket’sOralMedicine-11thEd.11thEd.
Greenberg,M.S.(2004):Intravenousbisphosphonatesandosteonecrosis.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod98(3):259-260.
Guzzardella,G.A.,Fini,M.,etal.(2002):Laserstimulationonbonedefecthealing:aninvitrostudy.LasersMedSci17(3):216-220.
Hansen,T.,Kirkpatrick,C.J.,etal. (2006): Increasednumbersofosteoclastsexpressingcysteine proteinase cathepsin K in patients with infected osteoradionecrosis andbisphosphonate-associated osteonecrosis--a paradoxical observation? VirchowsArch449(4):448-454.
Hansen, T., Kunkel, M., et al. (2006): Osteonecrosis of the jaws in patients treatedwith bisphosphonates - histomorphologic analysis in comparison with infectedosteoradionecrosis.JOralPatholMed35(3):155-160.
Harper,R.P.andFung,E.(2007):Resolutionofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthemandible:possibleapplicationforintermittentlow-doseparathyroidhormone[rhPTH(1-34)].JOralMaxillofacSurg65(3):573-580.
Hoefert, S. and Eufinger, H. (2011): Relevance of a prolonged preoperative antibioticregimeinthetreatmentofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw.JOralMaxillofacSurg69(2):362-380.
141
Hoff,A.O.,Toth,B.B.,etal.(2008):Frequencyandriskfactorsassociatedwithosteonecrosisof the jaw incancer treatedwith intravenousbisphosphonates. JBoneMinerRes 23(6):826-836.
Holzinger,D.,Seemann,R.,etal(2013):Long-termsuccessofsurgeryinbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws(BRONJs).OralOncol49(1):66-70.
Hopf,H.W.andHolm,J.(2008):Hyperoxiaandinfection.BestPractResClinAnaesthesiol22(3):553-569.
Hsu, C.C., Chuang, Y.W., et al. (2006): Solitary fibular metastasis from lung cancermimickingstressfracture.ClinNuclMed31:269-71.
Ikebe,T.(2012):PathophysiologyofBRONJ:Drug-relatedosteoclasticdiseaseofthejaw.OralScienceInternational10:1-8.
Jabbour, Z., El-Hakim, M., et al (2012): The outcomes of conservative and surgicaltreatmentofstage2bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:acaseseries.IntJOralMaxillofacSurg41(11):1404-9.
Jackson,K.,Ashby,M.,etal.(2001):‘Burst’ketamineforrefractorycancerpain:anopen-labelauditof39patients.JPainSymptomManage22:834-42.
Kademani,D.,Koka,S.,etal.(2006):Primarysurgicaltherapyforosteonecrosisofthejawsecondarytobisphosphonatetherapy.MayoClinProc81(8):1100-1103.
Khan,A.(2008):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.CanFamPhysician 54(7):1019-1021.
Khan, A.A., Sandor, G.K., et al. (2008): Canadian Consensus Practice Guidelines forBisphosphonate Associated Osteonecrosis of the Jaw. J Rheumatol 35(7): 1391-1397.
Khosla,S.,Burr,D.,etal. (2007):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisof the jaw:reportofataskforceoftheAmericanSocietyforBoneandMineralResearch.JBoneMinerRes22(10):1479-1491.
Kobayashi,Y.,Hiraga,T.,etal.(2010):Zoledronicaciddelayswoundhealingofthetoothextractionsocket, inhibitsoralepithelialcellmigration,andpromotesproliferationandadhesion tohydroxyapatiteoforalbacteria,withoutcausingosteonecrosisofthejaw,inmice.JBoneMinerMetab28(2):165-175.
Kos,M.,Kuebler,J.F.,etal.(2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:areviewof34casesandevaluationofrisk.JCraniomaxillofacSurg38(4):255-259.
Kos, M. and Luczak, K. (2009): Bisphosphonates promote jaw osteonecrosis throughfacilitatingbacterialcolonization.BioscienceHypotheses2:34-36.
Kuhl,S.,Walter,C.,etal.(2012):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws-Areview.OralOncol48(10):938-947.
Kumar,S.K.,Gorur,A.,etal.(2010):Theroleofmicrobialbiofilmsinosteonecrosisofthejawassociatedwithbisphosphonatetherapy.CurrOsteoporosRep8(1):40-48.
Kumar,S.K.,Meru,M.,etal.(2008):Osteonecrosisofthejawssecondarytobisphosphonatetherapy:acaseseries.JContempDentPract9(1):63-69.
142
Landesberg,R.,Cozin,M.,etal.(2008):Inhibitionoforalmucosalcellwoundhealingbybisphosphonates.JOralMaxillofacSurg66(5):839-847.
Lau,A.N.andAdachi,J.D.(2009):Resolutionofosteonecrosisofthejawafterteriparatide[recombinanthumanPTH-(1-34)]therapy.JRheumatol36(8):1835-1837.
Lazarovici,T.S.,Yahalom,R.,etal.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:asingle-centerstudyof101patients.JOralMaxillofacSurg67(4):850-855.
Lee, J.J., Cheng, S.J., et al. (2011): Successful treatmentof advancedbisphosphonate-relatedosteonecrosisof themandiblewithadjunctive teriparatidetherapy. HeadNeck33(9):1366-1371.
LemoundJ.,Eckardt,A.,etal. (2012):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthemandible:reliablesofttissuereconstructionusingalocalmyofascialflap.ClinOralInvestig16(4):1143-52.
Lesclous,P.,AbiNajm,S.,etal.(2009):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:akeyroleofinflammation?Bone45(5):843-852.
Lew,D.P.andWaldvogel,F.A.(2004):Osteomyelitis.Lancet364(9431):369-379.
Magopoulos, C., Karakinaris, G., et al. (2007): Osteonecrosis of the jaws due tobisphosphonateuse.Areviewof60casesandtreatmentproposals.AmJOtolaryngol 28(3):158-163.
Marangoni, S., Bettini, G., et al. (2011). L’ossigenoterapia iperbarica non modifical’andamentodellaBRONJ:risultatidiunostudiosperimentale.AttidelXVIICongressoNazionaledellaSocietà ItalianadiChirurgiaMaxillo-Facciale (SICMF),Como, Italy.MonduzziEd.
Markose,G.,Mackenzie,F.R.,etal.(2009):Bisphosphonateosteonecrosis:aprotocolforsurgicalmanagement.BrJOralMaxillofacSurg47(4):294-297.
Martin, T.J. (2000): Report on the American Society for Bone and Mineral ResearchAnnualScientificMeeting,StLouis,MO,USA,30September-4October1999.TrendsEndocrinolMetab11(2):72-73.
Marx,R.E.,Cillo,J.E.,Jr.,etal.(2007):Oralbisphosphonate-inducedosteonecrosis:riskfactors,predictionofriskusingserumCTXtesting,prevention,andtreatment.JOralMaxillofacSurg65(12):2397-2410.
Marx, R.E., Sawatari, Y., et al. (2005): Bisphosphonate-induced exposed bone(osteonecrosis/osteopetrosis)ofthejaws:riskfactors,recognition,prevention,andtreatment.JOralMaxillofacSurg63(11):1567-1575.
Marx, R.E. and Tursun, R. (2012): Suppurative osteomyelitis, bisphosphonate inducedosteonecrosis, osteoradionecrosis: a blinded histopathologic comparison and itsimplicationsforthemechanismofeachdisease.IntJOralMaxillofacSurg41(3):283-289.
Marx, R.E. (2009): Reconstruction of defects caused by bisphosphonate-inducedosteonecrosisofthejaw.JOralMaxillofacSurg65(5suppl):107-119.
143
McLeod,N.M.,Brennan,P.A.,etal.(2012):Bisphosphonateosteonecrosisofthejaw:ahistoricalandcontemporaryreview.Surgeon10(1):36-42.
Mercandante,S.,Villari,P.,etal.(2003):BurstKetaminetoreverseopioidtoleranceincancerpain.JPainSymptomManage25:302-305.
Migliorati, C.A. (2005): Bisphosphonate-associated oral osteonecrosis. Oral Surg OralMedOralPatholOralRadiolEndod99(2):135.
Migliorati,C.A.,Epstein,J.B.,etal.(2011).Osteonecrosisofthejawandbisphosphonatesincancer:anarrativereview.NatRevEndocrinol7(1):34-42.
Migliorati,C.A.,Schubert,M.M.,etal.(2005):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisof mandibular and maxillary bone: an emerging oral complication of supportivecancertherapy.Cancer104(1):83-93.
Miksad, R.A., Lai, K.C., et al. (2011): Quality of life implications of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.Oncologist16(1):121-132.
Miller,P.D.(2011):Thekidneyandbisphosphonates.Bone49(1):77-81.
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali (settembre 2010):Raccomandazioneperlaprevenzionedell’osteonecrosidellamascella/mandiboladabifosfonati.Raccomandazionen.10.
Moretti, F., Pelliccioni,G.A., et al. (2011):A prospective clinical trial for assessing theefficacyofaminimallyinvasiveprotocolinpatientswithbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaws.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod112(6):777-782.
Mucke,T.,Haarmann,S.etal.(2009):Bisphosphonaterelatedosteonecrosisofthejawstreatedbysurgicalresectionandimmediateosseousmicrovascularreconstruction.JCraniomaxillofacSurg37(5):291-297.
MückeT.,KoschinskiJ.,etal.(2011):Outcomeoftreatmentandparametersinfluencingrecurrence in patients with bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws. JCancerResClinOncol137(5):907-13.
Muller,P.,Guggenheim,B.,etal.(2007):Efficacyofgasiformozoneandphotodynamictherapyonamultispeciesoralbiofilminvitro.EurJOralSci115(1):77-80.
Mundy, G.R. (2002): Metastasis to bone: causes, consequences and therapeuticopportunities.NatRevCancer2(8):584-593.
Naik,N.H.andRusso,T.A.(2009):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:theroleofactinomyces.ClinInfectDis49(11):1729-1732.
Narongroeknawin,P.,Danila,M.I.,etal.(2010):Bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw,withhealingafterteriparatide:areviewoftheliteratureandacasereport.SpecCareDentist30(2):77-82.
Narvaez, J., Narvaez, J.A., et al. (2012): Lack of response to teriparatide therapy forbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.OsteoporosInt.24(2):735-6
144
Neer,R.M.,Arnaud,C.D.,etal.(2001):Effectofparathyroidhormone(1-34)onfracturesandbonemineral density in postmenopausalwomenwithosteoporosis.N Engl JMed344(19):1434-1441.
Nocini,P.F.,Saia,G.,etal.(2009):Vascularizedfibulaflapreconstructionofthemandibleinbisphosphonate-relatedosteonecrosis.EurJSurgOncol35(4):373-379.
Otto, S., Hafner, S., et al. (2010): Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: ispHthemissingpartinthepathogenesispuzzle?JOralMaxillofacSurg68(5):1158-1161.
Pabst, A.M., Ziebart, T., et al. (2012): The influence of bisphosphonates on viability,migration, and apoptosis of human oral keratinocytes - in vitro study. Clin OralInvestig16(1):87-93.
PatelS.,ChoyeeS.,etal.(2012):Non-exposedbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:acriticalassessmentofcurrentdefinition,staging,andtreatmentguidelines.OralDis18(7):625-32.
Pautke,C.,Bauer,F.,etal.(2011):Flourescence-guidedboneresectioninbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws:firstclinicalresultsofaprospectivepilotstudy.JOralMaxillofacSurg69(1):84-91.
Posten, W., Wrone, D.A., et al. (2005): Low-level laser therapy for wound healing:mechanismandefficacy.DermatolSurg31(3):334-340.
Rajan P., Warner A., et al. (1999): Fibular metastasis from renal cell carcinomamasqueradingasdeepveinthrombosis.BJUInt84:735-6.
Ravosa,M.J., Ning, J., et al. (2011): Bisphosphonate effects on the behaviour of oralepithelialcellsandoralfibroblasts.ArchOralBiol56(5):491-498.
Reid,I.R.(2009):Osteonecrosisofthejaw:whogetsit,andwhy?Bone44(1):4-10.
Ripamonti, C.I., Cislaghi, E., et al. (2011): Efficacy and safety of medical ozone (O3)deliveredinoilsuspensionapplicationsforthetreatmentofosteonecrosisofthejawinpatientswithbonemetastasestreatedwithbisphosphonates:PreliminaryresultsofaphaseI-IIstudy.OralOncol47(3):185-190.
Roelofs,A.J.,Jauhiainen,M.,etal.(2009):PeripheralbloodmonocytesareresponsibleforgammadeltaTcellactivationinducedbyzoledronicacidthroughaccumulationofIPP/DMAPP.BrJHaematol144(2):245-250.
Romeo, U., Galanakis, A., et al. (2011): Observation of pain control in patients withbisphosphonate-induced osteonecrosis using low level laser therapy: preliminaryresults.PhotomedLaserSurg29(7):447-452.
Rowshan,H.H.,Parham,M.A.,etal.(2010):Effectofintermittentsystemicadministrationofrecombinantparathyroidhormone(1-34)onmandibularfracturehealinginrats.JOralMaxillofacSurg68(2):260-267.
Ruggiero,S.L.,Dodson,T.B.,etal.(2009):AmericanAssociationofOralandMaxillofacialSurgeonspositionpaperonbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws--2009update.JOralMaxillofacSurg67(5Suppl):2-12.
145
Ruggiero, S.L. and Drew, S.J. (2007): Osteonecrosis of the jaws and bisphosphonatetherapy.JDentRes86(11):1013-1021.
Ruggiero,S.L.,Fantasia,J.,etal.(2006):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw:backgroundandguidelinesfordiagnosis,stagingandmanagement.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod102(4):433-441.
Ruggiero, S.L. andMehrotra, B. (2009): Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosis of theJaw:Diagnosis,Prevention,andManagement.AnnuRevMed60:85-96.
Ruggiero,S.L.andWoo,S.B.(2008):Biophosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.DentClinNorthAm52(1):111-128.
Saia,G.,Blandamura,S.,etal.(2010):Occurrenceofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawaftersurgicaltoothextraction.JOralMaxillofacSurg68(4):797-804.
Scoletta, M., Arduino, P.G. et al. (2010): Effect of low-level laser irradiation onbisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws: preliminary results of aprospectivestudy.PhotomedLaserSurg28(2):179-184.
Sedghizadeh, P.P., Kumar, S.K., et al. (2008): Identification of microbial biofilms inosteonecrosisof the jaws secondary tobisphosphonate therapy. JOralMaxillofacSurg66(4):767-775.
Sedghizadeh,P.P.,Kumar,S.K.,etal.(2009):Microbialbiofilmsinosteomyelitisofthejawandosteonecrosisofthejawsecondarytobisphosphonatetherapy.JAmDentAssoc 140(10):1259-1265.
SethR.,FutranN.D.,etal (2010):Outcomesofvascularizedbonegraftreconstructionofthemandibleinbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.Laryngoscope120(11):2165-71.
Stockmann,P., Vairaktaris, E., et al. (2010):Osteotomyandprimarywound closure inbisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: a prospective clinical studywith12monthsfollow-up.SupportCareCancer18(4):449-460.
Stubinger, S., Dissmann, J.P., et al. (2009). A preliminary report about treatment ofbisphosphonaterelatedosteonecrosisofthejawwithEr:YAGlaserablation.LasersSurgMed41(1):26-30.
Subramanian, G., Cohen, H.V., et al. (2011): A model for the pathogenesis ofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejawandteriparatide’spotentialroleinitsresolution.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod112(6):744-753.
Terpos, E., Sezer, O., et al. (2009): The use of bisphosphonates inmultiplemyeloma:recommendationsofanexpertpanelonbehalfoftheEuropeanMyelomaNetwork.AnnOncol20(8):1303-1317.
Totola, A., Bettini, G., et al. (2010): Caratteristiche dell’osso alveolare in corso ditrattamentoconamino-bisfosfonati:risultatidiunostudiopilotacaso-controllo.Attidel Congresso:Osteonecrosi deimascellari - prevenzione, diagnosi, trattamento -Update2010,Alessandria.
Tsai,K.Y.,Huang,C.S.,etal.(2010):Moreontheresolutionofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw.JRheumatol37(3):675;authorreply676.
146
Tubiana-Hulin,M., Spielmann,M., et al. (2009): Physiopathology andmanagementofosteonecrosis of the jaws related to bisphosphonate therapy formalignant bonelesions.AFrenchexpertpanelanalysis.CritRevOncolHematol71(1):12-21.
Urade, M., Tanaka, N., et al. (2011): Nationwide survey for bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejawsinJapan.JOralMaxillofacSurg69(11):364-371.
Vahle, J.L., Sato, M., et al. (2002): Skeletal changes in rats given daily subcutaneousinjections of recombinant human parathyroid hormone (1-34) for 2 years andrelevancetohumansafety.ToxicolPathol30(3):312-321.
Vescovi, P., Manfredi, M., et al. (2012): Early surgical laser-assisted management ofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws(BRONJ):aretrospectiveanalysisof101treatedsiteswithlong-termfollow-up.PhotomedLaserSurg30(1):5-13.
Vescovi,P.,Manfredi,M.,etal.(2010):SurgicalapproachwithEr:YAGlaseronosteonecrosisofthe jaws(ONJ) inpatientsunderbisphosphonatetherapy(BPT).LasersMedSci 25(1):101-113.
Vescovi, P.,Merigo, E., et al. (2008): Nd:YAG laser biostimulation in the treatment ofbisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:clinicalexperiencein28cases.PhotomedLaserSurg26(1):37-46.
Vescovi,P.,Merigo,E.,etal.(2006):Bisphosphonate-associatedosteonecrosis(BON)ofthejaws:apossibletreatment?JOralMaxillofacSurg64(9):1460-1462.
Vescovi,P.,Merigo,E.,etal.(2012):Bisphosphonates-relatedosteonecrosisofthejaws:aconcisereviewoftheliteratureandareportofasingle-centreexperiencewith151patients.JOralPatholMed41(3):214-221.
Vescovi,P.andNammour,S.(2010):Bisphosphonate-RelatedOsteonecrosisoftheJaw(BRONJ)therapy.Acriticalreview.MinervaStomatol59(4):181-203,204-113.
Voss, P.J., Joshi Oshero, J., et al. (2012): Surgical treatment of bisphosphonate-associatedosteonecrosisofthejaw:Technicalreportandfollowupof21patients.JCraniomaxillofacSurg40(8):719-25.
Wei, X., Pushalkar, S., et al. (2012):Molecular profilingof oralmicrobiota in jawbonesamples of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.Oral Dis 18(6): 602-612.
Wen,D.,Qing,L.,etal(2011):Anatomicsitevariabilityinratskeletaluptakeanddesorptionoffluorescentlylabeledbisphosphonate.OralDis17(4):427-32.
Wilde,F.,Heufelder,M.,etal.(2011):Theroleofsurgicaltherapyinthemanagementofintravenousbisphosphonates-relatedosteonecrosisofthejaw.OralSurgOralMedOralPatholOralRadiolEndod111(2):153-163.
Williamson,R.A.(2010):Surgicalmanagementofbisphosphonateinducedosteonecrosisofthejaws.IntJOralMaxillofacSurg39(3):251-255.
Woo,S.B.,Hellstein, J.W.,etal. (2006):Narrative [corrected] review:bisphosphonatesandosteonecrosisofthejaws.AnnInternMed144(10):753-761.
147
Wutzl, A., Biedermann, E., et al. (2008): Treatment results of bisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.HeadNeck30(9):1224-1230.
Wutzl,A.,Pohl,S.,etal.(2012):Factorsinfluencingsurgicaltreatmentofbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaws.HeadNeck34(2):194-200.
Yamazaki,Y.,Kitagawa,Y.,etal. (2010):UseofFDGPETtoevaluatehyperbaricoxygentherapyforbisphosphonate-relatedosteonecrosisofthejaw.ClinNuclMed35(8):590-591.
Yoneda,T.,Hagino,H.,etal. (2010):Bisphosphonate-relatedosteonecrosisof the jaw:positionpaperfromtheAlliedTaskForceCommitteeofJapaneseSocietyforBoneandMineralResearch,JapanOsteoporosisSociety,JapaneseSocietyofPeriodontology,JapaneseSocietyforOralandMaxillofacialRadiology,andJapaneseSocietyofOralandMaxillofacialSurgeons.JBoneMinerMetab28(4):365-383.
App
endi
ce 4
: pro
toco
llo te
rape
utico
del
la B
RON
J
TERA
PIA
Stad
io 1
(BRO
NJ
foca
le)
Prot
ocol
lo s
tand
ard:
teR
aPi
a m
edic
O-c
hiR
uR
gic
a c
Om
bin
ata
Chir
urgi
a
den
to-a
lveo
lare
Tera
pia
anti
setti
ca
topica
Tera
pia
anti
bioti
ca
sistem
icape
riop
eratoria
Sosp
ensi
one
peri
oper
ator
ia N
BP
Dett
aglio
per
chi
rurg
ia d
ento
-alv
eola
re:
cure
ttag
e os
seo,
eve
ntua
lmen
te a
ssoc
iato
a s
eque
stre
ctom
ia e
/o fi
stol
ecto
mia
, 1.
(ane
stesialo
cale/loco-region
ale)con
utilizzodilem
bim
uco-pe
riosteip
erla
chiusuraprimariadelsito
chirurgico,in
assen
zaditen
sion
e;ch
irur
gia
rese
ttiva
mar
gina
le2.
,(ane
stesialocale/loco-regiona
le):aspo
rtazione
dicassett
oosseo-de
ntoalveolare,osteo
plasticadirim
odellamen
todeibordi,
chiusuraprimariadelsito
chirurgicoconlembim
uco-pe
riostei,inassen
zaditen
sion
e.
Indi
cazi
one:re
cidivadiB
RONJd
opocurettageosseo
Cons
iglia
bile:impiegodipiezochirurgiaechirurgialaser-assistitaperridurreiltrau
mati
smosuossoemucoseorali
Dett
aglio
per
tera
pia
anti
setti
ca:
stad
io 1
a (a
ssen
za d
i sup
pura
zion
e): c
lore
xidi
na a
lcoo
lica
0.2%
(2 s
ciac
qui/
die)
dalgiornode
ll’op
erazione
fino
allagua
rigion
ede
lsito
diintervento
stad
io 1
b (p
rese
nza
di s
uppu
razi
one)
: clo
rexi
dina
alc
oolic
a 0.
2%(
2 sc
iacq
ui/d
ie) da
iniziare1setti
man
aprim
ade
ll’interven
toecon
tinua
refino
allagua
rigion
ede
lsitochirurgico
Dett
aglio
per
tera
pia
anti
bioti
ca s
iste
mic
a:
stad
io 1
a (a
ssen
za d
i sup
pura
zion
e)M
olec
ola
: a
mox
icill
ina
+ ac
ido
clav
ulan
ico1 [1
grx3/die] o
sul
tam
icill
ina1 [7
50mgx3/die].Possibileassociazion
econ
met
roni
dazo
lo2 [5
00mgx3/die].Inpazienti
conallergiaaccertataapen
icillinesono
con
sigliabili
erit
rom
icin
a, c
linda
mic
ina
o ci
profl
oxac
ina
Via
di s
omm
inis
traz
ione
: p
er o
sD
urat
a:
da
lgiornode
ll’interven
toper7-10giorniofino
allagua
rigion
ede
lsito
chirurgico
stad
io 1
b (p
rese
nza
di s
uppu
razi
one)
Mol
ecol
a
: am
oxic
illin
a +
acid
o cl
avul
anic
o1 [1grx3/die] o
sul
tam
icill
ina1 [7
50mgx3/die]associataam
etro
nida
zolo
2 [500
mgx3/die].Inpazienti
con
allergia
accertataape
nicilline
son
oconsigliabili
erit
rom
icin
a, c
linda
mic
ina
o ci
profl
oxac
ina
Via
di s
omm
inis
traz
ione
: p
er o
sD
urat
a
:dainiziarsi1setti
man
aprim
ade
ll’interven
toecon
tinua
reper7-10giorniofino
allagua
rigion
ede
lsito
chirurgico
Dett
aglio
per
sos
pens
ione
NBP
:ècon
sigliabilelasospe
nsione
dell’N
BPdalm
omen
todellachirurgiaallagua
rigion
ebiolog
icade
itessuti(4-6setti
man
e),sop
rattutt
one
lcasodip
azienteon
cologicoin
terapiaconNBP
e.v.m
ensile,sen
titoilpa
reredelm
edicoprescrittore
mon
itor
aggi
o po
st-o
pera
tori
o:visita
dicon
trolloa1-3-6-12mesi.Esam
eTC
dicon
trolloa6e12mesi.Incasodigua
rigion
eilpa
zien
terientranelfo
llow-up.
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--Pr
otoc
olli
alte
rnati
vi: t
eRa
Pia
med
ica
nO
n c
hiR
uRg
ica.D
aconsiderarsidop
orifiu
todapa
rtede
lpaziente,onell’impo
ssibilitàdiapp
licazione
delprotocollo
stand
ard.
Late
rapiamed
icano
nchirurgicacon
stadite
rapiaan
tisetti
cadim
antenimen
tocon
clorexidina
0.12%
non
alcoo
lica(2sciacqu
i/die pe
r7giornialm
ese)editerap
ia
antib
ioticacomepe
rstad
io1b,dainiziareallacom
parsadidoloreesupp
urazione
eprosegu
ireper7-10giorni.U
tileassociareisegue
ntipresidi:
bios
timol
azio
ne (o
zono
tera
pia,
lase
r)
ossi
geno
tera
pia
iper
baric
a
terip
arati
de (s
olo
in p
azie
nte
oste
opor
otico
e n
on o
ncol
ogic
o)
stad
io 2
(BRO
NJ
diff
usa)
Prot
ocol
lo s
tand
ard:
teR
aPi
a m
edic
O-c
hiR
uR
gic
a c
Om
bin
ata
Chir
urgi
a
rese
ttiva
Tera
pia
anti
setti
ca
topica
Tera
pia
anti
bioti
ca
sistem
icape
riop
eratoria
Sosp
ensi
one
peri
oper
ator
ia N
BP
Dett
aglio
per
Chi
rurg
ia re
setti
va:
mar
gina
le
1.
(ane
stesialoco-regiona
leonarcosi):aspo
rtazione
dicassettoosseo-de
ntoalveolare,osteo
plasticadirimod
ellamen
todeibordi,chiusuraprim
ariadel
sitochirurgicoconlembim
uco-pe
riosteiinassenzadite
nsione
Indi
cazi
one:perlo
calizzazion
eman
dibo
larediB
RONJ;con
sigliabilein
primaistanzainpazienti
intratt
amen
tocon
NBP
perpatolog
iaosteo
metab
olica
segm
enta
le
2.
(ane
stesiagen
erale):aspo
rtazione
atutt
ospessoredell’ossocoinvolto
,inclusivode
lpe
riostio
,pe
rviaintrao
raleesclusiva(mascellare)ointra
extra-oralecombina
ta(man
dibo
la);con
servazione
deitessutimolli(m
ucoseecute)ne
lsito
diresezione
ossea(consen
titaaspo
rtazione
seletti
vadifi
stole);
ricostruzion
eman
dibo
larecon
placcaintitanioincasodiemi-m
andibu
lectom
ia;lembo
dipe
rone
vascolarizzatoincasodim
andibu
lectom
iasub
totale.
Ricostruzion
emascellarecon
lembo
diBicha
tpersep
arazione
dellecavità
naso-sinu
sali;ricostruzion
econlembo
diperon
evascolarizzatoincasodiasportazion
ede
llam
esostrutt
ura;valutazione
preop
eratoriadeim
arginidiresezione
inte
ssutoosseoradiolog
icam
entein
tegroallaTCeMR;e
sameistologicosep
aratode
imarginidiresezione
.
Indi
cazi
one:perlo
calizzazion
emascellarediB
RONJ,perre
cidivaBRO
NJd
oporesezion
emargina
ledellam
andibo
la.
Cons
iglia
bile
:impiegodipiezochirurgiaechirurgialaser-assistitaperridurreiltrau
mati
smo
Dett
aglio
per
Ter
apia
anti
setti
ca:
stad
io 2
a
(ass
enza
di s
uppu
razi
one)
: clo
rexi
dina
alc
oolic
a 0.
2%(2
sci
acqu
i/di
e) dalgiornode
ll’op
erazione
fino
allagua
rigion
ede
lsito
diintervento;
stad
io 2
b
(pr
esen
za d
i sup
pura
zion
e):
clor
exid
ina
alco
olic
a 0.
2%(
2 sc
iacq
ui/d
ie) iniziata1setti
man
aprim
ade
ll’interven
toefino
allagua
rigion
ede
lsito
di
interven
to
Dett
aglio
per
tera
pia
antib
iotic
a si
stem
ica:
stad
io 2
a (a
ssen
za d
i sup
pura
zion
e)M
olec
ola:
sulb
acta
m/a
mpi
cilli
na1 [1grx3/die] o
ceft
riax
one3 a
ssociataaM
etro
nida
zolo
2 [500
mgx3/die].Inpazienti
con
allergiaaccertataapen
icillinesono
consigliabili
erit
rom
icin
a, c
linda
mic
ina
o ci
profl
oxac
ina
Via
di s
omm
inis
traz
ione
: sistemicae.v.
Dur
ata:
dalgiornode
ll’interven
toper7-10giorniofino
allagua
rigion
ede
lsito
chirurgico
stad
io 2
b (p
rese
nza
di s
uppu
razi
one)
Mol
ecol
a
: pr
eope
rato
rio: a
mox
icill
ina
+ ac
ido
clav
ulan
ico1
[1grx3/die],
o su
ltam
icill
ina [750
mgx2/die]associataam
etro
nida
zolo
2 [500
mgx3/die]
peri-
post
oper
ator
io: s
ulba
ctam
/am
pici
llina
1 [1
grx3/die] o
ceft
riax
one3 a
ssociataam
etro
nida
zolo
2 [500
mgx3/die]
Inpazienti
con
allergiaaccertataapen
icillinesono
con
sigliabili
erit
rom
icin
a, c
linda
mic
ina
o ci
profl
oxac
ina
Via
di s
omm
inis
traz
ione
: p
erospreo
peratoria,sistemicapo
st-ope
ratoria
Dur
ata:
dain
iziarsi1setti
man
aprim
ade
ll’interven
toecon
tinua
reper7-10giorniofino
allagua
rigion
ede
lsito
chirurgico
Dett
aglio
per
sos
pens
ione
NBP
:ècon
sigliabilelasospe
nsione
dell’N
BPdalm
omen
todellachirurgiaallagua
rigion
ebiolog
icade
itessuti(4-6setti
man
e),sop
rattutt
one
lcasodiu
npa
zien
teoncolog
icointe
rapiaconNBP
e.v.m
ensile,sen
titoilpa
reredelm
edicoprescrittore.
mon
itor
aggi
o po
st-o
pera
tori
o:visita
dicon
trolloa1-3-6-12mesi.Esam
eTC
dicon
trolloa6e12mesi.Incasodigua
rigion
eilpa
zien
terientranelfo
llow-up.
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--Pr
otoc
olli
alte
rnati
vi: t
eRa
Pia
med
ica
nO
n c
hiR
uRg
ica.D
aconsiderarsidop
orifiu
todapa
rtede
lpaziente,onell’impo
ssibilitàdiapp
licazione
delprotocollo
stand
ard.
Late
rapiamed
icano
nchirurgicacon
stadite
rapiaan
tisetti
cadim
antenimen
tocon
clorexidina
0.12%
non
alcoo
lica(2sciacqu
i/die pe
r7giornialm
ese)editerap
ia
antib
ioticacomepe
rstad
io1b,dainiziareallacom
parsadidoloreesupp
urazione
eprosegu
ireper7-10giorni.U
tileassociareisegue
ntipresidi:
bios
timol
azio
ne (o
zono
tera
pia,
lase
r)
ossi
geno
tera
pia
iper
baric
a
terip
arati
de (s
olo
in p
azie
nte
oste
opor
otico
e n
on o
ncol
ogic
o)
Stad
io 3
(BRO
NJ
com
plic
ata)
Prot
ocol
lo s
tand
ard:
teR
aPi
a m
edic
O-c
hiR
uR
gic
a c
Om
bin
ata
Chir
urgi
a
rese
ttiva
Tera
pia
anti
setti
ca
topica
Tera
pia
anti
bioti
ca
sistem
icape
riop
eratoria
Sosp
ensi
one
peri
oper
ator
ia N
BP
Dett
aglio
per
Chi
rurg
ia re
setti
va:
segm
enta
le (an
estesiagene
rale):aspo
rtazione
atutt
ospessoredell’ossocoinvolto
,inclusivode
lpe
riostio
,pe
rviaintrao
raleesclusiva(mascellare)ointra
extra-oralecombina
ta(man
dibo
la);con
servazione
deitessutimolli(m
ucoseecute)ne
lsito
diresezione
ossea(consen
titaaspo
rtazione
seletti
vadifi
stole);
ricostruzion
eman
dibo
larecon
placcaintitanioincasodiemi-m
andibu
lectom
ia;lembo
dipe
rone
vascolarizzatoincasodim
andibu
lectom
iasub
totale.
Ricostruzion
emascellarecon
lembo
diBicha
tpersep
arazione
dellecavità
naso-sinu
sali;ricostruzion
econlembo
diperon
evascolarizzatoincasodiasportazion
ede
llam
esostrutt
ura;valutazione
preop
eratoriadeim
arginidiresezione
inte
ssutoosseoradiolog
icam
entein
tegroallaTCeMR;esameistologicosep
aratode
imarginidiresezione
.In
dica
zion
e:pazienti
inNBP
perm
alatti
eon
cologiche,ovverorecidivaBRO
NJd
oporesezion
emargina
le,inpa
zien
ticonmalatti
adibasegiud
icatastab
ile
dalcuran
te
Cons
iglia
bile
:impiegodipiezochirurgiaechirurgialaser-assistitaperridurreiltrau
mati
smo
Dett
aglio
per
Ter
apia
anti
setti
ca:
clor
exid
ina
alco
olic
a 0.
2%(2
sci
acqu
i/di
e) dalgiornode
ll’op
erazione
fino
allagua
rigion
ede
lsito
diintervento
Cons
iglia
bile
: in
pres
enza
di i
mpo
rtan
te s
ecre
zion
e pu
rule
nta,
tera
pia
antis
ettica
pre
oper
ator
ia c
ome
per s
tadi
o 2b
Dett
aglio
per
tera
pia
antib
iotic
a si
stem
ica:
Mol
ecol
a:
su
lbac
tam
/am
pici
llina
1 [1grx3/die] o
ceft
riax
one3 a
ssociataaM
etro
nida
zolo
2 [500
mgx3/die].Inpazienti
con
allergiaaccertataapen
icillinesono
consigliabili
erit
rom
icin
a, c
linda
mic
ina
o ci
profl
oxac
ina
Via
di s
omm
inis
traz
ione
: sistemicae.v.
Dur
ata:
dalgiornode
ll’interven
toper7-10giorniofino
allagua
rigion
ede
lsito
chirurgico
Cons
iglia
bile
: in
pres
enza
di i
mpo
rtan
te s
ecre
zion
e pu
rule
nta,
tera
pia
antib
iotic
a pr
eope
rato
ria c
ome
per s
tadi
o 2b
.
Dett
aglio
per
sos
pens
ione
NBP
:ècon
sigliabilelasospe
nsione
dell’N
BPdalm
omen
todellachirurgiaallagua
rigion
ebiolog
icade
itessuti(4-6setti
man
e),sop
rattutt
one
lcasodiu
npa
zien
teoncolog
icointe
rapiaconNBP
e.v.m
ensile,sen
titoilpa
reredelm
edicoprescrittore
mon
itor
aggi
o po
st-o
pera
tori
o:visita
dicon
trolloa1-3-6-12mesi.Esam
eTC
dicon
trolloa6e12mesi.Incasodigua
rigion
eilpa
zien
terien
trane
lfollow-updiprevenzione
de
llaBRO
NJ
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--Pr
otoc
olli
alte
rnati
vi: t
eRa
Pia
med
ica
nO
n c
hiR
uRg
ica.D
aconsiderarsidop
orifiu
todapa
rtede
lpaziente,onell’impo
ssibilitàdiapp
licazione
delprotocollo
stand
ard.
Late
rapiamed
icano
nchirurgicacon
stadite
rapiaan
tisetti
cadim
antenimen
tocon
clorexidina
0.12%
non
alcoo
lica(2sciacqu
i/die pe
r7giornialm
ese)editerap
ia
antib
ioticacomepe
rstad
io1b,dainiziareallacom
parsadidoloreesupp
urazione
eprosegu
ireper7-10giorni.U
tileassociareisegue
ntipresidi:
bios
timol
azio
ne (o
zono
tera
pia,
lase
r)
ossi
geno
tera
pia
iper
baric
a
terip
arati
de (s
olo
in p
azie
nte
oste
opor
otico
e n
on o
ncol
ogic
o)
1 atti
vicon
troGram-negati
vieGram-positiviβ-la
ttam
asiresistenti
2 prevenzione
delleinfezion
ipost-op
eratoriecau
satedaba
tteriana
erob
i,pa
rticolarm
enteBacteroidesecocchigram-positiviana
erob
i3 a
ttivicon
troGram-negati
viofloramistacon
presenzadiGram-negati
vire
sisten
tiaipiùcom
unianti
bioti
ci-uti
lein
pazienti
defed
ati


































































































































































![CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 2010[1]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/6194d09b1254ae5fee4bd7b5/chirurgia-maxillo-facciale-20101.jpg)