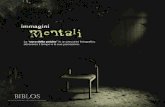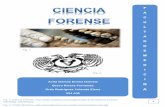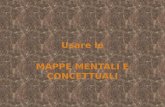SIMULAZIONE DELLE MALATTIE MENTALI IN AMBITO FORENSE ...
Transcript of SIMULAZIONE DELLE MALATTIE MENTALI IN AMBITO FORENSE ...

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA
CORSO DI FORMAZIONE
IN
PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE
2017
SIMULAZIONE DELLE MALATTIE MENTALI IN
AMBITO FORENSE:
NUOVI STRUMENTI VALUTATIVI.

“La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa necessariamente
attraverso la conoscenza di se stessi.”
Italo Calvino. (1923-1985)
INTRODUZIONE
Saper fingere può anche essere una virtù. Non è da tutti e per tutti la
simulazione di patologia mentale. Facile sembrerebbe agli occhi di chi non
conosce le sottigliezze della psicopatologia. Simulare un mal di pancia
potrebbe essere alla mercé di molti, ma entrare nel ruolo di paziente con
malattia mentale presuppone una conoscenza totale di ciò che si vuol simulare.
In ambito clinico il tentativo di smascherare un simulatore potrebbe
non essere di alcuna utilità; cardine dell’efficacia di una terapia dovrebbe
essere infatti l’alleanza terapeutica, l’eliminazione di ogni forma di
pregiudizio, l’essere acritici e l’aver un rapporto di fiducia con il paziente.
Quando però si affaccia il dubbio di simulazione di patologia mentale, il
clinico si deve dare la possibilità di riuscire a svelare l’inganno. Lo psicologo
giuridico e lo psichiatra invece possono essere chiamati a verificare la
veridicità della malattia dichiarata durante una perizia e/o consulenza.
Dopo un breve escursus storico sull’origine della simulazione e le varie
caratteristiche e declinazioni dei vari contesti penali e civili dove la
simulazione porta vantaggi, si passa ad illustrare le teorie psicologiche che
hanno tentato di spiegare i perché della simulazione.
Il corpo centrale dell’elaborato illustra e descrive l’esame peritale e
l’utilizzo dei nuovi tests per rivelare la simulazione: la SIRS-2 intervista
strutturata creata appositamente per misurare la simulazione, il SIMS
questionario di autovalutazione per il riconoscimento della simulazione e il
PAI test di personalità. Non ho ritenuto opportuno illustrare altri tests come:
MCMI IV, TOMM e M-FAST in quanto tests non ancora tradotti e validati in
Italia. Per quanto attiene al V.M.G.T. di L. Bender, WAIS nelle sue varie

forme, Scale Wechsler di Memoria, Figura complessa di REY e Disegno della
figura umana analizzata sia con il metodo teorizzato da Machover che da
quello “globale” di Koppitz, questi, non sono stati trattati in quanto non
rappresentano una novità nell’ambito dei tests di rilievo per la simulazione
delle malattie mentali in ambito forense.
Un discorso a parte meritano l’MMPI-2, il test Rorschach.
Il test MMPI2 a venti anni dalla pubblicazione in Italia è stato da poco ri-
standardizzato con un miglioramento nella formulazione testuale di alcuni
items oramai lontani dal linguaggio e dalla cultura odierna e con nuovi
riferimenti normativi relativi ad un nuovo campione d’esame e pertanto è stato
riportato nel seguente elaborato.
In merito al test di Rorschach criticato negli stati uniti già a partire
dagli anni ’50 e ’60, il cosidetto Rorschach controversy o Rorschach Debate
non si è mai esaurito nel mondo scientifico neanche in seguito della
pubblicazione di “The Rorschach: A Compresive System” da parte di Exner
nel 1974, si consideri il fatto che a partire dal 2000 la Presidential Task Force
sull’Assessment della Division 12 (Clinical Psychology) dell’American
Psychological Association (APA) ha sconsigliato di proseguire
l’insegnamento delle tecniche proiettive nei cicli formativi universitari per
psicologi. Inoltre, in alcuni stati USA, l’utilizzo di tali tecniche di indagine non
viene ammesso nel processo, in quanto non sempre è stato valutato che esse
raggiungano gli standard richiesti per le prove scientifiche (ad es. il criterio
Daubert); in alcuni casi, è avvenuto che consulenti esperti venissero ricusati,
per aver basato le proprie conclusioni su tecniche proiettive, essi possono
addirittura rischiare per questo procedimenti di natura deontologica.
Numerosi articoli riguardanti lo stato scientifico del Rorchach CS apparsi
negli anni nelle maggiori riviste del settore (Psychological Assessment,
Assessment e Journal of Clinical Psychology) hanno sempre messo in dubbio
le sue capacità psicometriche e di individuazione della simulazione.
Da uno studio di Roberto Catanesi (2010, Lecce. Intervento
sull’infermità di mente e responsabilità penale) sui tests più usati in psichiatria
forense in USA e Canada si rileva che risulta usata la WAIS nel 76% dei casi,

l’MMPI2 nel 68% dei casi, il Wechsler Memory Scale nel 51%, il test di
Bender nel 34% e il Rorschach al 23° posto nel 14% delle casistiche anche
dopo il SIMS.
Nel Regno Unito al primo posto troviamo il test di Millon, il Psychopathy
Check-List-revisited, WAIS, MMP-2, il Culture-free Self-Esteem Inventory, il
Personality Diagnostic Questionnaire mentre poco usato è il Rorschach e per
procedimenti penali di poco conto.
In Australia troviamo in ambito forense WAIS, REY Complex Figure Test,
MMPI-2, mentre al Rorschach non viene data importanza.
In altri paesi il Rorschach è poco più che un test folkloristico.
In Italia invece troviamo le seguenti stime di utilizzo:
nei procedimenti penali il Rorschach nel 76% e l’MMPI-2 nel 36% mentre nei
procedimenti civili il Rorschach nel 79% e l’MMPI-2 nel 49% dei casi.
Evidente per l’affetto che gli psicologi italiani nutrono per questo test.
Pertanto con le dovute valutazioni a riguardo si ritenuto utile inserirlo in
questa trattazione.

PREAMBOLO
“La verità al fine non si cela; non val simulazione.
Simulazion è frustrata avanti a tanto giudice.”
Leonardo Da Vinci. (1452-1519)
Alla voce SIMULAZIONE, dal latino SIMULATIO-ONIS, denominativo di
SIMUL (insieme) SIMILIS (simile), fare il simile, darsi l’aspetto,
rappresentare; nel vocabolario Treccani troviamo scritto:
“qualsiasi atto che tende a far sorgere in altri un falso giudizio”, sono
riportati diversi specifici significati, tra l’altro …”simulazione di infermità”
reato consistente in una falsa affermazione di malattia nel caso di un militare,
… per ottenere un riconoscimento di una data condizione psicofisica
nell’ambito della medicina legale, ecc…
La simulazione accompagna l’uomo fin dalla sua nascita, la naturale tendenza
dell’essere umano a mettere in atto fenomeni di finzione per ottenere un
vantaggio è comune a molte altre specie animali, (fenomeno del mimetismo)
alcune esempi sono il fingersi morto per cacciare o per sopravvivere ad un
attacco, fingere una gravidanza per nutrimento o protezione e via dicendo, la
simulazione per la propria incolumità e sopravvivenza, ha subìto, al pari
dell’evoluzione umana un cambiamento, una intenzionalità scaturita dalla
dimensione psicologica caratteristica dell’essere umano.
Proprio questa relazione indivisibile tra simulazione e coscienza, intesa come
“coscienza di qualcosa”, “capacità di significare” e quindi comunicare,
conduce obbligatoriamente l’incognita della simulazione di malattia e nel
nostro caso di malattia mentale alla sua specificità antropologica in quanto
rappresentante della complessità dell’esistenza umana.
Nella storia molti sono gli episodi di simulazione di stati morbosi che sono stati
descritti e segnalati.

“Per molte ragioni gli uomini fingono di esser ammalati, sembra addunque opportuno
che il medico sappia scoprire la verità in tutti i casi di tal fatta…”
Claudius Galenus. (130 -210 )
Nei racconti di Plutarco:
“… Nicia, durante la seconda guerra punica, per evitare di essere consegnato
ai Cartaginesi, finse di essere pazzo davanti al popolo riunito in assemblea.”
“… Soside si autoinferse una ferita attribuendola ai mercenari di Dione. I
medici esaminata la ferita, la considerarono troppo superficiale per essere stata
provocata dal taglio di una spada: le lesioni prodotte da questo tipo di arma,
infatti, sono più profonde al centro, per il peso dell’arma. Al contrario, la ferita
di Soside era superficiale in tutta la sua lunghezza, e presentava molti punti di
inizio come è normale quando ci si colpisce da soli e ci si infligge dei colpi
attenuati in quanto si prova dolore … L’uomo a quel punto fu condannato a
morte.”
Dagli annali di Tacito:
“… Sotto il regno di Tiberio, muore la moglie del pretore Plauzio Silvano,
caduta di notte nel giardino della camera matrimoniale. Il padre della donna
trascina il marito in giudizio davanti a Tiberio. Plauzio Silvano dice
all’imperatore che la giovane si era buttata giù di sua volontà, mentre lui
dormiva e non sapeva cosa stava accadendo. Tiberio allora si reca a controllare
sul posto e scopre segni evidenti di lotta e resistenza. Si tratta di una finta
pazzia, shock dopo un dramma? Il marito non sa, non ricorda, non parla chiaro.
L’imperatore, dopo avere esaminato tutto, si rende conto che non si tratta di un
suicidio ma di un omicidio, riferisce al Senato e vengono designati i giudici.
Poi capisce e capiscono tutti che in caso di processo, essendo coinvolte persone
di un livello sociale elevato, verranno fuori dettagli spiacevoli per tutti. La
nonna Urgulania manda un pugnale all’imputato, che non ha il coraggio di
suicidarsi, ma si fa recidere le vene da uno schiavo.”

Galeno in una sua opera che dedica alla simulazione “De quomodo morborum
simulantes sint deprehendendi” scrive di lesioni artificialmente provocate per
trarre altrui in inganno e poi continua:
“... per molte ragioni gli uomini fingono di essere ammalati. E’, dunque
opportuno che il medico sappia scoprire la verità in tutti i casi di tal fatta!!!
Così è lecito distinguere lo sputo sanguigno proveniente dalle parti vicine alla
bocca da quello originato da qualche parte degli organi respiratori!!! E invero
furono scoperti alcuni che tossivano volontariamente sputando sangue alla fine
della tosse, chè in essi si apriva una venuzza a loro volontà!!! Alcuni poi
fingevano di delirare e di essere stolti e cercavano di far stolti gli altri!!!”
In tutto il medioevo la simulazione di malattie permette a mendicanti e briganti
la sopravvivenza attraverso l’offerta di elemosine e la possibilità di ladri ed
assassini di mostrarsi innocenti.
Lutero così riporta:
“… c’erano individui che all’ora della Messa accorrevano in chiesa e quando
il celebrante impartiva la benedizione si mettevano in bocca un pezzo di sapone
con cui producevano schiuma dalla bocca … ed erano presi da convulsioni, si
buttavano a terra sotto gli occhi di tutti. Così potevano star sicuri di ricevere
elemosina dai fedeli.”
Per farsi un idea di quanto fosse diffuso il fenomeno basti citare la “corte dei
miracoli” un insediamento alla periferia della vecchia Parigi dove trovavano
rifugio imbroglioni e briganti e i ciechi ritrovavano la vista, i sordi l’udito, gli
zoppi riprendevano a camminare e gli altri infermi miracolosamente
recuperavano la salute.
In seguito, tali fenomeni vengono sempre più individuati e sanzionati è nel
1288 che a Bologna si costituisce un vero e proprio albo dei medici periti volto
all’accertamento delle condizioni mediche dei pazienti e allo smascheramento
delle simulazioni.
Voglio fornire un ultimo accenno alle simulazioni nella storia riferendomi ai
primi anni del 900 dove nelle carceri napoletane la follia era simulata anche
solo per ottenere il vitto da malato, di poco migliore rispetto a quello dei
detenuti ordinari e anche nel periodo bellico della Prima guerra mondiale in

Italia, dove accanto al fenomeno della simulazione aumenta quello
dell’autolesionismo, una disposizione nel 1917 istituisce ospedali per
autolesionisti dove il sospettato era sottoposto ad esami per l’accertamento
dello stato reale e dando priorità più a questo che alle cure, anche con specifici
provvedimenti presi prima e dopo le dimissioni (punizioni, invio al fronte ecc
ecc).
“In questi ospedali specializzati non sempre fu facile reperire la prova della
frode, del mezzo lesivo e neppure del primitivo meccanismo d’azione.”
In ogni caso studiando i grafici all’uopo instituiti, si vide che,
corrispondentemente ai periodi di grandi azioni, aumentava in modo
considerevole, il numero dei ricoverati.
Le ferite alle mani rappresentavano da sole circa i 4/5 del totale e quelle alla
mano sinistra preponderavano notevolmente su quelle della mano destra.
“Altra malattia frequentemente simulata era la sciatica. Se ne imparava
dapprima con l’aiuto dei medici italiani, pur essi prigionieri la sintomatologia
più appariscente: dalla particolare zoppia, alla reazione dolorosa, durante la
pressione sui Valleix ed il segno di Lasègue.
E per meglio completare il quadro, si provocava un atrofia dell’arto interessato,
assoggettandolo ad una immobilità assoluta e prolungata: talvolta lo si fasciava
molto strettamente o anche lo si ingessava per parecchi giorni; mentre si
cercava di ipertrofizzare l’altro arto, mediante ripetuti massaggi, o ginnastica
opportuna.
Si simulava la nevrastenia, l’epilessia, la corea, la paralisi del facciale, le forme
di melanconia o quelle maniacali oppure paranoiche.
Nulla sì lasciò di intentato e la patologia fu percorsa in ogni campo, per lungo e
largo. Si adoperarono agenti fisici, dall’azione meccanica a quella del calore e
del freddo. Si ricorse anche ad agenti chimici di ogni genere e ci si servì pure
di agenti infettivi.
Assai numerose furono le psicosi simulate … stati di astenia nervosa, stati
depressivi, stati allucinatori, confusionali, tremori, convulsioni, ecc…”1
1 Cerisoli M., Cimino L., Vasapollo D.,(2014) “La simulazione in ambito neurologico e
psichiatrico” Società Editrice Universo, pag.21

MODERNA DEFINIZIONE DI SIMULAZIONE
“I bugiardi più spontanei sono i truffatori patologici,
e ciò che convince di più nelle loro menzogne è il fatto che vi credono essi stessi, in
quanto non sono più in grado di ben distinguere la verità dalla finzione.”
Carl Gustav Jung. (1875-1961)
Nel 1903 anche Jung attenziona il problema che si trovava al centro del
dibattito psichiatrico del tempo in quanto la conoscenza della simulazione si
legava alla scoperta di nuovi quadri clinici sia nel campo dell’isterismo che
della demenza precoce. Nella sua opera “Simulazione della malattia mentale”
si discosta dalla psichiatria ufficiale e affronta il tema da un’angolazione
eminentemente psicologica ma anche rilevando aspetti sociali (stretta affinità
fra simulazione e furto) affermando la radice isterica della simulazione
fondandosi sull’osservazione clinica di uno stato patologico affine (caso di
stupore isterico in una detenuta in carcere preventivo). Egli mette in evidenza
la contiguità fra la simulazione del soggetto sottoposto a perizia clinica o
giudiziaria e la finzione dell’attore, circoscritta al libero spazio dell’esibizione
artistica: Jung sostiene che la differenza fra le due condizioni sia tutta nella
capacità di mantenere salda la struttura cosciente. I simulatori verrebbero
infatti trascinati dal grado soggettivo di suggestionabilità fino a sovrapporre
una seconda personalità a quella originaria e a cadere in quello stato di perdita
di coscienza che si definiva ‘crepuscolare’ (sindrome di Ganser2).
2 Dal nome dello psichiatra tedesco che per primo la descrisse nel 1898 osservando il
comportamento bizzarro di tre detenuti in attesa di giudizio e lo classificò come ‘specifico stato isterico crepuscolare’ il cui sintomo fondamentale è il rispondere di traverso con risposte assurde e approssimative e un comportamento bizzarro con episodi di eccitamento e stupore. Riteneva che i tre detenuti non fossero simulatori ma soffrissero di una patologia bizzarra. Ad oggi il dibattito sulla veridicità della patologia è ancora aperto, secondo alcuni autori è simulazione secondo altri si tratta di un’iniziale volontà simulatoria sulla quale si innesta una ‘processualità isterica’.

Figura 1 Continuum psicopatologico tra simulazione e stato crepuscolare di coscienza.
Jung quindi postula l’esistenza di meccanismi automatici, che stimolati da un
atto isterico s’imporrebbero con veemenza dell’io cosciente, sormontandolo
con la loro carica.
Dopo aver passato in rassegna la principale letteratura sull’argomento e aver
ricordato la difficoltà di accertare la simulazione, Jung conclude affermando,
che la simulazione è essa stessa stato patologico:
“… un’emorragia polmonare isterica è simulata, illusoria, ma non per questo
il paziente è un simulatore, egli è realmente malato, sebbene non di polmoni. E
se il medico dice che il paziente simula vuol dire che egli non ha ben
interpretato il sintomo, cioè non lo ha riconosciuto come sintomo isterico.”3
La cospicua casistica prodotta nell’opera s’illumina di una nuova luce: umili
individui, presunti santi vengono colti nel loro umano soffrire, reale, anche se
celato dietro l’intenzione volontaria della simulazione.
Si inaugura così una prospettiva psicoanalitica di ampia concezione del disagio
psichico ispirandosi alla psichiatria francese di Janet che è uno dei primi
studiosi ad affrontare il problema della psicopatogenesi dei disturbi simulatori.
Janet sostiene che forti sentimenti esercitano un effetto dissociante sulla
coscienza dato che emerge quasi esclusivamente una rappresentazione
sentimentale e la restante parte della vita psichica si sottrae al possesso
dell’attenzione.
Jung appunto ribadisce come l’investimento di una carica affettiva molto
importante provoca uno stato di attenzione dissociata. In seguito il soggetto
3 Jung C.G.(1903) “La simulazione nella malattia mentale” Bollati Boringhieri pag 54

trova un buon compenso con lo stato simulatorio che scivola nel subcosciente e
vi prende radice.
In tale interpretazione psicopatogenica si parte da una rappresentazione di
malattia a forte carica emotiva e si passa per un distacco dal piano di
consapevolezza, giungendo infine all’esordio ver e proprio di una sindrome che
si automatizza per un periodo indefinibile, indipendentemente da ogni aspetto
cosciente e volitivo.

“La soggettività umana è l’enigma di ogni scienza.”
Franco Basaglia. (1924-1980)
Nel suo trattato Borri (1922)4 richiamandosi a Leoncini (direttore dell’Istituto
medco-legale di Firenze nel 1906) descrive la simulazione vera come
fenomeno riguardante disturbi soggettivi e o funzionali come algie varie,
cefalea, vertigini, astenie, turbe del visus o dell’udito, deficit motori, disturbi
mentali, ecc ecc…la distingue inoltre dalla dissimulazione: tacere e nascondere
al momento della visita uno stato morboso o una lesione traumatica con
relativo esito a conoscenza del soggetto. Anche Puccini (1973) nel suo testo5,
fa suoi gli scritti di Leoncini e Borri ed amplia il concetto di simulazione a
diverse situazioni:
-Soggetto sano che finge di essere ammalato: simulazione in senso stretto.
-Soggetto sano che si procura la malattia: autolesionismo.
-Soggetto malato che si finge sano: dissimulazione.
Completano questa classificazione altre forme:
-Soggetto malato che modifica gli effetti della malattia peggiorandone l’entità:
aggravamento, facendo apparire più gravi i segni e sintomi: esagerazione.
-Soggetto che ritarda la guarigione: prolungamento.
-Soggetto che cerca di riferire la malattia a causa diversa da quella reale:
pretestazione.
-Soggetto che cerca di farla apparire meno grave: attenuazione.
In ambito più squisitamente psichiatrico una definizione che a tutt’oggi può
essere ritenuta valida è quella di Callieri e Semerari (1959)
"un processo psicologico caratterizzato dalla decisione cosciente di riprodurre
imitandoli, sintomi patologici, e di mantenere tale imitazione per un tempo più
o meno lungo e con l’aiuto di uno sforzo continuo fino al conseguimento dello
scopo, quando il simulatore non si renda conto dell’inutilità del suo
atteggiamento."6
4 Borri L,.(1922) “Trattato di medicina legale” Vallardi Editore
5 Puccini C,. (1973) “Manuale di medicina legale” Vallardi Editore
6 Callieri B, Semerari A,. (1959) “La simulazione di malattia mentale” Abruzzini Editore, Roma.

Affermerà successivamente Callieri (2000): “…simulare e dissimulare possono
essere considerate due facce di una realtà nascosta e unica, due soci che sono
tutt’uno come la patologia e il benessere. Negare la realtà e affermare i
desideri: non sempre illegale è la simulazione. Ottenere un beneficio e
conservare un ruolo: non sempre immorale è la simulazione. Divenire quello
che non si è, o che si pensa di non essere.”
Secondo Nivoli (2011)7, si può distinguere la possibilità di una sintomatologia
psichiatrica secondo personali aspettative, fantasie e pregiudizi sulla malattia
mentale, possibile altresì imitare, ripetere, mimare in maniera più o meno
grossolana sintomi psichici osservati in altri soggetti malati mentali autentici, è
possibile una rievocazione messa in atto di sintomi psichiatrici assenti al
momento della valutazione ma realmente presenti nel passato del simulatore.
Ulteriore aspetto di simulazione per Nivoli sono: l’arricchimento di patologia
psichica spesso in presenza di patologia organica accertata, mascheramento
comparsa e/o esibizione di sintomi psichiatrici che nascondono una reale
differente psicopatologia e la dissimulazione che è manifestazione di
benessere che nasconde una patologia.
Nel DSM V la simulazione mentale viene inclusa fra le condizioni che possono
essere oggetto di attenzione clinica, non una diagnosi ma una definizione di
una condizione:
"La presentazione o produzione volontaria di sintomi psichici o fisici
esagerati. I sintomi sono prodotti per perseguire uno scopo che è riconoscibile
attraverso la comprensione della simulazione dell’individuo piuttosto che
attraverso la sua psicologia."
Nell’ICD X (International Classification Disease) alla voce F 68.1 più
genericamente troviamo:
“Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o
psicologici (disturbo fittizio, paziente peregrinante, simulazione di malattia per
motivi evidenti Z 76.8, Sindrome di Münchhausen, Sindrome di Hospital-
hopper, dermatite fittizia).”
7 Nivoli et all (2011)“La simulazione di malattia mentale nelle istituzioni penitenziarie” in
Giornale Italiano di Psicopatologia 17. Pagg. 293-302.

“La gente manipola e viene manipolata, imbroglia e viene imbrogliata in
continuazione, senza rendersene conto. Fanno del male e ne ricevono senza
rendersene conto. Rifiutano di rendersene conto perché non potrebbero sopportarlo.”
Giancarlo Carofiglio. (1961)
Tutte queste definizioni e classificazioni risentono di modelli concettuali
differenti, sostanzialmente tre, il primo definito patogenetico quando si ritiene
che la simulazione sia un primo movens di una vera patologia mentale e che si
manifesta con la simulazione per poi sfociare in una psicopatologia florida.
Chi ritiene valido questo modello rivaluta la simulazione nei contesti relativi ad
ogni ulteriore scompenso e de-enfatizza la simulazione nei contesti forensi.
L'orientamento che definisce la simulazione uno stile di risposta non
patogenetica ma bensì una falsificazione di sintomi allo scopo di ottenere
vantaggi esterni, è quella criminologico, il modello prevede che la simulazione
abbia il solo obbiettivo di raggiungere un guadagno secondario immeritato,
considera come fattore di rischio per la simulazione problemi pregressi con la
legge, esperienze antisociali e un tratto stabile di personalità antisociale, de-
enfatizza la simulazione nel contesto clinico.
Infine secondo Richars Rogers (1990/1997)8 c’è un modello adattativo
concettualizzando la simulazione come scelta ragionata, dove in un contesto
percepito come ostile e pericoloso, in presenza di aspettative ma in assenza di
valide alternative, l’individuo è portato ad inscenare comportamenti definiti in
ambito psichiatrico-forense simulazione.
In questo i simulatori sono individui che effettuano una valutazione più o meno
cosciente dei costi e benefici rispetto al loro obiettivo prefigurato.
I professionisti che si concentrano su questo modello molto probabilmente
considerano l’ampiezza delle conseguenze e la mancanza di alternative come
fattore di rischio per le simulazioni e de-enfatizzano la simulazione negli
ambiti dove i soggetti esaminati hanno poco interesse ad apparire ammalati.
8 Vedi bibliografia

L'analisi psicopatologica è l’unica determinante per distinguere i simulatori dai
malati allo scopo di garantire a questi ultimi il diritto alla cura e agli altri il
diritto all'ascolto del bisogno per far si che la simulazione non si trasformi in
un disturbo conclamato.

“Lo strumento fondamentale per la manipolazione della realtà è la manipolazione
delle parole. Se puoi controllare il significato delle parole, puoi controllare le persone
che devono usare le parole…..”
Philip K. Dick. (1928-1982)
Le malattie mentali maggiormente simulate sono:
la Schizofrenia che è rappresentata raramente in contesti psichiatrico-forensi a
carattere penale, ma è molto frequente nella dissimulazione nei procedimenti di
adozione o affidamento dei minori;
la cosiddetta Sindrome di Ganser nel regime carcerario;
Quadri Depressivi sono simulati per finalità medico legale prevalentemente
per ottenere un beneficio o in relazione alla detenzione o al riconoscimento di
danno biologico, in sedi civilistiche la dissimulazione è frequente nei casi di
affidamento minorile;
le Amnesie sono simulate frequentemente dagli imputati di fatti di sangue che
affermano a vario titolo di non ricordare il crimine avvenuto, ma anche nei casi
di valutazione di danno biologico a seguito di traumi;
il Disturbo Post Traumatico da Stress che è prevalentemente simulato per
scopi economici, i sintomi principali conosciuti attraverso i media sono
facilmente simulabili in quanto poco verificabili;
Stati Isterici in più contesti;
Disturbi di personalità sempre più frequenti in tutto l’ambito forense;
Stati Ipomaniacali e Maniacali nel regime carcerario e dissimulati nell’affido
minorile;
Stati Psicotici deliranti in soggetti sottoposti a giudizio e rappresentati più
diffusamente, rispetto alla schizofrenia, nel regime carcerario;
Fornari9, ritiene possibile individuare il simulatore in quanto manifesta:
-Imitazioni di sintomi singoli isolati non legati da una correlazione patologica
-Esibizione ed elenco dei disturbi, il vero malato tende a negare la malattia.
-Minore coerenza e costanza sintomatologica rispetto al malato autentico.
9 Fornari U., (2013) “Trattato di psichiatria forense” Edizioni Utet Giuridica

-Denuncia di stati crepuscolari di coscienza e quadri pseudo demenziali.
-Descrizione precisa e scientificamente corretta di deliri e allucinazioni.
-Presenza di disturbi psicosomatici amplificando globalmente la malattia.
-Refrattarietà ai trattamenti specifici.
-Presenza di componente isterica sia nel comportamento che nell’elenco dei
disturbi.
-Adozione di comportamenti puerili ed infantili come drammatizzazione,
variazione dell’umore e ricerca della mamma.
-Miglioramenti e guarigioni rapide e miracolose correlate all'andamento del
procedimento penale.
Più recentemente secondo gli studi di Slick et all10 hanno evidenziato specifici
criteri diagnostici al fine di diagnosticare anche le disfunzioni cognitive
simulate (MND) distinguendo quattro criteri:
-Presenza di un incentivo esterno sostanziale.
-Presenza di evidenze basate sui test neuropsicologici.
-Presenza di prove basate su test self report.
-Esclusioni di spiegazioni alternative per le prove incluse nei precedenti criteri.
10
AA.VV. (1999) “La perizia psicologica in ambito civile e penale” FrancoAngeli Editore.

L’ESAME PERITALE
“L’inconfutabilità di una teoria non è (come spesso si crede) un pregio, bensì un
difetto. Ogni controllo genuino di una teoria è un tentativo di falsificarla, o di
confutarla. La controllabilità coincide con la falsificabilità; alcune teorie sono
controllabili, o esposte alla confutazione, più di altre; esse per così dire, corrono
rischi maggiori.”
Karl Raimund Popper. (1902-1994)
Nella pratica forense una problematica con la quale i consulenti si devono
confrontare è la possibilità che, l’esaminando, simuli una condizione
psicopatologica in realtà non presente.
Tale atteggiamento è determinato dai vantaggi che possono derivare dalla
simulazione di malattia che si estendono nei diversi contesti della valutazione.
Le stime più recenti della presenza di simulazione nelle valutazioni peritali
fanno riferimento a percentuali incluse tra il 13% ed il 21% (Rogers, et al.
2004; Vitacco et al., 2007)11.
La valutazione dell’effettiva simulazione è un processo complesso: il
consulente deve essere consapevole che esiste il simulatore, cioè colui che
pone in essere sintomi psichici e/o fisici che non corrispondono alla realtà ma
dall’altra parte ci sono anche i non simulatori, cioè i malati che effettivamente
presentano un disturbo psichico più o meno complesso.
Nella valutazione della simulazione l’esame clinico deve prevedere un’attenta
indagine sulla storia personale del soggetto, un’analisi accurata dei sintomi
attuali ed un attento esame dello stato mentale.
11
Rogers, R., Jackosn, R.L., Sewell, K.W., Harrison, K.S. (2004). An examination of the ECST-R as screen for feigned incompetency to stand trial. Psychological Assessment, 16, 213-223. Vitacco, M.J., Rogers, R., Gabel, J. (2007). An evaluation of malingering screens with competency to stand trial patients: A known groups comparison. Law and Human Behavior, 31, 249-260.

“Ognuno ascolta quello che capisce.”
Wolfang Goethe. ( 1749-1832)
Una intervista lunga può rivelare incongruenze nella narrazione o discrepanze
tra sintomi riferiti e comportamento osservato, può determinare un
“abbassamento della guardia” soprattutto durante le pause e, secondo Drob &
Berger (1987)12, compito dell’intervistatore è quello di far sì che l’esaminando,
almeno per un attimo, dimentichi o abbandoni il ruolo.
Conoscere le tipologie di simulazione possibili può permettere di evitare un
involontario suggerimento dei sintomi usati per la simulazione delle malattie
mentali, evitare di essere coinvolti in relazioni manipolatorie con gli
esaminandi, migliorare la valutazione clinica per il riconoscimento e
trattamento delle simulazioni (vedi Tabella 1).
12
Drob, S.L., Berger, R.H. (1987). The determination of malingering: A comprehensive clinical-forensic approach. The Journal of Psychiatry and Law, 15, 519-538.

Tabella 1. Forme di simulazioni delle malattie mentali in ambito forense.
Aggravare Il paziente aumenta la gravità clinica dei sintomi
Inflazionare Il paziente, per essere creduto, lamenta progressivamente sempre nuovi sintomi diversi tra loro
Inventare Il paziente, nel corso del colloquio, intuisce l’importanza di un sintomo non descritto in precedenza, perché assente, e lo lamenta
Riaggiustare Il paziente, dopo aver preso coscienza della poca credibilità delle sue lamentele iniziali, cerca di modificarle per renderle più credibili
Temporeggiare Il paziente, di fronte a domande cui non sa dare una risposta, cerca “di prendere tempo” per capire che cosa dovrebbe rispondere
Sfuggire Il paziente trovandosi in difficoltà con lo psichiatra per timore di essere palesemente smascherato cerca in qualche modo di interrompere il colloquio
Inorridire Il paziente, per dimostrare la sua pretesa di malattia di mente, ricorre a comportamenti fuori dall’ordinario che provocano sgomento, disgusto, orrore in chi le osserva
Impietosire Il paziente per essere creduto cerca, con il suo comportamento, di suscitare sentimenti di pietà, commiserazione e di benevolente desiderio di aiutarlo
Incuriosire Il paziente mette in atto comportamenti o verbalizzazioni ritenuti sintomi di malattia mentale che hanno lo scopo di promuovere una grande curiosità per la loro stranezza e bizzarria
Disturbare Il paziente cerca di proporre la propria pretesa malattia mentale, attraverso un comportamento molestatore assillante con continue richieste ai medici ed allo psichiatra
Ricattare Il paziente, per convalidare la propria pretesa malattia mentale, minaccia di compiere atti autolesionistici gravi, lesione all’integrità fisica delle persone, il suicidio o l’omicidio
Predire Il paziente descrive la sintomatologia di una psicopatologia che ritiene possa presentarsi in futuro pur non essendo presente allo stato attuale
Ricordare Il paziente presenta una sintomatologia che lo ha colpito per la sua gravità in passato, a livello di vittima, di spettatore o di persona informata
Associare Il paziente per avvalorare la propria pretesa malattia mentale cerca di trasformare lo psichiatra in un amico compiacente od in un complice
Focalizzare Il paziente dirige il contenuto del colloquio con lo psichiatra su di una precisa richiesta gestita in modo rivendicativo, rifiutando di descrivere adeguatamente la sintomatologia
Predicare Il paziente tende a ripetere, in modo stereotipato, una stessa tipologia di discorso, che ritiene significativa di una patologia mentale
Drammatizzare Il paziente, per avvalorare la sua pretesa psicopatologica, esibisce, con carattere di estrema urgenza, una sintomatologia presentata come drammatica

“Non puoi aspettarti di vedere al primo sguardo.
Osservare è per certi versi un arte che bisogna apprendere.”
William Herschel. (1738-1822)
Il primo strumento per la verifica di simulazione in ambito forense e clinico è
l’esame peritale composto da: anamnesi, colloquio clinico esame obiettivo
rilevazioni strumentali e status.
L’anamnesi (dal greco “ricordo”) consiste nella raccolta di dati il più possibile
obiettivi, verificabili attraverso documentazione e quando ciò non è possibile ci
si attiene a quanto riferito dal soggetto.
Si struttura in familiare, fisiologica, patologica, psicopatologica, scolastica e
lavorativa, giudiziaria. Si raccolgono quindi i dati relativi alla storia familiare
sia d’origine che attuale, notizie sullo sviluppo fisico ed eventuali malattie
occorse. Dopodichè si indaga su eventuali trascorsi di patologie psichiatriche
e servizi di riferimento. Inoltre si pone attenzione sul percorso scolastico e
lavorativo ed eventuali precedenti penali.
Il colloquio clinico invece analizza e valuta i vissuti del soggetto sia rispetto
alla propria storia sia rispetto ai fatti accaduti di cui è stato protagonista.
Si può articolare con tre modalità differenti:
COLLOQUIO LIBERO, si svolge come una normale conversazione e gli
argomenti devono essere inizialmente indirizzati dall’esaminatore ma lasciando
assoluta libertà di espressione al soggetto. Ha per scopo di saggiare le funzioni
psichiche del soggetto e il patrimonio ideativo.
COLLOQUIO TEMATICO, si esegue con domande su specifici argomenti da
cui possono emergere manifestazioni psicopatologiche, usando argomenti
conosciuti come problematici e conflittuali per poter verificare la capacità
critica e le reazioni emotive
COLLOQUIO A CONTESTAZIONE, si attuano modalità che tendono a
provocare reazioni nel soggetto, sottoponendolo ad una situazione di stress e
frustrazione, con lo scopo di neutralizzare eventuali meccanismi difensivi
consci e inconsci per determinare nel soggetto forti reazioni emotive e fargli

perdere il controllo della situazione. Si usa per verificare l’aggressività, l’acting
out e l’aderenza alla realtà.
Nell’esame obiettivo si eseguono un insieme di manovre diagnostiche
effettuate per verificare la presenza o assenza, nel paziente, dei segni (o
sintomi obiettivi) indicativi di una deviazione dalla condizione di normalità
fisiologica, tipicamente si mettono in atto:
ISPEZIONE, dove “il medico, con il solo ausilio della vista, ricerca alterazioni
dei parametri fisiologici, per esempio torace ingrandito, ingrossamento del
collo (in alcuni casi le alterazioni possono comunque rientrare in una
situazione non patologica) e lesioni come cicatrici, ematomi, che possono
essere utili a rinforzare il sospetto clinico o a delineare la storia clinica del
paziente.”
PALPAZIONE, che “viene effettuata tramite la palpazione di una regione
anatomica (per esempio la mammella o l'addome). Nel caso dell'addome la
palpazione si suddivide in superficiale (alla ricerca del cosiddetto "risentimento
peritoneale", ovvero la contrazione da parte del paziente dei muscoli
addominali, frequente per esempio nei casi di appendicite) e profonda
(effettuabile solo in assenza di risentimento peritoneale, alla ricerca di
alterazioni a livello addominale). Nella palpazione rientra l'esame del polso
arterioso.”
PERCUSSIONE, che “viene effettuata con l'ausilio di un dito (o più dita,
dipende dalla comodità del medico) plessimetro (che viene poggiato su una
determinata zona anatomica) e un dito (o più dita) plessore (che percuote il dito
plessimetro). L'effetto è quello di provocare, tramite la percussione, un suono
che rifletterà la natura della zona sottostante: ovvero il suono si propagherà
meglio se il dito plessimetro verrà poggiato in corrispondenza di zone meno
dense (in cui la presenza di parenchima è minore: per esempio il polmone)
dando origine a un suono definito "chiaro", si propagherà meno, invece, nelle
zone in cui la presenza di parenchima è maggiore, dando origine a un suono
definito "ottuso" (per esempio nell'addome). Il sospetto clinico nasce nel
momento in cui si riscontra un suono diverso da quello che ci si sarebbe

aspettati (per esempio se si riscontra un suono ottuso in corrispondenza del
polmone, dove ci si aspetterebbe un suono chiaro).”
AUSCULTAZIONE, che “si effettua tramite un fonendoscopio che viene
poggiato sulla cute, in corrispondenza della zona di cui si vuole sentire i vari
suoni.”
Nella diagnostica strumentale, quando si avvale di apparecchiature o strumenti
particolari, tipicamente troviamo pratiche di Neuroimaging, EEG, EMG,
evidenza di Biomarcatori, ecc ecc.
Nello STATUS, si indagano le funzioni mentali superiori e tra l’altro si
valutano l’atteggiamento e il comportamento generale verificando l’aspetto, la
modalità di vestirsi, l’igiene personale, il grado di socievolezza e l’uso del
linguaggio. Si evince quindi se è collaborante o reticente, la padronanza di sé e
la mimica facciale pure dà informazioni insieme alla gestualità e all’attività
motoria. Importanti informazioni si ricavano dall’attenzione e concentrazione
ed eventuali reazioni emotive, si osserva la qualità del pensiero e l’ideazione.
In ultimo si valutano, capacità di astrazione e di critica insieme e competenze
logiche.
In ambito psicodiagnostico i tests utili al rilevamento della simulazione si
possono distinguere in due categorie: questionari di personalità che contengono
al loro interno anche delle scale specificatamente costruite per rilevare la
malattia mentale finta, ci sono poi tests costruiti appositamente per valutare la
simulazione. Nel primo gruppo sono compresi tra l’altro il Minnesota
Multiphasic Personality Inventory–2 (MMPI2) ed il Personality Assessment
Inventory (PAI), nel secondo gruppo, si incontrano strumenti progettati proprio
con il fine di rilevare la simulazione di malattia come il SIMS e la SIRS nella
sua versione aggiornata SIRS2.

SIRS-2
L’intervista strutturata per i sintomi riferiti, SIRS2, di Rogers, Sewell e Gillard,
1992-2010, è valutata in America del Nord come il principale strumento di
misura e il più diffuso, per il riconoscimento della simulazione dei disturbi
mentali in ambito forense, ultimamente utilizzato anche in contesti clinici da
Phillips e Fallon., 2000. La prima edizione risale al 1992 la seconda è del 2010,
ed in Italia la seconda edizione è stata tradotta e pubblicata nel 2016 a cura di
Pezzuolo-Ciappi-Zago.
Si giunge ad una classificazione di simulazione secondo SIRS2 quando, una
volta completato lo scoring, si adotta un algoritmo che attraverso diagrammi di
flusso e regole decisionali, avanza nelle classi del SIRS2:
Figura 2. Algoritmo decisionale della SIRS2.

L’intervista di 156 item è completamente strutturata e a differenza delle
interviste semi-strutturate non permette agli esaminatori di investigare o porre
domande proprie. E’ composta da sei sezioni principali a loro volta suddivise
in due sequenze parallele. Ogni sequenza è composta da indagini dettagliate,
ripetute e indagini generali.
La somministrazione della SIRS2 pone pochi vincoli all’intervistatore in
termini di materiali per il test e di ambiente fisico. I soli requisiti del setting
sono la riservatezza e l’assenza di rumori eccessivi e di interruzioni, non è
necessario comunque che l’esaminatore cerchi il silenzio assoluto in una stanza
insonorizzata, perché è stato somministrato in contesti correttivi, in cui il
rumore di fondo è una variabile costante.
E’ importante comunque che questo non interferisca con la capacità
dell’esaminato di ascoltare e rispondere e/o non lo distragga. Solitamente il
tempo necessario per la somministrazione varia: con la popolazione di
esaminandi con buon funzionamento che rispondono genuinamente agli item
sono sufficienti trenta minuti, esaminandi marcatamente compromessi o che
simulino spesso, richiedono un tempo maggiore per la somministrazione di
circa 45 minuti. Tutte le somministrazioni che superano un’ora devono essere
attentamente esaminate per escludere che gli esaminati non siano stati
collaborativi all’intervista.
Il test può essere somministrato a persone di età superiore ai 18 anni,
principalmente in individui con capacità intellettive nella norma o borderline.
Tuttavia è stato utilizzato con esaminandi con diagnosi di ritardo mentale lieve.
Nell’adattamento italiano l’età compresa dei partecipanti è fra 18 e 83 anni
suddivisa in tre gruppi: campione normale, campione psichiatrico e campione
forense quest’ultimo è costituito da persone coinvolte in controversie legali per
risarcimento danni, imputabilità, affidamento minori e abuso sessuale.
Rogers ha diviso le strategie di rilevazione in due categorie: improbabili e
amplificate. Le strategie di rilevazione improbabili identificano i simulatori
dalla semplice presenza di sintomi improbabili e finte lamentele. Le strategie di
rilevazioni amplificate identificano i simulatori dall’importanza dei loro
sintomi e dalle caratteristiche associate. La corretta valutazione del

deterioramento cognitivo simulato è valutata tramite strategie di rilevazione
improbabili.
L’intervista strutturata dei sintomi riferiti è costituita da otto scale primarie con
eccellente validità discriminante nel distinguere risposte fornite da un
campione di simulatori rispetto ad un campione di individui con disturbo
mentale riconosciuto e che non presentano tentativo di simulazione (nella
pratica clinica anche alcuni simulatori possono presentare disturbi psichiatrici
riconosciuti). L’intervista SIRS2 è progettata per rilevare gli otto stili di
risposta comunemente associati con la simulazione (vedi Tabella 2).
Tabella 2. Stili difensivi secondo SIRS2
“Lally (2003)13 riscontra che l‘utilizzo del SIRS è considerato accettabile
dalla maggior parte dei professionisti forensi (89%) e raccomandato dalla
maggior parte di loro (89%). Più recentemente Archer et al. (2006)14 riportano
che il SIRS2 è utilizzato dai professionisti forensi al fine di verificare la
simulazione di malattia o la effettiva disabilità cognitiva (86,2%).
13
Lally, S. J. (2003). What tests are acceptable for use in forensic evaluations? A survey of experts. Professional Psychology: Research and Practice, 34, 491-498 14
Archer, R.P., Buffington-Vollum, J.K., Stredny, R.V. e Handel, R.W. (2006). A survey of psychological test use patterns among forensic psychologists. Journal of Personality Assessment, 87, 84-94.

Per raggiungere tale obiettivo, sono stati integrati più di 2300 protocolli SIRS,
somministrati a partecipanti provenienti dall‘ambito clinico, clinico-forense,
carcerario, di comunità. Con l’inclusione inoltre dei dati sulla attendibilità e dei
dati provenienti da somministrazioni multiple agli stessi gruppi di soggetti.”
Al momento della pubblicazione in America nel 2010 il numero totale dei
protocolli disponibili per un‘analisi dell’affidabilità e dell’efficacia superava i
2.500 (Rogers, S., Sewell K.W. e Gillard, N.D., 2010)15.
Anche alla luce delle numerose indagini statistiche espletate per l’adattamento
italiano del test, è possibile concludere che esso offre allo psicodiagnosta la
possibilità di studiare la simulazione in modo assai più preciso e puntuale di
quanto non fosse possibile in precedenza. Inoltre non solo rileva la presenza di
simulazione ma anche la modalità con la quale si evidenzia (esagerazione di
sintomi vs invenzione di sintomatologia) e livello di attendibilità (simulazione
indeterminata, probabile, certa; vedi Tabella 3)
Tabella 3. Calcolo delle scale e degli indici
15
Rogers, S., Sewell, K.W. e Gillard N.D. (2010). SIRS-2 - Structured Interview of Reported Symptoms, 2nd Edition. Odessa FL: Psychological Assessment Resources (ed. it.: Pezzuolo, S., Ciappi, S. e Zago S. (2016). Firenze, Hogrefe Editore).

MMPI-2
Fra i numerosi test obiettivi messi a punto per lo studio della personalità il più
conosciuto, il più diffuso ed il più usato è, senza dubbio, il Minnesota
Multiphasic Personality Inventory, MMPI messo a punto nel 1940 da
Hathaway e McKinley, oggi sostituito da una sua revisione del 1989, MMPI2
(Hathaway et al., 1989)16. Il MMPI2 può essere somministrato a tutti i soggetti
con più di 18 anni e con un livello culturale tale da garantire la comprensione
del significato degli item. Nell’ultima versione il test è composto da 567
affermazioni (ma ne esiste anche una versione ridotta, di sole 357
affermazioni) alle quali il soggetto può rispondere soltanto "vero" o "falso" a
seconda che la ritenga prevalentemente vera o falsa per lui. Le affermazioni
riguardano argomenti eterogenei, dai sintomi somatici alla sessualità, dalla
sfera familiare a quella religiosa, dalla cultura ai rapporti interpersonali,
eccetera. I 567 item si articolano in 13 scale, 3 di controllo e 10 cliniche. Le
dimensioni cliniche per quanto rimandino, con la loro denominazione, a
categorie psichiatriche, devono essere viste come dimensioni psicologiche
presenti anche nei soggetti normali ed assumono significato patologico solo nei
valori estremi. Le scale di controllo forniscono indicazioni circa la validità del
test: di queste si deve tener conto, non solo nell’interpretazione delle scale
cliniche, ma anche nell’assegnazione dei punteggi in alcune scale cliniche.
Per ogni scala, clinica e di controllo, un’apposita griglia consente il calcolo dei
punteggi grezzi che, già nel foglio di siglatura, diventano punteggi
standardizzati T (un punteggio standard con media pari a 50 e deviazione
standard uguale a 10) che consentono il confronto diretto tra i valori delle varie
scale. I limiti del "range" di valori normali è stato fissato arbitrariamente a più
o meno due deviazioni standard (2DS) dalla media dei punteggi ottenuti da un
campione di soggetti normali. Unendo con una linea i punteggi ottenuti nelle
16
Butcher, J. N., Graham, J. R., Tellegen, A., & Kaemmer, B. (1989). Manual for the restandardized Minnesota Multiphasic Personality Inventory: MMPI-2. Minneapolis: University of Minnesota Press.

scale di controllo da un lato ed in quelle cliniche dall’altro, si ottiene il profilo
MMPI del soggetto. Nell’interpretazione del profilo vengono prese in
considerazione, in primo luogo, le scale di controllo e poi, in correlazione con
queste, le scale cliniche.
Per la misurazione della possibile simulazione sono molto importanti le scale
di controllo della validità che sono:
“L” misura la tendenza a falsificare i risultati del test cercando di fornire
un’immagine di (lie) sé socialmente favorevole. Gli item che la compongono si
riferiscono a comportamenti largamente diffusi nella popolazione generale la
cui negazione, pur ponendo il soggetto in una luce più favorevole, è
improbabile che costituisca una risposta sincera.
“F” rileva la tendenza a fornire risposte atipiche o inusuali. La scala raccoglie
una serie (frequency) di voci alle quali solo una piccola percentuale del
campione normativo (non più del 10% e spesso meno del 5%) ha risposto in
una determinata direzione. Un alto punteggio può suggerire errori di siglatura,
o la mancata comprensione degli item o delle istruzioni, o negligenza nel
fornire le risposte, o gravi disturbi emotivi in atto.
“K” misura l’atteggiamento di difesa nei confronti della manifestazione aperta
delle proprie (correction) reazioni emotive e dei propri disturbi psicopatologici
e di conseguenza anche nei riguardi della situazione del test. Costituisce un
indice di validità del test più sottile dei precedenti, risultando sensibile anche a
tentativi di dissimulazione poco grossolani. Un punteggio elevato può deporre
per ipercontrollo, rigidità, tendenza a presentare all’esterno una "facciata"
accettabile, mentre un punteggio basso può indicare eccessiva autocritica.
Da queste scale si ricava l’indice “F-K” ricavato dalla differenza fra il
punteggio grezzo alla scala F e alla scala K ha una provata capacità di
individuare la simulazione. Inoltre un altro indice è “Fp” (Frequenza-
Psicopatologica) fornisce una misura delle risposte attinenti ad aspetti
psicopatologici e infrequentemente fornite dalla popolazione generale e da
pazienti psichiatrici in regime di ricovero; che ci indica la possibilità di una
probabile simulazione e si evidenzia come riportato nei grafici sotto riportati.

Tabella 4. Indice sintetico di simulazione di patologia nel MMPI2
Tabella 5. Interpretazione dei punteggi della scala Fp del MMPI2

Esempio di configurazione tipica della simulazione di patologia: è probabile che gli
esaminandi con questa configurazione simulino un quadro psicopatologico grave e
generalizzato, riferendo la presenza di sintomi rari anche in popolazioni
psichiatriche. In situazioni simili le scale K, L e S risultano particolarmente depresse.
Si può concludere che il test MMPI-2 fornisce delle indicazioni per coadiuvare
l’esperto nell’esame peritale e giungere ad una diagnosi e ad un eventuale
riconoscimento di simulazione.

RORSCHACH
Il test di Rorschach è certamente il più noto test proiettivo di personalità. I test
proiettivi consentono di cogliere il corso del processo spontaneo del pensiero
del soggetto ponendolo di fronte ad una situazione-stimolo ‘ambigua’ a cui
risponde in funzione del significato emotivo-affettivo che tale situazione ha per
lui, consentendo di esprimere indirettamente le caratteristiche della sua vita
psichica e delle sue dinamiche. Mediante la valutazione delle reazioni a stimoli
diversi si cerca di ricostruire lo schema della personalità del soggetto.
Questo test fu proposto da Hermann Rorschach nel 1921 per valutare la
personalità attraverso l’analisi della percezione. E’ composto da 10 tavole,
ognuna delle quali presenta su sfondo bianco una macchia di inchiostro nero
e/o colorato, a simmetria bilaterale, alle quali il soggetto deve attribuire un
significato. Si prende nota della posizione in cui ogni tavola viene tenuta dal
soggetto, del tempo trascorso fra la presentazione e la prima risposta, del
contenuto dell’interpretazione, degli eventuali commenti e del comportamento
generale durante la prova. Finita la presentazione delle tavole viene svolta la
cosiddetta “inchiesta”, vengono cioè ripresentate le tavole al soggetto per
stabilire la localizzazione (la zona della macchia a cui si riferiva la risposta) e i
determinanti delle percezioni (le qualità percettive della macchia che hanno
suscitato le risposte: forma, colore, movimento, ecc…). Generalmente vengono
prese in considerazione anche altre categorie, in particolare il contenuto
(umano, animale, inanimato, ecc..), la qualità formale (adeguatezza della
risposta stimolo) e l’originalità (interpretazioni meno comuni).
Le risposte vengono “siglate”: cioè contrassegnate con simboli che indicano la
categoria di appartenenza. Ad ogni categoria è attribuito un significato
psicologico ma nell’interpretazione si tiene conto soprattutto del rapporto fra le
diverse sigle e anche di altri aspetti non quantificabili come lo shock (reazione
emotiva espressa di fronte a una tavola), il rifiuto (incapacità di dare una
risposta), la perseverazione (ripetizione di una risposta), le confabulazioni
(risposte senza attinenza con lo stimolo), ecc…

Per quanto riguarda il test Rorschach, si è osservato che con un adeguato
addestramento il soggetto è in grado di simulare una condizione non reale;
basterebbe infatti affermare di vedere ciò che non si vede realmente per alterare
la validità del test.
I simulatori vengono comunque smascherati in base a indici significativi come
i seguenti (Capri - Fontanesi, 1985):
- resistenze e allungamento dei tempi di latenza;
- abbondanza di rifiuti (>2);
- basso numero di risposte;
- alta percentuale di risposte volgari;
- alto F%, con protocollo tendente alla coartazione;
- confabulazione;
- assenza di risposte di movimento classiche;
- risposte vaghe;
- percezioni indefinite;
- comportamento evasivo;
- lamentele durante l'applicazione della prova;
- iperproduttività, talvolta bizzarra e molto imprecisa;
- incongruenza nel comportamento (es.: risposte accettabili in tavole
unanimamente considerate difficili, e rifiuti in tavole facili).

SIMS
Il SIMS Structured Inventory of Malingered Symtomatology è stato
costruito come strumento di screening per l’individuazione della simulazione
di psicopatologia e di sintomi neuropsicologici. E’ un questionario multiassiale
ed è stato sviluppato per essere somministrato a persone con più di 18 anni è
stato validato con campioni di tipo clinico-forense, psichiatrico e non clinico. Il
tempo medio di somministrazione è breve, circa 10-15 minuti anche se i
soggetti simulatori impiegano più tempo. E’ composto da 75 item con risposta
vero/falso e si articola in 5 scale ciascuna di 15 item.
Le scale sono:
Psicosi P che valuta il grado con cui il soggetto riporta sintomi psicotici
inusuali e bizzarri che non sono tipici nei pazienti psichiatrici.
Danno Neurologico NI che valuta il grado con cui il soggetto riporta
sintomi neurologici illogici o decisamente atipici.
Disturbi anamnestici AM che valutano il grado con cui soggetto
riferisce disturbi di memoria inconsistenti con il pattern di danno o
disfunzione cerebrale riscontrati.
Bassa intelligenza LI valuta il grado con cui il soggetto inventa e/o
esagera deficit intellettivi attraverso prestazioni deficitarie in item di
semplice conoscenza generale.
Disturbi affettivi AF valuta il grado con cui il soggetto presenta sintomi
atipici di depressione e ansia.

Tabella 6. Riassunto delle scale SIMS
Se i punteggi risultano superare i cut-off in una o più scale è necessario
procedere con una valutazione esaustiva del comportamento simulativo, in
particolare se si sospetta simulazione di psicopatologia è necessario la
somministrazione di interviste strutturate già validate come la SIRS.
Un aspetto implicitamente connesso all’individuazione della simulazione è una
corretta discriminazione fra reale presenza di psicopatologia, o deficit
cognitivo, e la presenza di sintomi fittizi e intenzionalmente simulati. I
punteggi di cut-off sono quei punteggi identificati come quelli che
differenziano nel miglior modo possibile i soggetti sinceri dai simulatori,
quindi punteggi che permettono di identificare il maggior numero possibile di
simulatori.
I risultati ottenuti sul campione di sviluppo del test hanno evidenziato che le
scale individuali presentano un’elevata efficienza nella discriminazione fra
soggetti simulatori e soggetti sinceri con un’efficienza che va da 75,12% (scala
P) a 88,24% (scala AM). Inoltre il punteggio totale risulta essere il miglior
indicatore per distinguere i simulatori dai non simulatori all’interno del
campione di sviluppo.

Quando tutti i gruppi sperimentali sono stati raggruppati in un unico gruppo di
simulatori il punteggio totale ha dimostrato un’accuratezza del 94,96%.
Il test, comunque presenta un’alta sensibilità nel rilevare i simulatori e una
validità discriminante superiore a quella delle scale F e K dell’MMPI-2
(Rogers 2008)17, infatti i dati in letteratura definiscono il SIMS un valido
strumento di screening, con ottimi tassi di sensibilità e specificità complessive.
Rogers dimostrò, nella sua rassegna di studi condotte dal 1992 al 200618, come
questo strumento presenti un’ottima accuratezza discriminativa attestata,
pressochè in ogni ricerca, da alti valori di sensibilità e specificità.
Una corretta discriminazione della simulazione da altri problemi mentali o
disturbi cognitivi ha importanti implicazioni in relazione al processo di
stigmatizzazione dell’individuo simulatore e alla possibilità di usufruire di
adeguati servizi o benefici da parte di un soggetto con un reale problema
psicopatologico o cognitivo.
Esistono due tipologie di errori quando si utilizzano delle misure per
classificare gli individui:
-Falsi positivi, ovvero individui sinceri o soggetti affetti da sintomi reali che
vengono erroneamente classificati come simulatori
-Falsi negativi ovvero simulatori che vengono erroneamente classificati come
soggetti affetti da disturbi cognitivi o da una reale psicopatologia.
La sensibilità, cioè la probabilità che un simulatore venga identificato come
tale e la specificità cioè la probabilità che un individuo onesto sia classificato
come tale e non come simulatore sono le qualifiche che permettono di valutare
la capacità di un test di valutare correttamente un individuo.
La capacità globale di classificazione del test è chiamata efficienza o HIT
RATE.
Il SIMS è stato costruito come strumento che pone le basi per valutazioni più
approfondite, infatti gli errori possono poi essere corretti successivamente
dall’utilizzo di altri strumenti come il SIRS2.
17
Rogers, R. Clinical assessment of malingering and deception. (cap. IV, pp 303-334) New York: Guilford Press. 18
ibidem

Concludendo nell’interpretazione il soggetto che totalizza più di 14 nel
punteggio totale è identificato come possibile simulatore e perciò necessita di
una valutazione successiva dato l’elevato numero dei sintomi atipici,
improbabili, incoerenti e illogici che il soggetto presenta.

PAI
Il PAI Personal Assessment Inventory è un questionario di self report
pubblicato dal Lesly Morey (1991, 2007)19 per la valutazione della personalità
e della psicopatologia della persona. Pubblicato in Italia nel 2016 da Zennaro -
Santo Di Nuovo - Fulcheri e Mazzesch, rappresenta una valida alternativa
all’MMPI-2 e creare uno strumento di valutazione che misurasse aree rilevanti
per la diagnosi e la pianificazione del trattamento. E’ un efficace questionario
di personalità ateorico composto da 344 item, pensato per l’età adulta (dai 18
anni in poi) che si somministra agevolmente per la sua brevità (45 minuti circa)
e per la sua facilità di comprensione anche per soggetti con bassa scolarità.
Esiste anche una versione per adolescenti (PAI-A) dai 12 ai 18 anni composto
da 264 item.
Le aree valutate dagli autori sono cinque: Validità Risposte. Sintomi Clinici,
Stili Interpersonali, Complicanze per il Trattamento e ulteriori Indici
supplementari per valutare attendibilità e validità del test.
Su queste cinque scale è stato costruito il test utilizzando due tipi di validità:
quella di contenuto (ogni scala ha un campione equilibrato di elementi
rappresentativo di quel costrutto e anche la valutazione della gravità del
contenuto) e quella discriminante (ogni scala è distinta dall’altra).
Il test è stato standardizzato sia su popolazione generale che su popolazione
clinica. Questa duplice taratura consente un confronto preciso nella rilevazione
di aspetti psicopatologici.
Gli item prevedono una scala Likert di risposta a quattro valori e sono
organizzati in scale di validità, scale cliniche, scale di trattamento e scale
interpersonali non sovrapponibili fra loro.
19
Morey L.C. (2016). PAI – Personality Assessment Inventory. Edizione Hogrefe

Le scale cliniche comprendono 11 scale comprendendo tre grandi categorie di
disturbi: area nevrotica, area psicotica e disturbi relativi al comportamento e
alle dipendenze.
Due sono le scale specifiche per caratteristiche antisociali e per quelle
borderline.
Le scale di trattamento sono 5: aggressività (AGG), Ideazioni Suicidarie (SUI),
Stress (STR), Mancanza di supporto (NON), Rifiuto del Trattamento (RXR) e
Indice relativo al Processo Terapeutico (TPI).
Permettono di ipotizzare la compliance e le eventuali complicazioni nel
trattamento, rivelando il rischio potenziale per sé e per gli altri, l’impatto di
eventuali fattori stressanti recenti sulle aree di vita, il livello e la qualità del
supporto sociale e infine un indice di motivazione ad intraprendere un
eventuale trattamento.
Le due scale interpersonali forniscono informazioni sulle relazioni e le
interazioni della persona: Dominanza (DOM), Necessità di Accettazione
(WRM). Lo stile interpersonale viene valutato lungo due poli: caldo e
socievole-freddo e riluttante, mentre gli aspetti relativi alla dominanza-
sottomissione vengono valutati sulla scala centrata su questi due poli.
Le scale di validità sono 4:
Inconsistenza (INC/10 paia di item): indica il grado di coerenza con cui il
soggetto ha risposto all’intero inventario. Ciascun coppia è costituita da item
altamente correlati (positivamente o negativamente).
Infrequenza (INF/8): Indica se il soggetto ha risposto distrattamente, in modo
casuale o idiosincratico. Gli item sono neutrali rispetto alla psicopatologia e
ricevono un livello di approvazione o estremamente alto o estremamente basso.
Impressione Negativa (NIM/9): suggerisce un’eccessiva impressione
sfavorevole o simulazione di disturbo.
Impressione Positiva (PIM/9): suggerisce la presentazione di un’impressione
molto favorevole o una riluttanza ad ammettere piccoli difetti. (Vedi Tabella 7
per una comparazione con le scale del MMPI2)

Tabella 7. Confronto tra indicatori di simulazione tra MMPI2 e PAI
Nel questionario sono presenti 27 item critici per la valutazione di
comportamenti patologici che possono richiedere attenzione immediata (ad es.
rischio suicidario) e si basano su due criteri: hanno un contenuto specifico su
crisi potenzialmente in atto e sono item che generalmente ottengono una
percentuale bassa di consenso.
Servono per chiarire meglio l’elevazione di determinate scale e sono i seguenti:
Indice difensivo (DEF): si riferisce a configurazioni di 9 scale che si
osservano più frequentemente nei soggetti istruiti a fornire
un’immagine di Sé positiva, rispetto alla popolazione normativa o
clinica.
Funzione discriminante Caschel (CDF): tentativo di presentarsi in
modo distorto, sicchè il profilo probabilmente riflette il modo in cui il
soggetto desidera apparire.
Indice di simulazione di malattia (MAL): si tratta di configurazioni di 8
scale che si osservano più frequentemente nelle persone che simulano,
che nei pazienti reali.

Funzione discriminante Rogers (RDF): permette di distinguere i
protocolli di pazienti onesti dai simulatori, prevede una combinazione
ponderata di 20 punteggi che genera un punteggio discriminante
associato ad un punteggio di cut-off pari a 0. Quindi coloro che
ottengono un punteggio superiore a tale valore vengono classificati
come simulatori.
Indice di potenziale suicidio: potenziale rischio suicidario.
Indice di potenziale violenza: indice di violenza potenziale.
Indice di processo di trattamento: indice di propensione al trattamento
(Vedi Tabella 8).

Tabella 8. Calcolo indici del PAI

Purtroppo il test non misura alcuni costrutti che potrebbero essere di
preoccupazione clinica (ad esempio i disturbi alimentari) e quindi è utile
integrare il PAI con altri test.
In ambito forense è molto utile per le perizie in quanto vi sono le scale cliniche
indispensabili per l’inquadramento diagnostico e le scale di controllo:
inconsistenza, infrequenza, impressione negativa, impressione positiva e altri
indicatori di simulazione e malingering utili per questo tipo di valutazioni. E
quindi molto utilizzato negli Stati Uniti in ambito giuridico.
A seguire un profilo di sospetta simulazione al PAI.





CONCLUSIONI
“Il mio centro è dentro di me.” Erich Fromm. (1900-1980)
Negli ultimi anni sono aumentati i dibattitti in merito ai diversi metodi di
valutazione per la pratica clinica e forense: Vengono proposti e utilizzati con
fondamenti teorici e metodologici diversi molti tests sottoforma di interviste
strutturate o semi strutturate e test proiettivi. In questo elaborato ne ho
selezionati alcuni utilizzati per evidenziare la simulazione in ambito giuridico.
Vi sono numerosi studi di attendibilità in merito che avvalorano l’utilizzo di
alcuni piuttosto che altri.
Ho scelto di presentare come primo test la SIRS2 (Structured Interview of
Reported Symptoms, Second Edition) che è stata riconosciuta come il miglior
strumento di misura per la valutazione della simulazione dei disturbi mentali.
Essa “...aggiorna la letteratura sulla simulazione di malattia con un‘attenzione
particolare alle strategie di rilevazione e di applicazione clinica. Combina
inoltre i dati che derivano dal processo di validazione della SIRS. originale
con le ricerche più recenti. Con l‘inclusione inoltre dei dati sulla attendibilità
e dei dati provenienti da somministrazioni multiple agli stessi gruppi di
soggetti (i cosidetti within-subjects designs), il numero totale dei protocolli
disponibili per un‘analisi dell‘affidabilità e dell‘efficacia supera i 2.500“
(Rogers, S., Sewell K.W. e Gillard, N.D., 2010).20
Lally (2003)21 riscontrò che l‘utilizzo della SIRS era considerato accettabile
dalla maggior parte dei professionisti forensi (89%) e raccomandato dalla
20
Rogers, S., Sewell, K.W. e Gillard N.D. (2010). SIRS-2 - Structured Interview of Reported Symptoms, 2nd Edition. Odessa FL: Psychological Assessment Resources (ed. it.: Pezzuolo, S., Ciappi, S. e Zago S. (2016). Firenze, Hogrefe Editore). 21
Lally, S.J. (2003). What tests are acceptable for use in forensic evaluations? A study of experts. Professional psychology: Research and Practice, 34, 491-498.

maggior parte di loro (89%). Più recentemente Archer et al. (2006)22
osservarono che la SIRS era ampiamente utilizzata dai professionisti forensi al
fine di verificare la simulazione di malattia o la effettiva disabilità cognitiva
(86,2%).
Per tutti gli strumenti sopracitati è importante, specie ai fini delle valutazioni
diagnostiche giudiziarie e peritali, valutare la possibilità di simulazione. Come
si è detto, negli inventari MMPi-2 e PAI sono presenti diverse scale di validità;
esse assicurano l’attendibilità richiesta nelle valutazioni giuridiche, in
particolare per il PAI che ha ben 8 scale e indici di controllo23; così come per il
Rorschach sono stati individuati indicatori di simulazione come abbiamo
ampiamente illustrato nella descrizione del test24. Ma possiamo dire che usato
insieme al MMPI-2 il Rorschach è risultato utile per individuare la deliberata
simulazione di psicosi.
Rifacendosi alle conclusioni d un recente studio25 che indaga e approfondisce
soprattutto gli indici di validità, mettendo in relazione Rorschach e inventari di
personalità hanno confermato che questa relazione è complessa e articolata.
Mentre la produttività del Rorschach non appare connessa ad aspetti di validità,
la quantità globale dei dettagli e lo stile analitico, al contrario di quello globale,
sembra correlare con una maggiore apertura alla valutazione psicologica
(esponendosi alla valutazione negativa), con minore desiderabilità sociale e
minore tendenza difensiva. La difensività appare correlata anche ad un
incremento di risposte a contenuto animale e dell’indice di egocentrismo. Le
difese positive al Rorschach si contrappongono agli indicatori di simulazione e
alla tendenza di dare impressione negativa. Indicatori Rorschach come le difese
positive, a rotazione delle tavole, la presenza di contenuti premorbosi sono
diversamente connessi ad aspetti di validità ma è soprattutto l’indice Lambda a
22
Archer, R.P., Buffington-Vollum, J.K., Stredny, R.V. e Handel, R.W. (2006). A survey of psychological test use patterns among forensic psychologists. Journal of Personality Assessment, 87, 84-94. 23
Vedi gli studi di Boccacccini, Murrai, Duncan 2006 e Kucharski, Toomey, Fila Dunkan 2007 nella bibliografia 24
Vedi paragrafo attinente 25
Di Nuovo S., Inturri A., Longo S. “Proprietà psicometriche e inventari di personalità e del test Rorschach: studio sulla validità concorrente e indicazioni per la valutazione clinica e forense” su PSYCHOFENIA- ANNO XVII N°29/2014.

mostrare buona validità nell’evidenziare tendenza alla difensività, alla
desiderabilità sociale e alla dissimulazione.
L’indice di malingering del PAI risulta significativamente connesso con il
Lambda.
Nello studio citato si conclude che entrambe le tipologie degli strumenti hanno
utili criteri di attendibilità e andrebbero utilizzati congiuntamente per effettuare
una efficace diagnosi integrata.
Dopo aver esposto come sia possibile svelare efficacemente una simulazione
mediante vari strumenti anche testologici si rimanda all’abilità del clinico la
capacità di effettuare una diagnosi e la scelta dei test più idonei dopo aver
valutato il contesto di riferimento e l’esaminato con il colloquio clinico che
resta il principale strumento di valutazione.
“Nella filosofia greca classica, la Ragione è la facoltà cognitiva atta a distinguere ciò
che è vero da ciò che è falso, nella misura in cui verità sono in primo luogo una
condizione dell'Essere, della Realtà – e solo su questa base sono una proprietà di
proposizioni. Il discorso vero, la logica, rivela ed esprime ciò che realmente è, in
quanto distinto da ciò che appare (reale). In virtù di tale equazione tra Verità ed
Essere (reale) la Verità è un valore, poiché Essere è meglio che Non-Essere.”
Herbert Marcuse. (1898-1979)

BIBLIOGRAFIA
o Abbate L., Capri P. (1988). La diagnosi psicologica in ambito forense.
In L. De Cataldo Neuburger (Ed.), La giustizia penale e la fluidità del
sapere: ragionamento sul metodo. Padova: Cedam.
o Acklin M.W., McDowell C.J., Orndoff S. (1992). Statistical power
and the Rorschach: 1975-1991. Journal of Personality Assessment, 59,
366-379.
o Acklin M.W., McDowell C.J.,Verschell M.S. (2000). Interobserver
agreement, intraobserver reliability, and the Rorschach Comprehensive
System. Journal of Personality Assessment, 74, 15–47.
o American Psychiatric Association. DSM-IV-TR. Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Text Revision
o Andreoli V, Cassano GB, Rossi R. (a cura di) (2002) ICD-10/ICD-9-
CM. Classificazione parallela. Edizione italiana Milano- Masson.
o Andreoli V. (2000). Il Medico di Medicina Generale e la Psichiatria.
Milano. Editore Masson.
o Balestrieri M., Bellantuono C., Berardi D., Di Giannantonio M.,
Rigatelli M. Siracusano A., Zoccali R.A. (2007). Manuale di
Psichiatria. Roma. Il Pensiero Scientifico.
o Blais, Mark A.; Baity, Matthew R. and Hopwood, Christopher J.
“Clinical Applications of the Personality Assessment Inventory”.
Routledge, Oct. 2011
o Bini L, Bazzi T. Trattato di Psichiatria. Milano: Vallardi, 1954-1959.
o Boccaccini M.T., Murrie D.C., Duncan S.A. (2006). Screening for
malingering in a criminal-forensic sample with the Personality
Assessment Inventory. Psychological Assessment 18 (4), 415-423.
o Borri L. (1922) Trattato di Medicina Legale Vallardi Editore.
o Callieri B, Semerari A. (1959) La simulazione di malattia mentale.
Roma: Abruzzini Editore, 1959.

o Callieri B, Di Biagio F. Meccanismi e ritmi ripetitivi in psicologia e in
psichiatria. Arch Psicol Neur Psich 1957; 18: 107.
o De Cataldo N. (a cura di), 2010, Scienza e processo penale: linee guida
per l’acquisizione della prova scientifica, ISISC – CEDAM.
o Di Nuovo S. (1989). Il test di Rorschach in psicopatologia. Milano:
FrancoAngeli.
o Di Nuovo S., Cuffaro M. (2004). Il Rorschach in pratica: per la
psicologia clinica e per la perizia in ambito giuridico. Milano:
FrancoAngeli.
o Douglas K.S., Hart S.D., Kropp P.R. (2001). Validity of the
Personality Assessment Inventory for forensic assessment. International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 45 (2).
o Ekman P. (2009). I Volti della Menzogna. Gli indizi dell’inganno nei
rapporti interpersonali. Giunti Editori.
o Edens J.F., Cruise K.R., Buffington-Vollum, J.K. (2001). Forensic
and correctional applications of the Personality Assessment Inventory.
Behavioral Sciences and the Law, 19, 519-543.
o Exner J.E.Jr. (1974). The Rorschach: a Comprehensive System. Vol.
1, 1st ed. New York:Wiley.
o Exner J.E.Jr. (1999).The Rorschach: measurement concepts and issues
of validity. In S.E. Embretson, S.L. Hershberger (Eds.), The new rules
of measurement:What every psychologist and educator should know.
Mahwah: Erlbaum.
o Exner J.E.Jr. (2001). Rorschach changes following brief and short-
term therapy. Clinical Psychology: Science and Practice, 59 (1), 59-71.
o Exner J.E.Jr. (2003). The Rorschach Basic Foundation The
Rorschach, Basic Foundations and Principles of Interpretation. 4th ed.
New York:Wiley
o Exner J.E.Jr., Erdberg P. (2005). The Rorschach: A Comprehensive
System:Vol. 2.
o Ferracuti, S., Parisi, L., & Coppotelli, A. (2007). Simulare la malattia
mentale. Centro scientifico.

o Ferracuti, Stefano, et al. (2008). I test mentali in psicologia giuridica e
forense. Centro Scientifico Editore.
o Fratini C. (2014). La simulazione di patologia in ambito giuridico.
State of Mind
o Gabbard GO. Psichiatria psicodinamica. IV ed. Milano: Raffaello
Cortina Editore, 2007.
o Gacono C.B. (1988). The use of the Psychopathy Checklist-Revised
(PCL- R) and Rorschach in treatment planning with antisocial
personality disordered patients. International Journal of Offender
Therapy and Comparative Criminology, 42 (1), 49-64.
o Gacono C.B. (2002). Introduction to a special series: Forensic
psychodiagnostic testing. Journal of Forensic Psychology Practice 2 (3),
1-10.
o Gacono C.B., Barton Evans F. (2008). (Eds.). The Handbook of
Forensic Rorschach Assessment. New York: Routledge/Taylor &
Francis.
o Giberti F, Rossi R. Manuale di Psichiatria. VI ed. Padova: Piccin &
Vallardi, 2009.
o Hiller G.B., Rosenthal R., Bornstein R.F., Berry D.T.R., Brunell-
Neuleib S. (1999). A comparative meta-analysis of Rorschach and
MMPI validity. Psychological Assessment, 11, 278-296.
o Iorio M, Massimelli M, Maina G, et al. (2009) Simulazioni in
medicina legale. Torino: Edizioni Minerva Medica.
o Jung CG.(1973) Simulazione di malattia mentale. Torino: Bollati
Boringhieri.
o Kucharski L.T., Toomey J.P., Fila K., Duncan S. (2007). Detection
of malingering of psychiatric disorder with the Personality Assessment
Inventory: An investigation of criminal defendants. Journal of
Personality Assessment, 88 (1), 25-32.
o Leoncini F. (1925) La perizia e l’autopsia come elementi integrativi del
giudizio. Spoleto.

o Meyer G.J. (1997b). On the interpretation of personality Assessment
methods: the Rorschach and the MMPI. Journal of Personality
Assessment, 68, 297- 330.
o Morey L.C. (1997). The Personality Assessment Screener (professional
manual: Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
o Morey L.C. (2007). The Personality Assessment Inventory
professional manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.
o Morey L.C. (2016). PAI – Personality Assessment Inventory. Edizione
Hogrefe
o Nivoli GC, Lorettu L, Sanna MN, et al. (2006) Simulazione e
malattia mentale. In: Volterra V, editor. Psichiatria forense,
criminologia ed etica psichiatrica. Milano: Masson.
o Nivoli GC. (2005) Il perito e il consulente di parte in psichiatria
forense. Torino: Centro Scientifico Editore.
o Pajardi, Daniela, Lucia Macrı,̀ and Isabella Merzagora Betsos
(2006). Guida alla valutazione del danno psichico. Giuffrè.
o Pancheri P, Cassano GB. (1999) Trattato Italiano di Psichiatria (II
ed.). Milano: Masson.
o Penta P. (1900) La simulazione della pazzia e il suo significato
antropologico, etnico, clinico e medico-legale. Napoli: Francesco
Perrella Editore.
o Popper K., (1986), in AA.VV., Filosofia e pedagogia dalle origini a
oggi, vol. 3, p. 615, La Scuola, Brescia.
o Puccini C. (1973) Manuale di Medicina Legale. Vallardi Editore.
o Rogers, R., Bagby, R.M., & Dickens S.E. (1992). Structured
Interview of Reported Symptoms (SIRS): Professional Manual. Odessa,
FL: Psychological Assessment Resources.
o Rogers, R., Jackosn, R.L., Sewell, K.W., Harrison, K.S. (2004). An
examination of the ECST-R as screen for feigned incompetency to
stand trial. Psychological Assessment, 16, 213-223.
o Rogers, R., Sewell, K. W., & Gillard, N. D. (2010). Structured
Interview of Reported Symptoms (SIRS), 2nd Edition, Professional

Manual. Lutz, FL: Psychological Assessment Resources, Inc. (ad. it.: a
cura di S. Ciappi, S. Pezzuolo, S. Zago. Firenze: Hogrefe Editore,
2016).
o Salvi M. (2013). L’Intervento dello Psicologo Penitenziario. State of
Mind.
o Stracciari, Andrea, Angelo Bianchi, and Giuseppe Sartori (2010).
Neuropsicologia forense. Il mulino.