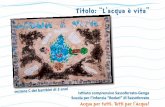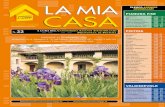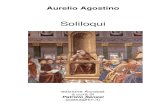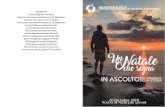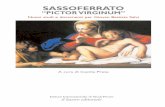Sassoferrato Mia Anno 2008
-
Upload
luigi-garofoli -
Category
Documents
-
view
519 -
download
5
Transcript of Sassoferrato Mia Anno 2008

SassoferratoPubblicazione a cura dell’Associazione
“Sassoferratesi nel mondo”N°2 - Luglio 2008 mia

Direttore: Raniero Massoli-NovelliVice direttore: Perseo TrojaniRedazione: Timoteo Benedetti
Alberto AlbertiniValentina ArtegianiMassimo BardelliUmberto Comodi BallantiAntonio Maria LuziGiovanni PesciarelliVittorio Toni
Associazione “Sassoferratesi nel mondo”Palazzo BaldiniCorso Don Minzoni, 4060041 Sassoferrato (An)
Segreteria : Tel. 0732 959345Fax 0732 [email protected]
Sopra: Francesco Garofoli - Paesaggio sotto la neve - 1986 - AcquaforteFoto di copertina: Raniero Massoli-Novelli
Grafica e stampa: Tipografia Garofoli [email protected]
N°2 - Luglio 2008

SassoferratomiaLa nostra Associazione è nata e si è con-cretizzata con poche e semplici conside-razioni. Essere sassoferratesi è comeessere nati in qualsiasi altro paese. I na-poletani direbbero “ogni scarrafone èbell’ a mamma soja”. Noi siamo consa-pevoli di appartenere ad un territorio lacui storia viene da lontano, la sua cultura,bellezza, arte, tradizioni, tutti ingredientiinteressanti per riflettere, compiacersi,meditare ed elaborare. Miscela preziosaper accendere un futuro che sappia por-tare a traguardi dignitosi, ambiziosi adesclusivo beneficio della collettività.I due anni velocemente trascorsi ci hannoappena introdotto nell’ingranaggio dellavalorizzazione del nostro territorio, di per-sonaggi che con la capacità, l’impegno, laserietà hanno raggiunto posizioni di ri-lievo contribuendo a portare alto il con-
cetto di “sassoferratesità”. Importante ri-teniamo sia non dimenticare anche coloroche in passato si sono impegnati in talsenso. Un ringraziamento particolare ainostri soci (oltre 70, finora, da diverseparti del mondo) che ci sostengono inparte con i contributi indispensabili per ilprosieguo della vita dell’Associazione.Grazie inoltre a coloro che collaboranocon pubblicazioni e servizi vari. Ringra-ziamenti al Comune di Sassoferrato, allaFondazione Cassa di Risparmio di Fa-briano e Cupramontana, alla Farroteca diMonterosso di Lea Luzi, alle fiorerie LaPrimavera e Clorofilla di Sassoferrato.Ringraziamenti infine ai componenti ilConsiglio Direttivo per il volontario impe-gno supportato da una notevole passioneper la loro terra.
Timoteo Benedetti
La parola al Presidente
Visita periodicamente il nostro sitowww.sassoferratomia.ite troverai tutte le informazioni utili sull’Associazione.
Segnalazioni, suggerimenti e iniziative da parte dei soci possono essere inviate a:[email protected]

2
Sabato 11 agosto 2007, presso la Sala del Consiglio Comunale di Sas-soferrato, alla presenza di un numerosissimo pubblico, del Sindaco Ri-naldi, dell’Assessore alla Cultura Censi, del Presidente Onorariodell’Associazione Padre Stefano Troiani e di tutto il Consiglio Direttivodell’Associazione si è svolta la seconda premiazione del Premio MonteStrega. Un breve saluto del Primo Cittadino evidenzia le finalità dellaAssociazione e riconosce i lodevoli meriti dei nostri premiati concitta-dini che hanno saputo, nelle loro specifiche attività, dare lustro al no-stro paese, contribuendo a migliorare l’immagine della nostraSassoferrato.La parola passa poi al nostro Presidente Timoteo Benedetti per un sim-patico saluto ai premiati, ai loro familiari e a tutti gli intervenuti. Lamolla che spinge i collaboratori e gli associati altro non è che l’amoreper la nostra terra, la nostra cultura, le nostre tradizioni particolar-mente sentite soprattutto da coloro che vivono lontano dal proprioPaese.I personaggi contemporanei prescelti sono stati il Dott. Franco Fra-sconi, il Prof. Raniero Massoli-Novelli e Padre Armando Pierucci, men-tre quelli premiati “alla Memoria”: Padre Antonio Lisandrini, DonAlberico Pagnani e Prof. Guido Vitaletti.Il loro profilo professionale viene di seguito evidenziato nelle loro spe-cifiche peculiarità.Molto simpatici ed interessanti gli interventi dei premiati nonche quellidei familiari dei premi alla memoria, in particolare quello del giovaneGiacomo Pagnani che con bravura e spigliatezza ha ricordato la bellafigura di Don A. Pagnani.La cerimonia si è svolta con la consegna dei premi (ceramica raffigu-rante il paesaggio del Monte Strega eseguita dagli alunni della scuolamedia Bartolo da Sassoferrato diretta dal Prof. Calagreti) e relativapergamena) intercalata da piacevoli brani musicali di Alissa Bruschi eFrancesco Fioranelli.Ringraziamenti al Comune di Sassoferrato, alla Fondazione Cassa diRisparmio di Fabriano e Cupramontana, al presentatore della manife-stazione Vittorio Toni (in assenza giustificata dell’ormai titolare BiagioMarini), alla Ditta “Farroteca Monterosso” di Lea Luzi, dispensatrice diun succulento buffet, alle Ditte Fiori e Piante Primavera e Clorofilla edinfine a Massimo Bardelli, delegato Regionale della FIAF, per il servi-zio fotografico.
Premio Monte StregaEdizione 2007
Su il sipario...
Premiazione presso la Sala Consiliare
Padre A. Pierucci, Raniero Massoli-Novelli e Franco Frasconi

3
Dott. FRANCO FRASCONIE’ nato a Sassoferrato, dove ha frequentatogli studi fino al Liceo Scientifico, si è poi lau-reato in Fisica Nucleare presso l’Università diBologna.
Con una borsa di studio ha prima lavoratocome ricercatore al Politecnico di Milano oc-cupandosi di materiali compositi per applica-zioni tecnologicamente avanzate.Nel 1988 si è trasferito al CERN di Ginevra
dove, con il gruppo del Prof. Zichichi ha lavo-rato all’esperimento L3 nell’ambito della fi-sica subnucleare.Successivamente, nel 1991,si è trasferito in Germania dedicandosi allarealizzazione di un rivelatoreVXD nel contestodell’esperimento ZEUS di Amburgo, dive-nendo coordinatore e responsabile del cor-retto funzionamento dello stesso. Ritornato alCERN di Ginevra ha collaborato con il Prof. T.Ypsilantis allo studio di un rivelatore di neu-trini solari da installare presso i laboratori delGran Sasso.Nel 1955 si è trasferito alla Syra-cuse University (U.S.A.) con l’incarico di Re-search Associate Professor unendosi algruppo coinvolto nello studio e realizzazionedi un rivelatore di luce Cherenkov per l’espe-rimento CLEO III. Sempre presso la SyracuseUniversity ha tenuto corsi sulle tecniche di ri-velazione della radiazione nucleare e subnu-cleare. Nel 1997 è rientrato in Italiaassumendo l’incarico di ricercatore presso laSezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di Fi-sica Nucleare.Nell’ambito di una collabora-zione Italo-Francese ha preso parte comecoordinatore al progetto per la realizzazione
dell’interferometro VIRGO dei sistemi di iso-lamento sismico degli specchi realizzati dalgruppo I.N.F.N. di Pisa, dove dal 2003 ottienel’avanzamento a “Primo Ricercatore” pressola stessa Sezione dell’Istituto Nazionale di Fi-sica Nucleare da cui dipende. E’ stato inoltreresponsabile scientifico per 4 anni (2002-2006) del dipartimento all’interno del Labora-torio E.G.O. legato al suddetto progettoVIRGO. L’esperienza acquisita è comprovatada oltre 100 pubblicazioni su riviste specializ-zate elencateci e agli atti di questa Associa-zione “ Sassoferratesi nel Mondo.”
Prof. RANIERO MASSOLI NOVELLIProfessore universitario di geologia, con lapassione per i viaggi, l’ambiente naturale ela fotografia, vive e lavora a Roma.Ha insegnato nelle Università di Cagliari, Mo-gadiscio, Addis Abeba, l’Aquila e Roma Tre.E’ stato vicepresidente della SIGEA (SocietàItaliana di Geologia Ambientale) ed è mem-bro di numerose associazioni scientifiche edambientali italiane e straniere.E’ autore di oltre 160 pubblicazioni scientifi-
I premiati
Timoteo Benedetti, Luigi Rinaldi e Franco Frasconi Gianni Pesciarelli, Franco Brescini e Padre Armando Pierucci
Padre Stefano Troiani, Vittorio Toni e Franco Frasconi Raniero Massoli-Novelli e Bassimo Bardelli

4
che, e di cinque volumi divulgativi su temati-che ambientali: Lo stagno di Molentargius(1976), East Africa (1985), Ecologia in Sarde-gna (1986), Le zone umide della Sardegna(1989), Monumenti geologici: conservare ilpatrimonio della Terra (1998); ”I miei viaggi”(2007). E’ autore di un CD fotografico, bilin-gue, Geositi: conservare il patrimonio geolo-gico (2001), il primo ad essere pubblicato inItalia in tale settore, dove vi è un capitolo de-dicato alla geologia di Sassoferrato e din-torni. Nel lontano biennio1959-1960 è statoautore di una importante tesi di laurea dal ti-tolo “Aspetti geologici e idrogeologici del ter-ritorio tra Sassoferrato ed il Monte Cucco”,ricca di spunti ancora oggi attuali.Successivamente come geologo professioni-
sta, ha collaborato a fondamentali ricerchedi acqua per il Comune di Sassoferrato.Negli anni ’70 ha scritto ed operato perl’apertura al pubblico delle Grotte di Frasassi,in polemica con associazioni che vi si oppo-nevano.Recentemente con il giovane collega France-sco Lunardi, ha progettato un importante iti-nerario geoturistico che parte dalle Grotte diFrasassi, passa per Sassoferrato e dintornied arriva al Monte Catria.Ha poi contribuito alla crerazione del Museodella Miniera di Zolfo di Cabernardi e fa partedel Comitato per la difesa del Monte Ro-tondo.E’ da molti anni giornalista pubblicista, ed haviaggiato e fotografato in oltre 50 Paesi. Conarticoli e foto ha collaborato a quotidianicome l’Unione Sarda e il Giornale, ed ha pe-riodici come Geologia dell’Ambiente, Diana,Ambiente, Habitat, Airone; con scritti, foto edinterviste ha spesso portato il territorio diSassoferrato, con le sue importanti valenzeambientali, all’attenzione della stampa na-zionale.
PADRE ARMANDO PIERUCCI
Marchigiano di Sassoferrato per la sua lungaattività svolta nella nostra cittadina, è nato nel1935 a Maiolati Spontini. Diplomato in cantogregoriano, pianoforte, musica corale e dire-zione di coro, organo e composizione organi-stica, risiede a Gerusalemme. Dal 1988 èorganista del Santo Sepolcro e Presidente delConservatorio di Musica “ Magnificat “ chefece “nascere”, 10 anni fa, per superare le bar-riere fra ebrei e palestinesi, per far incontrarepersone di diversa etnia, religione e naziona-lità. Il corpo insegnante di questa singolarescuola è infatti formato da Israeliani, Palesti-nesi, Armeni, Europei, Arabi, Americani: cri-stiani di tutte le confessioni, israeliti emusulmani. Padre Armando Pierucci, dopo il di-ploma, ha insegnato organo e composizioned’organo per molti anni al Conservatorio di Pe-saro, ha tenuto numerosissimi concerti in Italiae all’estero come direttore di coro e organista,scrivendo musiche per organo, arpa, ottoni. InTerra Santa compone molte messe in latino edin arabo e musiche. Padre Armando Pierucci èconsiderato in Europa il “più grande composi-tore e organista”. Il suo grande desiderio di im-parare a suonare è vivo fin da bambino e, solograzie a questa forte motivazione e alla provvi-denza, imparò a suonare: era allora proibito perun fratino andare a suonare l’armonium in cap-pella. La sua passione per la musica, dopo unavita dedicata all’insegnamento lo ha guidato susentieri inimmaginabili, fondando, contro ogniavversità, l’Istituto Musicale il Magnificat inTerra Santa. Così Padre Pierucci narra di sé: “Lamusica è stata tutta la mia vita..., mi ha per-messo di incontrare persone di grande levaturaculturale e spirituale..., di entrare nell’inse-gnamento in conservatorio e di essere arrivatoin Terra Santa e, poiché non ci può essere mu-sica senza insegnamento, di poter aprire unascuola innovatrice!”.
PADRE ANTONIO LISANDRINI
Sono molti i meriti e le motivazioni che pos-sono accompagnare l’assegnazione del PremioMonte Strega a Padre Antonio Lisandrini, la cuigrandezza s’è manifestata in modo preminentenell’oratoria sacra, tanto da essere chiamato il“Demostene del XX secolo”.Laureato all’Università Cattolica di Milano conuna tesi su Spinosa, insegnò Filosofia nell’Uni-versità di Urbino, di poi sociologia ed eloquenzasacra, rispettivamente nel Pontificio AteneoAntoniano e nell’Università Luterana di Roma.Fu consultatore nel Sinodo Romano e membrodi una commissione preparatoria del ConcilioEcumenico; nell’ordine a cui apparteneva rive-stì vari incarichi che assolse con impegno ecompetenza. Fu locatore assiduo alla Radio Va-ticana e alla Rai. Le sue più grandi trasmissionisono state le radiocronache dei funerali di PioXII e dell’incoronazione di Giovanni XXIII.Alla televisione curò documentari di grande in-teresse religioso e culturale, come gli “Attidegli Apostoli” e “Attraverso la Bibbia”; fu at-
tivo parlatore anche presso diversi centri tele-visivi degli Stati Uniti. L’oratoria fu la suagrande vocazione, raggiungendo le più altevette della comunicazione di massa e rinno-vando i modi di pensare e la trattazione di dot-trine religiose e sociali.
L’assessore Censi consegna la pergamena al fa-miliare di P. A. Lisandrini

5
Attraverso la predicazione si affermò come unodei più affascinanti protagonisti della storiacattolica del XX secolo in Italia, qualificandosicome una delle punte di diamante del rinnova-mento politico-religioso della società italiana,in cerca, dopo la funesta parentesi della se-conda guerra mondiale, di una nuova immaginee di un nuovo assetto.Con una predicazione del messaggio evange-lico forte e convinta, con una straordinaria sim-patia umana e religiosa, raggiunse il cuore el’intelligenza delle masse aprendole alla pro-posta di rinnovamento del pensiero politico edella pratica religiosa e sociale della Chiesa.Per la notorietà delle sue doti oratorie fu chia-mato ha svolgere il ministero in tutta Italia, inGermania, Inghilterra, Egitto, Argentina e inmolti stati del Nord e Sud America; a BuenosAires, in una circostanza ebbe un milione diuditori; negli ultimi anni predicò in India, inGiappone, a Formosa; parlò più volte nei piùgrandi teatri d’Italia e di altri paesi, in sedi uni-versitarie. Sentì profondamente gli ideali dellalibertà e della giustizia sociale, combattè ogniforma di violenza, mettendosi anche a fiancodelle formazioni partigiane delle nostre mon-tagne. Amò profondamente la sua e nostracittà di Sassoferrato; per esprimere questo sen-timento coniò una parola di grande forza e vita:la “Sassoferratesità”.
DON ALBERICO PAGNANISpirito profondamente religioso e nobile figuradi intellettuale, i suoi studi hanno spaziato in
varie discipline, con particolare riferimento aquelle storiche, nelle quali ha approfondito conserietà e passione i momenti più salienti e gliavvenimenti più incisivi della vita nelle nostreterre, affidandoli per sempre alla civica memo-ria. I due suoi volumi: “La Storia di Sentinum”e “Storia di Sassoferrato” costituiscono ancora,a parecchi decenni dalla loro pubblicazione, lescritture di riferimento di ogni successiva ri-
cerca delle opere edite riguardanti le nostreterre, le nostre genti, le loro civiltà, gli avveni-menti accaduti dall’antichità fino agli anni cin-quanta del Novecento. Cultore esemplare dellaagiografia monastica e sacerdotale, con i suoiscritti ha saputo tracciare ritratti di grande ri-lievo, contribuendo all’ampliamento di quellaspecifica letteratura che ha, appunto, per og-getto la vita dei santi, narrandone con acutezzainterpretativa e fine stile letterario le vicendeumane ed evidenziandone i grandi meriti pa-storali. I suoi scritti, che costituiscono un im-portante e corposo lascito, oggi sonocertamente di grande aiuto nella conoscenzadelle vicende storiche e della realtà di questiluoghi, a cui si dedicò con profondo amore egrande rispetto, sapendoli descrivere e rappre-sentandoli, tra l’altro, con affetto ma al con-tempo con rigorosa misura.
PROF. GUIDO VITALETTINasce a Roma da famiglia originaria di Val-
dolmo, trascorre l’infanzia e la gioventù traRoma e le Marche, cui sempre rimane attac-cato. Laureatosi in lettere all’Università diRoma, si dedica all’insegnamento come ordi-nario presso vari Licei ed Università, tra cui laScuola Normale di Pisa e l’Università di Lucca,nonché quella di Lisbona. Dirige il GiornaleDantesco dal 1922 al 1927. A Lisbona arriva nel1926, vi rimane quattro anni, assumendo l’in-
carico di Addetto Culturale presso l’Amba-sciata d’Italia, incarico conferitogli dal GovernoItaliano che poi riceverà successivamenteanche per l’Ambasciata d’Italia a Londra. Nelfrattempo decide di voler trascorre il suo tempolibero nelleMarche ed acquista a Sassoferrato,in Castello, una parte dell’allora dirupo PalazzoBentivoglio, che verrà completamente ristrut-turato. Nel 1930 parte per il Brasile, dove èstato invitato a tenere un ciclo di conferenze suVasco de Gama, Camoes e i suoi legami storicitra Portogallo e Brasile; anche qui collabora conl’Ambasciata d’Italia a Rio de Janeiro. Dopo treanni rientra in Europa, a Nizza, con l’incarico difondare la Libreria Italiana. Nel 1935 si reca aCopenhagen dove fonda la Società di StudiDanteschi; nel 1936 viene incaricato di fondaree dirigere la Scuola Italiana, destinata ai figli
degli italiani residenti in Inghilterra; sempre nel1936 decide di fare un breve viaggio in Italiaper motivi di salute, convinto che il clima delleAlpi gli avrebbe giovato. Muore improvvisa-mente a Torino. Nel suo testamento moralechiede di essere sepolto nelle sue amateMar-che, alle falde del Monte Strega; le sue ceneririposano nella cappella di famiglia del cimiterodi Camporè. Guido Vialetti ha amato profonda-mente la propria cittadina e la sua terra mar-chigiana (vedi gli studi”Dolce Terra di Marca”);è stato valido consigliere delle nostre Istitu-zioni. Ha effettuato studi su Sentinum e rifon-dato il locale Museo Archeologico; hapubblicato testi e stampe sulla vita e le operedi importanti personaggi sassoferratesi; hapubblicato testi e laudi spirituali, testi di sto-ria, letteratura, su artisti come MichelangeloBuonarroti, Dante Alighieri, Torquato Tasso ealtri. Ha messo in risalto la Corte di Urbino. Haraccontato l’opera del Salvi pittore eseguita aPerugia e Venezia. Moltissime sono state lesue pubblicazioni, di cui 46 monografie chesono reperibili presso gli archivi informaticidelle regioni italiane. I sassoferratesi sono or-gogliosi di annoverare tra i propri concittadiniun personaggio come il Prof. Guido Vialetti.
Ritirano il premio i giovani nipoti Giacomo Pagnanie Riccardo Troncanetti.
Gianni Pesciarelli consegna il premio ad AnnaVitaletti.

6
1 2 3
4 5
6 7
8 9

7
La premiazione del Prossimo premio MonteStrega 2008, si terrà SABATO 23 AGOSTO,alle ore 16,00 presso la Sala Consiliare delComune di Sassoferrato.I premiati saranno:Renzo Ruzziconi, Docente e Ricercatore Re-sponsabile Università Facoltà di Chimica diPerugia e Basilicata;
Giuseppe Vitaletti, Docente e RicercatoreResponsabile di Economia e Finanze Univer-sità di Roma e Viterbo (Tuscia). Esperto con-sulente Ministero di Economia e Finanze inmateria di Federalismo Fiscale.
La serata sarà allietata dalla bella voce di Ro-sita Tassi.
I premiati “alla memoria” saranno:
Pietro Camilli, Sindaco di Sassoferrato nellaprima legislatura post bellica;
Albertino Castellucci, Onorevole e Sindacodi Sassoferrato;
Robert Mondavi, è stato, tra i figli del con-cittadino Cesare Mondavi, colui che, con ilfratello Pietro, ha reso grande l’azienda vini-cola “ Mondavi Winary”, considerata tra lepiù prestigiose degli USA;
Domenico Morbidelli, sassoferratese, coni suoi figli e nipoti, ha dato grande prestigioalla città di Extrema, Brasile.
DOMENICA 24 AGOSTO p.v. la manifesta-zione si concluderà con la visita guidata, deisoci dell’Associazione e di coloro che vor-ranno partecipare, ai tre Musei cittadini conil seguente programma:ore 9,00 visita al Museo Miniera di Zolfo diCabernardiore 10,30 visita al Museo Tradizioni Popolariore 11,00 visita al Museo Archeologicoore 13,00 pranzo sociale presso Ristorante LaRocca. L’invito alla partecipazione è aperto aiSoci e coloro che vorranno prenderne parte.È obbligatoria la prenotazione entro il20/08/08- Tel.073295444
Diretta web delPremio Monte Strega 2008Sarà possibile assistere alla diretta della serata di premiazione del 23 agosto 2008collegandosi dalle ore 16,00 al sito www.sassoferrato.tv.
www.sassoferrato.tv
Premio Monte Strega2008
Il 23 agosto la terza edizione
Pagina precedente:
1. In prima fila la fam. Vitaletti
2. La cantante Alissa Bruschi
3. Giacomo Pagnani e Riccardo Troncanetti
4. Vittorio Toni e Padre Armando Pierucci
5. Padre Armando Pierucci e Anna Porfiri
6. Franco Frasconi
7. Padre A. Pierucci e Raniero Massoli-Novelli
8. Giovanni Pesciarelli
9. Mario Toni e Padre Armando Pierucci

8
Come ormai da tempo i mezzi di informazioneci stanno ricordando, la disponibilità di com-bustibili fossili (petrolio e suoi derivati, car-bone e gas naturali) che sono alla basedelladomanda energetica della nostra società, staper arrivare ad un livello di guardia preoccu-pante a causa dell’esaurimento dei giaci-menti noti e delle sempre più elevatedifficoltà di individuarne dei nuovi. In ag-giunta, alcune nazioni in forte espansioneeconomica, Cina ed India in testa, stanno au-mentando oltre le previsioni, la domanda dicombustibili per soddisfare le richieste ener-getiche che tale crescita impone per restareal passo con gli obiettivi economici. Un altroaspetto del problema energetico è rappre-sentato dall’inquinamento del pianeta deri-vante dalla emissione di gas serra prodottidurante l’uso dei combustibili fossili. Accer-tato che il primo problema ha creato scompi-glio nel calcolo delle previsioni sull’utilizzodelle riserve energetiche, il secondo haaperto orizzonti inquietanti su problemi pertroppo tempo sottovalutati o dimenticati chemeritano risposte immediate. Il futuro ener-getico, pertanto, sembra il nodo crucialedella nostra organizzazione societaria e ilproblema principale per le generazioni attualie future. Trovare una soluzione duratura aquesti due problemi solo apparentemente di-sgiunti, rappresenta un obiettivo sul quale unqualsiasi paese moderno e civile deve con-centrarsi con il preciso scopo di fornire alter-native all’utilizzo dei combustibili fossili chesiano durature, sicure e che limitino il loroimpatto ambientale sul pianeta. Nel nostropaese, che non ha a disposizione giacimentidi combustibili fossili rilevanti per poter sod-disfare il fabbisogno energetico nazionale, ilproblema della mancanza di fonti di energiasta creando un ostacolo in più ad una econo-mia in piena recessione. La soluzione del pro-blema energetico potrebbe influenzaresignificativamente anche quella di altri adesso connessi.
Le alternative La sostituzione delle attualifonti di energia è sicuramente un’impresanon semplice. Per troppo tempo abbiamovisto a grande distanza temporale il giornodel loro esaurimento. Solo recentemente cistiamo accorgendo che il 2050, prima datafissata come limite ultimo per l’utilizzo degliattuali combustibili, e ancora piu’ recente-
mente il 2040 come aggiornamento delle pre-visioni tenendo conto della continua crescitadi domanda energetica, rendono le prospet-tive molto piu’ preoccupanti. Nel frattempoci si è affrettati a dire, che un’ottima alter-nativa ai combustibili fossili e’ rappresentatadallo sfruttamento dell’energia solare.Anche se questa alternativa può essere con-siderata valida, la cosa merita un’analisi tec-nologica più dettagliata che cerchi di metterein risalto sia gli aspetti positivi sia quelli ne-gativi. Il Sole irraggia in nostro pianeta conuna quantità enorme di energia solare (circa10000 volte superiore a tutta l’energia usatadall’uomo) ma poco concentrata e piuttostodifficile da convertire in energia facilmentesfruttabile (principalmente elettricità) con ef-ficienze accettabili. L’intensità della radia-
zione solare che in media arriva sulla terra e’pari a circa 1000 W per metro quadrato di su-perficie. La tecnologia fin qui sviluppata perlo sfruttamento di questa fonte rinnovabile dienergia si basa su tre tipi di pannelli: - ilPannello Solare che sfrutta i raggi solariper riscaldare un liquido con speciali carat-teristiche contenuto nel suo interno. Il liquidocede a sua volta calore, tramite uno scam-biatore di calore, all’acqua contenuta in unserbatoio di accumulo (produzione di energiatermica); - il Pannello Solare a Concen-trazione che sfrutta degli specchi paraboliciper concentrare i raggi solari su un tubo rice-
vitore in cui scorre un fluido termovettore ouna serie di specchi piani che concentrano iraggi all’estremità di una torre in cui è postauna caldaia riempita di sali che per il calorefondono. In entrambi i casi “l’apparato rice-vente” si riscalda a temperature molto ele-vate (400°C ~ 600°C); - il PannelloFotovoltaico che sfrutta le proprietà dei se-miconduttori (principalmente silicio) di cui e’costituito, per produrre energia elettricaquando sollecitati dalla luce. Le celle foto-voltaiche convertono la luce solare diretta-mente in energia elettrica ma hanno unaefficienza media del 15%. Gli altri tipi di pan-nelli solari si attestano su livelli poco supe-riori portando il computo complessivodell’efficienza intorno al 20% (circa 200 Wper metro quadrato di superficie). A questa
bassa efficienza va aggiunta l’intermittenzadell’energia prodotta. Mentre i pannelli so-lari vengono utilizzati per fornire acqua caldae riscaldamento ad abitazioni, i pannelli fo-tovoltaici vengono utilizzati prevalentementeper alimentare dispositivi distanti dalle retielettriche. In entrambi i casi si ha un rendi-mento variabile legato alle condizioni mete-reologiche e al ciclo giorno-notte.
Un’altra buona alternativa allo sfruttamentodell’energia solare e’ rappresentata dal-l’energia eolica. Questa fonte rinnovabiledi energia si basa sulla conversione del-
Energia: quale futuro?di Franco Frasconi

9
l’energia cinetica posseduta dal vento che in-veste le pale di un generatore eolico, in ener-gia elettrica. Il suo sfruttamento può esserepensato tenendo presente sia una produzionecentralizzata in impianti da porre in luoghi altie ventilati, sia un eventuale decentramentoenergetico con impianti di piccola taglia,composti da un numero esiguo di pale (1-3pale da 3-4 MW – milioni di Watt) con lequali si genera in loco l’energia consumata.
La tecnologia disponibile per questo tipo disfruttamento utilizza macchine eoliche (ge-neratori eolici) di due diversi tipi:i Generatori Eolici ad asse verticale conridotte quantità di parti mobili, alta resistenzaalle forti raffiche di vento, possibilità di sfrut-tare qualsiasi direzione del vento senza do-versi riorientare continuamente;i Generatori Eolici ad asse orizzontaleformati da una torre in acciaio (altezza varia-bile fra 60 e i 100 m) sulla cui sommità sitrova un involucro (gondola) che contiene ungeneratore elettrico azionato da un rotore apale lunghe circa 20 m (solitamente 2 o 3)che genera una potenza molto variabile (tipi-camente 600.000 Watt che equivale al fab-bisogno elettrico giornaliero di circa 500famiglie). Di particolare interesse per unpaese circondato dall’acqua come l’Italia e’anche la possibilità di sfruttare a pieno re-gime l’energia idraulica basata sullo spo-stamento di grandi masse d’acqua perprodurre energia elettrica. Questo tipo disfruttamento ha il grande vantaggio di essererinnovabile e la tecnologia per fare ciò e’nota da tempo anche se ultimamente si sonofatti dei progressi interessanti. Le normaliturbine utilizzate nelle centrali idroelettriche
per la trasformazione dell’energia cineticadell’acqua in energia elettrica possono es-sere affiancate da sofisticate turbine per losfruttamento dei moti di marea e delleonde. Il movimento del mare è, infatti,un’enorme fonte di energia quasi inutilizzatae cercare di trarre vantaggi dal suo utilizzo si-gnificherebbe mettere a disposizione degliutenti un’altra fonte energetica a costi con-tenuti.
Fra le fonti di energia alternativa a basso obassissimo impatto ambientale, non va di-menticato anche il potenziale sfruttamentodell’energia geotermica. In questo caso sitratta di riuscire ad estrarre e canalizzarel’energia termica accumulata nel sottosuoloche si manifesta in superficie mediante eru-zioni quasi sempre non controllabili. I pro-blemi legati a questo tipo di giacimenti sonorappresentati dall’elevato costo delle perfo-razioni di elevata profondità e della canaliz-zazione necessaria per l’utilizzo finale.Limitandosi, però, a sfruttamenti locali si puòcreare rete fornendo direttamente all’utenteenergia termica. Questo e’ un po’ quello cheaccade in Toscana dove esistono due giaci-menti geotermici a dominante vapore (Larde-rello 400 milioni di Watt e Monte Amiata 22milioni di Watt) utilizzati per il fabbisognoenergetico locale. Proprio su questo argo-mento sta partendo un programma di ricercarivolto al monitoraggio e al possibile sfrutta-mento di energia geotermica nell’area deiCampi Flegrei (Campania). Il progetto CFDDP(Campi Flegrei Deep Drilling Project – Pro-getto di Perforazioni in Profondità dei CampiFlegrei), questo e’ il nome che gli e’ statodato, mira a fare dei Campi Flegrei un labo-
ratorio naturale per il monitoraggio dell’atti-vità vulcanica locale. Oltre a migliorare la ge-stione di una delle aree a piu’ alto rischiosismico del pianeta, attraverso questo pro-getto si spera di riuscire a rilanciare l’uso del-l’energia geotermica in Italia ed in particolarenel Meridione. La geotermia, infatti, e’ unafonte rinnovabile a basso impatto ambien-tale. Le emissioni di anidride carbonica dellecentrali geotermiche sono, a parità di po-tenza energetica fornita, nel peggiore deicasi 20 volte inferiori rispetto a centrali ali-mentate con combustibili fossili.
La prospettiva idrogeno e il nucleareAttenzione particolare meritano l’idrogeno eil nucleare come alternative all’utilizzo deicombustibili fossili. L’idrogeno e’ salito allaribalta fra i possibili sostituti del petrolio, so-prattutto come combustibile per i mezzi ditrasporto, nascondendo però tutti i suoi limiti.E’ vero che il suo utilizzo abbatterebbe note-volmente le emissioni di gas serra in atmo-sfera, ma allo stato gassoso esiste in naturasolo in piccole percentuali. Deve perciò es-sere prodotto artificialmente attraverso pro-cessi che necessitano di un sostanzialeapporto energetico esterno che non semprerisulta vantaggioso dal punto di vista del bi-lancio finale (per produrre idrogeno ad esem-pio per via elettrolitica, serve una volta emezza l’energia che si può ricavare dalla suacombustione). In aggiunta se ricavato per viatermica dal metano, il processo ha lo svan-taggio di produrre anche anidride carbonica.L’idrogeno, pertanto, può essere consideratoun vettore energetico solo se si riesce a pro-durlo a basso costo, senza emissione di gasserra e a veicolarlo risolvendo i problemi disicurezza che pone.L’incidente alla centrale nucleare di Cher-nobyl del 1986, invece, ha definitivamentemesso la parola fine alla diffusione delle cen-trali nucleari, almeno in Italia, e all’utilizzo dienergia da esse prodotto. Nel 1987, infatti, ilpopolo italiano fu chiamato alle urne peresprimere un parere sulla opportunità omeno, di continuare a sviluppare la tecnolo-gia per il nucleare e quindi poter usufruire deisuoi benefici attraverso l’installazione di cen-trali per la produzione energetica. Tutti sap-piamo quali furono gli sviluppi che nederivarono sulla scia emotiva dei ricordi dellacatastrofe, ma alcune osservazioni meritanodi essere fatte. A distanza di piu’ di venti annie con un maggior distacco sugli eventi, si e’capito che l’incidente era legato principal-mente alla tecnologia obsoleta che venivaimpiegata in quella centrale oltre al fatto che

10
forse l’incidente poteva essere evitato o al-meno avrebbe potuto avere un impatto menodevastante su tutta Europa se, chi lo avevaprovocato, si fosse comportato in maniera piùresponsabile. La seconda osservazione e’ chein questi casi i confini nazionali perdono disignificato: non avere centrali nucleari sul no-stro territorio non significa evitare problemisimili a quelli di allora. Il fatto che a causa diun incidente del genere tutta l’Europa siastata contaminata dalle polveri radioattive,dovrebbe far riflettere, dal momento che, unodei nostri confinanti, la Francia, risponde alfabbisogno energetico nazionale producendoenergia per mezzo di centrali nucleari. Anzi,la loro produzione energetica in eccesso civiene venduta a caro prezzo con immissionediretta nella nostra rete di distribuzione. Per-
sonalmente sono convinto che il referendumstesso ha creato un altro problema, perchéoltre a rinunciare allo sviluppo della tecnolo-gia per la costruzione delle centrali nucleari,abbiamo, più o meno inconsapevolmente,dato mandato ai nostri governanti di cessareogni forma di finanziamento per la ricerca sulnucleare e campi affini. Ad oggi questa sem-bra la conseguenza piu’ grave, dal momentoche abbiamo perso piu’ di venti anni di tempoche, probabilmente, sarà impossibile recupe-rare. I paesi che anno investito nello sviluppodel nucleare, oggi sono in grado di metterein funzione centrali di terza generazione aciclo chiuso (i prodotti radioattivi della primacombustione vengono riprocessati riducendoil tempo di decadimento delle scorie radioat-tive) con reattori a sicurezza intrinseca (il pro-
cesso di reazione a catena si estingue auto-maticamente in caso di incidente e il nocciolosprofonda in un assorbitore di neutroni). .Resta comunque da affrontare il problemadello smaltimento delle scorie radioattive,ma gia’ con l’utilizzo del ciclo chiuso del com-bustibile si apre uno spiraglio su quello chesembra essere il limite maggiore di questatecnologia.
Considerazioni conclusive Le ridotte di-sponibilità di combustibili fossili unite alleemissioni di sostanze altamente inquinanti ea gas serra che derivano dalla loro combu-stione, impongono la diversificazione dellaproduzione energetica. Le fonti rinnovabili(solare, eolico, idrico e geotermico) unite alletecnologie fino ad oggi acquisite per il nu-cleare e l’idrogeno, rappresentano un pac-chetto di soluzioni che si complementano avicenda. Sulla base delle conoscenze sin quiacquisite, sarà importante farci guidare nellascelta di quale alternativa utilizzare dal terri-torio stesso su cui dovranno essere installatele diverse centrali (solari, eoliche, ecc.).L’idea che sta prendendo forma e’ quella disfruttare la possibilità di decentrare la pro-duzione energetica (piccole centrali dissemi-nate sul territorio in funzione dellecaratteristiche geologiche ed ambientali) ri-ducendo le perdite (bassa efficienza) e i ri-schi del trasporto. Il futuro energetico saràpertanto segnato dalla nascita di una rete dipiccoli produttori di energia (che sfruttanotecnologie diverse), un po’ come e’ la condi-visione delle banche dati per gli utenti di in-ternet attraverso la rete informatica.
Nota del DirettoreL’articolo di Franco Frasconi sulle fonti ener-getiche di oggi e di domani mi sembra di no-tevole qualità e chiarezza. Appare evidenteche ogni produzione energetica produce unimpatto, piccolo o grande a seconda dei casi,sull’ambiente e sulla nostra qualità della vita.Forse per questo, per completare il quadro, oc-correrà accennare anche alla necessità ed aibenefici del risparmio energetico e della ridu-zione dei consumi di energia, luce ed acqua:tutti ne parliamo, ma in pochi ci sforziamo difarlo.Quanto al nucleare, in tanti non riusciamo adimenticare i visi deformi di migliaia di bam-bini ucraini che ancora oggi, a distanza di 22anni dall’incidente di Chernobyl, seguitano in-credibilmente a nascere straziati nel corpo, eche ogni tanto, la TV ci fa vedere.
R.M.N.

11
La frazione di Montelago è quella situata allamaggiore altitudine tra le quarantotto frazionidi Sassoferrato, essendo l’abitato posto a m726 di quota, alle falde del Monte Strega (m.1276), una delle più belle cime della dorsaleappenninica umbro-marchigiana.Molte persone, i turisti che arrivano nel-
l’amena località ma anche i cittadini sasso-ferratesi, si chiedono: “Montelago va bene,ma quale lago?”, poiché di laghi, anche pic-coli, in questo territorio non se ne vedono.Eppure il lago è certamente esistito, come pe-raltro già affermato da altri studiosi del terri-torio di Sassoferrato, come il Pagnani (“Storiadi Sassoferrato”, 1959, p. 274) che giusta-mente afferma come il nome del paese derivida un lago prosciugato. Con queste note si in-tende portare prove certe, di tipo geologico,circa l’origine e l’esistenza del piccolo lago e
proporre ipotesi sulla sua scomparsa.Come già affermai nella mia tesi di laurea del1960 “Aspetti geologici ed idrogeologici delterritorio tra Sassoferrato ed il Monte Strega”le prove geologiche dell’esistenza nei tempipassati di un piccolo lago naturale adiacenteall’abitato di Montelago sono almeno tre e
tutte molto evidenti.Innanzitutto la frana di detrito di falda, ossiadi materiale quasi incoerente, che ostruì il pic-colo corso d’acqua sottostante a Montelago:un fosso breve ma ricco di acqua per la pre-senza di sorgenti che nel passato avevanomolto probabilmente portate superiori aquelle attuali. Le due sorgenti vengono local-mente denominate “del Lago” e sono ambe-due captate per l’acquedotto di Sassoferrato,assieme ad altre sorgenti ubicate a valle dellaantica frana.
Il corpo di questa paleofrana, come la chia-mano i geologi, venuta giù da un versantemolto ripido, oggi quasi verticale, del MonteForia, risulta tuttora ben visibile dall’alto,come si può osservare dalla cartina topogra-fica dell’area d’interesse e soprattutto dallefoto panoramiche. Per essere più chiari, l’area
di distacco della frana, coperta oggi da fittavegetazione, è ubicata sul versante oppostoa quello dove sorge l’abitato, un poco più amonte.Ancora, a monte del corpo della frana cheostruì il corso d’acqua, vi è una piccola pia-nura, da molti secoli coltivata, pianura cherappresenta il fondo dell’antico lago. Inoltrelateralmente, lungo il fosso ove scorre il pic-colo torrente, con Mario Maracchini, profondoconoscitore di Montelago e dintorni, guida edamico fin dalle mie prime ricerche negli anni
Montelago: dov’è il lago?Raniero Massoli-Novelli
Panorama della frana che originò il piccolo lago di Montelago: la frana scesa dal Monte Foria è a sinistra, i campi coltivati a destra sono l’antico fondo dellago. (Foto R.Massoli - Novelli)

12
50, recentemente scomparso e che qui ricordocon commozione ed affetto, rinvenimmo al-cuni depositi scuri, torbosi, sottilmente strati-ficati, dell’antico lago. Due campioni di talidepositi, prelevati con cura e posti in due sac-chetti impermeabili e sigillati, vennero ana-lizzati nel laboratorio di micropaleontologiadell’Istituto di Geologia dell’Università diRoma, dove vennero definiti di origine limnica
(ossia deposito lacuale) per la presenza di unamicrofauna tipica di tale ambiente.Montelago nel passato ha quindi avuto concertezza, a breve distanza dall’abitato, un pic-colo lago naturale originato da una frana, unaorigine abbastanza rara. Infatti i laghi di si-mile origine ed ancora oggi esistenti sono po-chissimi: cito i due maggiori, quello di Alleghenelle Alpi orientali e quello di Scanno adia-cente al parco nazionale d’Abruzzo. Ambeduesono stati originati da grandi paleofrane dimateriali rocciosi e compatti come i calcari,che hanno creato una specie di sbarramentoben stabile e duraturo.Al contrario i laghi per frana di materiali de-
tritici ed incoerenti, come quello di Monte-lago, scompaiono nel tempo con una certa fa-cilità. Infatti lo sbarramento viene man manoeroso dalle acque che vi premono contro e checercano l’antico flusso verso valle, il materialeargilloso che inizialmente ha fatto da cementotra i granuli viene fluidificato, a poco a poco,con tempi ovviamente diversi da caso a casoe difficilmente quantificabili, fino a quando un
poco d’acqua riesce a filtrare, poi sempre dipiù, infine il materiale che aveva creato losbarramento viene portato via e la valle ri-prende il suo antico ritmo ed il suo aspettooriginale.A mia conoscenza non vi sono dati per ipotiz-zare quando sia avvenuta la paleofrana dalForia e la conseguente formazione del piccololago naturale di Montelago, mentre qualcheipotesi si può fare per la scomparsa dellostesso.Circa la formazione del lago il Pagnani rac-conta che il nome Montelago compare in do-cumenti del 1200: si può arguire che il lago,che certamente ha dato origine al toponimo,
esisteva da prima. D’altra parte la presenzadi sottili strati torbosi sul fondo dell’anticaarea occupata dallo specchio d’acqua diceche il periodo di vita del lago è stato piuttostolungo, poiché per creare depositi organicistratificati, seppure pochi e sottili, necessi-tano secoli e secoli, anche millenni.Quanto alla scomparsa del lago non vi sonodati certi ma esistono voci di popolo della pre-
senza del lago ancora a metà dell’800. Nonrappresentano certezze ma vale la pena di ri-portare tali voci. Nora Antonelli, nata a Mon-telago nel 1930 ed ivi sempre vissuta, ricorda,e mi ha personalmente riferito, che il nonnoDaniele Antonelli, nato a Montelago nel 1852ed ivi spentosi nel 1951 (tira aria buona daqueste parti!), affermava che da bambino sibagnava nelle acque del lago. Ancora altrevoci di anziani residenti affermano che i lorogenitori avevano indicato un grande masso dicalcare bianco, oggi esistente e visibile amezza costa lungo un sentiero, con attaccatoun anello in ferro, come luogo di ormeggio peruna piccola barca con cui qualcuno pescava.
Il paesaggio diMontelagoMontelago è un paesino ameno, da parecchi anni meta di un buonturismo escursionistico, soprattutto estivo. Le mete per i visitatoririsultano numerose, ad iniziare dalle passeggiate in quota con ariabuona, dai boschi di faggio, dai grandi prati fioriti anche in estate,dagli stupendi paesaggi che si godono da ogni parte, dalla possi-bilità di raccogliere more, fragoline, funghi, qualche tartufo.Dallo Strega si vedono lì sotto Pergola, Monterosso e Sassofer-rato, lo sguardo spazia poi fino all’Adriatico ed al promontorio delConero; girandosi, ecco dall’altra parte tutta la dorsale dei montiumbro-marchigiani, dal cono del Cucco a sinistra fino al bian-cheggiare della rupe di S. Marino e dei monti di Carpegna con ilSasso Simone e Simoncello, in lontananza sulla destra e versonord.Dal Foria si osserva un panorama ancora più impressionante, do-minato dall’imponente scenario del Monte Catria, con il suo enormeparetone di calcare bianco, di età Mesozoica, che incombe su IsolaFossara e sul Sentino, che piccolo piccolo scorre nel fondovalle,mentre a destra ecco apparire tra la vegetazione il bel monasterodi Fonte Avellana, insomma un paesaggio da meditazione.Altre attrazioni per i visitatori dei monti sopra Montelago sono damolti decenni il Rifugio, che è stato per un certo periodo sede di unCEA (Centro di Educazione Ambientale) del WWF e l’antistante re-cinto con i daini, recinto che, assieme ad un’oasi di protezione dellafauna di circa 1000 ha, viene gestito dall’Amministrazione Provin-ciale di Ancona e che da sempre attrae numerosi visitatori, so-
prattutto i più piccoli.Sotto il profilo della vegetazione, il paesaggio di Montelago è ve-ramente “verde”, vi sono boschi misti da ogni parte. Nella partebassa della montagna si osservano l’orniello e il carpino nero conpiccoli boschi di roverella, dove sono presenti anche l’acero mon-tano, il corniolo, il biancospino, il prugnolo. Caratteristica è lapresenza diffusa del ginepro e della ginestra laddove si aprono ra-dure, come ad esempio quella grande e bellissima di Pian Cer-reto sul versante sud-occidentale del Monte Foria. Nella partesommitale dei boschi, sono presenti alcuni esemplari di faggio ecerro poiché si sta passando verso gli splendidi boschi di faggiopresenti e godibili alle quote superiori. La fauna selvatica ha in-vece avuto una evoluzione negativa: una volta vi erano specie pre-ziose, oggi praticamente scomparse malgrado l’istituzione da moltidecenni della grande oasi, come la bellissima coturnice e la starnaautoctona; invece sono enormemente aumentate, e si osservanodappertutto, le pericolose cornacchie grigie, che in branchi anchenumerosi fanno strage di uova, di nidiacei degli altri uccelli e per-sino di piccoli mammiferi. Per fortuna si osservano numerosi ra-paci, dal piccolo e diffuso gheppio alla grande e scura poiana, etalvolta anche i più rari falchi pellegrino e sparviero. Come in tuttol’Appennino anche qui sono molto aumentati i cinghiali, origina-riamente provenienti dall’adiacente area protetta del Catria, oggipresenti in gruppi fin troppo numerosi e che con le loro scorribandenotturne danneggiano le poche, preziose coltivazioni qui tradizio-nali, in particolare quella della famosa patata di Montelago.
R.M.N.

13
Vento di poesiadi P. Stefano Troiani
Tratto dalla prefazione del volume In fra lo sasso e il ferro - Versi raccolti a Sassoferrato, a cura di Graziano Ligi, ed. Centro Culturale “Baldas-sare Olimpo degli Alessandri” - Sassoferrato, 2008. Nelle edicole e nelle librerie.
Il vento della poesia, con l’ispirazione forte espontanea, da sempre soffia nell’anima dellegenti sassoferratesi.Testimonianze antiche, riscoperte dai cumulidi rovine dell’Agro Sentinate, come le epigrafiche si leggono nelle lapidi sepolcrali e civili,hanno spesso scritture dove l’anima di quellegenti che li abitavano – pur dedicandosi ai la-vori più vari: quello dei campi, dell’artigianato,della pastorizia, del commercio, dell’arte, delferro e del vetro, delle lettere nei pubblici uf-fici e negli impieghi di altre varie esperienzedi vita – era sollevata ai pensieri più alti, aisentimenti più nobili della religiosità: allorala parola detta o scritta si rivestiva di quelleforme che assomigliavano ai grandi carmidella cultura e della civiltà più alta.Lo stesso spirito che animava la comunica-zione più elevata della parola, suggeriva e sti-molava l’invenzione e il fare degli artisti,pittori, scultori, muratori e architetti che riu-scirono a impiantare nell’Agro Sentinate unacittà splendida per i suoi monumenti, per gliintrecci viari, per i complessi termali e le casee le ville ornate di raffigurazioni murarie e pit-toriche di grande perizia e di valori d’ispira-zione.Quando verso il Mille, sulle alture come aguardia della città sentinate della pianuraormai disfatta, l’ispirazione poetica non ab-bandonò la nuova gente che seppe inventareun nome aspro ma solenne per la nuova città,deducendolo dagli elementi grezzi del monte:il sasso e il ferro.E il logo che l’accompagna risale da una co-noscenza dei simboli profonda e capace dicomprendere tutto insieme, nella poca am-piezza del testo poetico, l’essere del contestourbano e i valori morali e civili della gente chel’abita: Saxum ferro jugor, cordis constantiafirmor.Il percorso urbanistico si snoda via via nei se-coli come un nastro risalente dalle bassuredel piano compiaciuto del movimento e deicolori che case e palazzi, monumenti e mona-steri, dispiegano tra il verde, tra il cielo e laterra dell’ampio paesaggio.
Nacque allora, in quei tempi lontani, il cantonuovo della gente sassoferratese che si è neltempo ampliato come memoria d’una lungastoria e come espressione di vita, di individuie di popolo, capaci di comunicare i sentimentipiù profondi e più vari della vita, nei modi let-terari più estrosi.Nelle campagne e nelle aie, fino a non moltidecenni fa, durante i lavori di raccolta delgrano e degli altri frutti della terra si ascolta-vano i canti tradizionali di continuo rinnovatie accresciuti che esprimevano gioia e fiducia,sentimenti di amicizia e di socievolezza; nellesere ancora oggi sembra espandersi per le viee viuzze i canti d’amore e di passione dellagioventù sassoferratese.Le compagnie degli improvvisatori, ed eranotanti; ne citeremo alcuni: Terzoni, Zucca, Pas-seri, Rossi, Carlo Alessandrelli, Fiore e Vin-cenzo Troiani, i Vitaletti, i Roani e tanti altri,nelle osterie della città e dei paesi, fino aglianni ’50, hanno raccolto e tramandato unaspetto pieno di fascino e di cultura popolaredella civiltà sassoferratese.La poesia popolare ha avuto un cultore di stra-ordinaria forza di lingua e di fantasia tra Otto-Novecento nel “Poeta dello Strega”, PietroPietrucci.All’inizio dell’umanesimo sarà Nicolò Perotti aresuscitare nella lingua latina la perfezioneletteraria della poesia classica.Nella lingua nuova s’impenna il genio di Bal-dassarre Olimpo a spandere per tutt’Italia ilcanto d’amore che allieta le festi delle corti edel popolo. Accanto all’Olimpo, il poeta ano-nimo sassoferratese racconterà in versi deli-ziosi i fatti, le persone, le glorie vere eleggendarie dell’antica Sentinum, e i fatti diSassoferrato del suo tempo.Poche decine di anni dopo l’ammirabile can-tata poetica della “Divina Commedia” del-l’Alighieri, a Sassoferrato, nello scripturiumdi qualche convento si copiava il grandepoema: questo fatto era, ed è, la testimo-nianza e la conferma dell’interesse e del-l’amore della civiltà della gentesassoferratese per la poesia.
Il poeta dello StregaContro gli avvocati “radice d’ogni in-ganno e tradimento”.(P. Stefano Troiani)
Come non sentirò tal lima al core.Al vedermi in tal modo assassinatoDa chi chiamossi mio gran protettoreE fu di paghe e onori cumulato!Lungi dagli avvocati, o mio lettore,Se di beni non vuoi renderti orbato;Son essi i traditor della giustiziaFlagello al mondo, pessima nequizia.
Adoprano l’ingegno e la periziaSol per salvare infami e scellerati.Traggono dalle galere l’immondiziaPerché sieno in società grandi reati,Non paventano mai dell’ingiustiziaSol di trovarsi in borsa esonerati.E usando a scopo loro la sevizia,Corrompono per fin chi in alto uffizia.
Nel giuntar sempre trovano letiziaMaestri d’ipocrisia cupi e fecondi(E raro quell’Ivon che non invizia)Crudeli e di pecunia sitibondi.Dolce con lor la pratica s’iniziaMa se tu di prudenza non abbondiFra le maledizion dirai lor vale,Piangerai senza bene il fatto male.
Ma presto gusteran quel servizialeChe Cerbero farà sui lor gropponi,Cogli unghioni affilati meno maleDa lor pelle trarrà gran maccheroniLa giustizia del cielo cui non valeLor frode abbindolar né paroloni.Volendo che sia resa la parigliaMi sembra già che dica; piglia, piglia !Amen
Pietro Petrucci, il poeta dello Strega.

14
Due o tre cose che penso di saperesu Padre StefanoTroianiBruno d’Arcevia - (tratto dal libro “Scritti e opere in onore di Padre Stefano Troiani”)
Quando conobbi Padre Stefano, rimpiansi subito di non averlo incon-trato prima.Un rapporto speciale quello subito instaurato tra me che amo galleg-giare appeso all’immaginazione, qualche palmo sopra la quotidianità,e Stefano dolcemente avvezzo a traslare la temporaneità nella tem-poralità: una sorta di deriva parallela dalla cui levità è possibile affer-
rare, quasi per miracolo, la complessità fremente del mondo sino adedurne sintesi di pace. Una dimensione claustrale in grado di proiet-tare il chiostro nella piazza e la piazza nel cielo.L’umiltà francescana di cui Stefano è esemplare rappresentazione na-sconde da sempre una vivissima attività al fianco di innumerevoli ar-tisti ed intellettuali, tutti inevitabilmente divenuti amici ed in fondodebitori di tanta delicata attenzione.Le personalità multiformi e complesse di questi uomini d’ingegnohanno trovato proprio in questa mistica attenzione il conforto di quellaserenità che non sarebbe stata loro concessa senza l’intercessione pa-cificatrice di questo uomo di fede e, d’altro canto, immagino che Ste-fano abbia saggiamente approfittato della imprevedibilità concettualedi questi strani interlocutori per arricchire la sua capacità umana non-ché pastorale.Ciò che scaturisce da queste particolari esperienze è la portentosa ca-pacità di saper cogliere una ragione anche laddove tutto sembrerebbefollia e nello stesso momento saper protrarre quella ragione fin den-tro alla miracolosa follia della fede.Tante parole ascoltate e poche dette solo quando si rendevano ne-cessarie; tante cose fatte anche quando ai più sembravano inessen-ziali: il”Premio Sassoferrato” voluto e curato amorevolmente fin daglianni ’50, un “Museo delle tradizioni popolari”, quando solo un’alta in-tuizione poteva concepire questo genere di ricerca antropologica, tantepubblicazioni per codificare studi e pensieri di ricercatori ed umanistigiovani e non più giovani, continui sforzi personali anche economici.
Sono personalmente testimone di aver visto molte volte un’acquafortedonata da un artista amico, trasformarsi in un “sediciesimo” di cono-scenza.Una profonda attenzione al bello, coltivata attraverso una rara cono-scenza estetica, fin dalla tesi di laurea con Italo Mancini, accompa-gnata dalla perseverante convinzione che al bello si coniughi il bene,ha fatto sì che spesso nelle selezioni espositive Padre Stefano abbiamesso a fianco artisti di grande valore con artisti solo volenterosi: lastoria del bello vissuta attraverso l’attualità dell’apostolato.Non sempre la gente delle nostre contrade ha capito e spesso avràscosso la testa dubbiosa di fronte a quelle che sembravano stranezzeinutili, o velleitarie per chi è da sempre attento alle contingenze piùcrude.Ora non più, ma un tempo c’era sempre, tra le labbra sottilmente ar-gute di questo amico francescano, una sigaretta fumata fino al filtrosenza che mai le mani intente a sfogliare carteggi di ogni sorta la al-lontanassero dalla bocca: la sigaretta penzolava bianca al ritmo delleparole fino quasi a sfiorare il mento ed era cenere sulla tonaca, sullascrivania e sulla carta; la sola polvere di mondanità che Stefano con-cedeva al suo pacato rigore.Una parola di tanto in tanto proferita ad interrompere la sua innatapropensione all’ascolto conferiva agli incontri l’aura dell’incanto ed in-fondo la sensazione di un amichevole confessione.Nel momento del commiato, risolto in un abbraccio affettuoso, ho sem-pre sentito quel particolare sollievo, come da una tacita assoluzione.So di un amico artista il quale, pur coniugato, era stato colto da amoreper una giovane fanciulla; ho sentito Padre Stefano replicare a quellaconfidenza che, comunque fosse, l’amore è pur sempre un dono di Dio.Tanta serenità profusa quotidianamente a tutti coloro che hanno laventura di incontrarlo scaturisce da uno spirito insospettabilmente in-quieto, da notti segnate da insonnia e da una macerazione dell’animadella quale solo pochi amici cari e confidenti sono a conoscenza.Una disciplina tenacemente perseguita dentro la Regola del Santo diAssisi e forse indisciplinatamente vissuta agli occhi dell’Ordine.La sospensione di ogni giudizio razionale di fronte all’ineffabilità deiSanti, la ragione disposta ad astenersi davanti all’evento che allude almiracolo, dispongono la mente di questo francescano ad accettareanche ciò che non è dato di capire: è questa apertura di senso l’ereditàche ognuno ha contratto avendo avuto la fortuna di colloquiare conStefano.Una sola volta ho visto il suo sguardo benevolente e curioso accigliarsiin un severo rimprovero e fu quando ingenuamente mi permisi di scher-zare sulla confessione: “questa – mi disse- è una cosa su cui non sideve scherzare, sapessi quale sofferenza mi provoca questo Sacra-mento”.Io non so se quella rara beatitudine che provo quando sono con Stefanoe quella sospensione sul tempo saranno mai riconosciute come il donodi un Santo, ma di certo ad ogni incontro con questo dolcissimo amicosi rinnova il miracolo della serenità.

15
Sassoferrato è oggi una cittadina compresanel territorio marchigiano, disposta su più li-velli e circondata da una corona di monti,tranquilla e a volte quasi sonnolenta, ma inun passato molto remoto proprio qui, in unaurbs che dal VI secolo a.C. si chiamava Senti-num e apparteneva agli Umbri, si svolse unodegli eventi bellici più cruenti e famosi che lastoria ricordi.Sulla battaglia di Sentinum, detta anche “bat-taglia delle Nazioni”, che decise le sorti dellapenisola che oggi chiamiamo Italia affer-mando la supremazia di Roma, sono statiscritti fiumi di parole, a partire dall’opera dellostorico Tito Livio che ne ha descritto le variefasi con puntuale chiarezza nella sua monu-
mentale opera Ab Urbe condita libri CXLII.Nell’ambito della narrazione di quell’eventobellico, Livio riferisce un episodio che illustraquella che i Greci definivano areté, e dopo diloro i Romani chiamarono virtus, cioè il valoredel vir, del guerriero, una qualità che com-prendeva tutta una serie di implicazioni, ilsenso del dovere verso la patria, il rispettodella memoria degli antenati, il coraggio inbattaglia. L’episodio a cui si sta facendo rife-rimento è il rito di devotio posto in essere dalconsole Publio Decio Mure nel 295 a.C. (Liv.,X, 28), nel corso della battaglia decisiva dellaterza guerra sannitica. La devotio, sostantivoderivato dal verbo devov re, consisteva nel sa-crificare se stessi agli dèi inferi per ottenernein cambio la vittoria per il proprio esercito:unus pro omnibus. Il comandante romano, in
situazioni estreme, decideva in pratica di ri-nunciare alla propria vita pur di salvare l’eser-cito e la patria e distruggere i nemici. Ladevotio prevedeva un rituale ben preciso, dicui ancora oggi non si comprendono del tuttoi significati: indossata la toga praetexta, di cuiun lembo doveva coprire il capo (capite ve-lato), con i piedi su un giavellotto e tenendosiil mento con una mano, il devotus pronun-ciava una formula che Tito Livio (VIII, 9, 4) ciha tramandato:Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona,Lares, Divi Novensiles, Di Indigetes, Divi, quo-rum est potestam nostrorum hostiumque,Dique Manes, vos precor veneror, veniampeto feroque, uti populo Romano Quiritiumvim victoriam prosperetis hostesque populiRomani Quiritium terrore formidine mortequeadficiatis. Sicut verbis nuncupavi, ita pro republica populi Romani Quiritium, exercitu, le-gionibus, auxiliis populi Romani Quiritium, le-giones auxiliaque hostium mecum DeisManibus Tellurique devoveo.“Giano, Giove, padre Marte, Quirino, Bellona,Lari, Dèi Novensili, Dèi Indigeti, dèi che avetepotere su noi e sui nemici, Dèi Mani, vi prego,vi venero, vi chiedo e da voi avrò la grazia chevoi accordiate al popolo romano dei Quiriti po-tenza e vittoria, e rechiate terrore, spaventoe morte ai nemici del popolo romano dei Qui-riti. E come ho dichiarato a parole, così io con-sacro insieme con me agli dèi Mani e allaTerra le legioni e le milizie ausiliarie dei ne-mici, per la gloria della repubblica del popoloromano dei Quiriti, per l’eser-cito, per le legioni, per le mi-lizie ausiliarie del popoloromano dei Quiriti”. Dopoaver pronunciato la formula,con la toga stretta all’uso deiGabii (cinctus Gabinus), il co-mandante, salito a cavallo, sigettava tra le fila nemichetrovando la morte. Il gesto,generoso e temerario altempo stesso, rese immortalela fama di Decio Mure ilquale, tuttavia, sembra chenon sia stato il solo fra i Decii a compiere ilrito di devotio: si narra infatti (Liv., VIII, 9-10)che anche il padre si sia immolato per la pa-tria nel corso della guerra contro i Latini nel
340 a.C., a Veseri in Campania, e che un figliodallo stesso nome abbia voluto seguire leorme del padre e del nonno nella battaglia diAusculum, oggi Ascoli Satriano, nel 279 a.C.(Cic., Tusc. Disp. I, 37, 89) contro le milizie diuna coalizione guidata da Pirro, re dell’Epiro.L’azione di Decio Mure nella battaglia di Sen-tinum fu celebrata con una fabula praetextadal tragediografo pesarese Lucio Accio, De-cius seu Aeneadae, ma già nel mondo grecoaveva avuto larga eco in Duride di Samo, sto-rico di corrente aristotelica. Gli storici, so-prattutto in epoche recenti, hanno tuttaviaattribuito il giusto merito della vittoria ancheall’altro grande console della battaglia di Sen-tinum, Fabio Massimo Rulliano, veteranodelle guerre contro i Sanniti, la cui strategiabellica si rivelò vincente sulla compagine gui-data dal sannita Gellio Egnazio. L’importanza,l’eco e le ripercussioni che la battaglia di Sen-tinum ebbero in quel tempo furono enormi. Lostesso Livio così si espresse (Liv., X, 30):magna eius diei quo in Sentinati agro bella-
tum, fama est, “grande è la fama di quelgiorno in cui si combattè nell’agro sentinate”;un giorno, aggiungiamo, che determinò l’inar-restabile ascesa di Roma che divenne in breve
La battaglia di Sentinumdi Tiziana Gubbiotti

16
Il premio “Monte Strega”, alla sua secondaedizione, si è svolto quest’anno nella salaconsiliare del Comune di Sassoferrato. La salaè particolarmente affollata e gli sguardi ditanti volti noti, anche se gli anni sono passati,si incrociano, mentre con tangibile interesse estupore si ascolta la presentazione del curri-culum dei premiati da parte di alcuni di noi eil “racconto” della propria vita dalla loro vivavoce o da quella dei parenti. Una particolarecommozione si avverte mentre parla PadrePierucci che ripercorre la sua vita a partiredalla fanciullezza, usando un linguaggio sem-plice, ma denso di significato e di ricordi di unpassato ormai lontano e così diverso daltempo attuale, ma “presente” nel vissuto enella memoria della maggior parte dei pre-senti. Mentre ascolto e rivivo episodi dellamia fanciullezza e della mia adolescenza duevolti in particolare mi colpiscono e mi ripor-tano piacevolmente indietro nel tempo: la“mia” maestra, signora Concetta AgostiniDiotallevi e la “mia” professoressa di letteredella scuola media, signora Diana Boldrini Vi-taletti, presenti in sala. Non avrei mai imma-ginato di incontrare, proprio per questacircostanza, oggi, due persone così significa-tive nella mia vita! Sembra ieri, eppure è pas-sato più di mezzo secolo! Quanta storiavissuta “si legge” sui nostri volti! Ed io inevi-tabilmente penso al percorso della mia esi-stenza, a dire il vero abbastanzamovimentato, e sento che la passione educa-tiva e l’amore allo studio, che ha caratteriz-zato tutta la mia vita, affonda le sue radici inquegli anni lontani, in quei contesti di vita così
diversi da quelli attuali. Rivedo i loro volti diallora e risento la loro voce: convinta, chiara,motivata e motivante, la loro presenza com-petente, professionale e discreta, desiderosadi stare con noi, di “essere” lì. Di svolgere conpassione e con piacere un compito impor-tante. Si perché la scuola “vale” ed è impor-tante, ieri come oggi! Quante volte neimomenti particolarmente significativi e impe-gnativi della mia professione o al termine diun incontro importante, quando più di una per-sona veniva a ringraziarmi, ho ripensato aquegli anni lontani, a quei volti, che, insiemea tanti altri, hanno contribuito, ognuno per lasua parte, a mettere le basi e a farmi scoprireil progetto di vita attraverso il quale avrei im-pegnato la mia esistenza. Non è profonda-mente vero infatti che tutti noi ci portiamonella mente e nel cuore le persone: genitori,fratelli, amici, insegnanti, altri, con cui ab-biamo un dialogo interiore? Queste figurevengono alla ribalta e ne siamo consapevolisoprattutto nei momenti importanti e il loroapporto positivo o meno dipende dal ricordodell’esperienza vissuta insieme, che comun-que ha lasciato “il segno” nel personale pro-cesso di crescita!Guardando il volto della signora ConcettaAgostini non posso non rivedere la scuola ele-mentare di Cacciamponi. Ospitava allora,negli anni cinquanta, una trentina di alunni ditutte le classi. L’insegnante era solo lei, unasola maestra! Oggi sarebbe semplicementeimpensabile! Fu tuttavia un’esperienza unicaed eccezionale! Da quella scuola sono“usciti” non solo operai e casalinghe, ma
anche maestre, professoresse, medici, assi-stenti sociali, direttrice didattica (la sotto-scritta). Una lunga esperienza di scuola mi fadire infatti che è stata una grande e signifi-cativa esperienza che ci ha trasmesso l’amoreal sapere e alla vita. Chi ha frequentato quellascuola, e alcuni sono presenti in sala, ricor-dano sicuramente che accanto alla scuolac’era una bella fontana: tre ampie vasche,riempite continuamente da tre grandi zampillidi acqua che scendevano dall’alto e un abbe-veratoio con un rubinetto “dorato”. Durantela ricreazione andavamo lì a dissetarci e a gio-care. Com’era bello vedere quell’acqua limpi-dissima! Il suo continuo mormorio sembravapurificare e rigenerare i nostri animi. Non perniente infatti “l’acqua è un elemento origina-rio della vita e perciò anche uno dei simbolioriginari dell’umanità”! Se il vecchio murodella fontana, l’unico che è rimasto, perchétutto il resto è stato inspiegabilmente abbat-tuto, potesse parlare, “narrerebbe” tante sto-rie vere, belle e meno belle, lieti e tristi, dilavoro, di grandi fatiche e di festa, ma tuttericche di vita, di sentimenti, di emozioni, dipensieri e di riflessioni! Come i racconti d’in-fanzia di P. Pierucci farebbero rivivere grandi
Sguardi e ricordifra tanti volti notidi Rita Ferri
caput mundi. (Nella miniatura in alto, la bat-taglia di Sentinum raffigurata nel manoscritto0777, fol. 164v, contenente la traduzione fran-cese dell’opera storica di Livio, risalente al1370 circa e conservato nella BibliothèqueSainte-Geneviève di Parigi; in basso una mi-niatura raffigurante Rulliano, in un codice del-l’opera di Valerio Massimo, Facta et dictamemorabilia, ms. Français 289, fol. 278v,
conservato alla Bibliothèque Nationale deFrance a Parigi).Grazie a Tito Livio, conosciamo questa impor-tante pagina di storia vissuta dai nostri avi-proprio qui, nella nostra terra, “agrosentinate” nei dintorni di Sentinum, forse pro-prio lì verso il Monte Strega (Camporè) dovela terra, ancora oggi, contiene le ceneri di mi-gliaia di soldati dell’una e dell’altra fazione
che sono state oggetto di pianto, di rispetto,di orgoglio, di vanto presso le rispettive fami-glie. Di Sentinum ci restano le poche vestigiache con grande interesse solo oggi tentiamodi conservare per noi e per i nostri posteri,come abbiamo conservato i loro nomi (Decio,Giulia, Fabio, Lidia, Massimo, Lavinia, Clau-dio), le loro Leggi e il loro Diritto.

emozioni e ricordi, che in parte hanno contri-buito a strutturare la nostrta personalità.La Professoressa Diana Boldrini è commossae contenta nel vedere tanti suoi ex-alunni,oggi uomini e donne con i capelli bianchi, conuna famiglia, una professione, ciascuno conuna sua storia personale. Lei stessa, a con-clusione dell’incontro, mentre ci salutiamo ri-corda quegli anni lontani ed episodi personalirelativi ad alcune di noi, al nostro impegno, alnostro “successo scolastico”, alle soddisfa-zioni provate nella sua professione. Un piace-vole ricordo, durante l’ora di latino, miriguarda personalmente e ascolto con com-mozione e gioia! Vedo ancora vivo nei suoiocchi quel desiderio di farci conoscere e ap-prezzare la bellezza del latino, della lingua ita-liana e del cammino fatto dall’umanità.Ripensando a tutto questo non posso, oggi,non constatare quanto sia vero che è bello ap-prendere e che dà un’intima soddisfazione,anche se esige sudore, impegno, fatica, eser-cizio, aspetti tutti importanti per crescere! Maaltrettanto significativo e determinante è“chi” guida nell’apprendimento. Si apprendeinfatti in modo significativo solo se si riesce arendere, ciò che si vuole trasmettere agli altri,una nostra verità esistenziale, qualcosa di tal-mente significativo per noi da dare “sapore”alla nostra vita. Si trasmette allora attraversotutta la propria persona l’amore al conoscere,al sapere, alla ricerca continua di un appren-dimento che ci rende migliori. Non mi stupisceaffatto allora, ricordare che il mio piacere diandare a scuola sapeva superare difficoltà
che oggi si stenta a credere, andare a scuolaa piedi per sette chilometri con la neve! Eral’anno 1956: l’anno della grande nevicata. Fuun inverno freddo e bianchissimo. Ho ancoradavanti agli occhi la lunga e bianchissimastrada che da Filipponi porta a Sassoferrato:la neve ammucchiata ai lati della strada altaquasi due metri. Si camminava a piedi, la cor-riera era bloccata dalla neve e dal ghiaccio.Gli uomini salivano sui tetti per rimuovere laneve accumulata per prevenire i crolli. Ognifamiglia al mattino spalava la neve davantialla propria abitazione sia a Cacciamponi siain Castello, dove allora era situata la scuola.La neve rimase per molto tempo sulle strade.Ma io ricordo di non aver “perso” un giornodi scuola! E la professoressa Diana Boldriniera in classe ad aspettarci! Ricordare i puntidi riferimento che ci hanno aiutato a crescerefa bene all’animo umano, dà forza e sostegnoe ci stimola a riflettere, a ripensare e rivedereil nostro modo di educare e a sentire quantosia importante il legame tra generazioni.Offrire, oggi, opportunità di dialogo reciprocoe collegare tra loro le generazioni è infattiun’istanza molto sentita. Per l’adulto-anzianorivisitare la propria avventura esistenziale èun’esperienza che lo pone non solo nella con-dizione di apprendere da se stesso, ma di fardono alle giovani generazioni della saggezzache viene da una lunga esperienza. E l’inizia-tiva “Premio Monte Strega” ha anche questoobiettivo: vivere insieme esperienze, comequella odierna, tra età diverse della vita. Sonooccasioni che creano legami, sintonie e
scambi relazionali arricchenti per ciascuno:per il giovane, per l’adulto, per l’anziano. At-tivano processi di maturazione, di accetta-zione di sé, di riscoperta di un nuovoequilibrio, con se stessi, con gli altri, con ilmondo. Aiutano e permettono di continuare asentire la pienezza della dignità di ogni vitanella sua fatica e nella sua bellezza in ognietà della vita e a scegliere le”cose” più alte.La trasmissione di valori culturali, morali, ci-vili e spirituali, che hanno attraversato i rac-conti delle esperienze di vita dei premiati, hasicuramente lasciato un segno in ciascuno dinoi aiutando a riscoprire che ciò che vale è“essere” così importante, oggi, in una societàimmersa in un eccesso di “avere”. Ed inoltrehanno trasmesso concretamente, attraversoesperienze vissute, senso di appartenenza, diidentità, passione per la vita e per la propriaprofessione. E’ stato scritto che oggi avanzauna generazione “senza racconto”. Mentresappiamo bene che è sempre una storia che cisalva come uomini. Il racconto infatti dellestorie di uomini e di donne assume sempre unparticolare valore, perché ci pone di fronte aun quadro di persone reali, nella lotta con pro-blemi reali (ben diversi dai reality show chefiniscono per imporre dei modelli effimeri evuoti!). Oggi la mentalità dominante portapurtroppo a considerare comportamenti eazioni scorrette e violente non poi tanto gravi,addirittura sa trasformarle in vincenti e cosìfiniscono per avvelenare la convivenza civile.Tutto ciò che non viene più “coltivato” diventainfatti barbarie: non comprendere, anzi ne-gare, la bellezza di ciò che è elevato porta al-l’ignoranza e nello stesso tempo alla pretesa.E’ significativo perciò ricordare e scoprire uo-mini e donne, anche del nostro territorio, chehanno saputo impegnare la vita e continuanoa farlo per ragioni nobili ed esemplari. I rac-conti autobiografici possono accomunare tuttie attivare altro pensiero emozionale: tutti in-fatti sono capaci di raccontare la propria sto-ria di vita a qualcun altro che sappiaaccoglierla. E nel raccontare la sua vita ognipersona descrive fatti e avvenimenti accadutinel tempo, ma anche i propri comportamenti,le proprie reazioni e così può meglio com-prendere che la risposta ai fatti che accadonodipende dalle sue azioni e dalla sua respon-sabilità. E’ infatti la risposta dell’uomo a sce-gliere e determinare il senso della propriaesistenza! Ecco perché alcune storie di vitapossono illuminare, orientare, aiutare a cre-scere e a fare scelte libere e responsabili.
17

18
A settant’anni dalla nascita e a trenta dalla pre-matura scomparsa, la figura di Carlo Antogniniconserva intatta la sua grandezza di uomo vo-tato alla cultura della sua regione. Nato ad An-cona nel 1937 e qui morto nel 1977, Antognini èstato critico letterario e critico d’arte, operatoreculturale e editore, che nel giro di poco più di undecennio si è imposto come intellettuale di razzaa livello nazionale. Impegnato in particolare sullaquestione della identità regionale delleMarche,Antognini ne ha valorizzato le personalità lette-rarie e artistiche, riflettendo sulla cosiddetta“marchigianità” senza cadere nelle secche dicerto provincialismo, bensì mostrando la ric-chezza interpretativa della categoria di regiona-lità, grazie alla quale ha disegnato una identitàmarchigiana in cui la fierezza regionale si co-niuga con l’orgoglio delle “cento città”, vale adire: identità unitaria e, insieme, pluralistica.Torna dunque utile e doveroso ricordare questopersonaggio straordinario, un autodidatta cheraggiunse, grazie alla sua intelligenza e sensibi-lità, alla sua preparazione e al suo impegno, unalto livello culturale, per cui si fa apprezzare atutt’oggi per la originalità e la consistenza deisuoi interventi e delle sue iniziative, che costi-tuiscono ancora un punto di riferimento ineludi-bile per chiunque affronti la questione dellaculturamarchigiana. Per tracciarne un essenzialeritratto, si potrebbero utilizzare le annotazioni,con cui due noti critici letterari hanno contras-segnato l’opera di Carlo Antognini: ci sembra,infatti, che forniscano le coordinate per indivi-duare il significato della sua presenza nel pano-rama regionale e nazionale. La primaannotazione è di Carlo Bo, e si trova nella Pre-sentazione al mio volume Come un volo di ron-dini (L’Astrogallo, Ancona 1980, pp. 10-11); sitratta di una duplice immagine marinaresca:quella del capitano e quella dell’armatore; in-fatti, con riferimento alla attività di scrittore e dicritico di Antognini, Bo lo paragonava ad “un ca-pitano che si trovi a guidare la sua nave da solo,solo di fronte a unmare sconfinato”, e parlandopoi di Antognini editore, scriveva che il fonda-tore de L’Astrogallo non si era limitato a “stabi-lire l’ora e il punto d’arrivo delle navi”, ma si erafatto “armatore” e aveva varato libri, “mandan-doli in giro per il mondo”. L’altro critico lettera-rio che ha saputo offrire una efficace immaginedell’opera di Antognini è Geno Pampaloni, ilquale, nella sua Introduzione al volume di scrittiantogniniani, da me curato col titolo La criticacome fatto morale (L’Astrogallo, Ancona 1986,p. 11), riassume “in un’immagine la definizionedi un esercizio critico di così schietto e tenaceimpegno” come quello di Antognini, dicendo che“la critica di Antognini è la critica della mano
tesa”. Si tratta di una mano tesa in una triplicedirezione: “al lettore, perché accresca la qualitàdelle conoscenze; all’autore, per aiutarlo a co-noscersi; alla società letteraria, perché valutinella giusta misura valori e disvalori che s’in-trecciano in essa”. Questa immagine ben siadatta non solo ad Antognini critico (cui facevariferimento Pampaloni), ma anche ad Antogninieditore: in entrambi i casi, infatti, Antognini eser-citava il suo diritto-dovere di “recensore”, valu-tando nel primo caso libri pubblicati da altri, enel secondo caso libri che lui stesso ipotizzava dipubblicare. Ecco, queste immagini -del capitano-armatore, e del critico dalla mano tesa- ci sem-bra che permettano di avvicinarci correttamentead Antognini: le parole di Bo aiutano a cogliereil senso della sua impresa, e quelle di Pampa-loni aiutano a definire il suomodo di operare. Daparte nostra, con i volumi antogniniani che ab-biamo curato e con gli articoli che gli abbiamodedicato, abbiamo cercato di mostrarne la sta-tura culturale e morale, evidenziandone l’indi-pendenza e la responsabilità di giudizio, lalibertà e la coerenza delle operazioni, la com-pattezza e l’acutezza delle proposte. Sono, que-ste, tutte caratteristiche che rendono legittimoparlare di un vero e proprio “stile”, che ha resoinconfondibili i molteplici interventi di Antognini:sia come critico letterario e d’arte, sia come edi-tore; senza soluzione di continuità appare il suoimpegno in questi ambiti, espressioni diverse diuna originale presenza, che è stata assoluta-mente omogenea e influente. I suoi contributi,in certi casi veri e propri eventi, si sono impostiall’attenzione non solo regionale ma anche na-zionale; pensiamo in particolare alla ideazionedellamostra “MarcheArte ’74: consuntivi e pro-poste” (cf. il relativoCatalogo), e alla fondazionedella casa editrice “L’Astrogallo” (cf. il relativoCatalogo). Queste e altre iniziative hanno se-gnato una fondamentale stagione nello sviluppoculturale delleMarche, tanto che è legittimo af-fermare che è a partire da Antognini che si è ri-proposto in termini niente affatto provinciali il“caso Marche”, e la questione della “marchi-gianità” ha assunto i toni alti di una ricerca let-teraria e artistica che approdava ad una identitàregionale, caratterizzata da una peculiarità:quella d’essere, per così, dire, un “plurale sin-golare”. Un “plurale” fin nel nome sono leMar-che, ma un plurale “singolare” in quanto lamultipolarità che le contraddistingue non ne an-nulla l’unità, tant’è vero che dai marchigianiviene in genere espressa una duplice apparte-nenza: quella alla propria città e, insieme, quellaalla propria regione; dunque, un’identità com-plessa, quella marchigiana, che mostra come ladiversità possa non ostacolare l’identità, ma co-
stituirne la specificità. Certo, occorre che il plu-ralismo non sia dispersivo, ma capace di incre-mentare, nel rispetto delle differenze locali, ilsenso di una comune appartenenza regionale.Ecco perché , si rende necessario offrire, per cosìdire, una “casa comune” alle diverse esperienzee valenze presenti nella regione. Proprio questoha fatto Carlo Antognini: infatti, l’antologia degliScrittori marchigiani del Novecento (pubblicatadall’editore Bagaloni di Ancona), lamostra d’artedi cinque eccellenze marchigiane (organizzata aJesi dalla Provincia di Ancona) e la casa editrice(operante nella sua casa ad Ancona con la col-laborazione della sorella Fiorisa: cf. il catalogodelle edizioni de L’Astrogallo e il volume diMar-cello Venturoli, Lettera alla “postina”, entrambipubblicati da L’Astrogallo, rispettivamente nel1997 e nel 2002) costituiscono contributi essen-ziali alla costruzione della casa comunemarchi-giana, in cui Carlo Antognini ha saputo farconvivere le molteplici espressioni del multi-forme ingegno dei marchigiani. E’, questo, ilnovum che Antognini ha portato alla storia cul-turale delle Marche. E che ha interessato diret-tamente anche Sassoferrato. Infatti per leedizioni de L’Astrogallo apparve nel 1974 nellacollana “La giustezza” il volume intitolato Ma-drigali d’amore e altre poesie d’amore di Olimpoda Sassoferrato. Grazie alla cura di Franco Sca-taglini, fu così riproposta la figura di BaldassarreOlimpo degli Alessandri, nato a Sassoferrato nel1486 emorto a Perugia nel 1540. La poesia amo-rosa di questo frate minorita -come annotavaScataglini nella introduzione al volume- “si pro-pone nella sua modernità, scrittura che svolgelinguisticamente al futuro il dono di una virile in-quietudine”. Ma, per lungo tempo, l’opera diOlimpo non fu compresa: parve “arida tecnicaversificatoria quel che era poesia altamente ispi-rata e perfettamente eseguita”. Ebbene, la ri-proposta editoriale di Antognini ha fatto giustiziadi questa incomprensione. Da aggiungere che lacosa si è ripetuta per altri autori che Antogniniha “riscoperto”: e ogni volta –daOlimpo daSas-soferrato a Grimaldi di Fano, da Morselli di Pe-saro a Matacotta di Fermo- il risultato è andatoben al di là dei confini regionali.
Lo stile di Carlo Antogninidi Giancarlo Galeazzi

19
Ricordi sassoferratesidi Padre Armando Pierucci
Non vi nascondo che sonomolto sorpreso per l'attenzione con cui mi ono-rate. Sorpreso, perché io non sono nato a Sassoferrato; ci sono venutocon la mia Mamma, con mio fratello Tranquillo e mia sorella Cesira, per-ché mio padre era morto e mia Madre aveva trovato lavoro presso il pa-stificio Giacani. Era la primavera del 1939; io non avevo ancora 4 anni.Santina dell'albergo Ciccarelli ricorda quel bambino spaurito che sgra-nava gli occhi su tutto un mondo che gli si apriva dinnanzi. Io ricordo, è ilmio primo ricordo, il cavallo, il carro, lemasserizie; un bambino sopra tuttoquesto. I saluti. Partimmo dalle Moie al mattino; arrivammo alla sera. Alcavallo gli dispiaceva portarci lontano. I bambini fanno presto ad am-bientarsi. La piazzetta delle Logge divenne la nostra palestra. Si giocavaa salta murello, a bazzica (e ogni tanto qualche vetro andava in frantumi);
nei pomeriggi d'estate s'affacciava qualche signore con un catino d'aquain mano: "Non fate baccano!", e lanciava l'acqua su noi che eravamo giàfuori tiro (ce ne aveva dato il tempo). Qui ho preso l'accento che tuttorami porto addosso, anche se parlo inglese. "Di dove è Lei?", mi chiedono.Non sanno se sonomarchigiano o umbro. "Sono di Sassoferrato: sul con-fine", rispondo. Spesso scendevo al pastificio dove lavorava mia Madre.Io stavo con Gianfranco, il figlio dei Giacami. Era anche lui del '35 e dellostesso Comune di Maiolati Spontini. Andavamo nei vari reparti. La gentelavorava sodo. Al mulino c'era un uomo che con una mano alzava su unsacco di farina che pesava un quintale. La Signora Albina, la mamma diFranco, era nota per la sua carità. Ormai la guerra era cominciata e tuttiavevano bisogno di carità. Chi lavorava al pastificio non moriva di fame.Ma non si vive solo di pane. I miei compagni più grandi s'ingegnavano afare delle sigarette con i pampini secchi o con i filamenti che stanno sultronco delle viti. La nostra casa stava sopra un androne e un chiassuoloin cui si davano convegno i gatti in amore. Un signore propose a miamadre di prendergli qualche gatto. Per ogni gatto le avrebbe dato un chilodi lardo.Ma lei preferiva friggere con l'olio di secondamano che qualcunole dava. Anche quando sono entrato nel seminario francescano del Con-vento della Pace, lo scenario Sassoferratese era lo stesso. Si stava co-struendo il nuovo collegio e noi aiutavamo, rubando una mezz'ora allaricreazione: portavamo le pietre; eravamo 80 fraticelli e si faceva prestoad ammucchiarne tante. Ogni mese piegavamo il foglietto da spedire aibenefattori; era intitolato "I Piccoli Missionari di S. Antonio". Poi c'eranoi frati grandi: P. Fazzini che lavorava per 2 muratori e un mulo; P. AngeloMazzini che animava tutti con il suo entusiasmo; P. PasqualeMeo, il pre-dicatore che ci raccontava la generosità dei Benefattori. In breve: quello
che deve fare un uomo, come dev'essere un frate, l'ho imparato allora: l'hoimparato qui, a Sassoferrato. Un uomo deve lavorare, non importa in qualecampo; ma deve dare il massimo di sé; un frate deve anche avere il cuoreaperto, capace di dare quanto riceve, perché la gente è buona. Quando,19 anni fa, sono andato in Terra Santa, nonmi sono proposto di fare qual-cosa; ho fatto quello che ogni Sassoferratese avrebbe fatto. Ero andatoa Gerusalemme come organista del Santo Sepolcro. A 53 anni capivo chenon avrei potuto continuare quel servizio, che è uno dei tipici della Cu-stodia Francescana dei Luoghi Santi, per più di una ventina d'anni. Mipreoccupai allora di insegnar musica a qualche giovane, frate o laico. Per7 anni insistei, senza riuscire a cavare un ragno dal buco. Tutti mi dice-vano: "Con lamusica qui non si vive". Un ragazzo di 14 anni, dopo aver stu-diato 4 anni conme, viene a dirmi: "Ora sono grande; devo pensare al miofuturo", e si congeda. C'era una volta un frate che andava con un asino.Questi s'impunta, com'è solito. Allora il frate gli dice: "Senti: per scienzami vinci, ma per tigna no, eh!". Gli diede un morso sull'orecchio e l'asinopartì al galoppo. Allora 12 anni fa ho proposto al Capitolo dei frati di aprireuna scuola di musica, così avrei dimostrato che con la musica si può vi-vere anche in Medio Oriente. Erano 65 frati e 65 mani approvarono l'isti-tuzione di una Scuola diMusica. Ho lavorato a tutto campo; ho insegnatotanto che il Ministro Generale mi ha nominato "professore emerito". unonore che raramente si dà ai musicisti. Ho suonato notte e giorno per i ser-vizi liturgici; ho armonizzato centinaia e centinaia di canti per la chiesa, perla scuola; ho composto 18 messe per vari complessi, affinché non scom-parissero i cori di chiesa; ho composto 4 cantate, incise tutte, eccetto an-cora l'ultima, la Terra dei Fioretti, su CD. Posso dire di aver sollevato unquintale con unamano. Non era un sacco di farina; sembrava un sacco disabbia del deserto; invece era terra buona. Adesso la nostra scuola dimusica, l'Istituto "Magnificat", ha 180 allievi e 20 tra professori e perso-nale ausiliario. Insegniamo: Piano, Organo, Violino, Flauto, Canto, Com-posizione, Violoncello e Percussione. Abbiamo una convenzione con ilConservatorio "A. Pedrollo" di Vicenza. I nostri allievi possono andare a Vi-cenza per gli esami finali e per ricevere il master. Abbiamo ormai 6 di-plomati; uno dei nostri allievi sta trascorrendo 2 anni a Vicenza perottenere il master.Ogni anno organizziamo un concorso pianistico al quale partecipano una70.ina di giovani palestinesi e israeliani. Abbiamo due cori: uno di adultiper il servizio liturgico; uno di ragazzi: il "Yasmine Choir". Nell'aprile scorsosiamo stati a Roma, dove ci ha accolto e ascoltato il SindacoW. Veltroni;e a Vicenza, dove abbiamo inciso un CD di canti arabi. Abbiamo stam-pato in tre volumi la Storia della Musica in lingua araba. Ma non vogliotediarvi con l'elenco delle iniziative realizzate in 13 anni. Dico soltantoche la volontà di non chiudere la porta davanti a nessun ragazzo/a che cichiedesse di studiar musica; e la necessità di avere buoni insegnanti cihanno condotto ad avere tra noi Cristiani di tutte le confessioni: cattolici,ortodossi, protestanti; e poi musulmani, ebrei, palestinesi, armeni, euro-pei. RicordoMuna,May, eMuhammad, tre fratelli palestinesi di religioneislamica. Anno scorso i loro genitori decisero di non mandarli più al "Ma-gnificat", per non doverli trasportare con l'auto altre volte ancora. "Bastaquello che sapete".Ma i tre ragazzi, due studenti di piano e uno di violino,hanno piantato il muso. "Al volere del re e al pianto dei figli non si resi-ste". Così, dopo tre settimane i tre ragazzi sono tornati da noi. Muna, lapiù grande, ha incontrato la sua professoressa, un'ebrea, nel corridoio.Sembravano due innamorate. L'Israeliana ha abbracciato la Palestinese.Concludo: se qualcosa di buono c'è stato, l'ho imparato a Sassoferrato. Seun miracolo c'è stato, questo è un miracolo della musica, del lavoro, del-l'amore.

20
Un triste ricordo dell’infanziadi Francesca Luzi
Era l’agosto del 1954, cantava la cicala tra fronde arse di sete d’acquache tardava a venire da un cielo tutto azzurro e senza tracce di nubi.Avevo nove anni, ma ricordo, nei particolari, quel che avvenne nellamia casa, quel pomeriggio tanto afoso dell’estate sassoferratese.Mia madre era seduta accanto al tavolo della cucina, tutta sofferenteper la calura appena mitigata da un soffio di venticello, che entrava dauna finestra socchiusa. Mio padre era là, anche lui, in cerca di un po’di sollievo, in quella siesta tanto bruciante di sole e di luce. Rigagnolidi sudore gli segnavano la fronte scendendo sul viso e disperdendositra i peli della barba, non rasata da una buona settimana. Un rumoreimprovviso di passi frettolosi scosse la sonnolenza di mio padre e miamadre. Poi due potenti bussi alla porta di casa. Corsi ad aprire chie-dendo:”Chi è?” Una voce di donna risponde:”Sono io, zia Siria.” Tuttapresa da ansia continuava:”Riccardo, mio marito, è quii? Sono ore e oreche lo cerco. Da una mattinata manca da casa!!!” Con tremore e pre-occupazione risposi:”No, qui non c’è. Qui non s’è visto!” Mentre ac-cogliendo zia Siria le dicevo queste parole, non certo rassicuranti perlei, con la mente venivo ripensando, senza capirne il legame, ad uncerto discorso che lo zio Riccardo, mi disse in una giornata, che per luinon doveva essere proprio tranquilla:”La vita è brutta. Vorrei propriomorire. Il peso del lavoro mi schiaccia, non c’è più nessuna sicurezza.Questi campi, che mi vedono e sentono tutto il giorno, a lavorare nondanno frutti a sufficienza. Quel poco di pane che si guadagna bisognadividerlo con il padrone. A che serve la vita, se non a piangere tutto ilgiorno?” Poi lo zio continuava a lamentarsi che i suoi figli non capi-vano la situazione; mentre tutto andava così, loro cercavano, anzi pre-tendevano avere una bella moto, vestiti di gran marca e tante altrecose lussuose e quindi costose. “Non fanno che chiedere di divertirsi!Sempre più divertimenti! Vedi, non si accontentano mai!” Zio Riccardoaveva una grande fiducia nei miei confronti. A volte lo vedevo pian-gere! Vederlo così mi faceva veramente pena e compassione, veden-
dolo con le lacrime agli occhi – io ancora quasi bambina – mi chie-devo con meraviglia:”Ma anche i grandi piangono…? Di tutto questonon dissi mai niente a nessuno. Lo zio Riccardo più volte mi avevadetto:”Ti raccomando di non parlare di queste cose che ti dico e nem-meno di avermi visto così triste, ti raccomando non parlare con nes-suno. Te lo proibisco” Io come mi aveva detto con tanta afflizione eautorità, non parlai mai con nessuno. Avevo quasi paura di riferire qual-cosa. Come seppi che non era tornato a casa, con tutti i parenti e amicimi sono messa a cercarlo con tanto amore e voglia di trovarlo. Attra-versavo le maggesi e i filari di viti, quasi con la certezza di trovarlo edi poterlo accompagnare a casa. Mentre correvo tra i filari, sudata eassetata, di tanto in tanto allungavo una mano sui grappoli d’uva, perstrappare qualche chicco, che mi sembrava un po’ più maturo o menoacerbo. Velocemente me lo mettevo in bocca, ma per il sapore acerbomi sembrava di succhiare un limone. Correvo e via via alzavo lavoce:”Riccardo! Riccardo! Riccar..” Ma nessun segno di risposta. Di-cevo tra me:”potessi sentire la sua voce, potessi intravederlo” e in-tanto mi avvicinavo a una casa dei miei parenti. Correvo veloce, la terralavorata di fresco, morbida, tratteneva i miei piedi e intanto i filari delleviti, gli oppi che le sorreggevano, le piante di frutta me li vedevo quasiun’immagine unica, come quando si intravedevano da un treno o dauna macchina in corsa. “Riccardo! Riccardo!” Continuavo a chiamarecon la voce sempre più affaticata per la corsa e per il troppo gridare.A tratti, nella corsa e nel gridare, mi passava per la testa il pensieroche Riccardo fosse morto e, intanto sentivo la stanchezza del troppocorrere e chiamare. Decisi di tornare indietro, entrata in casa dissi aimiei parenti, che forse lo zio Riccardo era morto. I miei parenti non ce-dettero, anzi presero le mie parole come quelle di una bambina chenon sa quello che dice. Dentro di me, l’idea che zio si fosse suicidato,cominciava ad essere una certezza. Ero bambina si, ma riuscivo a ri-collegare questa fuga dello zio con quanto mi aveva detto con dispe-razione nei nostri incontri, diciamo quasi segreti. Uscita di casa vidimolta gente che si era radunata davanti la porta della cantina; il si-lenzio era rotto da un bisbiglio. Tutti si aspettavano qualcosa di graveaccaduto a Riccardo. Non si sbagliavano. Infatti un amico di Riccardo,forte, robusto, appena diede una spallata alla porta malandata dellacantina, una scena tragica si presentò agli occhi della gente accorsa.Era là, Riccardo, sdraiato sul terriccio della cantina; tutto sanguinantee ormai privo di vita. Io, bambina, non avevo mai visto una scena cosìdrammatica e triste. Non saprei dire se ero più presa dal terrore o dallacuriosità di assistere a uno spettacolo tanto allucinante. Vedevo che ilsangue rosso vermiglio gli usciva da una tempia e formava come un ri-gagnolo che sul terriccio scuro si andava allargando e formando comeuna pozzanghera di sangue. Riccardo era là, steso sulla fredda terra;sembrava dormisse tranquillo e sereno, come abbandonato in unsogno. Forse non ha avuto paura della morte; forse la pensava comeun interminabile riposo, cullato dalle mani leggere e amorose di unamamma. Tutti i familiari, i vicini accorsi osservavano il cadavere, si-lenziosi e sconcertati da quella scelta di morte che Riccardo avevafatto, sicuro in un momento di smarrimento della ragione e del senti-mento. Anche la zia Siria era accorsa; piangeva e baciava la frontefredda di Riccardo. Risalita in casa prese un rosario; ritornò e composele mani del povero defunto sul petto, con la corona tra le dita. I passidella zia Siria lasciavano tracce di sangue sull’erba dell’aia antistante

21
la cantina e i suoi lamenti rompevano il silenzio; a volte il brusio dellagente che addolorata commentava l’accaduto, rattristava ancora di piùla scena già tanto grigia e dolorosa e assurda. Al lato del corpo di Ric-cardo steso sul terriccio, si vedeva la pistola usata per la triste opera-zione. Io ero là e osservavo la gente che in vario modo partecipava allascena. Con chi piangeva e commiserava la fine di Riccardo c’eranoanche i curiosi che si limitavano a dare un occhiata fredda e distaccataal cadavere e allo stesso modo ai parenti. Io venivo pensando, mentreguardavo il morto, ai discorsi fatti con me e in particolare venivo ri-portando alla mente le tante volte che Riccardo mi aveva confidato diessere stanco della vita. I giovani figli di Riccardo erano pure là e trai pianti accarezzavano il volto del padre pallido e smorto, quasi incre-duli per l’accaduto. Guardandoli si poteva capire che nel segreto delcuore si sforzassero di trovare i motivi di quella scelta del padre e secon la loro condotta, non sempre approvata dal padre, non fossero inqualche modo corresponsabili di tale fine. Erano presenti anche i ca-rabinieri che si davano da fare con le parole, con gesti e operazioniper stabilire le cause, le modalità della morte di Riccardo. Sopra ilvocio della gente raccolta nella cantina e nell’aia, sentii una voce piùforte, era il nonno Fedele che, dall’alto del terrazzo, dov’era seduto colmento appoggiato sulle mani raccolte sul bastone che lo sorreggeva inequilibrio. Vedendo tanta gente presentiva qualcosa di straordinario,
ma non riusciva a rendersi conto del motivo di tanta agitazione intornola casa.Allora gridava, chiamava e nessuno rispondeva e si dava pensiero peresaudire il suo desiderio di sapere, di rendersi conto di quanto era ac-caduto, che certo doveva essere importante per muovere tanta gente,anzi forse doveva essere qualcosa di tragico e doveva riguardare lasua famiglia. Io vedevo e ascoltavo il povero vecchio e mi rendevoconto di quello che pensava e desiderava giustamente sapere. Nonavevo il coraggio di andargli a raccontare l’accaduto. Seppure con unaforte pena, non mi sono presa la responsabilità di esaudire il nonnotanto agitato. Il vecchio non ha saputo mai cosa era veramente acca-duto al povero Riccardo, che pure era suo figlio e ne aveva diritto di co-noscere la triste fine. l nonno aveva avuto anche un figlio che morìgiovane lasciando tre figlie in tenera età, ma al tempo dell’accadutoben mature di anni e di esperienza di vita. Questo fatto lo porto con meda tanti anni e ha costituito per me, allora bambina, un momento di ri-flessione sul senso del vivere e del morire, insieme a un colpo al cuoreche l’ha reso capace di dominare il sentimento e di saper piangere di-nanzi a qualunque forma di dolore solo nell’anima. Come può avvenireche un uomo si tolga la vita? Una oscurità misteriosa avvolge il gestodel suicida. Il suicida non è un superuomo, ma un uomo che ha perdutoil senso della vita.
Soggiornare a Sassoferrato in B&B

22
Erano giorni d’estate degli anni ’30 quando“Gioannino de Cavaliero” manda il suo aiu-tante “Checco del Canterino” a prendere i co-lori per dipingere la canonica di SanGiovanni. L’aiutante, aspirante/imbianchino,con la nota della spesa, parte a piedi per ilCastello a Sassoferrato. Arrivato a destina-zione, era normale che prima di passare al-l’emporio di Righetta (supermercato o, sevogliamo, centro commerciale di allora), si fa-cesse una colazione all’Osteria del Gallo, ti-pica locanda con mescita di vino, generialimentari e cucina, di Amedeo. Amedeo, acui più che vendere piaceva chiacchierare,
attacca subito “bottone” con l’aspirante im-bianchino:”... che bella giornata! Come maida queste parti? Dove lavorate? Che novac’è?” Lui, più sbrigativo, gli racconta con dueparole il motivo della venuta e dopo aver or-dinato e mangiato del pane con due sardellee soprattutto bevuto mezzo litro di vino, vaper pagare, ma dalla tasca gli cade inavver-titamente la nota dei colori. Quando poi, è lìall’emporio, non trovandosi la nota Righettalo rimanda da Amedeo, sicura che solo lì po-teva averla persa. Infatti, poco dopo, “guardacaso” la ritrova. Nel frattempo, però, Ame-deo, approfittando del fatto che Checco nonsapeva leggere, aveva provveduto a modifi-carla, aggiungendo ai quantitativi stabilitiuno zero, cosicché, anziché prendere un chilodi polvere di colore celeste, per sfumare ilcielo della canonica, ne prese dieci, anzichéprendere un un chilo di giallo, per marcare latonalità delle cappelle, ne prese dieci e cosìvia. Praticamente svuotò il negozio di tutti icolori tanto che fu necessario fare ritorno aSan Gianni con la cariola. Potete immaginarecome questo poveraccio arrivò a destina-zione, sotto il sole di luglio, fradicio di sudoreper di più assalito da tutti gli improperi diGioannino che, dopo un breve interrogatorio,capì che solo l’amico Amedeo poteva averglitirato questo “pesante”scherzo. Come siaveva poi notizia di questi scherzi? Anche seallora non c’erano i mezzi di comunicazione
di oggi, non ci dimentichiamo che a Sasso-ferrato esistevano 29 osterie, è come se oggici fossero 29 bar, 29 pub, 29 stazioni radio,29 siti internet. Allora, gli avventori, tra unabicchierata e l’altra, facevano conversazioniraccontandosi di tutto e di più. Insomma, cisi divertiva anche così.Alla prossima! Ma aspettatevi pure il con-trario, cioè sarà Amedeo che subirà scherzi,perché… chi la fa l’aspetti. Inoltre, sempreper ravvivare la monotonia dei tempi acca-deva che tra l’oste Amedeo e il farmacistaDott. Mario Poeti ci fosse una complicità re-ciproca : capitava che un contadino, recan-dosi in farmacia - luogo dove si entravasempre in punta di piedi e col cappello inmano -, chiedesse una medicina che il “SorMario” non poteva preparare, allora (con ariaseriosa che solo lui sapeva fare) lo mandavada Amedeo lì, in cima alla salita, il qualeAmedeo, con rammarico gli comunicava conaltrettanta faccia scansonata di averla ter-minata poco prima (mi dispiace buon uomoma i sulfamidici l’ho finiti 5 minuti fa). PoiAmedeo, per non essere da meno, a suavolta indirizzava all’amico farmacista qualchesprovveduto avventore che magari ordinavauna porzione di “ceci cottori” piatto che inquel giorno non veniva cucinato. Insomma sitrovavano su “scherzi a parte”? Su “Amicimiei”? Decidete voi. Si stava peggio, ma siviveva meglio.
Gli scherzi di nonnoAmedeodi Vittorio e Mario Toni

23
Un grande fotografo contemporaneo, quelloche si può definire uno dei grandi fotoreporterviventi, Gianni Berengo Gardin, ama dire chele fotografie non sono opere, ma testimo-nianze: “le mie foto sono racconti delle coseche ho visto”. Il mito per eccellenza Henri Car-tier-Bresson ha scritto: “La macchina foto-grafica è per me un blocco di schizzi, lostrumento dell’intuito e della spontaneità, ildetentore dell’attimo…” Questa breve intro-duzione, per rafforzare la tesi dell’importanzadella fotografia come documentazione sto-rica.Documentare un momento, un’espressione,un’azione che a distanza di tempo ricondur-ranno il pensiero, immediatamente, ad undato periodo, ad un avvenimento, ad un pre-ciso istante che, magari, ha segnato il mondo,questo è lo scopo principale di un bravo foto-reporter. Raccontare con immagini quello chesi vede. “Il miliziano che cade” del grande fo-tografo Robert Capa è la testimonianza di unmomento storico, è diventato un simbolo per-ché aveva una grande potenza espressiva. Peril fotoreporter le fotografie hanno come de-stinazione naturale le pagine di un giornale,di un settimanale, o di un libro, ora sempre dipiù le pagine di internet.Sono testimonianze, raccon-tano quello che il fotografovede. Secondo alcuni una fo-tografia di reportage potràessere giudicata comeun’opera d’arte solo a poste-riori, solo passata l’emozionedel momento si potrà dare ungiudizio estetico. Immaginiche rimangono testimo-nianza, il che non vieta, co-munque, a grandi musei,come il MoMa di New Yorko il Getty Museum, di inte-ressarsi a fotografie di re-porter. Sono tanti gliappassionati che, affascinatidai lavori dei maestri, cer-cano di creare un proprio lin-guaggio fotografico e diraccontare per immagini laloro realtà, o meglio quelloche loro vedono. Diventanocosì, a loro volta, testimoni
del proprio tempo; forse non raggiungerannole vette dei loro miti, le loro immagini nonavranno la forza di quelle dei maestri del fo-togiornalismo, però saranno, certamente, unatraccia, una documentazione ugualmente im-portante. Una ricchezza per il paese che dellapropria storia e cultura vuole fare tesoro.A loro, e a tutti quelli che premono il pulsantedi scatto di una macchina fotografica, augurodi poter provare le sensazioni descritte da
Henri Cartier –Bresson: “Fotografare è tratte-nere il respiro quando tutte le nostre facoltàconvergono per captare la realtà fugace; aquesto punto l’immagine catturata divieneuna grande gioia fisica e intellettuale.”
Fotogiornalismo eArteMassimo Bardelli - BFI - Delegato FIAF Regione Marche
Foto sotto: da sin.: Bertini, Benedetti, Rosa, Maio-latesi, Riccardi, Renzaglia, Rossi, Lunardi. Una de-scrizione completa della fotografia è consultabilepresso la pag.:http://www.sassoferrato.tv/page43/page43.html

24
Tornando a casaL. Pierce Carson
Il giornalista americano L. Pierce Carson hascritto per il sito internet americano “The NapaValley REGISTER.com” e per la nostra Rivista ilseguente articolo dove racconta la storia di JulieSanti Prince, nata a Casacaggioni (Sassoferrato)e poi emigrata in California, divenendo la Per-sonal Assistant della prestigiosa famiglia di Ro-bert Mondavi, anch’esso di originisassoferratesi in quanto figlio di Cesare Mon-davi, nostro compaesano emigrato negli USAoltre cento anni fa.Cesare e i suoi figli (Robert e Peter) crearono aNapa Valley (California) l’azienda vinicola“Mondavi Winery”, oggi tra le più importanti efamose di tutta l’America. (R.M.N.)
ThomasWolfe scrisse che non si deve ritornaresul luogo di nascita se non da anziani: inveceJulie è già ritornata più volte nel suo originarioterritorio di Sassoferrato, pittoresco paese dellecolline marchigiane.Nel suo precedente viaggio, Julie si fece ac-compagnare da sua figlia e suo nipote per farloro conoscere le proprie origini, in una regioneche era una volta abitata da soli contadini e mi-natori. Infatti i genitori di Julie emigrarono inUSA nella metà degli anni ‘50, dopo la chiusuradella miniera di zolfo di Cabernardi, miniera chedava loro il necessario per vivere. Entrambi i ge-nitori trovarono lavoro presso l’industria del vinonel NapaWalley (California ), una strada seguitaanche da Julie divenuta Personal Assistant diMargrit Biever e Robert Mondavi nella loro im-portante azienda vinicola. In agosto dello scorsoanno ho incontrato Julie a Roma, prima di pren-dere il treno per Ancona, una città industriale
dell’Adriatico. Siamo scesi a Fabriano dove ab-biamo successivamente incontrato alcuni cuginidi Julie.Durante le 2 ore e mezzo di viaggio ho appresoche questa piccola energica bionda che avevoconosciuto al Mondavi Winery era GiulianaSanti, nata a Casacaggioni, una piccola frazionein collina alla periferia di Sassoferrato. Sembraironico che lei si sia trovata a lavorare pressol’Azienda di Robert Mondavi anch’esso figlio digenitori nati a Sassoferrato”. Julie racconta diprovenire da una famiglia di contadini, suo padreAlfredo lavorò poi nella miniera di zolfo di Ca-bernardi. Incontrò la sua futura moglie quandoaveva ancora sei anni che viveva nella porta ac-
canto lì a Casacaggioni;frequentava anche lastessa scuola, formatada più classi, tutti in-sieme in un’unicastanza. A causa di av-venimenti verificatesiprima e durante la IIGuerra Mondiale, lavita quotidiana, ancheper i contadini, vennesconvolta e così anche iloro progetti dimatrimo-nio, perché poi, AlfredoSanti, vennemandato inEtiopia per i noti piani diMussolini. Al suo ri-
torno in Italia nel 1937 i suoi genitori si sposa-rono avendo ricevuto dal nonno, come dote, lacasa di campagna. La famiglia Santi ha avuto 4figli ma un maschio morì quando Julie avevasolo un anno. Julie ricorda lunghe e quotidianecamminate di 3 km su e giù dalla collina alla val-lata per andare alla vecchia scuola. Ricorda inol-tre che tutti i sabato sera, anche con la neve tuttii paesani attraversavano la valle e un piccolofiume per incontrare amici e vicini alla sala daballo presso la Fornace vicino casa. Il trasferi-mento avveniva sempre in gruppo e gli uominilo precedevano e lo chiudevano illuminando ilpercorso con lanterne a carburo inmodo da nonperdersi. I problemi del dopoguerra vennero alpettine negli anni ’50. Sarà la chiusura della mi-niera ad indurre la famiglia ad abbandonare laloro difficile vita per andare verso la promessadel nuovomondo. “Mio padre aveva un cugino,certo Amerigo Mondavi, nipote di Cesare Mon-
davi a Charles Krug (California) è così che miamadre fu invitata a venire a Napa Valley con lapromessa di lavoro”. Questa dell’estate 2007 èstata la quarta volta che Julie ha fatto visita aSassoferrato. Abbiamo avuto non solo i suoi pa-renti a guidarci in un giro turistico per la regionema anche Rita ed Umberto Ballanti, molto di-sponibili e ottimi conoscitori di Sassoferrato edintorni. I luoghi visitati sono stati numerosi ma,poichémi occupo professionalmente di cibo e divino, desidero ricordarne qui uno, la Farroteca diLea Luzi a S.Lorenzo vicino Pergola, un postosemplice dove abbiamo assaggiato ottimi piattitutti a base di farro, e bevuto in maniera deli-ziosa.La cittadina di Sassoferrato conta attualmentecirca 8000 abitanti, la metà di quella che eraprima dellamigrazione dimassa verso altri paesieuropei e verso il nuovo mondo negli anni ‘50.Sassoferrato è a circa 50 km dall’Adriatico sulledolci colline a ridosso dell’Appennino, nei pressidell’antica città Romana Sentinum e vicino alconfine con l’Umbria. Un castello (La Rocca) re-staurato fu eretto nel 14t° secolo. I suoi prodottiagricoli principali sono i cereali, fra cui l’anticofarro, carne bovina e ovina, miele e dai vignetinon lontani si produce vino pregiato, Verdicchiodei colli di Jesi e Lacrima di Morro d’Alba.I paesani sono orgogliosi della loro eredità e ilSindaco Luigi Rinaldi (eletto per la terza volta), exmembro del Parlamento Italiano, sottolinea chela cosiddetta “Battaglia delle Nazioni” ebbeluogo a Sentinum nel 295 a.c. dove i romanisconfissero una coalizione di Sanniti, Etruschi,Umbri e Galli. Roma così proseguì l’unificazionedell’Impero nell’Italia Centrale e l’area divennecrocevia e importante centro di commercio. Que-ste notizie ci sono state fornite durante la visitaal locale nuovoMuseoArcheologico, nonché al-l’altrettanto nuovoMuseoRurale delle TradizioniPopolari. È stato in quest’ultimo che abbiamoesaminato dalle vecchie cucine (i cui fornelli si-tuati nel sottofinestra) ai più rudimentali stru-menti agricoli, per circa 8000 oggetti cheraccontano la storia di Sassoferrato.
L. P. Carson con R. Ballanti, P. Stefano. L. Luzi, e i coniugi Massoli-Novelli
Giuliana Santi Prince

25
Julie Prince ha detto che ognuno dei suoi viaggia casa ha fornito sempre delle prospettive di-verse. “ Sono così orgogliosa che le persone diSassoferrato abbiano compiuto così tanto, spe-cialmente nei campi dell’arte e della cultura.Esse hanno fattomolta strada quando sono par-tita: eppure non sono viziate dal successo e con-ducono ancora una vita semplice”. Insieme aisuoi parenti Prince ha fatto visita alla minieradove il padre lavorò duramente per molti anni.Era la prima volta che visitava la dismessa mi-niera di zolfo di Cabernardi ed il piccolo museoallestito in una ex scuola statale. Abbiamo esa-minato attrezzi di lavoro rudimentali e fotografiedi coloro che hanno lavorato nel profondo dellaterra ed improvviso Julie trovò una foto di ungruppo di lavoratori tra cui suo padre, Alfredo;allora ci siamo raccolti commossi intorno a que-sto ritrovamento per ricordare ognuno l’impor-tanza delle radici della propria vita.Giuliana Santi Prince al termine di queste emo-zionanti visite, sorridendo e rivolgendosi a suanipote disse : “credo, si sia trattata per me, diun’altra vita”.
A SassoferratoPassano per la mente i pensieri,testimoni di bisogni ed esperienze,mentre percorro queste strade.Le valli e i boschi cedui,di stagione in stagione,si rivestono di colori.Metamorfosi delle stagioniPassate sui boschie sulle nostre vite,sul carpino nero, sull’acero, sul-l’ornoe sui querceti delle colline alte.L’anima mia curiosa e inquieta,di questi spaziconosce, ormai,ogni palpitaree il susseguirsi delle forme.
M’intrica sempre em’aggroviglia l’agro sentinate,la storia e la cultura di questa terradove sembra, ancor oggi,tutto immutato.Passata l’onda barbarica,innocente del tuo declino,e ancora avanti dicono diinsediamenti, di uomini,i primi su queste terre,e l’età di Roma, finita con te,umbra Sentinum,risorta sui monti doveripensando al tempo passatoripararon le genti,castro Saxiferrati,terra di Bernardino conteche sul discreto Sentinoin alto alzò il Castello.
Anche dei tuoi uomini illustrile vicende m’hanno preso,che ora, nomade, mi portanoa scorrere queste collinedalla mia Urbino.
Vitaliano Angelini
SeraScendono a sera le nebbiesu questi miei tetti,su queste case,su queste chiese trecenteschedi cui nessuno ricorda il nomeed un sensodi lieve malinconiainvade i vicoli semibuidove il tempone ha lambito le pietrecon lingue di fuoco.Passano a due a duei ragazzi…parlando forteed i loro visi s’illuminanoalla fioca lucedei lampionidi questo mio borgo remotocolor del tempo.La sera quiè una cantilena opprimenteche non sa, né vede,né immagina, né cerca,né ricorda, né piange,né chiama…né mi capisce.
Antonio Cerquarelli
SassoferratoSassoferrato lo ricordo sempre!Terra degli avi miei, dolce mia patria,che dei suoi monti ha le robuste tempre,dal Cucco, al Corno, allo Strega ed al Catria:mentre da quelli scendono i suoi fiumi,il Sanguirone, triste, ed il Sentino,tra scogli e boschi e campi verdi e dumi,e la Marena, all’incrocio vicino.In basso, il Borgo cresce; ma il Castellodomina in alto con l’austera Rocca,mentre su Chiese rendono più belloil panorama, e da ogni torre scoccal’onda sonora di robusta voce:San Pietro, San Francesco e poi la Pace,Santa Maria del Piano e Santa Croce,cantano insieme: echeggia la vivacemultipla schiera d’altri bronzi sagri,San Facondino il nuovo campanile,col tempio nuovo, attende:- Non sian magrii contributi tuoi, popol gentile ! –Da nord a sud, da occidente ad oriente,per valli e poggi s’apre sua campagna,feconda, od assai grama, alla semente,da Casalvento al Cerro a la Castagna.Rivedo i bei paesi lungo il monte,Baruccio, Castiglione,Venatura,alla mia vecchia casa alti di fronte,e, dietro, Monterosso e ogni altra Cura.Ripenso soprattutto al nido amico,con la Chiesina che il nonno vi fè,là dove nacqui e crebbi, Canderico,e alla casa dei morti a Camporè.Ma la gloria più bella e sempre vivaè quella dei suoi Santi, e dei migliorialtri suoi figli: il Cardinale Oliva,Ugo patrono, e i fulgidi splendoridei Francescani Martiri in Marocco,a Bartolo giurista, e il Collenuccio,e gli Agabiti e il Salvi….In un sol bloccoessi e tant’altri chiudere, mi cruccio:ma ridirli non posso ad uno ad uno,perché molti. Pei cari Sentinatid’oggi e domani i voti miei raduno:Imitino i lor Grandi, e sian beati !
Giuseppe FrancioliniVescovo di Cortona

26
Dal MassachusettsVengo da una famiglia vissuta per generazionia Coldellanoce, dove io sono nato nel 1944.A tredici anni, con mia madre Santa abbiamoraggiunto mio padre Nazzareno, già emigrato
negli Stati Uniti. Prestato il servizio militare nel-l’esercito degli Stati Uniti, mi sono specializ-zato in design per la finitura di interni dellacasa, ed ho creato una azienda per la produ-zione di cucine personalizzate di alta qualità elo studio di ambientazioni per interni; ora ge-stisco questa attività insieme con mio fratelloFranckie, nato qui in America. La nostraazienda è certificata e la nostra produzione èstata premiata più volte in mostre specializ-zate. Ricevere la vostra meravigliosa rivista“Sassoferrato mia” mi ha riportato indietronegli anni e l’ho letta con commozione, ricor-dando il paese dovo sono nato, i miei parenti egli amici della mia fanciullezza.Ho rivisto alcune volte il mio paese natale el’ho fatto conoscere anche a mio fratello e ainostri figli, purtroppo sono passati parecchianni dall’ultima visita e non so quando potrò ri-tornare ancora. Vi invio alcune foto di me emiofratello, e della nostra ditta. Non dimenticate dimandarmi il prossimo numero di “Sassoferratomia”.P.S. Chissà se vi sarà possibile pubblicare sullavostra rivista una foto di Coldellanoce, mi pia-cerebbe tanto esporla e far conoscere a tutti imiei clienti e conoscenti il paese dove sono lemie radici!Curio Nataloni
Da Peschiera Borromeo (Milano)Carissimi,che piacere rivedere i luoghi della mia gio-ventù, aderisco molto volentieri all’Associa-zione che mi è stata presentata da Mario eVittorio Toni, amici da moltissimi anni.Vi invio alcune notizie sulla mia vita.
Sono nata a Sassoferrato (il 14-04-1928), tre-dicesima figlia di Rinaldo Pesciarelli e di Er-mentina Sergiacomi. I miei primi vent’anni sonotrascorsi a Sassoferrato tra il Borgo e il Ca-stello, il 25 dicembre del 1952 mi sono sposatanella Cattedrale di San Pietro - Parroco Don Do-menico Becchetti – con Enrico Acerbi di San-severino Marche la cui famiglia era già dal1925 in Valle d’Aosta. Mi sono trasferita adAosta in seguito al matrimonio, ho avuto duefigli, Antonella e Paolo, purtroppo sono rima-sta vedova nel ’71 ma ce l’ho fatta ugualmenteed ora entrambi sono da molti anni laureati esistemati. Dal 2001 mi sono trasferita a Pe-schiera Borromeo per avvicinarmi a mia figlia(perché, se avrete fatto un rapido calcolo, ca-pirete che tra 2 mesi compirò 80 anni! Se Diolo vorrà). Ho due belle nipoti che assomiglianotutto alla nonna. Vi ringrazio per la documen-tazione ed il DVD inviatomi che ho trovato stu-pendo. Un abbraccio a tutti i Sassoferratesi socie non.Contraccambio un Buon AnnoGiuseppina Pesciarelli Acerbi
Da Soleuvre (Luxembourg)Cara Associazione,devo congratularmi per la bella iniziativa diaver pensato ai sassoferratesi “sparsi” nelmondo. Leggo con piacere la rivista chemi fa ri-vivere luoghi e usi della nostra terra lontana ericordare persone conosciute. Io, nel 1962 sonoandata a vivere in Lussemburgo dove i miei ge-nitori e mio fratello erano emigrati alcuni anniprima. Vivevamo a Differdange e lì ho inse-gnato per otto anni l’italiano ai figli dei nostriemigrati. E’ stata un’esperienza unica: tantis-simi piccoli italiani con un grande desiderio diapprendere la nostra bella lingua, di conoscerela nostra cultura e la regione di provenienza deiloro genitori.Sono rientrata in Italia nel 1970, poi nel 1996sono tornata in Lussemburgo ed ora abito a So-leuvre. Gli italiani hanno dato tanto al paeseche li ospita, hanno diffuso la loro cultura:cu-cina, arte, musica e hanno cercato di integrarsinella società lussemburghese, ma integrazionenon vuol dire dimenticare le proprie radici. An-ch’io sono molto legata al mio paese: Monte-rosso. E’ lì che sono nata, cresciuta, hotrascorso la fanciullezza, ho coltivato le mieamicizie e ogni anno vi torno con mio fratello,
nipoti e le loro famiglie. Purtroppo non ci sonopiù quelli che conoscevo e che mi hanno vistocrescere, ma ritrovo la mia maestra, Lina Luzi,che alla bella età di 90 anni, è ancora attiva econserva una lucida memoria. Tanti bei ricordiconservo di Sassoferrato dove sono stata im-pegnata per 15 anni nel mio lavoro di inse-gnante. Ho davanti i volti di tutti i miei alunni,ho in mente tutti i loro nomi. Ciascuno di noi haun sogno. Il mio è quello di poter trascorrereancora per lunghi anni alcuni mesi nel miopaese.Cordiali saluti.Giuseppina Arani
Da ArezzoSono figlia del dr. Ubaldo Fanucci, stimato me-dico condotto di Sassoferrato... ho magnifici ri-cordi di Sassoferrato, come Mara, Celestina,Patrizia, Maura del Castello; Leonella, Fiorella,Rosalba, Bernadetta, Enrica, Sergio, Maurizio,Fabrizio e tanti altri fino alla mitica Tiziana giùal Borgo. Scuole medie a Sasso, poi il Liceo aFabriano, l’Università a Perugia. Primo lavoro aSasso presso la farmacia Vianelli con l’indi-menticabile Dora. Poi Arezzo... Aderisco conpiacere all’Associazione e ringrazio per avermicontattato. Resto in attesa di ulteriori notizie.Mariella Fanucci
Da Impruneta (Firenze)Caro Benedetti, ho aderito con entusiasmo allavostra iniziativa”……… segue un interes-sante curriculum della sua vita professionalecome medico condotto prestata fuori della no-stra terra, dopo aver trascorso a Sassoferrato ilperiodo che lui definisce il più bello, quellodella giovinezza. Ci rivolge due richieste, laprima di non dimenticare fra i sassoferratesi il-lustri che non ci sono più l’on.le Albertino Ca-stellucci e il generale Ugo Salvioni; consigli chequesta Associazione prenderà in dovuta consi-derazione.La seconda consiste nell inviare un affettuo-sissimo saluto al nostro vice presidente prof.Raniero Massoli – Novelli, ricordandolo come“il piccolo Rani che sgambettava sul prato dellaRocca”, negli anni della seconda Guerra mon-diale . Conclude auspicando di essere a Sassoquanto prima e confida in un incontro perso-nale con il nostro presidente dott. Timoteo Be-nedetti.Manrico Gabriele
Le lettere dei nostri soci

27
DalWisconsinEgr. direttore della Rivista “Sassoferratesi nel Mondo”, grazie per avermi inviato questa bella foto
di Sassoferrato con il ponte della ferrovia.Mio padre è nato là oltre il ponte dei Felcioni e lavorava presso la Fornace di mattoni di fami-glia, situata proprio sotto le prime arcate di quel ponte della ferrovia.Lui, Sebastiano (Charly ) partì per l’America i primi anni del ‘900; era il più grande di otto figli(Sebastiano, Pietro, Dante, Adalgisa, Rina, Guido, Aminto e Nina), tre dei quali emigrati negli USA(Sebastiano, zio Guido e zia Rina) nei primi anni del secolo scorso. I primi anni per lui furono dif-ficili per diversi motivi ma poi riuscì ad inserirsi nel difficile tessuto della società americana,prima, lavorando nel commercio quando aprì un negozio di tessuti, poi, trovando occupazione
come dipendente e poi direttore di un Ufficio Postale.Non tornò più a Sassoferrato solo perché i trasferimenti di allora non erano quelli di oggi. La suastoria, i suoi ricordi, le sue origini sono state trasmesse a noi figli, come è stata trasmessa la lin-gua italiana che io amo parlare. Io sono nato in America ma le mie origini sono queste, anchemia madre proviene dall’Italia, da Fossato di Vico a pochi chilometri da Sassoferrato.Durante la mia vita mi sono occupato di marketing presso un’industria casearia italiana SartoriFoods. Sono venuto a Sassoferrato diverse volte e sempre con grande entusiasmo; non so sehanno influito le mie origini, ma quei viaggi li porto sempre con me e li considero i ricordi più belli.Complimenti, la Sua Rivista, le immagini, le storie dei Sassoferratesi nel Mondo mi emozionano.Dante Camilli
Posta aereaCi perviene una simpatica riflessione del nostroBiagioMarini, noto ed apprezzato presentatoredel Premio Monte Strega: “ porto sempre nellamia borsa “qualcosa” che mi tenga stretta-mente legato a questa nostra strana, com-plessa, dispersa e sperduta, lenta...Sassoferrato “. Biagio ci ricorda così a lunga di-stanza da casa, nei suoi frequenti viaggi di la-
voro in giro per il mondo. “In questo viaggio,quel “qualcosa”, è la rivista Sassoferrato mia,che leggo e di cui centellino la lettura per farneeconomia affinché mi accompagni il più possi-bile durante le trasferte. Qualche volta cerco dicoinvolgere colleghi o sconosciuti viaggiatoriper farli entrare in questa speciale atmosferache a tanta distanza da casa fa apparire il miopaese un gigante...Dall’interno delle sue mura siamo tutti moltocritici e io sono tra questi, ma fuori delle mura,dell’Arco deMinne, la prospettiva è diversa. Losi apprezza di più, anzi manca...Ne ho avuto la conferma quando ho letto nel-l’ultima rivista la lettera di Edmund Paoloni,nato negli USA ma figlio di nostri. emigranti,che con poche righe ha sintetizzato quanto siaforte l’attrazione verso le proprie origini. Comepure l’altro articolo, sulla famiglia Morbidelliemigrata in Brasile all’inizio del Novecento eche con istintiva passione è venuta a cercare leproprie radici tra i casolari sparsi ma sempre ac-coglienti delle nostre colline marchigiane. Gra-zie a voi e alla redazione per la capacità ditrasmettere anche a noi residenti queste stra-ordinarie emozioni dalle pagine di Sassoferratomia che ha riaperto il dialogo e valorizza i Sas-soferratesi nelMondo. Conclude BiagioMarini“l’augurio, che personalmente penso sia unacertezza, è che la sua diffusione raggiunga i piùremoti angoli del pianeta, dove in tempi lontanie recenti si sono stabiliti tanti nostri conterranei,portando nel cuore le proprie origini, nella spe-ranza almeno di un loro riflusso attraverso le te-stimonianze di esperienze e di ricordi.Lunga vita all’Associazione SASSOFERRATESInel MONDO”.
Biagio Marini
Foto R. Massoli-Novelli

28
Sauro Ippoliti(Sassoferrato 1921 - Cupramon-tana 2008)
Da sinistra: Franco Ragni, ArmandoFaggioni e Sauro Ippoliti.
A Sassoferrato ha trascorso conla sua famiglia l'infanzia e la gio-ventù, imparando ad amare pro-fondamente il suo paesed'origine e creando una imma-gine di sé gioiosa e comunica-tiva. Temperamento solare, il suosorriso e la sua proverbiale di-sponibilità lo hanno poi caratte-rizzato nell'esercizio dellaprofessione Medica cui ha dedi-cato la sua vita con vera pas-sione, prima a Maiolati Spontinisuccessivamente a Cupramon-tana. Ha mantenuto un profondoattaccamento al paese natio,dove tornava volentieri anche perfar visita all'amata sorella. Col-pito da una tragedia familiare chesegnerà dolorosamente la suavita, ha cercato di alleviare il suoanimo nella passione per lo sporte per la poesia. Ha amato e se-guito come dirigente sportivo, macertamente la poesia ha consen-tito di esprimere più efficace-mente i suoi sentimentiaiutandolo a liberare il suo animoricco e sensibile. Sassoferrato ri-corda con grande affetto e rico-noscenza questo suo illustreconcittadino accogliendo una sua
poesia nell'antologia "In fra losasso e il ferro" edito dal centroBaldassarre Olimpo degli Ales-sandri celebrandolo anche comesocio dell'associazione "Sasso-ferratesi nel mondo"Saluti Gianni
Addio dolce paesedi Sauro Ippoliti
Addio dolce paesemia terrachiara di vocimattutine di torrentidi limpidi orizzontiche s’incendiano al fuocodi levante.Addio piazza del Borgoantica di memoriee tucandido cimiterosopra il colleche consoli di attesal’ignudo esilio.Sempre mi torniche mia madre aspettadi rimboccarmiprodigo giaciglioove da tanto temponon riposo.
Enrico Benedetti
Era un “ragazzo” del ’36. Moltierano gli amici, quasi tutti dellastessa età, che formavano ilgruppo del “Castello”. Era pocopiù che bambino negli anni della
guerra, quando lo scultore Car-lino Canestrari lo scelse per al-cuni lavori come suo modello, peri lineamenti del viso. Gli studi piùimpegnativi a Fabriano dove i piùfortunati andavano felicementein littorina. Arriva il momento dilasciare Sassoferrato come tanti,e lui si trasferisce al nord. Erasoddisfatto di lavorare a Bresciadove si sposa e crea una bella fa-miglia. Lavora come Ispettore al-l’ENPI per tanti anni, impegnocondotto seriamente com’era nelsuo DNA e di tanti marchigianicome lui formatisi in quel conte-sto con genitori buoni ma severi,come severi erano i tempi. Tuttigli amici lasciati alla fine deglianni ’50 li ritroverà immancabil-mente a Sassoferrato ogni annoquando in estate ritornerà, conentusiasmo, a trascorrere leferie. Lui, amico di tutti, amantedella compagnia, dei ritrovi,pochi stravizi, qualche partita abiliardo o a carte presso l’incor-ruttibile bar del Gringo. Molteserate ad ascoltare la musica ecantare qualche romantica can-zone con Marcello, Grazia e Ser-gio, Graziella, Gigetto e Maria,Franco e Teresa, Lolita e Vera,Rani e Marisella, Marina e Mas-simo, Giuliana, Antonello e Ste-fania, Emilio, Claudia e tantialtri. Il terremoto del ’97 gli faràperdere temporaneamente lacasa delle vacanze a Sasso manon l’attaccamento alla suagente e al suo tanto amatopaese. Era molto orgoglioso diappartenere alla nostra Associa-zione e condivideva tutte le no-stre iniziative. Se ne è andato unbuon amico, a Brescia il 2 feb-braio di quest’anno, ma non il suoindimenticabile ricordo. Ciao Ri-ghetto a nome di tutti noi.
Vittorio Toni
Robert MondaviRobert Mondavi si è spento il 16maggio 2008 all’età di 94 anninella sua casa in California. La no-
stra Associazione aveva già deli-berato l’assegnazione a Robert delPremio Monte Strega 2008, cheora verrà conferito allamemoria. Ilnostro Presidente, Timoteo Bene-detti, ha dato comunicazione di ciònella lettera di condoglianze in-viata alla famiglia, invitando la si-gnora Margrit Mondavi ed altrifamiliari ad intervenire alla ceri-monia di conferimento del Premioil 23 agosto prossimo. Ha assicu-rato la sua presenza alla cerimoniail giornalista Pierce Carson delNapa Valley Register, amico dasempre della famiglia Mondavi edi Robert, del quale ha sempre do-cumentato nei suoi articoli e scrittii momenti salienti dell’attivitàpubblica e privata ed esaltatoeventi particolarmente significa-tivi della sua vita, come il conferi-mento della “Legione d’onore” daparte della Repubblica Francese.Questo ritorno di Pierce Carson faseguito al suo breve soggiorno aSassoferrato nell’estate 2007 incompagnia di un’altra nostra con-cittadina emigrata in California,Giuliana Santi Prince, che ritornavaa rivedere i parenti ed i luoghi dellasua infanzia. Di questo suo brevesoggiorno a Sassoferrato Pierceha poi pubblicato un simpatico, gu-stoso e ricco reportage sul NapaValley Register.
In ricordo dei nostri soci...

29
Correva l’anno...
Maiolatesi, Gioacchini, Porfiri,Rossi, Cipriani (arch. Porfiri) Pesciarelli, Caldarigi, Boldrini
Gioacchini, Cantimori, ? ,Amori, Toni, Porfiri (arch. Porfiri)
Al Bar Cesauri di Sassoferrato Agostini- Ferretti, Amori, Lunardi, Artegiani
Gita parrocchiale a La Verna (arch. Porfiri)

30
Raimondo Rossi è il ceramista che ha creatoper l’Associazione la scultura rappresentativadel Premio Monte Strega (maiolica policromacm. 30 x 18). E’ nato a Urbania (1939) dovevive ed opera. Nella vita ha insegnato lettere,dopo essersi laureato con il magnifico rettoredell’Università di Urbino, Carlo Bo, sul Jour-nal de voyage di Montaigne.Non poco influirà su di lui il clima artistico ur-binate e il fermento culturale della prestigiosaScuola del Libro. In Urbania diventa allievodell’artista ceramista Federico Melis chedirige la fabbrica Metauro. Le sue primeceramiche sono del 1958. Esponenel 1967 nella Galleria Montefel-tro di Urbania. Studia musica,pratica pianoforte e organo,pubblica numerose ricerchesugli organi antichi dellavalle del Metauro. Con l’edi-tore Brenno Bucciarelliespone i disegni sull’Inaugura-zione del pontificato di GiovanniPaolo II, in Roma, nella Saletta dellaLibreria Editrice Vaticana, in Piazza San Pie-tro, e nel 1984 presso i testi biblici per il Mes-salino domenicale, edito dalla Libreria EditriceVaticana. Arrigo Bugiani di Pisa lo chiama acollaborare nei libretti di Mal’Aria, da cui
trarrà ispirazione per la sua minirivista Primadel Vischio (1981-2007), 22 plaquet-tes, Stamperia GF di Urbino. Collabora conl’editore d’arte Fabrizio Mugnaini di Scan-dicci.Ha partecipato con una ceramica policroma,Angelo, alla Mostra d’arte sacra “Chi cer-cate?” di Senigallia, 1989. Sue opere sonostate donate alla Calcografia Nacional RealAcademia di San Fernandez di Spagna e allaFondazione il Pellicano di Trasanni di Urbino.
Ha tenuto mostre a Wolfsburg (1982), Kla-genfurt (1995 e 1997), Digione (1998). E’amico di poeti e scrittori con i quali ha colla-borato in molte edizioni d’arte. Nel luglio del2004 ha tenuto una mostra di ceramica, An-geli in Rassegna (2000-2004), nel lambitodella XXIV Mostra Mercato Nazionale d’Anti-quariato di Pennabilli, a cura di GastoneMosci e Gianfranco Giannini; nell’agosto del2004, Interpretazioni di Rembrandt, trenta ce-ramiche a cura di Raffaele Mazzoli, nell’am-bito delle Conversazioni di PalazzoPetrangolini di Urbino; nel novembre 2005,una impegnativa mostra personale, Dal dise-gno della Pittura, presso il Centro Svizzero diMilano, a cura di Gaetano e Zoe Fermani. Igrandi piatti decorati del Premio Nazionale diCultura Frontino Montefeltro: 1997 a VittorioLivi, 1998 a Glauco Mauri, 1999 a GastoneBertozzini, 2000 a Gianfranco Mariotti, 2001 aCarlo Bo per i 90 anni e a Teresa Federici,2002 a Umberto Paolucci, 2003 a Eliseo Mat-tiacci, 2004 ai f.lli Elvino e Walter Scavolini,2005 a Oscar Piattella, 2006 a Teresa Petran-golini, 2007° Riz Ortolani.
Raimondo Rossi
Bozzetto di R. Rossi per la ceramica del PremioMonte Strega

31
Il presepe diffusoLa nona edizione di questa manifestazione ha richiamato molti visita-tori nel periodo natalizio, lungo le vie del Centro Storico del Castello.Evitiamo ogni commento e lasciamoci trasportare dalle immagini cheriproducono, in una veste diversa, l’Arte Sacra della Natività, mante-nendo però sempre uguale il suo profondo significato. I ringraziamentisono particolarmente rivolti al Comune di Sassoferrato (Assessore allo
Sport e Spettacolo - Sig. Corrado Panetti) per la collaborazione e na-turalmente a tutti coloro che con passione, dedizione, impegno hannoprestato la loro opera dimostrando attaccamento ai valori della nostracittà. L’Organizzazione attende volontari che apportino idee, forze la-voro e quant’altro possa contribuire a migliorare l’iniziativa.
Sotto: alcuni scorci del presepe ideato da Vittorio Toni.

32
ManifestazioniculturaliaSassoferrato

33
ManifestazioniculturaliaSassoferratoCentro Culturale “Baldassarre Olimpo degli Alessandri”
Palazzo Baldini, corso Don Minzoni, 40 - 60041 Sassoferrato (AN)www.ccboa.it [email protected]
PATROCINIO COMUNE DI SASSOFERRATO
PREMIO DI POESIA E DEL RACCONTO BREVE“Baldassarre Olimpo degli Alessandri” – XIII Edizione 2008
REGOLAMENTO- Il Premio si propone di valorizzare l'impegno letterario, la creatività e le qualità espressive di nuovi poeti e scrittori. Il Premio ha cadenza
annuale e si rivolge a poeti e scrittori nati o residenti nelle Marche e nell’Umbria. Il Premio è esteso a tutti i marchigiani e gli umbri re-sidenti in altre regioni d’Italia e all’estero.
- Il Premio è suddiviso in tre sezioni:1 - Poesia in lingua italiana; 2 - Poesia in dialetto marchigiano; 3 - Racconto breve e poemetto in prosa.
- Si partecipa con tre liriche, edite o inedite, e/o fino a tre racconti o poemetti in prosa di max 6 cartelle. Alle opere in dialetto si dovràaggiungere la traduzione in lingua italiana, specificando il luogo a cui il dialetto si riferisce.
- Le opere devono essere inviate in cinque copie dattiloscritte, anonime. Alle suddette copie si deve allegare una busta chiusa firmata,all’interno della quale vengono specificati: nome, cognome, titoli (o incipit) delle opere presentate, indirizzo, eventuale e-mail e reca-pito telefonico. Va, altresì, specificata la sezione a cui si desidera partecipare.
- I componimenti devono essere inviati a: Segreteria del Premio “Baldassarre Olimpo degli Alessandri”, Palazzo Baldini, Corso Don Min-zoni, 40 - 60041 Sassoferrato (AN).
- Si può partecipare a più sezioni. La partecipazione prevede un’iscrizione di 10 euro (per ciascuna sezione) da versare sul C.C. postale47399449 intestato a Centro Culturale Baldassarre Olimpo degli Alessandri, Corso Don Minzoni, 40 - 60041 Sassoferrato (AN). Allabusta dovrà essere allegato il bollettino di pagamento.
- Non c’è limite d’età. Il tema è libero.- Il termine per la presentazione dei componimenti è fissato per il 6 settembre 2008 (fa fede il timbro postale).- Saranno premiati tre partecipanti per ogni sezione. Le poesie vincitrici saranno pubblicate negli “Atti del Premio di Poesia e del Racconto
Breve - Baldassarre Olimpo degli Alessandri” e nel sito web www.ccboa.it- La Giuria si riserva di segnalare opere meritevoli e di istituire premi speciali e menzioni di merito.- Ai soli premiati e segnalati sarà inviata comunicazione telegrafica.- I premi devono essere ritirati personalmente o da persona munita di delega. Non è previsto nessun rimborso spese per i premiati.- Le decisioni della Giuria sono insindacabili.- Gli elaborati non verranno restituiti.- La cerimonia finale di premiazione si terrà a Sassoferrato, domenica 12 ottobre 2008 alle ore 17.00, presso la Sala Consiliare del Co-
mune di Sassoferrato - Piazza Matteotti, 1.- Ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 i dati dei concorrenti saranno utilizzati unicamente all’interno del contesto del Premio. Ai sensi
dell’art. 11, con l’invio dei componimenti, il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali per i motivi sopraccitati.- La partecipazione al premio comporta la completa accettazione di tutte le norme del presente bando.- Il Premio prevede il conferimento di un riconoscimento alla carriera ad un autore marchigiano che si è distinto nel campo artistico-let-
terario.Ulteriori informazioni al tel. +39 0732.959345 (ore 10.00/12.00) o +39 349.7390436.
Sassoferratesi in AfricaÈ il titolo della pubblicazione di Augusto Cantarelli, terza edizione, presentata nella Sala consiliare del Comune di Sassoferrato il 3 mag-gio u.s. Il sindaco, on.le Luigi Rinaldi, ha illustrato il tema dell'incontro. È successivamente intervenuto l'autore Cantarelli che ha ringra-ziato il sindaco per l'ospitalità, padre Stefano Troiani per il qualificante patrocinio alla iniziativa editoriale ed il pubblico presente; ha citatoi nomi di alcuni reduci d'Africa che hanno inviato i loro saluti, uno per tutti Guerrino Gioacchini.Ha poi spiegato le motivazioni della terza edizione che risalgono al ritrovamento di altri nominativi di combattenti in terra d'Africa durantele ricerche sui Caduti del secondo conflitto mondiale, militari e civili. Questa pubblicazione consta di circa 200 pagine, una ricca docu-mentazione cartacea e fotografica nonché delle testimonianze di reduci ancora in vita. L'intervento successivo del dr. Ciammitti, il cui padreprese parte alla ultima difesa di Gondar, particolarmente interessante e molto apprezzata in quanto ricca di cifre e riferimenti precisi di eventidell'epoca. Assai pregevole il successivo intervento del prof.Massoli, profondo conoscitore di alcune regioni africane, territori, usi e costumi,anche per la sua professione di docente universitario ad Addis Abeba e Mogadiscio. L'ultimo intervento è stato del dr. Mario Severini, ori-ginario di Sassoferrato molto legato da profonda amicizia con tutta la famiglia Cantarelli, sopratutto rievocando la figura dello "zio Dot-tore" come medico condotto. A conclusione apprezzamenti per i relatori, per i temi trattati e soprattutto per il richiamo affettuoso verso quantiparteciparono a quegli eventi con umiltà, senso del dovere compiuto da militari e civili.

34
La cucina non rappresenta solo prosaica-mente un modo per nutrirsi: espressione arti-stica che affonda le sue radici in unatradizione culturale, è fonte regolare di pia-ceri sempre nuovi. Tra i Paesi in cui la cucinaraggiunge un livello di eccellenza quasi mi-
stico, l'Italia occupa una posizione di spicco.Culla del Rinascimento, punto di confluenzadi elementi provenienti da ogni angolo delMediterraneo, racchiude tesori che non sem-pre sono conosciuti come meritano.La cucina italiana è la più esportata delle cu-cine del mondo occidentale. La sua diffusioneebbe inizio quando Caterina de' Medici sposòil re di Francia Enrico II e fu accompagnata,alla partenza dall'Italia, da diversi cuochi dellasua corte fiorentina. Questo apporto feceuscire la cucina francese dal Medioevo (usodella forchetta, invenzione italiana!) e fu al-l'origine della cucina francese moderna; a par-tire dal 16o secolo, la corte di Francia gradivain modo particolare verdure come i carciofi,gli asparagi o i piselli, che venivano dall'Italia!Grazie a Marco Polo, che riporta in patria lapasta e il riso dalla Cina, e a Cristoforo Co-lombo con il pomodoro, nella fattispecie dal-l'America, la cucina italiana ha saputo farepropri prodotti esotici che l'hanno poi resa po-
polare in tutto il mondo.La cucina italiana, infatti, mette in risalto iprodotti. Li lascia parlare. Si tratta di una cu-cina semplice e poco lavorata, ma estrema-mente gustosa perché gli ingredienti sonosaporiti.Si prendano ad esempio gli spaghetti al po-modoro. Un pomodoro, un olio d'oliva e unparmigiano di qualità sono sufficienti per ot-tenere un piatto facile e delizioso!Basta solo imparare a cuocere la pasta comein Italia.La cucina è un elemento importante nel mododi vivere degli italiani, in cui si rispecchia lacultura rurale, ma ancor più quella familiare,materna. Le sue ricette rappresentano un ele-mento importante dello stile di vita e ciò si ri-flette nelle diverse culture esistenti e nellastoria del Paese. Gli italiani hanno una visioneintima, concreta, rassicurante della cucina.L'accento è messo meno sulla complessità ela virtuosità di un'alta cucina di lusso chesulla qualità dei prodotti e sul rigore quoti-diano. Un piatto deve essere preparato comesi deve, con serietà, rispettando le tradizioni,per ritrovare i sapori che sapeva dargli lamamma.Grazie ai suoi prodotti, rappresenta inoltre ilmiglior esempio della cucina nota come "dietamediterranea", considerata come una dellepiù tradizionali e ricche del mondo. Secondoricerche recenti, attenendosi a questa dietaalimentare si riducono notevolmente i rischidi malattie cardiache. Ma la cucina italiananon è solo una cucina mediterranea (basatasulla trilogia pane-olio-pomodoro), ha inte-grato anche influenze lombarde (riso, burro),alpine (polenta, panna, formaggio) e perfinoaustriache (bresaola, strudel, birra, cannella)ed arabe (cuscus e dolci in Sicilia). Come laFrancia, l'Italia è un Paese con straordinariericchezze regionali. E se per un italiano ilcuore della gastronomia italiana si situa trala Toscana (forse la più prestigiosa) e l'EmiliaRomagna (la più saporita e la più ricca), l'in-tera Penisola offre una grande varietà di pro-dotti (tartufo bianco, parmigiano, prosciuttoSan Daniele, tonno, riso, grappa, vini del Pie-monte e della Toscana...).La Francia, in materia di gastronomia come in
altri settori, rivendica sempre una certa ege-monia che oggi è rimessa in discussione. Nonsi può più affermare che la gastronomia fran-cese è la migliore del mondo. Oggi in Europasono emerse nuove tendenze. Ciò non toglieche dobbiamo tutti essere riconoscenti allaFrancia, a cui spetta il grande merito di averregalato al mondo le regole dell'alta cucina.La gastronomia francese resta un riferimentoculturale fondamentale ed inevitabile. La cu-cina francese è nata in ambiente aristocraticoe il suo modello è nazionale. La cucina ita-liana è popolare e regionale, ma regge il con-fronto con quella francese. Il suo vantaggiorisiede nel fatto che è meno lussuosa e piùfacilmente accessibile. I ristoranti italiani nonsono più soltanto pizzerie e trattorie. Si attri-buisce maggiore importanza alle materieprime, alla qualità del servizio, alla cottura ra-pida, all'uso parsimonioso delle materiegrasse. La cucina popolare è stata rivalutata.Vi è stato un mutamento culturale: l'Italia si èresa conto delle ampie possibilità offertedalla ricchezza della sua cucina e il mondo ga-stronomico ne ha preso atto. Non solo è statalarga fonte d'ispirazione del “world food”, maanche la maggior parte dei cuochi nei risto-ranti di tutto il mondo utilizzano nelle loro ri-cette prodotti e preparati di origine italiana(ricotta, aceto balsamico, tartufi bianchi, in-chiostro di seppia, parmigiano, risotto, car-paccio, ecc.).Per i francesi che scoprono questa ricchezza evarietà, la cucina italiana non è più una cari-catura dei piatti napoletani: pasta e pizza (cheè comunque diventata uno dei piatti più dif-fusi a livello mondiale). Apprezzano semprepiù la qualità delle sue ricette, caratterizzatedalla leggerezza. E la scelta dei prodotti uti-lizzati in questa "nouvelle cuisine" ha contri-buito ampiamente alla sua evoluzione, graziealla virtuosità dei cuochi italiani, ma anche esoprattutto alla varietà dei prodotti artigianaliche la produzione regionale italiana mette aloro disposizione. I francesi manifestano unrinnovato interesse per questa cucina. Alpunto che, invitati a pronunciarsi sulla mi-gliore cucina del mondo (ad eccezione diquella francese) i francesi citano la cucina ita-liana al primo posto (38%) con un netto van-
Italia, Italia, Italia miadi Carlo Bianchi
Carlo Bianchi, proprietario del ristorante SanFrancisco a Parigi.

35
taggio su quella cinese (21%), spagnola (11%) o del Maghreb (9%).Adesso parliamo della nostra bella Italia .Lasciando la Francia,attraverso il tunnel del Monte Bianco,si può am-mirare questa bella terra partendo dalle splendide montagne del Pie-monte fino ad arrivare in Trentino si scoprono lunghe catenemontuose,le stazioni invernali, i magnifici paesaggi,i suggestivi pae-sini incollati sui monti e i rigogliosi parchi che tutti ci invidiano.
Le belle cittàOltrepassata Torino possiamo godere del paesaggio di diversi laghi : illago di Como, il lago Maggiore e il lago di Garda.Milano, chiamata lacapitale del Nord.Verona con l’Arena che ci fa scoprire le nostre opere. Venezia, con isuoi palazzi che dominano i grandi canali ; piazza SanMarco, le chiese,i musei, le gondole che ci fanno scoprire la città attraverso le piccolecalle.L’architettura di questa città è unica al mondo e ci rende orgogliosi diessere italiani.Scendendo verso l’Italia centrale troviamo labella Emilia Romagna, laToscana,finoad arrivare in Umbria,Lazio e,dal-l’altra parte, la regione Mar-che. Quando un francesemi domanda di dovesono, rispondo «leMarche».La prima risposta è:« Ma dove sono leMarche ? »Alloraspiegando, si rav-viva la loro mentee rispondo : « Ah, lacosta Adriatica ; Ri-mini, Riccione etc... »Perche per i francesil’Italia che conoscono è IlPiemonte, la Toscana, Napolie le nostre belle isole. Loro nonsanno che la nostra regione è bellis-sima, basta guardare la posizione su una cartageografica e scoprirla. Il mare Adriatico con le sue inse-nature e le belle spiagge,montagne e bellissime colline. Il verde diquesta campagna con i suoi profumi e colori, il sole e le belle nottistellate. Il capoluogo di provincia è Ancona famosa per il suo porto,Urbino,la pittoresca Portonovo con il suo mare che sembra la Sardegna,Macerata con il suo magnifico Sferisterio, Ascoli Piceno, Fabriano lacittà della carta, Pesaro con il teatro Piccolo Rossini, San Leo.... Nondimentichiamo le abbazie e cattedrali, i monumenti storici : l’Eremodi Fonte Avellana, i pittori, scultori, fotografi, scrittori, giornalisti spor-tivi, i lavori artigianali i quali rappresentano la ricchezza che i nostriantenati hanno saputo transmetterci attraverso le generazioni. E poiancora i monti Sibillini, la catena degli Appennini con il Catria, Il Cucco, il monte Strega che dominano un panorama che sembra pittura o fo-tografia.Questa è una regione dove il lavoro quotidiano è il frutto e l’orgoglio
dei nostri padri. Si produce il grano, il mais, l’olio di oliva, il vino, fruttae verdure...Si allevano pecore, mucche, galline, oche, conigli, piccioni... Da quinasce la cucina marchigiana dove si naconde un fascino discreto perfarci apprezzare i sapori, i profumi e scoprire le ricette di un tempo ele mille varianti che a volte sono sconosciute o scomparse.Prendiamo per esempio il farro che oggi è un alimento rivalutato gra-zie anche al lavoro della signora Lea Luzi che con la sua pazienza ci per-mette di scoprire le sue ricette di paste e di dolci.Come non fermarsi ,dopo questa bella passeggiata alle grotte di Fra-sassi, una delle più belle di Europa, che meraviglia !!Un po’ più lontano arriviamo a Sassoferrato,paesino formato da duerioni. “Tra il Borgo e il Castello Sassoferrato dov’ello”Scopriamo i monumenti, la Rocca, le chiese, i nostri personaggi piùimportanti tra cui Giambattista Salvi. Troviamo i suoi quadri a Londra,Parigi, New York....Gli abitanti di Sassoferrato sono timidi e riservati consapevoli del loro
mestiere, delle sudate fatte per lavorare la terra e sapertrasmettere la nostra cultura ; i nostri piatti ti-
pici, il pane, la pasta fatta in casa con ilmattarello, le minestre di una volta
(con le fave...) quadrucci con iceci e brodo di gallina, fa-
gioli con le cotiche, polloe agnello al forno conle patatine, coniglioin porchetta, zam-pone e cotechinocon lenticchie diCastelluccio, pic-cione ripieno, la cre-scia con le cipolle e
rosmarino. E non di-mentichiamo il maiale,
l’unico animale dove siutilizza tutto ; prosciutto,
lonza, pancetta , spalletta, sa-lame, salsicce e le cotiche che i no-
stri nonni guardavano con cura percheserviva durante l’inverno per ungere i vecchi
scarponi di cuoio. Troviamo anche qualche dolce tipico : lacrescia fogliata, la zuppa inglese, le castagnole, le crescie di Pasqua....Un infinito grazie alle nostre nonne e mamme che hanno saputo tra-smetterci tutto il loro saper fare e hanno permesso di farci apprezzarequesta cucina piena di sapori e gusti. Da qui è nato un libro intitolato« Mamma Mia » che ho scritto e dedicato alla mia famiglia, con qual-che ricetta tipica del mio ricordo di bambino. Ora diamo un grande sa-luto a questa stupenda regione,discreta, forse un po timida,ma dalgrande fascino. Siamo consapevoli e orgogliosi della sua richezza.
Sopra: l’ingresso del ristorante in una elaborazione grafica.
RESTAURANT SAN FRANCISCO1, rue mirabeau - 75016 PARISTel. 01.46.47.84.89 – Fax 01.46.47.75.44Web: www.sanfrancisco.fr

36
Queste ricette sono tratte dal libro “Antologia della cucina popolare”a cura di Piergiorgio Angelini, Aurelio C., Balilla Beltrame, Nora Lip-paroni, Graziella Picchi, Antonio Trecciola, pubblicato dalla ComunitàMontana della Alta Valle dell’Esino (Fabriano, 1986) con la collabora-zione degli studenti delle scuole Elementari e Medie del Distretto Sco-lastico di Fabriano.
Frittata con le vitalbeIngredienti:gr. 300 di cime di vitalbe (tenere, raccolte in primavera )6uova, sale e pepe di mulinello 2 cucchiai di olio di olivadopo aver lavato le cime delle vitalbe, lessatele in abbondante acquasalata; scolatele, asciugatele e tritatele.Ora, nella padella dove sfrigola l’olio, rosolate il trito.A parte sbattete le uova. condendo con sale e pepe; unite la vitalba. poiversate il tutto nella padella e cuocete la frittata da ambo i lati, rigiran-dola aiutati da un coperchio piano più grande della bocca della padella.Una volta dorata, asciugatela sopra fogli di carta paglia e servitelacalda, tagliata a spicchi.
Spaghetti alla carbonaraIngredienti:1dl. di olio di olivagr, 120 di pancetta a dadini1 spicchio di aglio schiacciato (da buttare una volta rosolato)5 uova sbattute2 cucchiai di prezzemolo tritatogr. 80 di formaggio pecorino grattugiatosale e pepe di mulinelloIn una padellina soffriggere nell’olio la pancetta, profumandolo con lospicchio di aglio (da buttare prima di condire la pasta)Intanto, in una ciotola sbattere le uova insieme al prezzemolo ed alformaggio; regolate di sale e pepe. Trascorsi pochi minuti il condimentoè pronto per essere versato sulla pasta. mescolate più volte
Farro con fiori di zucchineIngredienti per 6 persone:1 dl. Di olio di oliva2 spicchi di aglio tritati½ cipolla tritata3 zucchine, affettate, sottilmente12 fiori di zucchine, nettati e tagliati a strisciolineun bicchiere di vino bianco seccogr. 400 di farro Monterossol. 1 di brodo di carnegr. 60 di formaggio pecorino grattugiatopepe di mulinelloMettere a bagno per due ore i chicchi di farro.In una padella ampia soffriggere nell’olio il trito di aglio e cipolla, poiaggiungere le zucchine ed i fiori, versate il vino bianco, quindi il farro
ed il brodo poco per volta, lasciandolo sfumare.A fine cottura servite questa vivanda calda, spolverizzandola di peco-rino e pepe.
Frittelle di meleIngredienti:mele, pelate, liberate dei torsoli ed affettatePer la pastella: 1/4 di latte2 uova sbattutegr. 40 di zuccheromezza bustina di vanigliauna punta di bicarbonato, mistràgr. 40 di farinastrutto e burro, per friggerecannella grattugiatazucchero a velo, per spolvero finaleLe fette di mela affogatele nel Mistrà e lasciatele riposare coperte. inuna ciotola ampia mescolate il latte con le uova, lo zucchero, la vani-glia, il bicarbonato e la farina, lavorando di continuo con la frusta me-tallica: la pastella deve risultare morbida ma densa.Ora, immergete le fette di mela nella pastella, poi subito tuffatele nellostrutto bollente per friggerle.Quando dorano, allora scolatele, asciugatele sui fogli di carta paglia,ricopritele di cannella e di zucchero a velo, quindi servitele.
Ricette della tradizione sassoferratesea cura di Sebastiana Locci

37
Costituzione della banca: le originiNel mese di ottobre del 1879 il Consiglio comunale di Sassoferrato,su proposta del consigliere Gustavo Garofoli, approva un ordine delgiorno in cui si ribadisce l’opportunità di addivenire alla costituzionedi una banca con le seguenti precisazioni: la Cassa di prestiti, di ri-sparmi e depositi è a favore di agricoltori, artigiani e industriali poveri;il 4% dovrà essere devoluto allo Spedale; sarà redatto uno statutoorganico da approvarsi dal Consiglio comunale e dalla Deputazioneprovinciale. Ulteriori e non meglio conosciuti ostacoli, tuttavia, impe-discono alla Banca di nascere. La Cassa Pensioni, che pure poteva ef-fettuare piccoli prestiti, assieme al Monte di Pietà, non potevanosoddisfare tale richiesta. Quest’ultimo poi versava in grave difficoltàe, per varie ragioni, da tempo era caduto in discredito. Non restavache ricorrere agli usurai locali che coi loro tassi proibitivi gravavanosoprattutto sui contadini.La banca popolare cooperativa di Sassoferrato si costituisce con attodel 29 maggio 1887 del notaio Ranieri Cecchetelli di Sassoferrato. As-sume la forma di Società Anonima Cooperativa di credito con capitaledi lire 25 ad Azione sottoscritto da 99 soci per un totale di Lit. 4.168 di-viso in 162 azioni. La somma suddetta fu depositata presso la Cassadi Risparmio di Jesi sul libretto n. 44116 nel maggio del stesso anno.
Soci fondatori (per ordine di comparizione nell'Atto costitutivo)1 STELLA Pietro Sindaco Sassoferrato2 JERETZ Ferdinando Ingegnere “3 CASTELLUCCI Angelo Possidente "4 TASSI Don Francesco Possidente "5 STRAMPELLI Giovanni Perito agronomo "6 FERRETTI Ubaldo Perito agronomo "7 PANTALISI don Biagio Parroco "8 BELARDINELLI Sabatino Maestro elementare "9 ANDREOLI-SCIPIONI Emidio Possidente "10 COLLINI Giovanni Avvocato "11 RAZZI Stefano Possidente "12 GAROFOLI Gustavo Avvocato "13 AMORI Eprefe Possidente "14 PERELLI Alfonso Possidente "15 RAGNINI Alessandro Segretario comunale “Fonte: Atto costitutivo Banca Popolare di Sassoferrato - 29/5/1887
I primi anniCon il resoconto dei primi dieci mesi di gestione, presentato all’as-semblea del 31 marzo 1889, si hanno le prime risultanze. Nell’ampiarelazione del Consiglio di Amministrazione sono evidenziati vari punti ri-guardanti la situazione patrimoniale, i depositi a risparmio, i prestiti egli sconti , i corrispondenti, il movimento di cassa. Il primo consiglio diamministrazione che firma il bilancio era composto oltre che dai nomi-nati Stella e Tassi, rispettivamente presidente e vicepresidente, da Giu-seppe Carletti, Angelo Castellucci, Domenico Melchiorri, Stefano Razzi
e Giovanni Strampelli. Facevano parte del Collegio sindacale SabatinoBelardinelli, Settimio Luzi, Alessandro Ragnini e Pacifico Simonetti.Per il secondo esercizio, riferito all’anno 1889, abbiamo a disposizionele due relazioni, degli amministratori e dei sindaci, e un interessanteprospetto comparativo. Da tali documenti si rileva un consistente svi-luppo dell’attività con riferimento ai principali indicatori finanziari.
Nuova sede della BancaAllo scopo di dare una sede più adeguata alla Banca, nell'assembleadei soci del 16 aprile 1899 il presidente comunica di aver dato disdettadei locali tenuti in affitto dalla Banca e che il Consiglio di amministra-zione aveva deliberato (il 28 febbraio 1899, dopo un’animata discus-sione e con sei voti contrari, su 115 ), di acquistare, per conto dellaBanca, uno stabile in piazza Bartolo, e precisamente l’intero secondopiano della casa Porfiri con la spesa complessiva di lire 4.164,05.Nella relazione dei Sindaci del 1901 si dà atto che per l'acquisto del lo-cale della Banca e per i lavori eseguiti si è speso più del previsto per-ché si è ritenuto di fare altri lavori, non contemplati in perizia, permigliorare la funzionalità della sede.
Festa della Banca (XXXV anniversario)Il 24 luglio 1921 la Banca Popolare celebra solennemente il suo XXXV an-niversario della fondazione. Fa stampare un numero unico di 4 paginesul quale sono illustrate le vicende passate ed attuali dell'Istituto di cre-dito. Un paragrafo dell'articolo di fondo è dedicato ai presidenti. Unastoria nella storia dei trent'anni, così efficacemente sintetizzata: "nellasala del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto pendono dalle paretidue magnifici quadri ad olio che l'arte raffinata del prof. Rodolfo Rossiseppe ritrarre da due vecchie fotografie. Sono le immagini dei due primipresidenti. Pietro Stella, il primo, che ha ricoperto la carica per undicianni portando contributo morale e materiale, quando ancora l'Istitutonon era poggiato su solide basi e l'atmosfera politica d'Italia generavanel pubblico serie apprensioni. Giovanni Strampelli, il secondo, che comel'altro, dette le sue energie, depositò tutti i suoi averi a garanzia della se-rietà e solidità della Banca. Per queste due figure scomparse tutti i cit-tadini conservano ricordo affettuoso e gratitudine. Fu poi presidente ilDott. Domenico Razzi e quindi il Dott. Domenico Melchiorri, che ricopretuttora la carica e che fu uno dei fondatori, ed ha oggi la soddisfazionedi vedere quale superba ascensione abbia compiuto l'Istituto".
La crisi economica del dopoguerraDopo un iniziale buon andamento di gestione, riscontrabile ad esem-pio nelle lusinghiere espressioni riferite al bilancio del 1918 e ai pre-cedenti, i primi anni del dopoguerra sono caratterizzati da incertezza sulpiano politico e da precarietà del quadro economico. l'avv. StellutoStelluti Scala riconosce giustissime le preoccupazioni esposte dalcomm. Stella, ma dice che bisogna anche preoccuparsi della disoccu-pazione in cui si trovano moltissimi operai. Dice inoltre che la crisi fi-nanziaria colpisce i grandi Istituti e non i piccoli e conclude insistendo
Storia della Banca Popolaredi Sassoferrato (1887-1945)di Renzo Franciolini

38
che, data la mancanza assoluta dei lavori e le difficoltà degli alloggi,sia bene che la Banca incominci subito i lavori.Il comm. avv. Ermogaste Stella, non crede che la disoccupazione, possaessere risolta con l'impiego per qualche mese di un numero molto re-lativo di operai, quanti cioè ne occorrerebbero per eseguire i lavoridella nuova sede sociale. Riguardo alla difficoltà di trovare alloggi diceche questa penuria non può essere risolta col nuovo edificio dellaBanca, in quanto in esso non potrebbero esservi che abitazioni per ilbidello e per un'altra famiglia o due al massimo. Cosa molto relativaquesta, in confronto alla grande necessità che si sente nel paese.Il rag. Assuero Cesaretti, a proposito della disoccupazione, dice chepiù di tutti se ne devono preoccupare il Governo ed il Comune, co-
munque in proporzioni maggiori di quanto non lo debba la Banca, laquale è un Istituto privato. Dice quindi che la Banca stessa potrebbeinvece finanziare il Comune o quella Cooperativa che prendesse l'ini-ziativa per la fabbricazione di case popolari. Rinaldo, Melchiade e Te-mistocle Cianca ed altri sono del parere che il momento attuale sia ilpiù favorevole per l'inizio dei lavori, data la diminuzione del prezzo delferro, del legname. Al termine della discussione, l’assemblea, “costa-tato che la crisi industriale ed agricola minaccia di turbare sempre piùla vita nazionale e che quindi gli istituti di credito previdenti debbonoastenersi dall’ immobilizzazione dei capitali per avere maggiore agi-lità sul continuo giro delle operazioni di credito”, approva il rinvio edesprime il proprio compiacimento al progettista Boldrini.
La grande crisi e le prime difficoltàA cominciare dal 1929, avvenimenti internazionali, interni e locali
sconvolgono il sistema bancario. Per coglierne meglio i vari aspettisono necessarie alcune digressioni. Nel 1913 era sorto l'Istituto di cre-dito per la cooperazione, ideato da Luzzati nel 1910, con l'espressa fi-nalità di agevolare il credito agli istituti cooperativi. Nel 1927 era gravela situazione dell'Istituto che venne trasformato prima in Banca Na-zionale del Lavoro e della Cooperazione, quindi in quello definitivo diBNL. Questa banca, è legata alla vita di alcune banche marchigianedell'epoca. Difatti il fallimento della Società bancaria marchigiana, av-venuto nel 1928, portò alla creazione della Banca delle Marche e degliAbruzzi, che subentrò, l'anno dopo, nell'attività creditizia di tutte le fi-liali della Società Marchigiana, salvando o sanando difficili o dolorosesituazioni. Il 1929 è un anno di svolta. Nonostante il buon andamentodella gestione, per ragioni prima internazionali - crollo della Borsa degliStati Uniti -, si intravedono le prime difficoltà che appaiono chiara-mente nell’assemblea degli azionisti del 14 aprile 1929. che ha creatonon pochi disagi di vario genere - ricorre più volte, anche se costante-mente esorcizzato, lo spettro del grave dissesto di un grosso istituto,la Società Bancaria Marchigiana, che aveva una filiale a Sassoferrato,nella stessa piazza Bartolo. L'assemblea termina dopo la rielezione peracclamazione dei consiglieri Castellucci Tito, Melchiorri Zeffirino, Se-verini Luigi e Stella Daniele. L'approssimarsi della crisi fatale si puòpercepire, anche dagli indicatori di bilancio che seguono:Anno Patrimonio Depositi (Soff.) Impieghi Utile/perdita Div.do1928 514.688 10.983.899 5.325.152 86.024,90 10.001929 572.770 10.383.557 6.113.069 65.776,41 ====1930 612.629 8.339.471 2.460.554 9.403,17 ====1931 622.032 4.323.574 620.071 188.322 (-) ====1932 ........... ........... ........... ...........1933 ........... ........... ........... ...........
La Banca Popolare Cooperativa di Sassoferrato

39
L’ultimo tentativo di bloccare la crisiAssemblea affollatissima con 132 partecipanti il 26 aprile 1931. C'ègrande preoccupazione ma anche la volontà di resistere alla crisi. Al-cuni ringraziamenti sono rivolti dal presidente "in questo duro cimento"al Prefetto grand' ufficiale Giuseppe Mormino, “ che ci ha assistito eci assiste con affetto che uguaglia quello di un concittadino” e al di-rettore della Banca d'Italia di Ancona Cav. Mario Mioni.Altra assoluta novità, che purtroppo conferma la gravità della crisi dellabanca e della sua dirigenza, è la mancata presentazione da parte delConsiglio di amministrazione di candidati propri e, ancor di più, l'ac-cettazione senza riserve, da parte dello stesso organo, dei "due av-versari di ieri" Piersante Strampelli e Celso Sadori, da cooptare comeconsiglieri. La anomalia è spiegata nella assemblea straordinaria deisoci del 29 maggio 1932, dove è riportato che "i Sindaci, ad eccezionedel Rev.do Don Enrico Andreini, non hanno ancora esaminato il Bilan-cio e quindi non firmata la relazione, mentre il Sindaco Fata David si èrifiutato sia di esaminare il Bilancio, sia di firmare la relazione". Nellastessa assemblea emergono le gravi difficoltà anche nei rapporti so-ciali. L'assemblea si conclude con la discussione riguardante i prov-vedimenti per la sistemazione della Banca. A tale riguardo il presidenteinforma che sarà convocata una nuova assemblea". Il riferimento è allarichiesta di Concordato preventivo presentata al Tribunale qualchegiorno prima (22 maggio) da parte del Consiglio di Amministrazione edaccolta con Decreto del 28 maggio 1932. Il Concordato preventivo dopoi vari adempimenti, è stato definitivamente omologato dal Tribunalecon sentenza del 24 marzo 1933.
La convenzione con la Cassa di risparmio di FabrianoPer ottemperare regolarmente agli oneri del concordato, il Consigliodi amministrazione della Banca ha definito un'intesa con la Cassa di ri-sparmio di Fabriano, secondo la quale quest’ultima si assume l'oneredi provvedere alle esigenze dei depositanti, a fronte di un impegnodella Banca sassoferratese a sciogliersi e mettersi in liquidazione se-condo modalità prestabilite. Ciò appare la naturale conseguenza dellaperdita totale del capitale sociale, costatata nell'assemblea degli azio-nisti del 26 giugno 1932. Le sopraggiunte difficoltà di vario tipo ren-dono estremamente lento il rimborso dei libretti di deposito che pureera stato pianificato con ogni prudenza. Dopo il consistente numero dirimborsi effettuato nel corso del 1937 e nei primi mesi del 1938 - dai3.118 libretti per lire 3.980.556 si è passati a 997 ammontanti a lire34.010 ancora da rimborsare, l’assemblea generale dei soci del 16 ot-tobre 1939 è costretta a stipulare un nuovo accordo con la Cassa di ri-sparmio per il pagamento dei libretti tuttora insoluti.
Lagestionedella liquidazionedurante la secondaguerramondialeIn queste ultime fasi di vita della Banca, lo spirito associativo si af-fievolisce sia per la crisi finanziaria, sia perché la guerra è ormai vi-cina. L'assemblea dei soci, riunita l'otto aprile 1940, registra lapartecipazione soltanto di otto soci. Il liquidatore Rossi nel leggerela sua relazione afferma che è "veramente mortificante dover costa-tare che non si sia ancora alla chiusura della liquidazione, ma i resi-dui sono duri a regolarizzare". Si dilunga sulle singole partite ancoraaperte e così prosegue: "...Il 24 febbraio di quest'anno abbiamo prov-veduto a fornire alla Cassa di Risparmio di Fabriano i mezzi necessariper il pagamento di tutti i depositi ancora da rimborsare che la Cassastessa si è obbligata ad estinguere.I Sindaci nella loro relazione del 13 marzo 1940, riferiscono che "la li-
quidazione dell'ex direttore Cesaretti fu autorizzata dall'assemblea del16 ottobre 1939; l’insussistenza attiva (lire 3.999,57) rappresenta l'im-porto dei mandati rimborsati all'Esattoria comunale onde ottenere losvincolo del deposito effettuato a suo tempo presso la Cassa di ri-sparmio e la sopravvenienza passiva (L. 568,23) è costituita dall'im-porto dell'addebito per deficienze del servizio esattoriale dellaCongregazione di Carità". Aggiungono che "nessun conto può farsi piùsulle attività ancora portate a bilancio sotto le voci "Portafoglio" e "Sof-ferenze" e che ritengono opportuno "autorizzare il liquidatore a de-pennare gli importi rappresentati da cambiali inesigibili e sofferenzeirrealizzabili".
La Cassa di risparmio a Sassoferrato: unica superstiteLa Cassa di risparmio trae indubbio vantaggio dalla crisi della BancaPopolare prima e della Banca delle Marche e degli Abruzzi poi. Anchei notabili locali, ormai rassegnati alla crisi irreversibile della “loro”Banca, si associano: troviamo infatti come soci della Cassa di ri-sparmio di Fabriano negli anni 35/36/37/38, i signori Castelluccigeom. Tito, Pierelli dott. Gustavo, Razzi dott. Dario, Rossi prof. Ro-dolfo, Stella avv. Ermogaste e, per il Recapito di Cabernardi, il geom.Pietro Ferroni.
Gli ultimi anni di guerraIn questi ultimi anni ormai la vicenda della Popolare é una pratica dachiudere, essendo prevalenti altre ben più gravi preoccupazioni.Negli anni 1943 e 1944 non si è compiuta alcuna operazione talché ilbilancio di chiusura proviene dall'ultima operazione compiuta nel 1942.ll rendiconto dell'anno 1942 in definitiva racchiude in sé il bilancio diliquidazione che risulta essere il seguente:ATTIVO: Dep.to c/o la Cassa di R.- Fil. di Sassoferrato: L. 1.299,49PASSIVO: Spese presunte chiusura della liquidazione: L. 1.299,49Il liquidatore Giovanni Rossi nella sua relazione finale dichiara: "do-dici anni non sono davvero pochi per liquidare una gestione di mode-sta mole, ma le sue ultime formalità sono state assai fastidiose"."Andata deserta l'Assemblea del 20 aprile 1942 - riferiscono i Sindacinella loro relazione - si differì di mese in mese l'approvazione dei ren-diconti dell'esercizio 1941, dato che nei primi mesi del 1942 furono ef-fettuate le ultime operazioni rimaste in essere per permettere dideliberare la chiusura della liquidazione: per un atto che rimase da sti-pulare, si giunse sino all'estate 1943 e le successive terribili vicendeattraversate giustificarono il ritardo della convocazione dell'Assem-blea finale".Cinque anni di storia della Banca e dell'intero paese - i più drammatici- traspaiono da queste poche cifre e dai forzati rinvii e sono sintetizzatinell'ultima assemblea dei Soci del 28 luglio 1945, svoltasi nei localidell'Esattoria Comunale di Sassoferrato, in piazza Bartolo, alla qualehanno partecipato sette soci, i cui nomi è doveroso ricordare: Ermo-gaste Stella, Luigi Severini, Giuseppe Paris, Antonio Salvioni, MarioPoeti fu Ismaele, Daniele Mancinelli e il sindaco revisore Avv. France-sco Stelluti. L'assemblea, approva tutti i documenti contabili presen-tati, all' unanimità, e chiude la liquidazione. E con l’ultima deliberatermina di scrivere un’ importante pagina di storia economica e civiledi Sassoferrato.
Sintesi dal volume “La Banca popolare cooperativa di Sassoferrato(1887-1945)”, edito dal Centro regionale dei movimenti sociali catto-lici e la resistenza nelle Marche - Sassoferrato - 1997

40
Olio su tela mt 2,20 x 1,50: trattasi dicopia del famoso quadro dal Caravaggio“La Cena in Emmaus” (il cui originale tro-vasi a Milano presso il Museo di Brera). Ildipinto, olio su tela, è stato eseguito dalnostro concittadino e Consigliere dellaAssociazione Mario Toni e donato nel2004 al Parroco della Cattedrale di AssisiMons. Giuseppe Rossetto in occasionedel 50.mo di sacerdozio. L’opera ha avutoil benestare della Commissione Arti Sacree della Soprintendenza Belle Arti di Peru-gia per la collocazione nella suddetta Cat-tedrale (San Ruffino), nell’abside in altoa sinistra sopra l’altare maggiore. Ricor-diamo che Don Giuseppe Rossetto hasvolto per anni il ministero pastorale nelleparrocchie di S.Pietro di Sassoferrato eS.Maria di Catobagli negli anni ‘50/60.
La pittura di MarioToni
Foto Studio Cico - Fabriano
SASSOFERRATO: DA VISITARE
AREA ARCHEOLOGICA DI SENTINUM(Loc. S. Lucia, a 2 km dal centro abitato)Orario visite: dal lunedì al sabato e la seconda equarta domenica del mese: ore 8.00-14.00.Primo e terzo venerdì del mese: ore 14.00-19.00Agosto: tutti i giorni, ore 16.30-19.30.Tel. 0732.956218/9561 - 338.4033204.Sono visibili le strade (cardo e decumano), ruderi dellemura, pavimenti a mosaico, colonne di granito. Re-centi campagne di scavo hanno consentito il rinveni-mento di un importante sito termale pubblico edhanno permesso di ricavare utilissime indicazioni sullaconformazione dell’impianto urbanistico di Sentinume portare alla luce strade, fondamenta, tracce di pa-vimenti e fognature di alcuni edifici del centro urbanodell’antica città romana.
MUSEO ARCHEOLOGICO(Palazzo dei Priori - piazza Matteotti)Orario visite: dal martedì al venerdì: ore 10.30-12.30.Sabato: ore 16.30-19.30.Agosto: ore 17.00-20.00, 21.15-23.15.Festivi: ore 10.30-12.30, 16.30-19.30.Tel. 0732.956218/9561 - 338.4033204.Ristrutturato di recente ed inaugurato il mese di marzou.s., vi figurano numerose sculture ed altri reperti chedocumentano gli aspetti più importanti della vita degliantichi abitanti di Sentinum: l’organizzazione della vitapolitica e sociale, la religione, gli strumenti necessariper una civile convivenza, anfore, lucerne, oggetti de-corativi, monete, ecc. Sul pavimento di due sale sonocollocati mosaici rinvenuti a Sentinum. Al piano infe-riore del Museo è possibile visitare il grande plasticoraffigurante la “Battaglia delle Nazioni” (avvenuta neipressi di Sentinum nel 295 a.c.) e la Sala Perottiana incui è custodita una preziosa raccolta di reliquari bi-zantini e fiamminghi, tra cui l’icona di San Demetrio dialtissimo valore storico-artistico. Il museo comprendeinoltre una sezione dedicata alla preistoria.
MUSEO DELLE TRADIZIONI POPOLARI(Palazzo Montanari)Orario visite: dal martedì al venerdì: ore 10.30-12.30.Sabato: ore 16.30-19.30.Agosto: ore 17.00-20.00, 21.15-23.15.Festivi: ore 10.30-12.30, 16.30-19.30.Partenza gruppi (da uff. turistico comunale):da martedì a venerdì: ore 11.00.Sabato e festivi (da museo archeologico):ore 11.00, 17.00, 18.00Tel. 0732.956218/9561 - 338.4033204.Il Museo, il cui edificio è stato completamente ristruttu-rato dopo i danni arrecati dal sisma del 1997, è stato al-lestito secondo moderni criteri scientifici. Gli ambienti,“ricostruiti” secondo tipici modelli abitativi delmondo ru-rale marchigiano, descrivono, attraverso gli oggetti e gliarredi una realtà fatta di cose semplici, pratiche, essen-ziali, ma certamente autentiche, come il duro lavoro e laquotidiana fatica di un’epoca ormai lontana. Il Museo èarticolato in 6 sezioni. Al piano terra sono ubicate leprime 4 sezioni: 1) Lavorazione della terra (aratura e se-mina); 2) Lavorazione dei prodotti (mietitura e trebbia-tura); 3) Lavorazioni domestiche (filatura, tessitura); 4)Mezzi di trasporto (birocci, carri). Nel piano seminterratosono ubicate le due sezioni che ricostruiscono, tramitegli arredi e gli oggetti dell’epoca, l’atmosfera che si re-spirava sia nella casa contadina che nelle botteghe degliartigiani; 5) Ambienti domestici (forno, cantina, dispensa,camere, cucina); 6) Lavorazioni artigiane (tornitore, fale-gname, arrotino, boscaiolo, ciabattino, bottaio, fabbro,maniscalco, muratore, cocciaro, cordaro, apicoltore).
MUSEO DELLAMINIERA DI ZOLFO(Loc. Cabernardi, a km.10 da Sassoferrato)Orario visite: Sabato e domenica: 15-19. Prenotazioni tel.0732-975241 - 975013 - 956231.Il Museo raccoglie in 5 ampie sale e in un lungo corri-doio, documenti, fotografie, attrezzi da lavoro dell’exMi-niera di Zolfo di Cabernardi. Ottanta anni di attivitàindustriale a cavallo tra gli ultimi anni dell’800 e la metàdel secolo scorso. La ricca documentazione presenta, in
una sezione, la vita del paese e di quello che fu il piùgrande ed esteso centro minerario solfifero d’Europa.
CHIESA DI SAN FRANCESCOVisite e prenotazioni: tel. 0732.9375 - 338.4033204Costruzione del 1245 di stile tardo romano o romano-go-tico. Conserva dipinti del Ramazzani e del Guerrieri. No-tevole un Crocifisso del 1300 di scuola riminese e cicli diaffreschi grotteschi di scuola umbro-marchigiana.
MONASTERO E CHIESA DI S. CHIARAVisite e prenotazioni: ore 9.00-11.30/15.30-17.00tel. 0732.9375Costruito nel XIII sec., all’interno ospita opere d’arte dinotevole pregio: unaNatività attribuita adAntonio da Pe-saro, un affresco di Scuola Umbra e due tra le più belleMadonne del Salvi; inoltre, una Annunciazione del Salvi.
ROCCA DI ALBORNOZMassiccia costruzione militare risalente al XIV sec. Co-struita per ordine del Cardinale Egidio Albornoz nel 1365,fu un efficiente presidio difensivo.
CHIESA DI SAN PIETROVisite e prenotazioni: tel. 0732.9375 - 338.4033204Chiesasortacon il primitivocastello feudale intornoal1200.Acquistò grande importanza a partire dal 1580 quando ilVescovo di Nocera diede alla Parrocchia di San Pietro il ti-tolo di Collegiata. Rovinò nel 1688, ma nel 1717 fu rico-struita e notevolmente ampliata così come si conservatutt’ora. Vi sono conservati anche altri interessanti dipinti.
RIONE BORGO E DINTORNI:Abbazia di S. Croce (Sec. XII)S. Maria del Ponte del Piano (Sec.XIV)S.Teresa d’Avila (1600) in stile neoclassicoSantuario dellaMadonna del Cerro (circa 10 Km. dal ca-poluogo)Chiesa di San LorenzoMartire a Coldellanoce (a 5 kmdalcapoluogo). Conserva lo stupendo Trittico di Matteo daGualdo del XV secolo.

Direttore: Raniero Massoli-NovelliVice direttore: Perseo TrojaniRedazione: Timoteo Benedetti
Alberto AlbertiniValentina ArtegianiMassimo BardelliUmberto Comodi BallantiAntonio Maria LuziGiovanni PesciarelliVittorio Toni
Associazione “Sassoferratesi nel mondo”Palazzo BaldiniCorso Don Minzoni, 4060041 Sassoferrato (An)
Segreteria : Tel. 0732 959345Fax 0732 [email protected]
Sopra: Francesco Garofoli - Paesaggio sotto la neve - 1986 - AcquaforteFoto di copertina: Raniero Massoli-Novelli
Grafica e stampa: Tipografia Garofoli [email protected]
N°2 - Luglio 2008

SassoferratoPubblicazione a cura dell’Associazione
“Sassoferratesi nel mondo”N°2 - Luglio 2008 mia