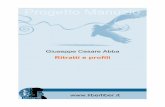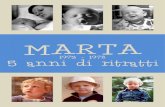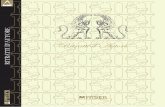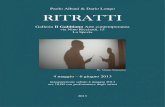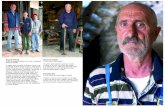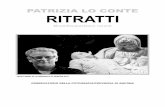Ritratti d'autori
-
Upload
francesca-marcotulli -
Category
Documents
-
view
12 -
download
0
description
Transcript of Ritratti d'autori
-
Ritratti dautori Le riviste
Inizi del 900: con lo sviluppo della borghesia fu comune a molti intellettuali fu lesigenza di intervenire nella vita pubblica e di esercitare un ruolo attivo nella societ, sullesempio dei poeti vate, e un ruolo importante nel soddisfare questa pulsione lo svolsero sopratutto le riviste periodiche. Le prime nacquero a Firenze nel 1903 con un comune programma antipositivista e antidemocratico. Il Regno 1903 - 1906, espressione del movimento razionalista, LHermes e il Leonardo (pi filosofico), sono riviste che perseguiranno fini simili in modo complementare, polemizzando con socialismo e democrazia, sostenendo la guerra come lezione di energia e di purificazione delle masse.
La Voce (1908): ambito fiorentino, per dare spazio opinionistico agli intellettuali. Quattro periodi con caratteristiche diverse a seconda dei direttori. 08 - 11: Prezzolini e Papini, il primo la diriger cercando di non separare cultura e politica. Si sciolsero con luscita di Salvemini, contrario alla causa della Libia; 12 - 13: Papini, separazione tra politica e letteratura, mezzo di diffusione importante per larte doltralpe (Mallarm); 1914: di nuovo Prezzolini, militanza politica irrazionalista e interventista; 14 - 16 (Voce bianca): Giuseppe De Robertis, alla rivista uno scopo letterario, stile frammentario tipico dellermetismo. Merito di portare una voce intellettuale nella societ di massa con una concezione etica della letteratura, dal 1914 diventa il campo del frammentassimo lirico, con Pietro Jahier, Rebora, Sbarbaro e Campana, in una tendenza antipositivistica etica e autobiografica.
Lacerba (1913 - 1915): Firenze, Papini e Soffici. Prevalentemente artistico letteraria, avanguardia futurista di Marinetti, poeti come Folgore, Palazzeschi e artisti come Boccioni. Arte aristocratica individualista, pulsione irrazionale ed estranea ai problemi concreti (freghiamoci della politica). Lorientamento cambia durante la guerra, spingendo la rivista a un violento impegno interventista vedendo la guerra come igiene del mondo ideale per un repulisti delle masse.
La Ronda (1919 - 1923): sullesempio de La Voce, a Roma. Personaggi come Cardarelli, Cecchi e Savinio, difenderanno lautonomia dello scrittore dalla politica. Nel mirino le avanguarde, particolarmente la follia contemporanea del futurismo. Ritorno allumanesimo e studio dei grandi modelli classici.
Valori Plastici (1918 - 1922): scia della Ronda, posizioni analoghe in campo artistico. Recupero critico delle grande lezioni del passato (Masaccio, Giotto), invito accolto da De Chirico, Carr, Picasso. Savinio e Broglio direttori. I dibattiti intellettuali controllati sotto il fascismo, si lasciano libere riviste come La Ronda e Valori Plastici perch filo reazionarie in linea col fascismo, ma parte il dibattito tra le riviste intorno ai temi posti dal fascismo stesso. Contrappose la tendenza di Strapaese (punta sulle radici rurali dellItalia, rivista Il Selvaggi, pittore Mino Maccari) a quella di Stracitt (insistenza sul modernismo cittadino e industriale, rivista 900, Bomtempolli, cerca unapertura europea e un recupero critico del futurismo). Nel 32 nasce lEmermetismo con la pubblicazione dellIsola di Alfonso Gatto e lOboe sommerso di Quasimodo: tendenza alla poesia pura, lirica ed estranea allideologia, verr espressa nel saggio di Carlo Bo del 38 Letteratura come vita, su Frontespizio (Firenze, rivista cattolica sciolta subito dopo i contrasti sul sostegno al partito fascista).
Solaria (1926 - 1934): Firenze, letterati puri come Montale, Gadda, Quasimodo, anche Vittorini, e critici come Salmi, De Benedetti e Contini. Alimentato il mito della cittadella delle lettere, chiusa in se stessa, che protegge i valori della civilt e della cultura della volgarit della societ di massa che li accerchia. Offerto uno scorcio sulle culture europee (traduzione di Joyce, Proust, pubblicizzato Svevo). La lezione di Solaria raccolta da Letteratura (37 - 68), dividendosi in due periodi e divenendo dopo il 50 una rivista di arte contemporanea.
Poltecnico (1945 - 1947): Elio Vittorini. Necessit di un impegno a causa della guerra e la lotta di liberazione, la posizione del letterato - letterato diventa indifendibile, trovandosi prima davanti ad una lotta di resistenza e poi ad una ricostruzione nazionale anche culturale. Vittorini accoglie lappello allimpegno di Jean Paul Sartre di unificare gli intellettuali a prescindere dalle loro ideologie, per la creazione di una nuova cultura in grado di aiutare ad eliminare lo sfruttamento e
-
la schiavit. Le sue scelte lo porteranno allo scontro on il PCI che voleva una rivista di partito: rifiut di suonare il piffero per la rivoluzione, rispondendo in un dibattito con Togliatti nel 46. Tra il 56 e il 60: organizzazione in senso industriale dellapparato culturale, con boom economico, consumismo e marketing editoriale e la diffusione della televisione che appiattiranno lofferta culturale che diventa un prodotto, ununica cultura di massa. Non pi lintellettuale vate, col suo insieme di valori e modello di societ. Si afferma lintellettuale specialista, escluso da cultura di massa o linterprete, non un mediatore sociale ma portavoce della propria esperienza culturale. Gli ultimi grandi intellettuali saranno Fortini, Pasolini e Sanguineti poi.
Officina (1956): Pasolini, nel 60 sar un gruppo culturale da cui potesse nascere lidea di una ricca cultura come forza motrice del rinnovamento della societ. Alla rivista Leonetti, Roversi, Bertolucci, Gadda, Caproni, Luzi, Volponi, Penna, Pagliarini, Ungaretti, Calvino e Rebora.
Il Verri (1956): Milano, Luciano Anceschi, promuove la tendenza della neoavanguardia per finire con la fondazione del Gruppo 63, partecipanti Eco e Sanguineti. Importanza al razionalismo critico al rapporto tra uomo e tecnica e allevoluzione della scienza aprendosi allEuropa.
Il Menab (1959): Torino, Vittorini e Calvino, conclusasi nel 66 (morte Vittorini). Continuo dello sperimentalismo dellOfficina, dialogo con la neoavanguardia ma senza prenderne le posizioni. Promossa una riflessione sul rapporto letteratura industria, ispirando Volponi e Pagliarini.
Gruppo 63 (1963 - 1969): Palermo, radicale, respinta in blocco la tradizione italiana per ispirarsi solo alle avanguardie europee del primo Novecento (espressionismo, futurismo, surrealismo). Smuovere il ristagno letterario neorealista. Anceschi, Nanni Balestrini, Eco, Pagliarini, Sanguineti e molti altri.
Carlo Emilio Gadda Milano, 1893 - Roma, 1973 Vita: famiglia borghese, morte del padre nel 1909 e madre che costringe i
suoi tre figli a durissimi sacrifici per poter mantenere lo stile di vita borghese. Smania materna per una buona apparenza sociale influir molto sulla vita dellautore. Studia ingegneria, nel 1915 partecipa alla Grande Guerra per la leva militare e verr fatto prigioniero a Caporetto fino alla fine della guerra. Questo evento alimenter la depressione del ragazzo, insieme allapprendimento della notizia della morte del fratello aviatore Enrico, che lui definir la parte migliore di me stesso. Nel 1920 si laurea (ingegneria), poi lavorer dal 22 al 24 in Argentina. 1926: frequenta il gruppo della rivista Solaria dando inizio allo sfogo della sua passione letteraria in un periodo di grande fertilit creativa, tra il 40 e il 50 alla Rai come responsabile culturale. Poi misantropico isolamento alla fine della sua vita.
Pensiero: Formazione culturale lombarda illuministica e positivista; Amore per ordine e razionalit a contrasto con uninstabile vita
familiare e sociale; Delusione bellica frustrer il suo bisogno di ordine; Inetta e appariscente borghesia italiana responsabile di un
tradimento storico, contro di essa risentiti attacchi sarcastici e critici; Il mondo un groviglio di cose e fenomeni ed irrazionale e caotico,
e c unimpossibilit di far convergere il tutto verso ununica soluzione;
Lautore arriver a ricerche stilistiche (plurilinguismo, pastiche - opere composte in larga parte con brani tratti da opere gi esistenti con intento prevalentemente imitativo) e tematiche (non-finito) per cercare di ordinare con la letteratura il caos del mondo presente.
-
Opere: Disorganicit e incompiutezza, opere e meditazioni abbozzate; Scritti teorico filosofici e critici > Meditazione Milanese (problema
della conoscenza) e I Viaggi La Morte (poetica e problemi linguistici); Narrativa - diario personale di guerra (Giornale di Guerra e di
Prigionia, 1955 poi rimaneggiato nel 1965); Saggio invettiva anti fascista (Eros e Priapo: da furore a cenere, 1967
- erotismo e massa); Fiabe (Primo Libro delle Favole, 1952); Raccolte di excursus, testi senza trama (Madonna dei Filosofi,
Castello di Udine, Adalgisa, Accoppiamenti Giudiziosi); Tentativi romanzeschi (La Meccanica, incompiuto; Un fulmine sul 220,
incompiuto, tenera storia damore sullo sfondo di Milano; La Cognizione del Dolore, 1963, narrativamente non finito, autobiografia sul contrasto tra lautore e la madre, in una immaginaria Milano proiettata in Sudamerica);
Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 1957: romanzo giallo che ribalta e sconnette il naturale ordine di questo genere, punto di vista di un investigatore filosofo, Francesco Ingravallo, incapace di risolvere il delitto di Liliana Balducci in via Merulana. Non si ha il trionfo della razionalit tipico del giallo, il pasticciaccio si basa su un finale dallimpossibilit di risoluzione. Emblematico il principio dellinvestigatore di non riuscire a trovare ununica causa agli eventi del mondo, verso cui ha cospirato una molteplicit di causali convergenti.
Elio Vittorini Vita: Siracusa, 1908 - Milano, 1966. Nel 1924 abbandona definitivamente la
Sicilia e nel 1930 si trasferisce a Firenze, nellambiente delle riviste Solaria e del fascismo di sinistra. Nel 1936 scoppia la guerra civile spagnola, e lautore inciter i fascisti italiani ad unirsi ai repubblicani nella lotta contro Franco con un articolo sulla rivista Bargello: finir deluso dal carattere illusorio del fascismo di sinistra che appogger il dittatore. Nel 1938 si trasferisce a Milano, dopo il periodo degli astratti furori; in prigione per la collaborazione con il PCI, nel 1947 si unisce alla resistenza italiana. Dopo la liberazione del 45 fonda Il Politecnico, che finir nel 1947 dopo aver dato risalto pi alla parte culturale che a quella politica, seguita dallabbandono del PCI. Fonder Il Menab(1959) con Calvino. Collaborer con leditore Einaudi.
Pensiero: Fiducia indiscussa nella letteratura ai suoi esordi, unita allimpegno
politico e ideologico (oscillazione continua fra letteratura e interessi politici), fra mito e storia e tra simbologia e ideologia;
La fase di vuoto dettata dal tradimento fascista causer la concezione degli astratti furori (una sofferenza per un mondo offeso, dove gli uomini che soffrono sono pi uomini e gli altri meno uomini - presente in Conversazione in Sicilia del 1941);
Agli ermetisti lo avvicina la tendenza a tradurre il dato reale in simbolo, linteresse invece per il mondo popolare e lo schieramento a favore degli offesi lo rende un precursore del Neorealismo.
Opere:
-
Piccola Borghesia, 1931: racconti, tipica ideologia del fascismo di sinistra (contraddice gli ideali di egualitarismo e democrazia per avvicinarsi a idee pi simili al fascismo, corrente anticapitalista che sosteneva il socialismo economico, critica alla boghesia) unita alle nuove esigenze letterarie (Svevo, Joyce, Proust);
Il garofano rosso, Erica e i suoi fratelli (1936, incompiuto, bambina che deve assumersi la responsabilit di crescere i fratelli fino a doversi prostituire);
Conversazione in Sicilia (1941): struttura circolare, viaggio mitico simbolico di un uomo (Silvestro Ferrauto) che ritorna nella sua terra nata ma il racconto non autobiografico. Continue ripetizioni di stilemi e situazioni, prosa ritmica e scandita nelle sue cinque parti che contribuiscono a rendere il racconto astratto e rituale. Le interpretazioni possibili sono diverse: il sogno e lallucinazione, testimoniate dallassenza di un vero filo rosso che colleghi tutti gli incontri del protagonista, estenuanti ripetizioni come quella del soffrire per il mondo offeso della quarta parte; la critica al fascismo, in chiave allegorica e simbolica, esempio dellarrotino che cerca i coltelli ma non ne trova come il rivoluzionario che cerca di agitare il popolo.
Opere fra mito e storia: Il Sempione (1947), La Garibaldina (1950), Le Citt del Mondo (1965), Le Donne di Messina (1949) e Uomini e no (1945, in cui Vittorini trasferisce la sua esperienza partigiana nel personaggio Enne 2, che ritrover il suo amore perduto Berta.
Insieme a Pavese un maestro del nuovo realismo degli anni Trenta: realismo senza matrice verista o realistica, ma lirica e simbolica. Il mito dellAmerica ben presente, assimila il realismo americano (scarno, sobrio e sintetico, frasi brevi e incisive) anche nel sogno ideologico di unumanit totale.
Cesare Pavese Vita: Lande (Cuneo), 1908 - Torino, 1950. Collabora con Einaudi gi nel 34.
Nel 35 mandato al confino per la partecipazione a Giustizia e Libert. Fatiche editoriali poetiche nel 36 (Lavorare Stanca), rattristato per la scoperta che la donna amata si era sposata. Nel Monteferrato dopo loccupazione tedesca nel 43. Dopo la liberazione anni di lavoro intenso fra LUnit, il PCI e i racconti (La luna e i fal, premio Strega). In bilico tra vita collettiva inafferrabile e impotenza per quello che era fuori dal suo io si suicider nel 1950.
Pensiero: Mitizzazione della campagna (che lintellettuale cittadino vuole usare
per recuperare il senso vero dellesistenza finendo a scoprire la propria solitudine);
Ricerca che oscilla fra lestraneit e limpotenza dellintellettuale oppure nella rivelazione del destino umano nei miti del passato;
La guerra in Italia si mostrer con tutto il suo peso tangibile di orrore
-
e morte; Insensatezza della realt: qualunque forma di impegno diventa
impossibile davanti ad essa; Estraneit alla guerra, diventa estraneit alla storia; Autonalisi intellettuale sulla guerra di La casa in collina si rivolge
nel dopoguerra ad una dolorosa e vana ricerca dellidentit (La luna e i fal), che non riuscir a risolvere e che lo spingeranno al suicidio;
Poesia: la poesia narrativa di Lavorare Stanca (1936) nellambito di Solaria guarda agli scrittori americani come Walt Whitman (tesi), simboli di un paese democratico. La novit stilistica, con il verso lungo, senza rime, funzionale a narrare esperienze; tematicamente ricalca la narrativa, il conflitto citt campagna, infanzia maturit, solitudine, lavoro e ozio, incomunicabilit;
Miticizzazione della poesia racconto, la realt si fonde al mito, riaffiorando gli universali fantastici dellinconscio che risalgono allinfanzia, luoghi mitici che il ricordo estrae dal tempo.
La Casa in Collina: tema della solitudine, storia di un professore che vive con spirito indifferente e apatico il periodo dei bombardamenti durante la guerra. Pavese si identifica nel protagonista senza pace che cerca unidentit ed un posto dove poter tornare indietro, isolandosi dalla guerra nella semplicit della campagna. Tema della fuga e del rimorso del protagonista.
La Luna e i Fal (1950): storia del protagonista Anguilla che ritorna dov cresciuto dopo essere emigrato in America. La luna scandisce il ritmo. Fal che ricordano le feste contadine collegati ad incendi che bruciano il passato, al fal per bruciare una ragazza alla fine del libro.
Alberto MoraviaVita: Roma, 1907 - 1990. Pseudonimo di Alberto Pincherle (ebreo). Abbiente famiglia borghese, ammalato di tubercolosi visse lesclusione che determiner il suo interesse per la professione letteraria (lesse Dante, Dostoevskij, Shakespeare, Mallarm, Goldoni, Joyce, Manzoni, Proust). Gli Indifferenti (1929), primo romanzo pubblicato ebbe un notevole successo. Negli anni Trenta terr alcune lezioni sul romanzo italiano in America, in Italia nascose le sue origini semite. Nel 1941 sposa la scrittrice Elsa Morante, nel 43 cerca rifugio dal dominio nazista. Collaborer col Corriere della Sera e fonder una rivista con Pasolini e Siciliano (Nuovi argomenti). Fu eletto deputato europeo con il PCI. Conviver negli ultimi anni della sua vita con Dacia Maraini.Pensiero:
Iniziatore del romanzo borghese (erede di Svevo);
Crisi esistenziale e sociale borghese ricondotta alle forme del realismo e della lucidit razionale;
Esistenzialismo e realismo psicologico;
-
Tratti costanti: influenza possessiva di sesso e denaro nella borghesia;
Estraniamento di fronte alla vita, struttura a inganni del romanzo;
Grave pessimismo dopo il miracolo economico degli anni 60, il popolo non pi unalternativa vista la diffusione del consumismo;
Opere: Realismo Borghese
(29-45, elementi realistici, esistenzialistici e surreali, Agostino e Gli Indifferenti);
Neorealismo (47-57, personaggi popolari che rappresentano unalternativa positiva rispetto al mondo borghese, La Ciociara 1957 - film di DeSica);
Pessimismo (60-90, cade la fiducia nel popolo, insensatezza della vita un tema costante, La Noia 1960).
Gli Indifferenti (1929): storia di due fratelli (Carla e Michele) incapaci di provare veri sentimenti, noia e indifferenza di fronte al declino sociale della loro famiglia, madre rimasta vedova, Rende le ipocrisie della societ borghese, inautentica e convenzionale. Esempio di prosa precisa, realistica in aperto contrasto con quella dominante nel periodo precedente. Struttura quasi teatrale e concepito inizialmente come una tragedia, riusc
-
a denunciare la vacuit morale della propria classe, i personaggi sono inetti quasi pirandelliani, incapaci di provare sincere passioni. Rifiuto di ogni problematica morale dei personaggi, emblematico lepisodio di Michele che vuole sparare allamante della moglie che vuole insidiare la sorella ma che si dimentica di caricare la pistola.
Primo LeviVita: Torino, 1919 - 1987. Famiglia ebrea, si laurea in chimica, che gli salver la vita al momento della deportazione ad Auschwitz (febbraio 44 - liberazione). Il viaggio per il ritorno (descritto nel romanzo La Tregua) a casa lo distrarr per poco dagli orrori indimenticabili che segneranno la sua vita. Si dedicher a far conoscere la sua esperienza, con opere come Se Questo Un Uomo (1947) e La Tregua (1963). Morir, forse suicida, cadendo dalla tromba delle scale della sua casa a Torino. Pensiero:
Se questo un uomo (1947): Stile descrittivo, semplice e razionale dellorrore nazista; opera sorretta da una forte volont di capire e di spiegare con la ragione lassurdit delle barbarie naziste, la dignit dellebreo deportato sta nella strenua volont di salvare lessenza dellumano anche nellinferno del lager; le vittime s o n o v i t t i m e d u e v o l t e , represse e si trasformano esse stesse in aguzzini dei loro compagni . La nar raz ione comincia dal viaggio verso Auschwitz, fino alla liberazione da parte dellArmata Rossa. Le r i fl e s s i o n i d e l l a u t o r e p e r m e t t o n o a l l e t t o r e d i i m m e d e s i m a r s i q u a s i completamente nel narratore.
Sempre una forte componente autobiografica;
Differenze significative tra le varie opere: SQEU unopera
-
che sembra quasi scr i t ta frettolosamente, con lansia di narrare il proprio dramma.
Opera: Saggi, racconti, poesie e romanzi che seguiranno il successo del testo autobiografico. Il sistema periodico (1975), La chiave a stella (1978), Se non ora, quando? (1982).
Elsa MoranteVita: Roma, 1912-1985. Manterr la propria autonomia collaborando a giornale dopo gli studi liceali. Nel 41 conosce Alberto Moravia, che diventer suo marito. A questo periodo risale il suo esordio letterario ma nel 1948 e nel 1952, dando alle stampe i romanzi pi convincenti. Menzogna e Sortilegio (premio Viareggio) e Lisola di Arturo (1957, premio Strega), confermandola una grande scrittrice. Un periodo di crisi e impegno civile seguir la separazione da Moravia nel 62. Nel 70: periodo di disillusione e ossessione per la vecchiaia, e nell83 tenter il suicidio (cause di salute che le impedivano di camminare forse hanno inciso). Pensiero:
N a r r a t i v a c h e n u t r e d i unammirazione sconfinata per la letteratura, sentita come una capacit di rivelazione e bellezza;
Costante il contrasto tra positivismo e completezza della narrazione ottocentesca e sensibilit psicologica novecentesca;
Aura di magia che circonda le sue opere;
Singolare interpretazione della storia: storia dei potenti e storia degli umili, grande storia tutto un inganno a spese della piccola storia.
Opere: Raccolta di racconti Il gioco segreto
(1941) e la fiaba Le bellissime avventure di Cater dalla trecciolina (1942);
Piena maturit in Menzogna e Sortilegio (1945) e Lisola di Arturo (1957);
Torner alle stampe poi nel 68 con Il mondo salvato dai ragazzini, in cui si vedono gi le influenze dellimpegno politico, fino alla disillusa testimonianza de La Storia (1974, la storia scandalo che dura da diecimila anni).
Lultimo romanzo Ara coeli (1982), lossessiva ricerca didentit di un
-
omosessuale; Lisola di Arturo (1957): ambientato
nel 1938, la storia del giovane Arturo Gerace che ormai adulto, nato e
cresciuto nella piccola isola di Procida nel golfo di Napoli, narra in
prima persona la sua infanzia e adolescenza. Tutti gli altri posti del
mondo sono forse frutto della sua immaginazione e della leggenda; infatti proietta in una dimensione
mitica e fiabesca il posto in cui vive. Finir per andare via dallisola con lamico Silvestro, lasciandosi tutto
alle spalle. Si pu inserire nella categoria del romanzo di formazione
(con un personaggio in crescita che diventa adulto(.
Paolo VolponiVita: Urbino, 1924 - Ancona, 1994. Tra Urbino e Milano, figura anomala di letterato, lunga e
continuata esperienza di lavoro allinterno del mondo industriale (prima Olivetti, collaboratore di Adriano Olivetti, e poi alla Fiat, da cui sar allontanato nell83 per la sua
adesione al PCI. Eletto senatore dal 1983, aderir a Rifondazione Comunista dopo la scissione democratica.
Pensiero: Mai atteggiamento di rifiuto pregiudiziale
della realt industriale e capitalista, sempre battutosi per una loro armonizzazione sociale, per tenere conto dellinteresse
comune; Progressivamente maturato un atteggiamento
radicale di critica; Constatazione dei guasti prodotti a danno del
mondo naturale e civile da parte dellindustria;
Nellopera conclusiva descrive il post moderno osservando che il mondo fatto di
merci, artificiale e plastificato; La vita: astratta, informatica, che produce un
processo di trasformazione della realt che lo circonda in qualcosa di inorganico.
Opere: Non solo narratore ma anche poeta: unisce
limpegno politico ad una densa vena lirica. Esordisce come poeta negli anni 50; Anni 60, romanzo: Memoriale (1962,
contadino reduce di guerra che fronteggia la
-
realt della fabbrica), La macchina mondiale (1965, un utopista si scontra con la
burocrazia, un proprietario terriero costretto a comparire in tribunale perch
accusato di violenza domestica sulla moglie; ricorda per certi versi 1984 di Orwell);
Corporale (1974, un intellettuale impaurito si costruisce un rifugio antiatomico e si salva
dalla materialit biologica nella sua alienazione); Il Sipario Ducale (1976,
intreccio della vita di un professore anarchico impegnato in politica); Le mosche
del capitale (1989, sulle vicende dellintellettuale Saraccini che vorrebbe
riformare lindustria per cui lavora, ma la sua genialit viene schiacciata dalle logiche di
potere e guadagno della sua azienda(; Il pianeta irritabile (1978): romanzo a met
strada tra il fantascientifico e lallegoria, profonda riflessione sociologica e filosofica.
Un mondo post apocalittico in cui ci sono quattro personaggi (un babbuino, un oca, un
elefante e un nano) che lavoravano tutti in un circo. Un viaggio verso una fantomatica terra
promessa iniziato dal babbuino che trasciner tutti gli altri, una specie di
cammino quasi dantesco verso la salvezza. Il foglio di carta di riso su cui scritta una
poesia regalata dalla suora di cui era innamorato al nano Memerte custodita gelosamente fino alla fine, per poi essere
condivisa con gli altri compagni di viaggio, facendo comparire una sorta di
comunitarismo che per Volponi parte da una condivisione e dalla rottura degli schemi del
passato, ossia la societ borghese del dopo guerra. Bisogna rompere con i vecchi
schemi, smettendola di proporre sistemi elitari e basati sullo sfruttamento del
prossimo. Italo Calvino
Vita: Cuba, 1923 - Siena, 1985. Forse il narratore italiano pi rappresentativo del secondo Novecento. Ne ha frequentato le principali tendenze letterarie (dal Neorealismo al Post
moderno), sempre restando a distanza da esse e svolgendo il proprio percorso di ricerca. Genitori dediti alle scienze, cresce a Sanremo dal 1925, educato in un ambiente antifascista laico e colto. Parteciper alla resistenza da universitario e militer nel PCI. Collaborer con
la casa editrice Einaudi. Nel 55 prende le distanze dal Neorealismo, e nel 59 con Elio Vittorini esponente del nuovo realismo fonda la rivista il Menab (che durer fino al 67). Il
1964 sar un anno di svolta: matrimonio, trasferimento a Parigi, anno che segna la cesura dei ventenni ideologici di Calvino che formano il percorso culturale dellautore. Da
-
impegno etico ad uno scientifico della lingua. Pensiero:
Elementi costanti: gusto cosmopolita, interesse per le scienze, tendenza alla
chiarezza e allesattezza, ma sopratutto caratteristico perch
tutto combinato con la fantasia; Scrittura chiara, esatta e precisa; Inizio letterario neorealista:
raccontare episodi di impegno storico;
Dal saggio Il midollo del leone (1945) in cui ancora crede nelluso
della letteratura come educazione, respinge la subordinazione e le
poetiche di partito abbandona il Neorealismo; La sfida al labirinto (1962), teorie del nuovo romanzo francese e della Neoavanguardia;
In Francia, con gli studi di semiologia, accoglie lidea che
luniverso linguistico abbia soppiantato la realt, dove il romanzo
chiuso in s, in un mondo a s stante;
Si avviciner successivamente al Post Moderno, con linvadenza del
linguaggio, la complessit dellesistenza, la riscrittura, la
tendenza al gioco e la leggerezza; In fondo data la sua formazione di
base illuminista sar sempre portato a credere nelluomo.
Opere: Due periodi:
1945 - 1964Neorealismo, Il sentiero dei nidi di ragno (47) e i racconti di Ultimo viene il corvo
(1949(; Fantastico allegorico, trilogia del Visconte Dimezzato, Il barone rampante, Il
cavaliere inesistente (1952 - 1959) e Marcovaldo ovvero le stagioni in citt (1963(;Sociale, La speculazione edilizia (1957), La nuvola di smog (1958) e La giornata di
uno scrutatore (1963, opera chiave nella svolta culturale calviniana(; 1964 - 1985
Scientifico, Le cosmicomiche (1965) e Ti con zero (1967(; Combinatorio, Il castello dei destini incrociati (1969) e La taverna dei destini
incrociati (1973(; Post moderno, Le citt invisibili (1972), Se una notte dinverno un viaggiatore
(1979) e Palomar (1983(.
Pier Paolo Pasolini
-
Vita: Bologna, 1922 - Fiumicino, 1975. Laurea in lettere, tesi su Pascoli. Durezza del padre e mitezza della madre: forse alla base del complesso edipico a cui ricollegabile lomosessualit dellautore (Supplica a mia madre). A Roma nel 49, ottiene successo con Ragazzi di Vita (1955) e Una Vita Violenta (1959). Tra il 55 e il 59 si dedica alla rivista bolognese lOfficina che ospiter le sue raccolte poetiche migliori. Dal 1960 il cinema: Mamma Roma (1962), Il Vangelo secondo Matteo (1964), Sal o le 120 giornate di Sodoma (1975) alcuni fra i titoli pi conosciuti. Il romanzo Petrolio che rimarr incompiuto (una specie di romanzo inchiesta sul mondo del settore petrolchimico) potrebbe essere una delle cause che spinsero allomicidio dellautore (ipotesi) nonostante sia stato arrestato lomicida. Pensiero e Opere:
Esordisce come poeta nel 1942 con Poesie a Casarsa, poi raccolte ne La meglio giovent (1954): primo periodo dialettale della poesia pasoliniana, i temi sono quelli simbolistici, il dialetto friulano serve a rappresentare la ricchezza e la resistenza del dialetto contro lomologazione linguistica neocapitalista;
Fortuna letteraria a Roma con i romanzi Ragazzi di Vita (1955,) e Una vita violenta (1959), riprende il neorealismo puntando a valorizzare la dimensione del sottoproletariato (anzich difenderlo) nella sua capacit di contrapporsi alla borghesia; siamo nel periodo poetico pienamente civile di Pasolini, con le raccolte Le ceneri di Gramsci (1957) e La religione del mio tempo (1961). In questo periodo abbiamo un finale sperimentale plurilinguistico, con poemetti narrativi in terzine che esprimono lideologia etica gramsciniana adottata da Pasolini;
La diffusione della cultura di massa mette in crisi lesistenza della variet di forme culturali, tendendo ad unificarle alla cultura dominante;
La civilt di massa riunendo in s tutte le culture diventa una cultura indipendente da quella dominante, ed necessariamente volgarizzata in modo da raggiungere un pubblico pi vasto possibile;
1961: battesimo cinematografico, con Accattone. Seguir lultimo periodo poetico con Poesia in forma di rosa
-
(1964, comprensivo di Supplica a mia madre) e Trasumanar e Organizzar (1971);
Il periodo confessionale dal 64 al 71: importanza popolare data al cinema che lascia spazio ad una poesia di stampo intimistico, con la propria alienazione di uomo nella massa, insieme ad un linguaggio giornalistico;
Negli ultimi anni lavora al romanzo documentaristico Petrolio (postumo, 1992) che confesser essere un lavoro che sar forse per il resto della mia vita;
La mutazione antropologica avvenuta con lo sviluppo di infrastrutture e comunicazioni ha creato un linguaggio tecnico industriale nazionale non multi culturale e non espressivo, soffocando la ricchezza culturale e le ragioni della letteratura;
Prover una resistenza da corsaro, combattendo i messaggi dei mass media borghesi utilizzandoli allo stesso modo, si distaccher dalle battaglie politiche;
Intuisce la violenza di questo sistema sociale;
Ragazzi di Vita (1955): adolescenti del sottoproletariato che vivono alla giornata, la storia nellimmediato dopoguerra. Sfrutta questo piccolo gruppo di protagonisti romani per narrare la miseria e il degrado sociale dellItalia intera in seguito al conflitto. Il cambiamento di Riccetto in manovale stipendiato segna il suo ingresso nel mondo individualista borghese ampiamente criticato da Pasolini;
Una vita violenta (1959): altro romanzo sul tema della vita del sottoproletariato romano. C lingresso della miseria morale accanto a quella materiale, attraverso il racconto dellevoluzione morale e politica di Tommasino Puzzilli, che si trova a fare i conti con
-
le dure leggi della vita che infrangeranno i suoi sogni di una vita tranquilla e borghese, il tutto narrato con freddezza e in modo distaccato.
Umberto SabaVita: Triesta, 1883 - Gorizia, 1957. Infanzia segnata dalla madre assente , cresciuto dalla balia per tre anni e definita madre di gioia, finch la sua vera madre, madre mesta, li separa. Lassenza del padre che abbandona la famiglia influisce sulla formazione ormai compromessa dellautore, sviluppando la sua separazione tra impulso vitale e i divieti della madre. Lesperienza militare a Salerno nel 1907 lo distrarr dalla famiglia, portandolo a comporre i Versi militari. Sposatosi con Lina nel 1908 (donna madre), nel 29 sar preso in cura dallo psicanalista Edoardo Weiss per una nevrosi. Prima e durante la seconda guerra mondiale, poich ebreo e perseguitato dalle leggi razziali, si rifuger da Ungaretti a Roma prima e a Firenze poi, dove lamicizia di Montale gli sar di grande conforto. Con la riedizione del Canzoniere del 1945 avr riconoscimenti per la sua poesia (premio Viareggio). Ader al PCI ma sar immediatamente deluso dalla vittoria DemoCristiana del 48. Nel 61 uscir postuma ledizione finale del Canzoniere.
Il Canzoniere, produzione poetica maggiore di Saba dal 1900 al 1954: Tre volumi gi nelledizione del 1945:
Canzoniere 21, 156 testi e otto sezioni (adolescenza, versi militari, casa e campagna, Trieste e una donna, La serena disperazione, durante la guerra, cose leggere e vaganti, lamorosa spina);
Volume secondo 1921 - 1932, 109 testi, otto sezioni (preludio e canzonette, autobiografia, prigioni, fanciulle, cuor morituro, luomo, preludio e fughe, il piccolo Berto);
Volume terzo 1933 - 1954, 172 testi, nove sezioni (parole, ultime cose, 1944, varie, epigrafe mediterranea, uccelli, quasi un racconto, sei poesie della vecchiaia); Questa struttura ne fa unopera unitaria dando massimo risalto allaspetto narrativo dei testi.
Tema centrale nella fitta trama psicologica la scissione dellio (Tre poesie alla mia balia), radici nellinfanzia;
Infanzia; Sesso e erotismo, nascosto nella dialettica tra
madre mesta e madre di gioia e riflesso nella figura di donna madre e donna fanciulla: i poeti per Saba erano sacerdoti delleros, cantori della brama sessuale;
Nello stile poetico il principio base il rifiuto della poesia artificiosa (DAnnunzio) a favore della chiarezza e dellonest (Manzoni). Lonest necessaria alla funzione sociale dei poeti, e consiste nel rapporto tra poesia e le elementari leggi della
-
vita. Lonest si deve rivelare nei confronti del proprio mondo interiore e psicologico;
Loriginalit dello stile del Canzoniere confermata nelle scelte metriche: mantenuta la metrica tradizionale e il linguaggio della tradizione. Uniformit per solo apparente poich la struttura corrosa internamente dagli enjambement, frantumando la metrica anche grazie alla strutturazione sintattica e ritmica. Caratteristico luso della rima, che non rifiuta di essere facile, ma mai banale per la profondit elementare di cui rivestita. Citando Pasolini non c parola in Saba che non risulti strappata al suo abituale significato.
Eugenio Montale



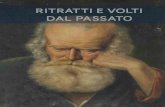
![[Manuale - ITA] - Corso Canon Di Fotografia (Persone E Ritratti)](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5571fe2049795991699aaee9/manuale-ita-corso-canon-di-fotografia-persone-e-ritratti.jpg)