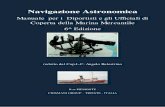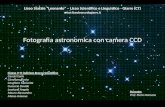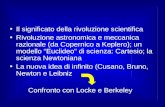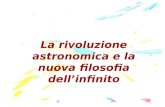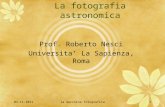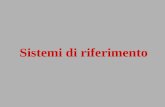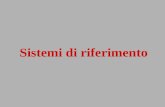Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica
-
Upload
federicaperra -
Category
Documents
-
view
652 -
download
0
description
Transcript of Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica
5/12/2018 Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/riassunto-rivoluzione-scientifica-e-astronomica 1/6
RIASSUNTI FILOSOFIA: LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA
1. UN EVENTO DI IMPORTANZA CAPITALE
In questi ultimi decenni nella storiografia italiana ed estera si è data sempre più importanza alla nascita della
scienza, dove la sua centralità consiste nella “rivoluzione scientifica”, che si colloca tra la data della
pubblicazione del capolavoro di Copernico Le rivoluzione dei corpi celesti e quella dell’opera di Newton I principi matematici di filosofia naturale.
LO SCHEMA CONCETTUALE DELLA SCIENZA MODERNA
Lo schema concettuale della rivoluzione scientifica, che troviamo concretizzato in Galileo, si può ricavare sia
in rapporto al nuovo modo di intendere la natura, sia in rapporto al nuovo modo di intendere il suo studio.
Dalla rivoluzione scientifica e dal metodo di Galileo, emergono:
- La concezione della natura come ordine oggettivo e casualmente strutturato da relazioni governate da
leggi;
- La concezione della scienza come sapere sperimentale - matematico e valido, avente come scopo la
conoscenza del mondo circostante e il dominio di essa da parte dal mondo.
Il nuovo modo di vedere la natura
La natura è oggettiva, in quanto essa costituisce un oggetto i cui caratteri non hanno niente a che fare con i
fini, i bisogni e i desideri dell’uomo. Mentre il mondo della magia appare come un organismo in cui ogni cosa
possieda un’anima, e risulta in rapporto di “simpatia” o “antipatia” con gli altri esseri, l’universo della scienza
appare come un ordine spogliato di ogni attributo, valore o qualità umana.
La natura è un ordine causale, in quanto in essa nulla avviene per caso, ma tutto è risultato di cause ben
precise. Galileo, interpreta la casualità come un rapporto costante tra due o più fatti, dei quali dato o tolto
l’uno è dato o tolto anche l’altro; ad esempio, dati i cento gradi l’acqua bolle, tolti i cento gradi l’acqua
smette di bollire. Tuttavia, delle quattro cause riconosciute da Aristotele, quali formale, materiale, efficiente
e finale, l’unica che viene confermata scientificamente è la causa efficiente, in quanto alla scienza interessa
solo l’insieme delle forze che producono quel fatto.
La natura un insieme di relazioni, in quanto l’attenzione del ricercatore è fisso non su dei principi segreti e
inverificabili posti alla base della realtà, ma su delle relazioni casuali che legano i fatti tra di loro. Infatti,
possiamo dire, che chi studia la natura, non si occupa dell’essenza dell’arcobaleno, ma dell’insieme delle
connessioni che lo legano ad altri fenomeni e che lo rendono comprensibile.
I fatti vengono governati da leggi, in quanto essendo casualmente legati tra di loro obbediranno a delle regole
uniformi, di conseguenza, dal punto di vista scientifico, la natura viene vista solo come un’insieme di leggi che
regolano i fenomeni e li rendono prevedibili.
Il nuovo modo di concepire la scienza La scienza è un sapere sperimentale, in quanto si fonda sull’osservazione dei fatti e le sue ipotesi sono
fondate sulla pratica non sulla razionalità. Tuttavia, l’esperienza di cui parla la scienza è una costruzione
complessa, su base matematica, e di conseguenza, la scienza moderna, giunge all’equazione “esperienza =
esperimento”. La scienza è un sapere matematico che si fonda sul calcolo e sulla misura, infatti la
“quantificazione” si rappresenta come una delle condizioni indispensabili dello studio della natura e come
uno dei punti di forza del metodo di Galileo.
La scienza è un sapere intersoggettivo, in quanto i suoi procedimenti vogliono essere alla portata di tutti, e le
sue scoperte pretendono di essere universalmente valide, quindi controllabili da tutti. Da ciò nasce
l’equazione “scienza = sapere universale”. Il fine della scienza è la conoscenza oggettiva del mondo e delle
sue leggi. Ma quanto riesce a essere libera da qualsiasi tipo di schema e preoccupazioni estranee, quanto più
la scienza va incontro a quel fondamentale interesse umano, ossia il dom ino dell’ambiente circostante;
infatti, conoscere le leggi della natura significa, poterla controllare a comandarla a nostro vantaggio.
5/12/2018 Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/riassunto-rivoluzione-scientifica-e-astronomica 2/6
Scienza e società
La scienza moderna nasce in un periodo storico caratterizzato da mutamenti strutturali dell’economia
europea e dal nuovo tipo di società che si è formato all’inizio dell’età moderna. La formazione di Stati
cittadini e nazionali fa nascere un sistema di vita più complesso e dinamico, che provoca una serie di esigenze
e problemi sociali, che si traducono in maggiori richieste tecniche. L’unione tra scienza e società moderna si
concretizza attraverso nuovi bisogni, che risiedono nelle nuove esigenze tecniche, le quali fingono da stimoloper la creazione di un sapere oggettivo capace di orientare l’uomo nel mondo.
Scienza e tecnica
Le maggiori richieste tecniche comportano una collaborazione tra artigiani e scienziati, in quanto gli artigiani
tradizionali sono impreparati a risolvere i nuovi problemi e, di conseguenza, chiedono aiuto a studiosi che
possiedono più ampie nozioni matematico – fisico, e viceversa. In questo modo tra scienziati e artigiani si
instaura quell’alleanza che costituisce una delle caratteristiche importanti della rivoluzione scientifica e che
porta al superamento del millenario abisso tra scienza pura e applicazioni pratiche. Anzi, la connessione tra
tecnica e scienza diviene così stretta che in molti casi abbiamo non solo tecnici che diventano scienziati o
scienziati che diventano tecnici, ma anche figure di scienziati, tecnici e artisti allo stesso tempo, dove una
prima manifestazione di questa collaborazione risiede nei trattati di cui è ricca la letteratura del ‘400 e del
‘500 e un’altra negli strumenti scientifici. Comunque, questa connessione primitiva tra scienza e tecnica non
implica l’utilizzo di una vera e propria tecnologia, ma ciò non esclude che la rivoluzione scientifica abbia
cominciato a formare quel circolo dialettico che costituisce uno dei tratti più vistosi della civiltà moderna.
Scienza e Rinascimento
Gli occamisti, non solo criticarono fortemente le teorie aristoteliche, ma diffusero una mentalità empiristica
favorevole alle ricerche naturalisti. Questi, fecero affermare, che la nascita della scienza si aggancia più
all’occamismo che al Rinascimento, ma in realtà il quest’ultimo rappresenta il terreno storico da cui è nata la
scienza, in quanto:
- in primo luogo, grazie alla sua laicizzazione del sapere e alla sua rivendicazione della libertà della ricercaintellettuale, il Rinascimento ha tracciato la strada della scienza;
- in secondo luogo, mediante il principio del “ritorno all’antico” e attraverso la traduzione di molte opere
scientifiche e filosofiche dell’antichità, la cultura rinascimentale ha permesso il risveglio di dottrine e figure
che erano state trascurate per secoli;
- in terzo luogo, grazie al suo naturalismo, il rinascimento ha posto quelle basi necessarie per portare avanti
un ampio sviluppo dell’indagine naturale.
Nella cultura rinascimentale, i filoni più importanti sono: l’aristotelismo, la filosofia della natura e la magia.
1. L’aristotelismo rinascimentale ha il merito di aver difeso i diritti della ragione e di aver elaborato il concetto
di ordine natura, reso possibile grazie a una catena di eventi causali, che rappresenta uno delle fondamenta
della scienza.
2. La filosofia naturale ha il merito di aver chiarito che i principi del mondo fisico sono i principi sensibili,
determinando l’equazione tra “ciò che la natura manifesta” e “ciò che i sensi fanno percepire”.
3. La magia ha il merito di aver aiutato a diffondere l’idea dell’uomo some signore delle forze naturali.
- in quarto luogo, il Rinascimento ha offerto alla scienza la convinzione che la natura è scritta in termini
geometrici, per cui l’unico linguaggio per esprimerla è quello matematico.
Scienza e scienziati
Altri studiosi invece ritengono che siano gli scienziati ad aver inventato la scienza, che da un lato è una realtà
ovvia, in quanto senza quelle menti geniali e creative la scienza non sarebbe mai nata, e di conseguenza, è
doveroso assegnare il giusto merito alle persone e al fattore “genio”. Tuttavia, si dovrebbe affermare che, la
scienza non è stata prodotta né dalle menti né dalle circostanze, ma da scienziati che hanno operatoall’interno di determinate circostanze storico – culturali.
Gli uomini della rivoluzioni scientifica, tralasciando gli astronomi e matematici di corte, non sono scienziati di
mestiere, ma individui che pur continuando a svolgere le proprie professioni, fanno delle ricerche; oppure
5/12/2018 Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/riassunto-rivoluzione-scientifica-e-astronomica 3/6
sono persone benestanti che hanno la possibilità di dedicarsi allo studio senza preoccupazioni economiche. E
poiché le università non sono a favore del nuovo sapere scientifico, essi organizzeranno poco alla volta quelle
istituzioni culturali chiamate Accademie scientifiche.
Scienze e idee-extrascientifiche
Il fatto che la scienza nasca in precise situazioni storico – culturali, e che venga svolta da persone concrete, cipermette di capire meglio il contributo delle idee extrascientifiche nella genesi delle teorie scientifiche. La
mente terrena è portata sempre a ritenere che le scoperte scientifiche derivino sempre da una serie di
osservazioni e ricerche anch’esse scientifiche. Tramite gli sviluppi della storia della scienza, oggi sappiamo
che alla base delle dottrine scientifiche vi sono spesso convinzioni metafisiche, credenze religiose, convinzioni
religiose, ecc, e quindi, ci siamo resi conto che la scienza possiede una base extrascientifica. Infatti le idee
scientifiche possono giungere da osservazioni sperimentale o da ragionamenti logico – matematici, ma anche
dalla fantasia, dal caso, dall’intuizione o dalla metafisica, l’importante che esse vengano confermate. Infatti,
che Newton, abbia scoperto la legge di gravità attraverso una mela oppure da un sogno è irrilevante, ciò che
conta alla scienza è il valore oggettivo della teoria formulata.
Le forze hanno combattuto la nuova scienza
Per affermarsi, la scienza moderna, ha dovuto combattere contro le tradizioni culturali e i teologi. La cultura
ufficiale si sentiva minacciata per una serie di motivi strettamente connessi tra loro. In primo luogo, perché il
sapere non riteneva più certe alcune teorie cosmologiche e fisiche, ritenute fino a quel momento certissime.
In secondo luogo, perché la scienza metteva in crisi le antiche certezze, e quindi la cultura tradizionale,
introducendo un nuovo modo di ragionare e ricercare, volto a rompere i “dogmi” del passato . La Chiesa era
intimorita dal fatto che la nuova scienza mettesse in discussione non solo l’autorità di Aristotele, ma anche
quella della Bibbia. Inoltre, a spaventare la Chiesa non erano solo i contenuti della nuova scienza, ma anche il
suo stesso metodo che consisteva nella libera ricerca, che si presentava come un problema, in quanto questa
nuova mentalità avrebbe potuto portare a dei mutamenti radicali. Accanto alla cultura aristotelica e della
Chiesa, vi era la magia e l’astrologia. Queste erano intimi dite dal fatto che la scienza si presentava un sapereutile all’uomo, ma in particolare aperto a tutto, al contrario della magia che era per pochi. Quindi possiamo
dire che, la vecchia cultura, la Chiesa e la magia si erano alleate contro la scienza, le quali cercarono
inutilmente di deviare intellettualmente e moralmente i seguaci delle nuove idee, perché, tali polemiche,
spronarono gli scienziati verso la ricerca di prove più solide a loro favore. Di conseguenza, la nuova scienza
finirà per imporsi, dimostrando con i fatti la propria veridicità e utilità sociale.
Conseguenze della nascita della scienza
Nel corso dei decenni successivi la scienza fu vista come un modello di sapere universale che, grazie alla sua
utilità, riesce a migliorare le condizioni umane. Al tempo degli illuministi l’idea della scienza come sapere vero
e utile fu l’arma contro l’ignoranza e la superstizione. Nell’ ‘800 si sviluppa il positivismo, dove la scienza
viene esaltata come una scienza autentica, e inseguirà l’idea di una civiltà scientifica, in cui l’uomo potràrealizzarsi. Nel ‘900, invece, venne assunto un comportamento più critico, in quanto l’approccio alla scienza
divenne più misurato perché ci si accorse che questa risultava ben lontana da spiegare tutto, anzi bastava
poco per distruggere qualche teoria e ricominciare da capo. Di conseguenza, in alcuni campi della cultura ci fu
un vero e proprio processo della scienza e un rifiuto della civiltà scientifica – tecnologica.
2. RILEVANZA E CARATTERISTICHE DELLA RIVOLUZIONE ASTRONOMICA
Attraverso la rivalutazione del cosmo, la rivoluzione astronomica da inizio a tutta la rivoluzione scientifica,
iniziata con Copernico, dove quest’ultimo ha dato inizio a un pensiero che coinvolge l’astronomia, la filosofia
e la teologia, e poi continuata anche con Galileo, Keplero, Giordano Bruno ecc..
L’universo degli antichi e dei medievali
La visione del mondo seguiva il modello aristotelico – tolemaico, dove affermava che il mondo era:
- unico in quanto veniva pensato come l’unico universo esistente;
5/12/2018 Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/riassunto-rivoluzione-scientifica-e-astronomica 4/6
- chiuso in quanto veniva immaginato come una sfera limitata dal cielo delle stelle fisse, oltre la quale non
c’era nulla, neanche il vuoto, questo perché Aristotele riteneva che ogni cosa è nell’universo, mentre
l’universo non si trova in nessun luogo;
- finito in quanto l’infinito, sempre secondo Aristotele, appariva solo come un’idea e non una realtà;
- fatto di sfere concentriche intese come qualcosa di solido e reale, su cui vi erano incastonate le stelle e i
pianeti;- suddiviso in due parti, una perfetta, ossia quella del mondo sopralunare composto dall’etere , e una
imperfetta, ossia il mondo sublunare composto dai quattro elementi.
L’intera visione del cosmo era avvalorata dall’autorità di Aristotele e della Bibbia e dall’esperienza dei sensi.
Dal geocentrismo all’eliocentrismo
Copernico: la ricerca di un nuovo sistema astronomico
Copernico, studioso di fisica celeste , teorico e matematico, riteneva che il sistema tolemaico fosse troppo
complesso, così cercò nei libri antichi delle soluzioni alternative, dove trovò che Iceta, i pitagorici, Eraclide,
ecc. avevano pensato ad un sistema eliocentrico e si propose di riprenderlo. Tale sistema poneva il sole al
centro dell’universo, dove attorno ad esso ruotavano i pianeti, compresa la Terra, la quale gira anche su se
stessa. Ma nonostante queste idee rivoluzionarie, in Copernico vi era ancora una concezione del mondo
simile a quello degli antichi, infatti concepiva l’universo come sferico, unico e racchiuso dal cielo delle stelle
fisse, inoltre accettava l’idea delle sfere perfette che racchiudevano i pianeti. Copernico, sulle sue teorie
scrisse un trattato, dove fu ci fu una perfezione anonima per opera del luterano Osiander, dove veniva
spiegato come il sistema eliocentrico fosse solo un’ipotesi matematica, la quale non rispecchiava la realtà.
Ovviamente, ciò tradiva il vero pensiero di Copernico, in quanto lui era convinto del contrario, ossia che il suo
modello rispecchiasse la realtà. A queste nuove idee ci furono delle obbiezioni, tra cui quelle a carico degli
aristotelici che si domandavano:
- se la terra si muove, allora perché tutte le cose su di essa non volano via?
- se la terra si muove da ovest a est, se lascio un oggetto, perché questo cade dritto e non si sposta da ovestverso est?
- se la terra si muove, perché non solleva un vento tale da scaraventare via cose e persone?
Più avanti, Galileo, trovò risposta a queste domande.
Brahe: il terzo sistema del mondo.
Brahe fu l’ideatore del sistema ticonico, ossia un sistema cosmologico misto, quindi veniva incontro a
Tolomeo e a Copernico, e non sembrava andare contro le sacre scritture. Tale sistema riteneva che i pianeti
girano intorno al sole,mentre quest’ultimo gira intorno alla terra, che rimane al centro dell’universo. Questo
sistema sembrava avere migliore accoglienza, in quanto era sostanzialmente conservatore, e quindi non
andava contro le sacre scritture.
Keplero: lo studio delle orbite e dei pianeti
Keplero fu un’assistente di Brahe ed esaltava la bellezza, la perfezione e la divinità dell’universo, infatti per lui
il sole, che stava al centro del mondo, era Dio e il numero dei pianeti intorno ad esso erano disposti
armonicamente. Successivamente lui si concentrò sulle orbite dei pianeti e dopo aver scoperto che queste
non svolgevano un movimento circolare, abbandono tale teoria e cercò delle forme differenti al cerchio, fino
a formulare tre leggi dei movimento dei pianeti. La prima legge affermava che le orbite descritte dai pianeti
intorno al sole sono ellissi dove il sole prende il posto di uno dei due fuochi. La seconda affermava che le aree
descritte dal segmento che unisce il pianeta con il sole sono proporzionali al tempo impiegato a descriverle.
Invece, la terza affermava che i quadrati dei tempi impiegati dai pianeti a percorrere tutta la loro orbita
stanno tra colo come i cubi dati dall’asse maggiore dell’ellisse. Le prime due leggi furono pubblicatenell’ Astronomia nova del 1609, mentre la terza fu pubblicata per la prima volta nello scritto Harmonices
mundi del 1619.
5/12/2018 Riassunto: Rivoluzione scientifica e astronomica - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/riassunto-rivoluzione-scientifica-e-astronomica 5/6
Dal mondo “chiuso” all’universo “aperto”: da Copernico a Bruno
Il ripristinarsi di un’idea sconfitta: l’infinità dell’universo
L’idea della pluralità dei mondi e dell’infinità del Tutto ebbe origine dai Greci, ma queste teorie non vennero accettate, in
quanto le concezioni infinitistiche degli atomisti erano più propense al modello aristotelico di un mondo finito. I
medievali, invece, che avevano un rifiuto verso l’atomismo, in quanto ritenuto un “filone eretico”, avevano abolito ogni
tipo di immagine astronomica diversa da quella stabilita dalla Chiesa. Ma il primo che affermo l’infinità del mondo fu
Cusano, dove la sua interpretazione non fu tanto esatta, in quanto negava l’universo f inito, ma allo stesso momento non
affermava l’infinità. Dunque, possiamo dire, che il suo universo più che infinito è indeterminato. Anche due studiosi del
‘500, Stellato Palingenio e Thomas Digges, avanzavano la proposta dell’infinità dell’universo, ma an che questa
attribuzione è incerta, in quanto Palingenio affermava più l’infinità del cielo di Dio, che l’infinità dell’universo. Mentre
l’inglese Digges modificò la concezione copernicana del mondo con un altro, ponendo le stelle sia sopra che sotto la lin ea
con la quale Copernico rappresentava l’ultima sphaera mundi . Ma la vera svolta la diede Giordano Bruno, filosofo che
occupò il secondo tratto della rivoluzione astronomica e che si staccò definitivamente dal mondo degli antichi e, fu più
propenso verso il mondo moderno.
Astronomia e filosofia in Bruno
La nuova visione del mondo di Bruno non deriva da osservazioni astronomiche o calcoli matematici, ma da un’intuizione
data dal suo pensiero alimentata dalle teorie copernicane. Infatti, egli credeva che la Terra è un pianeta che gira intorno
al sole, e pensava che le stelle potevano essere dei soli immobili circondati dai loro rispettivi pianeti, oppure l’universo al
posto di avere un sistema unico, non poteva ospitare un miliardo di soli-stelle, posizionati nei diversi spazi del mondo. Di
fronte a questi pensieri lui ne derivò che, tutte le stelle che noi vediamo dalla Terra, potrebbero essere tanti altri soli con i
rispettivi pianeti che girano intorno ad essi. Tuttavia, questa convinzione, viene posta sul piano astronomico e metafisico,
inoltre Brno riteneva che il mondo, avendo la sua causa in un mondo infinito, doveva per forza essere infinito.
Le tesi cosmologiche universali
A questo punto, i punti rivoluzionari erano:
- abbattimento delle mura dell’universo, quindi è infinito;
- pluralità dei mondi abitati, in quanto più l’universo si estendeva, più questo veniva abitato;
- stessa struttura e composizione tra mondo sublunare e mondo sopralunare, dunque sono elementi omogenei, e
attraverso queste eliminazione delle differenze tra questi due mondi, arriviamo a un’unificazione del cosmo.
- lo spazio viene considerato omogeneo in tutto l’universo. Lo spazio viene “geometrizzato” sulla base del modello
euclideo, di conseguenza è acentrico, poiché in esso non ci può essere un centro, in quanto tutti i riferimento (destra,
sinistra, ecc.) sono relativi.
- l’infinità dell’universo, punto che costituisce le fondamenta per tutti gli altri.
La “fredda” accoglienza delle tesi bruniane
Nonostante oggi le teorie bruniane risultino moderne, esse apparvero il frutto di una mente molto esaltata. Alcuni
astronomi del tempo, come Keplero, Galileo e Brahe, lo accolsero freddamente e in gran parte lo rifiutarono, respingendo
in particolare la pluralità dei mondi e l’infinità dell’universo. Ma ciò non avvenne soltanto per ragioni di correttezza
metodologica, ma anche perché esse apparivano oggettivamente troppo rivoluzionarie. Differente fu la reazione della
Chiesa e della vecchia cultura, che fino alla scomparsa del capolavoro di Copernico erano preoccupati dalle due idee
astronomiche, anche se ovviamente non tutti reagirono subito e allo stesso modo.
Federica Perra IV F
Anno scolastico 2011/2012
Liceo scientifico “G. Brotzu”