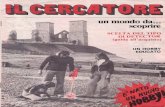RECENSIONI - Istituto Nazionale Ferruccio Parri - … è il frutto delle sue doti di ri cercatore:...
-
Upload
hoangthuan -
Category
Documents
-
view
221 -
download
0
Transcript of RECENSIONI - Istituto Nazionale Ferruccio Parri - … è il frutto delle sue doti di ri cercatore:...
R E C E N S I O N I
Gaetano Salvemini, Scritti sul fascismo(vol. I), Milano, Feltrinelli, 1961,pp. 677, L . 4800.
Se non ci fosse un Salvemini, biso- gnerebbe certo inventarlo. A questa positiva conclusione si finisce inevitabilmente per approdare ogni volta che dello storico pugliese si leggono gli scritti, tanto è l ’ interesse che essi sempre suscitano, mai disgiunto dalla profonda lezione di coscienza etica e di onestà intellettuale che in essi si può costante- mente ritrovare.
Non fa naturalmente eccezione questo primo volume di Scritti sul fascismo che Roberto Vivarelli ha curato nell’ambito della felice iniziativa editoriale volta a dare alle stampe l’ intera produzione salveminiana : anzi mai come qui,forse, sullo storico in senso stretto— inteso cioè come colui che, con opera di storia, vuole fare « un’opera mossa da interessi più mediati e indirizzata a fini meno contingenti, nel cui giudiziocomplessivo sia possibile mantenere un distacco maggiore » — prevale il maestro di etica, nella sua lucida intransigente condanna del fascismo. Condanna che però, prima ancora che dalla saldezza delle convinzioni e dalla forza dei principi, scaturisce irresistibile dalla logica del buon senso e dallo svolgimento dei fatti così come ce li presenta il Salvemini, sorretti cioè dal costante contributo di una documentazione la più ampia e la più obiettiva possibile, e dalla pacatezza del ragionamento di chi non si accontenta di vincere ma soprattutto mira a convincere. Ecco, in fondo, svelato il segreto di quel famoso realismo salveminiano che, essendo svincolato dalla rigida sudditanza a qualsiasi arido schema precostituito, anzi proprio per questo, riesce particolarmente a farsi valere in modo tanto positivo quanto più controversa appare la materia dibattuta.
E ’ appunto il caso del fascismo, la cui nascita e il cui avvento al potere— svolta decisiva della nostra storia — hanno fin qui logicamente costituito e ancora costituiscono motivo di attenta analisi e insieme oggetto di aspra contesa, con il risultato che la passione di parte spesso prende il sopravvento su una più equilibrata visione degli eventi che tenga necessariamente conto di una molteplicità di elementi e di circostanze.
Inutile sottolineare che per il Salve- mini il problema non si pone affatto, tale è l ’assoluto predominio dello storico, o quanto meno — come nel primo saggio del presente volume, La dittatura fascista in Italia, originalmente scritto per il pubblico anglosassone nell’esclusivo polemico intento di ribattere con prove inoppugnabili le menzogne e le falsificazioni che il noto propagandista del regime Luigi Villari, figlio del celebre storico Pasquale, aveva diffuso con il suo libro The Awakening of Italy — del cronistorico e del narratore documentato, sul partigiano fazioso (da non confondersi però con lo studioso moralmente impegnato).
Ciò gli permette, ad esempio, di riconoscere tranquillamente le gravi responsabilità dei socialisti nel preparare il clima in cui maturò e prosperò la violenza fascista — in modo particolare dei massimalisti, che egli accusa di « mentalità infantile » perchè convinti che « tutto ciò che veniva ad indebolire il Parlamento, istituto del mondo capitalistico, affrettava il crollo totale di quel mondo » — , ma al tempo stesso, e quindi con ancora maggiore autorevolezza, di denunciare altrettanto implacabilmente le colpevoli connivenze delle autorità militari (un intero capitolo delle sue L ezioni di Harvard vi dedica il Salvemini), delle forze di polizia, del potere giudiziario, in una parola della classe dirigente, dove si distinsero, nell’assidua opera di più o meno aperto e diretto favoreggiamento del regime, gli stessi presidenti del Consiglio Giolitti e Bo- nomi, per tacere di Facta, il Romolo Augustolo dell’Italia liberale ovvero — nota il Salvemini con impietosa crudezza — « uno dei maggiori idioti di tutti i tempi e di tutti i paesi ».
Non è questo naturalmente il solo drastico giudizio dello storico pugliese : Vittorio Emanuele III, ad esempio, dopo il 3 gennaio 1925, diventa « le roi fainéant » ossia « l'ultimo dei Merovingi », mentre il Gabriele d’Annunzio delle « giornate radiose », « questo dilettante di sadiche emozioni », è un uomo moralmente tarato i cui scritti di quegli anni « fanno pensare ai sogni di gloria, di ricchezza, di sangue e di concupiscenza di un cameriere ».
Brevi squarci, in realtà, seppur sfolgoranti di vis polemica, di un più vasto
Recensioni 8 i
affresco destinato a inchiodare il fascismo alla propria colpevolezza con tutto il suo carico di violenze e sopraffazioni, di lutti e rovine: fondamentali a questo proposito risultano soprattutto tre capitoli della Dittatura fascista —• in particolare quello dedicato al delitto Matteotti — , dove l’ agile e brillante narrazione salveminiana cede il passo a una semplice e magari arida (ma quanto drammatica!) elencazione di fatti dolorosi e dei loro responsabili (qualcuno tuttora vivente e tranquillamente in libertà come il famigerato torinese Piero Brandimarte, o da poco defunto come il non meno famigerato fiorentino Arco- novaldo Bonaccorsi), che tuttavia rappresenta il più schiacciante atto d’accusa nei confronti del fascismo, del suo capo, dei suoi accoliti, e (perchè no?) di quanti, più o meno conniventi, col- laborarono all’instaurazione della dittatura. La quale — e il Salvemini giustamente mette in rilievo questa sacrosanta « verità storica » — « non significò affatto la medicina contro la malattia bolscevica », ma « fu una nuova ed ancor più terrificante malattia — la guerra civile — che si sostituì all’esaltazione rivoluzionaria, quando questa volgeva già al tramonto; o era piuttosto una fase nuova ed ancor più terrificante di quella stessa malattia di cui più o meno soffrivano tutti i paesi: la nevrasteniadel dopoguerra ».
Ovvero un mito — il fascismo salvatore di un’Italia fatalmente destinata alla bolscevizzazione — distrutto completamente, e sulle rovine una grande indimenticabile lezione storica di impegno civile e di ammaestramento morale: un’eredità preziosa alla quale non sarà inutile, ma anzi necessario, rifarci nella costante difesa di quegli ideali di libertà che sempre furono in cima ai pensieri e alle preoccupazioni di Gaetano Salvemini.
G iorgio G ualerzi.
David T . Cattell, I comunisti e laguerra civile spagnola. Milano, Feltrinelli, 1962, pp. X-329, L . 3000.
David Treadwell Cattell è un giovane americano, autore di due opere sulla guerra civile spagnola (Communism and the Spanish Civil War, Berkeley Los Angeles, University of California Press, 1955; Soviet Diplomacy and the Spanish Civil War, Berkeley, Los An
geles, University of California Press, Ï957), che hanno acquistato in breve tempo un posto di primo piano tra la letteratura anglosassone sull’argomento. La prima delle due (si annuncia anche la prossima pubblicazione del volume sulla diplomazio sovietica) ci viene ora presentata in una buona traduzione dall’editore Feltrinelli.
Il Cattell affronta, per la prima volta sul piano storiografico, il problema dell’azione comunista in Spagna nel periodo 1936-1939, e si avventura bravamente su una specie di campo minato, con risultati tutto sommato non disprezzabili. Infatti, se i criteri generali cui l'opera è ispirata e la sua impostazione metodologica possono prestarsi a più d'una critica, è comunque doveroso riconoscere l'onestà del ricercatore, la sua scrupolosità, l’ assenza di prevenzioni, anche là dove, per mancanza di dati certi, egli è costretto a procedere per via di ipotesi, o addirittura a tentoni.
11 merito maggiore dell’opera del Cattel è il frutto delle sue doti di ricercatore: il puro lavoro sul documento e l’accurata ricostruzione del fatto portano quasi sempre a risultati accettabili nelle loro linee essenziali e permettono tra l'altro all’autore di eliminare una volta per tutte i numerosi elementi spuri, che con tenacia ancora resistono (quando non prosperano) quasi in ragione della loro banalità. Così il presunto tentativo di colpo di stato comunista prima del luglio 1936, le manovre del Comintern, i brogli delle sinistre alle elezioni di febbraio o l’ alibi fascista del pericolo bolscevico da affrontare nel nome della civiltà occidentale, dei valori cristiani, ecc. E ’ vero che non mancano le ingenuità e le annotazioni affrettate (si afferma, ad esempio, che nel 1932 Andrés Nin e Joaquin Maurfn abbandonarono il partito comunista «non essendo riusciti ad ottenere dal Comintern un atteggiamento più liberale, che consentisse loro maggiore libertà di azione »), ma i veri difetti del lavoro del Cattell ci sembrano altri; potremmo dire una non completa e maturata conoscenza della storia e dei problemi del movimento operaio europeo.
All'inizio del volume si afferma che la guerra spagnola « fu innanzi tutto provocata dall’esplosione dei numerosi conflitti interni, che si erano andati accumulando da anni, piuttosto che dalla manovra di una potenza straniera »; e
82 Recensioni
il giudizio è indubbiamente esatto. Ma, se la guerra è da considerarsi come la conclusione inevitabile di una profonda crisi sociale, possiamo avanzare parecchi dubbi sulle possibilità di riuscita di una analisi storica che, intendendo prendere in esame l’azione dei comunisti, la riduca ad un puro fenomeno di tattica politica. Il Cattell si rende parzialmente conto di ciò e scrive della impossibilità di « isolare l’azione dei comunisti dalla complicata rete dei loro rapporti con gli altri gruppi della Spagna repubblicana », affermando che tale separazione avrebbe dato soltanto una « mezza verità non priva di distorsioni »; ma Ja completezza cui egli aspira è da intendersi in senso tutto esteriore e meccanico. E ’ evidente che non si possono fare considerazioni sulla politica di un partito senza tener conto dei suoi rapporti con gli altri partiti, ma pensiamo che in primo luogo si dovrebbe parlare della « rete dei rapporti » tra i partiti stessi e la mutevole realtà del paese, problema questo al quale il precedente è necessariamente subordinato.
In questo modo, tutta la prima parte del volume, quella che tratta delle particolarità economiche e sociali della situazione spagnola e delle forme di lotta delle organizzazioni e dei partiti operai, viene ridotta ad un semplice riassunto introduttivo, mentre, a nostro parere, avrebbe dovuto inevitabilmente essere l’ impostazione generale di una problematica che non può in nessun caso essere trascurata se non si vuole limitare lo studio sul comuniSmo alla pura analisi di atti politici considerati a se; la problematica cioè relativa ai rapporti tra le organizzazioni socialiste e la ancor primitiva situazione delle campagne, alle tradizioni della jacquerie contadina, alle espressioni sociali di un capitalismo poco evoluto, alle caratteristiche del fascismo agrario e ai tentativi di rottura operate dalle moderne forme di lotta del partito comunista (con tutte le eventuali limitazioni di cui, in un paese come la Spagna, lo stesso comuniSmo poteva risentire).
Fuori da questa prospettiva i giudizi non possono che essere incerti ed approssimativi, a volte del tutto inaccettabili. Ad esempio, quando si afferma: " A causa del basso livello di vita che rasentava la fame, non c’è da meravigliarsi che i.I proletariato ed j contadini ricorressero alla violenza e aderissero
volentieri a quegli schemi utopistici, come l’anarchismo, che promettevano la libertà e l'equiparazione delle enormi differenze tra loro e i proprietari ». Con questo si potrebbe essere indotti a credere che gli « schemi utopistici » siano il prodotto delle società « a basso livello di vita » o a spiegare l ’anarchismo semplicemente con la fame. Con simili sbrigative definizioni non si possono spiegare dei fenomeni sociali (come l’anarchismo spagnolo) che devono essere invece valutati in tutta la loro portata se si vuole rendere intellegibile qualsiasi discorso sulla vita politica del paese, anche se tale discorso riguarda soltanto i socialdemocratici, i comunisti o i car- listi.
In questo senso ij Cattel ci sembra incapace di cogliere nella loro pienezza tutti i rapporti esistenti tra il grado di sviluppo economico e sociale di un paese e le forme della lotta politica : l’azione di un partito operaio sembra per lui chiusa entro un’alternativa ferrea, il riformismo o Ja guerra civile, ma sia nell’un caso che nell’ altro i complessi fattori che in tali forme trovano espressione politica non sono per nulla considerati. Certe valutazioni non possono quindi che lasciare perplessi, come quando, parlando dei socialisti, egli scrive: « la U. G. T ., insieme ai sindacati cattolici, era forte anche nei centri industriali del nord, poiché faceva una politica moderata e non ricorreva a metodi terroristici »; affermando poi, nelle righe seguenti: « ma la moderazione e il parlamentarismo non potevano andare molto lontano in un paese come la Spagna dove le elezioni erano controllate da un sistema di caciques, ossia di caporioni politici, e dove la violenza era legge. Di conseguenza, il programma moderato dei socialisti che tentavano di seguire la strada della democrazia in una situazione rivoluzionaria allontanò molti lavoratori spingendoli nelle braccia degli anarchici ». Frasi che si perdono in un labirinto di affermazioni contradditorie e che rivelano con molta chiarezza la mancata penetrazione dei problemi fondamentali.
Un altro problema che non ci sembra sia stato trattato in maniera adeguata è quello costituito dalla politica dei fronti popolari (che determina direttamente l’azione dei comunisti in Spagna).
Secondo il Cattell, l’ interpretazione
Recensioni 83
della situazione europea elaborata dal VII Congresso dell’Internazionale avrebbe condotto a stabilire che « era stata la debole politica borghese della social- democrazia e la inefficienza dei comunisti » a permettere l’avvento del fascismo; e che quindi, « per ritorcere la situazione contro il fascismo », era necessario « incrementare la forza e l’ influenza dei comunisti attraverso la collabo- razione con altri gruppi proletari ». In conclusione, il Congresso avrebbe proposto alle sezioni dell’ Internazionale un « nuovo schema d’azione » per preparare la rivoluzione e la dittatura del proletariato: « Il programma stabiliva dettagliatamente le tappe da seguire: primo, Fronte Unico; secondo, Fronte Popolare; terzo, governo di Fronte Unico o di Fronte Popolare; quarto, unità sindacale e partito unico del proletariato ». Il Cattell avverte che il piano non era tuttavia da considerarsi come « qualcosa di rigido e di obbligato », ma semplicemente come « uno schema del possibile sviluppo degli avvenimenti ».
Si perpetua in tal modo un errore, quello che consiste nel concepire l’ intera azione comunista semplicemente come una tattica, più o meno elasticamente applicata, mentre ci pare che la politica dei fronti popolari non potrebbe essere intesa nel suo giusto significato se non come un gigantesco sforzo, compiuto tra tentennamenti ed errori, per costituire un rapporto più diretto ed immediato tra le masse e il partito: non una manovra, ma quasi il tentativo di una moderna interpretazione dello sviluppo delle forze sociali, destinato ad informare l’ azione quotidiana dei comunisti per tutto un periodo storico. Così la guerra civile spagnola diventa un fenomeno scarsamente comprensibile se la si considera dal punto di vista degli immediati rapporti delle forze in presenza e non come Io sbocco di mezzo secolo di storia del movimento operaio europeo.
I limiti dell’opera risultano evidenti nella parte finale, quando il Cattel cerca, in verità con molte incertezze, di trarre delle conclusioni e non riesce a stabilire con precisione se gli obbiettivi dei comunisti consistessero nella realizzazione del « piano prestabilito », in una politica di resistenza ad oltranza al fascismo o nell’ appoggio della politica estera sovietica; mentre tutti questi elementi non dovrebbero essere conside
rati a sè, ma visti in funzione della politica dei fronti popolari, cioè nel quadro di una visione nuova dei rapporti tra il proletariato e gli altri strati della società.
Pur con queste manchevolezze il lavoro del Cattell presenta, come abbiamo detto, dei meriti incontestabili e sotto molti aspetti risulta per il momento insostituibile. La parte avuta dai comunisti attraverso le varie fasi della evoluzione dello Stato repubblicano, la ricostruzione delle giornate del maggio 1937, la posizione del partito verso i problemi della ricostruzione dell’esercito o a proposito del dibattito sulla questione delle realizzazioni rivoluzionarie, sono sempre il frutto di un’analisi sobria e precisa. E se lo sforzo del Cattell si fosse limitato a questo lavoro « analitico », il volume potrebbe di buon grado essere considerato un modello. Ma le intenzioni erano altre: quella di creare una sorta di tipologia della tattica comunista, quasi per servire a fini politici immediati. Sorge spesso infatti nel lettore il sospetto che tutta l’opera sia il frutto di un'esigenza nascosta, e magari inconfessata, quella di studiare il comuniSmo al solo scopo di poterlo meglio combattere. Ma anche in questo caso, e pur tralasciando le riserve che sul piano storiografico si sogliono addurre in simili circostanze, non crediamo si possano ottenere risultati sicuri riducendo complessi fenomeni sociali a semplici problemi di tattica politica.
G iorgio Rùvida.
Ignazio S ilone, La scuola dei dittatori,Milano, Mondadori, 1962, pp. 300,L . 2200.
La scuola dei dittatori non vorrebbe essere, come assunto, la storia di come andarono al potere Mussolini e Hitler, ma un compendio generale delle male arti, dispiegando le quali maestri di scuola e imbianchini, purché di buona stoffa, possono arrivare a racchiudere nelle loro mani la somma del potere. Di fatto, però, i riferimenti che qua e là si trovano a Lenin, Napoleone, Pietro il Grande e altri sono marginali e insufficienti a giustificare una teoria generale della dittatura, valida come tale anche in situazioni diverse da quelle dei grandi paesi dell’Europa occidentale nella prima metà del XX secolo. Diciamo della prima metà, e non perchè l’ azione
Recensioni84
del libro è supposta svolgersi nel 1939 (il che potrebbe essere un semplice espediente letterario), ma perchè gli elementi in esso addotti sono effettivamente insufficienti a spiegare il più importante e pericoloso dei fenomeni dittatoriali nella seconda metà del secolo, ossia la dittatura di De Gaulle, che è al tempo stesso molto più « classista » di quelle di Mussolini e di Hitler e, per altri aspetti, molto più nuova e inquietante.
In teoria, la parola dittatura dovrebbe indicare la pura forma di governo— ossia il potere personale di un uomo, o di un gruppo ristretto, che esercitano il potere senza controllo, se non proprio senza il consenso, dei governati — e prescindere da ogni implicazione relativa alla concreta azione di governo che il supposto dittatore esercita. Ciò di cui si parla in questo libro dovrebbe valere sia per le dittature di destra che per quelle di sinistra, e persino per quella che l ’A . chiama, con apparente paradosso, dittatura democratica, ossia « un totalitarismo di tipo giacobino, schiettamente democratico nell’ ideale e antidemocratico nel metodo, a causa delle condizioni arretrate delle masse » (p. 67); di fatto, l’A . sembra escludere la possibilità di una dittatura che non sia di destra, quando dice che « strada facendo, il mezzo si sostituisce al fine» (p. 68).
In realtà, i protagonisti e quasi i soli personaggi dell’indagine finiscono con l’essere Mussolini e Hitler, ossia due dittatori di destra, di umile estrazione, di tendenze demagogiche, che svolgono la loro azione a partire da una situazione di base caratterizzata dalla presenza al potere di una borghesia moderata, già minacciata sul fianco da una robusta destra tradizionale e impegnata frontalmente da un partito rivoluzionario.
Partendo da questi dati di base, gli aspiranti dittatori riescono a conseguire il loro scopo adottando il programma della destra tradizionale e sottraendo, con l ’aiuto di circostanze eccezionali— guerra, per l’Italia; crisi economica, per la Germania — , parte delle sue naturali milizie al partito rivoluzionario.
Diciamo subito che il Silone ci sembra aver colto un punto fondamentale, ossia che, malgrado il loro talento demagogico, la loro organizzazione para- militare, gli errori degli avversari, nè Mussolini nè Hitler sarebbero comunque riusciti ad andare al potere se coloro
cui istituzionalmente spettava il compito di difendere le istituzioni esistenti avessero avuto una minima volontà di resistere (si veda il capitolo: « Sui pericoli dei complotti e delle rivolte senza l'appoggio della polizia e dell’esercito »). E su un altro punto ancora ci sembra che egli abbia colto nel segno, ed è quando osserva che i servitori dello Stato non avrebbero potuto assolvere così male il proprio compito se il popolo che glielo aveva affidato non fosse stato, malgrado Je istituzioni ufficialmente democratiche, psicologicamente preparato alla dittatura. Ma, su questo punto, ci sembra che egli abbia fatto male a mettere troppo in ridicolo il personaggio del prof. Pickup, che parla come Barrés e Gobineau e rappresenta, nel libro, il fascismo libresco, intinto di fisime aristocratiche e irrimediabilmente inefficiente, in contrapposizione alla spregiudicata tattica demagogica del vero dittatore. Per che cosa crede Si- Ione che Mussolini montasse a cavallo e volasse, se non per la platea dei prof. Pickup e dei loro allievi, abbeverati alle fonti immortali dell’estetismo? Certo, un prof. Pickup che credesse veramente alle scemenze che dice sarebbe più d'impiccio che d ’utilità a un aspirante dittatore che ne facesse il proprio consigliere; ma, per un’azione a lunga scadenza, un prof. Pickup capace di far credere quelle cose agli altri è una manna per il regime.
Il lato più criticabile del libro, in compenso, ci sembra consistere nell’ a- ver pressoché per intero trascurato il carattere classista delle dittature considerate. E ’ vero che, secondo il suo assunto, il libro avrebbe dovuto fornire una chiave d ’interpretazione valida per tutte le dittature, e quindi anche per la dittatura del proletariato, o di chi la esercita in nome del proletariato, ma poiché, di fatto, si parla solo di Mussolini e di Hitler, tanto varrebbe allora parlarne fino in fondo. Se questi ultimi, in linea di principio aperti a tutte le avventure, disposti a tutti i programmi, di fatto trovarono da allearsi solo alle forze della destra tradizionale, non ci sembra che questo possa essere considerato un semplice fenomeno collaterale. Se anche si può contestare che il fascismo sia stato solo la reazione armata dei ceti industriali e agrari, come sostenne, allora, il Partito socialista, e come sostiene, oggi, la storiografia di
Recensioni 85
ispirazione marxista, resta tuttavia da spiegare il fatto che industriali, agrari, clero ed esercito si accomodarono benissimo nella nuova situazione, e che la politica interna ed estera del fascismo fu tutta volta, guarda caso, a realizzare quei postulati che quei gruppi di pressione avevano sottoposti ai governi italiani del dopoguerra. Questo signfica, se non altro, che la dittatura come mezzo di governo era meno incompatibile con gli interessi di quei gruppi di quanto non lo fosse con quelli di altri gruppi e di altre classi sociali.
Con tutto ciò, è un peccato che il libro si fermi al 1939. Perchè ad un’analisi un po’ approfondita non può sfuggire quanto, in definitiva, di peculiare e irripetibile vi fu nella dittatura di Mussolini e, più ancora, in quella di Hitler, mentre nuove forme di dittatura si insinuano nella nostra malferma democrazia. Per esempio, l’A . di questo libro cita, giustamente, fra le cause che diminuiscono la resistenza psicologica dell’uomo della strada, il condizionamento cui è sottoposto dalle moderne forme di propaganda, anche commerciale. Non si può dire, peraltro, che questi fenomeni fossero molto sviluppati nell’ Italia del 1922, e nemmeno nella Germania di dieci anni dopo: è oggi che essi si manifestano a livello di massa. Anche il punto in cui si contrappone l’ individualismo dell’operaio ottocentesco, psicologicamente ancora un artigiano, al livellamento dell’operaio nella grande industria moderna, è in certa misura contestabile. In realtà, si potrebbe anche sostenere che il fatto di riunire grandi masse di lavoratori in un solo luogo agisca invece in senso positivo, conferendo loro coscienza della propria forza e facilitandone l ’organizzazione, anche in senso rivoluzionario, e che, semmai, il pericolo della spoliti- cizzazione delle masse ricompaia proprio attraverso quell’altro modo di ricostituire l’ isolamento che si ottiene attraverso una disposizione urbanistica che rende difficile alle classi inferiori la vita associativa al di fuori delle ore di lavoro. Nei paesi più progrediti, l ’operaio passa la sera a tu per tu con la televisione, che è l’occhio e la voce del governo. Infine, non bisogna dimenticare che nessuna delle condizioni di estremo disagio — la guerra, la miseria — che caratterizzavano l’ Italia e la Germania alla vigilia della loro trasfor
mazione in dittature si verifica, per esempio, nella Francia d ’oggi, allo stesso modo che due dittatori — Franco e Salazar — sono riusciti fino ad oggi, e niente lascia credere che non possano farlo in perpetuo, ad evitare lo scoglio su cui un tempo sembrava dover necessariamente finire ogni dittatura, e cioè la guerra. Se, dunque, per certi versi l’esperienza di Mussolini e di Hitler non può essere trasportata di peso nel mondo di oggi, riacquistano invece valore certi elementi tradizionali della dittatura, cui Mussolini e Hitler in parte sfuggivano. De Gaulle è molto più « uomo del destino » di quanto lo sia mai stato alcun altro dittatore degli ultimi cinquantanni, tanto più che, a differenza, del dittatore ipotizzato e in parte ridicolizzato da Silone, le cui imprese al servizio della patria erano sempre, o almeno in gran parte, inventate, la gloria di De Gaulle è reale. Nessuno potrebbe dire di De Gaulle che è un avventuriero; ma ciononostante egli è un dittatore, come lo erano Pietro il Grande e Luigi X IV, che pure erano nati sui gradini del trono. Se alcuni degli elementi che hanno caratterizzato le dittature degli anni tragici — la guerra, la fame, l ’odio di classe esasperato — vengono meno, è la dittatura pertanto si spoglia del suo alone sanguinoso, si perde la violenza e rimane la tirannia. II dittatore è diventato monarca; la breve avventura wagneriana si dissolve: l’unico punto debole di tutta la faccenda è che i re possono durare dei secoli.
A ldo G iobbio.
Franco C atalano, L ’Italia dalla dittatura alla democrazia 1919-1948, Le- rici editori, pp. XII-869, L . 5000.
Questa nuova poderosa fatica del Catalano si diversifica da quella di argomento analogo data recentemente in luce per i tipi dell’U T E T grazie a caratteristiche che l’A . stesso, in una introduzione affabilmente discorsiva (come limpida, modesta, direi candida, è sempre la presenza dello scrittore in queste pagine) si premura di chiarire. Esse sono essenzialmente due, lo svolgimento assai più largo dedicato agli avvenimenti posteriori al 1940 e la preminente attenzione rivolta agli elementi economici e sociali nel corso del quindicennio precedente. Quest’ impostazione fa sì che l’opera del Catalano, facendo forza in
86 Recensioni
parte — nè l’A . lo nasconde — alle stesse sue intime inclinazioni, si prospetti come un’analisi di rapporti e contrasti di forze, con un rilevantissimo impegno politico, sempre però trasceso su piano prammatico, obiettivo, senza soverchia indulgenza per le suggestioni culturalistiche e dell’ interpretazione di costume. Su queste basi, gran parte della pubblicistica antifascista dell’emigrazione, accentrata sulle note polemiche del tono, dello stile, del rigore, sulla traccia gobettiana, e dell’ Amendola « aventiniano » (e del Matteotti « go- bettiano ») risulta rapidamente sfuocata, priva d’un distinto e concreto contenuto politico, d'un peso valutabile con certezza nel quadro d’una politica di potenza. E ’ proprio qui, ancora una volta, che la guerra di Spagna assume un carattere decisivo di spartiacque, assegnando definitivamente all’antifascismo un suo ruolo internazionale schiettamente politico, che travalica di gran lunga le rissosità spesso inconcludenti dell’emigrazione di Parigi, che toglie una volta per sempre agli esuli la qualità o il sospetto di rami secchi asportati dal grand’albero rigoglioso, per trascenderli ed inserirli in uno sfondo europeo e mondiale, in una prospettiva di potere, di società, di civiltà. In un certo senso, questo slargamento ed irrobustimento smisurato dell’ antifascismo, posteriore al suo momento di maggiore e più sterile depressione (ed immiserimento provin- cialesco) susseguente alla guerra etiopica, potrebbe richiamare alla mente la fortuna dell’ alternativa democratica e repubblicana su piano europeo all’indomani del colpo di Stato buonapartista del 2 dicembre, anche qui dopo lo sfilacciato disgregamento e le recriminazioni del 1849. Nell’un caso come nell’ altro, in Mazzini come in Rosselli, al di là dei risultati immediati, conta la dignità nuova, il respiro nuovo che l’ emigrazione italiana assume, a contatto operoso con le correnti più avanzate e consapevoli della politica europea, con gli esuli russi o con gli operai catalani, nelle pieghe stesse dell’azione di governo, a spronarla, a correggerla, a fornire ad essa obiettivi più vasti e più coscienti che non la mera tecnica diplomatica. In questo modo — ma soltanto allora — il fascismo diventa qualche cosa di più e di diverso che non un elemento dell’equilibrio, del gioco di potenza, si pone come sottofondo comune, come sostrato accumulato da decenni di propa
ganda, d ’incultura, di diseducazione politica, in buona parte della media opinione pubblica europea. Soltanto allora ogni Stato scopre in sè un proprio fascismo, e nasce la vocazione di limitarlo, di combatterlo: ed è una scoperta tragicamente feconda, non destinata certo ad esaurirsi tra le case diroccate della Berlino primavera 1945.
Giolitti, i socialisti, gli interventisti, campeggiano intanto, com’è naturale, all’ inizio della ricostruzione del Catalano. E si dovrà dare atto a lui di aver sotto- lineato con finezza la vocazione pacifista, e non neutralista del socialismo italiano. Si tratta di due termini, l’uno assoluto e di principio, l'altro tattico e contingente, non scambiabili a volontà: l ’uno nega l'esistenza della guerra, l’altro si limita a negarne l’opportunità. Come tutte le dichiarazioni di fede, peraltro, il pacifismo reca in sè una grave carenza politica : e su ciò vorreifermare l’attenzione. 11 pacifismo dei socialisti italiani, privo di sbocchi concreti circa il disarmo o soltanto la distensione internazionale, si limita ad essere un atto del tutto individuale di moralismo umanitario, un'obiezione di coscienza, nella quale possono tranquillamente convergere uomini delle più disparate provenienze politiche : ilpremio Nobel per la pace è andato al radicale Moneta, ed il conservatore Bonghi è stato promotore instancabile di congressi per la pace. Il pacifismo, come ogni atto di fede, non si difende, diceva bene Mussolini all’inizio del Popolo d ’Italia, se non con argomenti assoluti: una crepa fa crollare l’ interoedificio : chi tutto ha negato si trovaa dover tutto concedere. Questo spiega lo stato di subordinazione politica in cui il socialismo italiano si trovò a dover versare lungo tutta la guerra, la sua incapacità a riprendere l’ iniziativa su formule e prospettive nuove, l’ incomprensione che lo divise dalle masse rivoltesi ad esso per delusione ed esasperazione di quella guerra, per esser state magari ingannate nei loro propositi di rinnovamento e purificazione. Giacché — Catalano è il solo socialista, che io sappia, che abbia avuto il coraggio di dirlo — in seno alla minoranza che affrontò consapevolmente la guerra italiana gli imperialisti rappresentavano un’entità trascurabile, forse inferiore anche a quegli interventisti democratici che andavano
Recensioni 87
alle armi con una visione mazziniana delle nazionalità europee affratellate. Questi ultimi comunque si trovarono idealmente concordi in un comune im- pulso etico con la terza, e maggiore, frazione della minoranza di cui si discorreva, quella cioè che poneva alla guerra, la quarta e suprema del nostro Risorgimento, l’obiettivo del compimento delle nostre frontiere nazionali. Anche qui giova comunque distinguere nell’ ambito di questa che potrebbe dirsi interpretazione patriottica della guerra. Anche Salandra se ne mostrava fautore, con la sua formula del « sacro egoismo » (anticipata, lo si è visto nel recente convegno di Spoleto, da certa pubblicistica cattolica). Ma i giovani i cui propositi vennero condivisi e raccolti da Adolfo Omodeo non pensavano certo ad un ammodernamento della politica sabauda del carciofo, la cui ultima porzione restasse ormai da divorare. In essi riviveva soprattutto lo spirito liberatorio, l’ istinto civile e latamente umanistico del Risorgimento, in ciò tanto affine alla Resistenza, in un filone sotterraneo che percorre tutta la storia italiana dell’ultimo secolo: istinto che trapela anche nelparticolare peso e nell'accezione particolare che in questi episodi culminanti del nostro recente passato assume lo straniero: lo straniero che non è na-zionalisticamente inteso come il barbaro nemico che occorre schiacciare, bensì come una sorta di remora oscura, d ’impaccio oppressivo al libero espandersi della vita civile della nazione, il momento dialettico della tenebra da cui occorre liberarsi soprattutto per purificare sè stessi.
La valutazione che il Catalano offre del Giolitti e della sua politica non mi lascia viceversa del tutto soddisfatto. Si tratta di un rilievo critico che si può estendere un po’ a tutte le personalità dominanti del volume, da Nitti a Mussolini fino, più vistosamente e forse più seriamente, a De Gasperi ed a Togliatti. Questi personaggi vengon fuori con un ruolo decisivo di protagonisti, all’incirca come l’Eracle del F ilottete di Sofocle ed in genere come tutti i dii ex machina della tragedia classica o classicheggiante. Essi appaiono subito all’opera, in media re, senza che risaltino a sufficienza le basi culturali e politiche, spesso complesse e remote, del loro operare. Ciò conduce inevitabilmente
ad una certa eccessiva semplificazione del giudizio, soprattutto a danno di quelle figure, come appunto, e soprattutto, il Giolitti e il De Gasperi, nei cui confronti l ’atteggiamento dell’A . è fortemente critico, spesso incline all'aperta censura polemica e ad un acerbo biasimo. Chi scrive condivide appieno la massima parte di questi giudizi particolari: ma reputa cheavrebbe giovato ad una più esatta intelligenza della vita pubblica italiana sotto l’ egemonia di quei due statisti un esame più approfondito del loro passato, delle loro tradizioni, delle resistenze da essi incontrate, degli ostacoli superati, senza affidarsi alla facile formula stroncatoria del « trasformismo » che, per voler dire tutto, dice poco o nulla. Senza dubbio, sia il Giolitti che il De Gasperi hanno svolto opera consapevolmente e spesso pesantemente antisocialista, con l’ azione di rottura, di assimilazione esteriore e di svuotamento sostanziale da essi perseguita nei riguardi di determinate, malleabili e ben individuate frazioni del movimento operaio (la « corruzione» ed il selezionalismo di Salvemini): un’opera a lungo termine antidemocratica, con l’avvilimento profondo inflitto alle istituzioni parlamentari, alla funzione educatrice della stampa, alla cultura militante (essi erano d ’altronde uomini d’assemblea alla Cavour cioè rigorosamente deferenti alla maestà del parlamento soltanto in quanto docile cassa di risonanza dell’opera dell’esecutivo: strano a dirsi, il solo uomo di Stato che si sia creato con le proprie forze le proprie fortune, giorno per giorno, anno per anno, nell'assemblea, è stato quello passato alla storia con la maggior taccia di autoritario, Francesco Crispil). Detto e riconosciuto ciò, occorre tuttavia scendere nel fondo del loro « trasformismo », che non è semplice manipolazione programmatica nè ottusa resistenza frontale di classe, bensì l’ interpretazione, la direttiva e l’espressione ad un tempo di tutto un vastissimo movimento civile e sociale non soltanto della borghesia, movimento che nè Giolitti nè De Gasperi hanno creato, ma che hanno contribuito a suscitare, padroneggiandolo ed indirizzandolo a determinati obiettivi piuttosto che ad altri sulla base di certi presupposti ed attraverso strumenti di propaganda e di pressione ben precisi. Lo stesso di-
88 Recensioni
casi (qui più sul piano culturale ed ideologico che non su quello di governo) a proposito dell’entrata in scena di Togliatti, che reca sempre in sè alcunché di romanzesco, un evento impreveduto ed incomprensibile, che rovescia di punto in bianco, e radicalmente la situazione. Anche qui, dietro il gesto clamoroso di Togliatti, ci sono vent’anni di dichiarata ed ininterrotta tattica sovietica e comunista d’inserimento, di contatti, di alleanze, di fronti, con una valutazione realistica di potenza assolutamente spregiudicata : e ci sono soprattutto (non lo sidovrebbe mai dimenticare) vent’anni di lavoro all’interno, di propaganda capillare, che, pur tra alti e bassi, forniscono al partito comunista, unico fra i partiti o le consorterie clientelari italiane, la coscienza e pressoché la sicurezza di poter disporre di quadri e di seguaci abbastanza efficienti da non dissolversi e da non deflettere dal loro specifico obiettivo per mutamenti tattici, pur sconvolgenti, di vertice. Una lezione, anche questa, che i comunisti non avevano appreso dalle meditazioni intellettuali di Gramsci (o almeno non solo da esse) ma dall’evidenza dei fatti, dalla realtà postbellica di un partito socialista incapace di reinserire le masse smobilitate, con nuovi compiti, nella società, d ’ intenderle spesso nelle loro miserie e nelle loro grettezze, di fornire ad esse una parola d ’ordine che non fosse quella logora e stanca della negazione della guerra, già finita, e tanto sterilmente, un obiettivo che non fosse quello millenaristico di una rivoluzione « a tempo opportuno ».
Ottime riflessioni avanza il Catalano a proposito del carattere preminente (e grave più di ogni altro) di sedizione militare da attribuirsi alla impresa di Fiume e sulla genericità dell’appello di Nitti agli operai ed ai
contadini, a torto inteso, anche di recente, come un’apertura profondamente democratica dello Stato alle masse popolari, al di là degli stessi partiti. Nè esiterei a condividere, ancorché appaia un po’ salomonico nella puntigliosa ricerca ed assegnazione del diritto e del torto fra comunisti e riformisti, il giudizio sulla scissione di Livorno. E lo stesso dicasi allorché l ’A . esattamente individua nella collaborazione tra popolari e socialisti (ma con
quale presidente, essendo Nitti esautorato?) la sola logica e possibile soluzione della crisi seguita alla caduta del primo ministero Facta : o quandoscorge nella mancata fiducia nell’iniziativa popolare da parte dell’Aventino la causa principale del meritato fallimento di quest’ultimo, in critica corretta ma severa delle note opinioni di Amendola (una nota di costume: ipieni poteri dopo la marcia su Roma vennero concessi da un’assemblea un terzo della quale, comprese parecchie decine di deputati dell’estrema, erano assenti! Non per nulla Mussolini e la pubblicistica fiancheggiatrice individuarono subito il vero cadavere del 28
ottobre nel parlamento, che Amendola con caratteristica deformazione formalistica, s ’illudeva d ’aver nobilitato e vitalizzato in un’astensione che non sboccava nè nell’autonoma Costituente popolare nè nell’attiva ed assidua opposizione parlamentare alla legislazione fascista, che cominciava a toccare sistematicamente le istituzioni).
L ’analisi del periodo fascista, come s’è detto, si accentra su un esame dettagliato e documentatissimo degli elementi sociali ed economici della situazione, riportati, com'è naturale, ai termini internazionali di quest’ultima e ad essi costantemente collegati. La politica mussolinana viene così a perdere buona parte di quel colorito chiuso e provincialesco all’ interno, inquieto ed inconcludente all’ estero, con la quale la si vuole sommariamente valutare per trovare le sue giustificazioni o almeno i suoi moventi sempre in risonanze, più o meno pronte e cospicue, di avvenimenti internazionali. Si dilegua in tal modo l’immagine cara a certa pubblicistica deteriore così di parte fascista come antifascista di una Italia sequestrata dal mondo circostante, ripiegata su sè stessa a consumare una propria esperienza particolarissima ed irripetibile. Appare sempre più chiaro che l'Italia fascista, fino, come si diceva, allo choc violento e rivelatore della guerra di Spagna, non è stata affatto un elemento abnorme e neppure perturbatore nel quadro del concerto europeo fra le due guerre, nel quale si è inserita armonicamente, adeguandosi alle necessità quando queste fossero in contrasto con le premesse iniziali (la politica di difesa della lira), dibattendosi in difficoltà salariali e di
Recensioni 89
sovraproduzione comuni agli altri paesi capitalistici, pur se in Italia, naturai' mente, mancava quella vivacità di pressione e di denunzia propria di attivi ed autentici sindacati. Quanto d’altronde alla politica estera nella sua accezione tecnica, il problema delle origini e del fallimento del patto a quattro, suprema ed effimera misura di
equilibrio conseguita da Mussolini, resta tuttora aperto, nè possono sottacersi le responsabilità obiettive della Francia, impigliata nel suo sistema di garanzie che le impedivano una visione effettivamente e coraggiosamente innovatrice dèlia realtà europea. Sicché, scontata la bontà del metodo (del quale aveva peraltro offerto importanti anticipazioni Giampiero Carocci), resta da augurarsi che su questa via si prosegua, spostando magari l ’angolo d’osservazione, esaminando cioè il fascismo dall’esterno, la componente fascista nella politica europea di Londra o di Parigi. A questo arricchimento di prospettive dovrà finalmente accompagnarsi l'analisi sistematica delle componenti interne del fascismo. Si ha infatti l ’ impressione che il fenomeno, nelle sue grandi linee, e dopo gli inevitabili sbandamenti iniziali, abbia trovato rapidamente una sua dimensione storiografica nella quale convengono un po’ tutti gli studiosi. Il metodo di far parlare i fatti, le cifre, le statistiche, le testimonianze dei competenti, si è rivelato efficacissimo per tracciare diciamo così, il rendiconto, il consuntivo del fascismo nella vita italiana. Ora sarebbe però tempo di tornare ai programmi, alle intenzioni, agli uomini, in una parola: di mettere in chiaro che cosa il fascismo abbia voluto essere, ora che sappiamo, più o meno incontestabilmente, che cosa sia stato. Scriveva Salvemini, maestro insuperato di realismo storiografico, che il credere di essere è spesso non meno importante dell’ essere. Ed a noi interessa (mi sia consentito dire « a noi giovani », non per amore del vuoto cliché della generazione ma per il ricordo effettivamente sbiadito e nebbioso che abbiamo del fascismo « visto dal di dentro ») conoscere che cosa il fascismo abbia creduto di essere.. Il libro di Zangrandi che, avrebbe detto il generoso e caustico Luigi Russo, tanti petti ha scosso e inebriato (e tanti piedi d ’argilla, aggiungo io, ha rotto e pestato), ha avuto appunto questo gran merito, che trascende la perso
na dello scrittore e dei suoi pochi e stralunati amici d’un tempo: quello d ’aver tastato il polso del fascismo nel suo essere quotidiano, in un continuo susseguirsi di fantasmi, di ricordi, di speranze. Questo è il lavoro che ora andrebbe fatto : scendere giù dai primitivi bestioni archeologici del diciannovismo, dai Pasella e dai Terzaghi, giù per i tanti rivoli del fascismo repubblicano, sociale, sindacale, anticlericale, e poi ancora del nazionalismo fascista, del cle- rico-fascismo, della monarchia fascista, liberisti fiancheggiatori e socializzatori utopisti, i razzisti e gli internazionalisti, i vecchi intellettuali, i filosofi positivisti, e l’ irrazionalismo, e la nuova politica scolastica, e Bottai, e Spirito, e così via via, nell’immenso calderone, senza pretendere di mettere un ordine che non c’è, ma conoscendo però il disordine, prestando orecchio alle voci discordi e contraddittorie, che sono in fin dei conti voci della nostra storia, del nostro recente passato, e quindi appartengono indissolubilmente a noi stessi.
Senza dubbio l’ analisi dei fenomeni economici non esaurisce il quadro del condizionamento internazionale del fascismo e non vale a motivare interamente la politica del fascismo. Il Catalano si rende conto benissimo di ciò ed è proprio lui ad avvicinare, senza che tra le due posizioni si possa stabilire un rapporto rigoroso da causa ad effetto, le responsabilità anglo-americane nel traffico mondiale alla volontà di guerra del fascismo nell’ impresa etiopica (una volontà dunque che ha le sue scaturigini autoctone in quel gran ribollimento cui si accennava dianzi, e che conduce direttamente al momento di frattura della guerra di Spagna, una frattura unanimemente auspicata dal fascismo, ma con una gamma infinita di sfumature, di giustificazioni, che metterebbe conto indagare). Questa volontà di guerra, d’altronde, con la politica autarchica ad essa connessa, sposta obiettivamente l’economia nazionale ad una fase più avanzata dello sviluppo capitalistico, con l’ inizio della curva descensio- nale dell’economia agricola, che non si arresterà più fino ai giorni nostri, con l’espandersi della concentrazione monopolistica (e qui sarebbero da vedersi le infiltrazioni di questi colossi nella struttura burocratica e legislativa dello Stato), col passaggio in primo piano, con funzione egemonica non più di élite ma di massa, degli operai metalmeccanici
go Recensioni
dei vecchi scioperi torinesi rispetto al resto del proletariato.
A partire dalle vicende del 25 luglio, dopo una narrazione chiara ed equilibrata di quelle belliche (a proposito delle quali, forse, non c’è più gran che da aggiungere : notevoli le riserve del-l’A . circa il patto russo-tedesco, valutato comunque, com’è indiscutibile, sotto il mero profilo della politica di potenza sovietica, senza alcuna preoccupazione ideologica) l ’opera del Catalano si rende assai particolareggiata ed a noi converrà perciò sottolineare maggiormente qualche spunto da suggerire come ipotesi di lavoro. Così dicasi innanzi tutto per la sfumatura che separa Grandi da Bottai nell’opposizione a Mussolini. Dal sabotaggio del patto di pacificazione del 1921 fino a questa soluzione di autoritarismo monarchico, attraverso la politica anglofila diretta in funzione antibolscevica, Grandi è costantemente l ’uomo di una conservazione aggressiva, l’esponente di ben precisi interessi sociali ed economici che non rifuggono dal terrorismo pur di mantenere ad ogni costo i loro privilegi. Grandi e Balbo rappresentano le due faccie di una medesima violenza sistematica padana: ed ecco una nuova concordia discors la cui storia ventennale varrebbe la pena di ricostruire accuratamente! Bottai è viceversa un fascista tipico, tout court, un mussoliniano, si direbbe, ed è al tempo stesso un genuino e tradizionale uomo di cultura. Tutta la politica culturale, burocratica o militante, di Bottai si pone come uno dei temi più fascinosi a cui urge cominciare ad attendere: e si può prevedere cosa ardua lo sceverare in essa le parti riportabili ad una fronda stancamente velleitaria ed intellettualistica nei confronti del fascismo, o ad una captatio propagandistica degli intellettuali di professione, o ad un approfondimento e potenziamento coerente di posizioni tipiche del fascismo, o ad un’oasi di civile ed urbana tolleranza culturale più o meno disinteressata, od infine ad un sottofondo politico che mantenesse una circolazione europea nel- la_ cultura italiana e, di conseguenza, un contatto d’ incontri e di scontri con le correnti più vive della cultura militante o addirittura dell’antifascismo politico.
Argomento di molto interesse è anche quello concernente i programmi di pacificazione ventilati a lungo da Mus
solini durante la repubblica sociale, non tanto magari nel circoscritto ambito italiano (dove questa politica aveva chiare caratteristiche di disperato recupero, e venne comunque respinta con fermezza e con chiara coscienza politica dalle masse lavoratrici) quanto nella prospettiva di una compatta resistenza italiana all’ invadenza germanica. Scontati gli elementi della compressione brutale esercitata dal comando tedesco suH’ammini- strazione civile e militare della repubblica di Salò, e della funzione assoluta- mente complementare e subordinata riservata a quest’ultima, in prevalente funzione terroristica anti-partigiana, restano però da studiare nel dettaglio, in sede locale, gli atteggiamenti delle autorità fasciste nei confronti della cittadinanza da un lato e dei tedeschi dall’ altro, quando non addirittura della stessa Resistenza (penso soprattutto alla deportazione di operai italiani in Germania, alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, e soprattutto di quello industriale, alla protezione di riserve monetarie, di istituti, ecc.). In questo quadro due altri interlocutori, il ceto capitalistico e l’episcopato, andrebbero tenuti attentamente presenti. E — last but non least — si dovrebbe rivolgere un'attenzione, diciamo così, più individualizzante ai tedeschi, presentati fin qui impersonalmente come una sorta di Unni o di leones, e che bisognerebbe cominciare a studiare nei loro particolari atteggiamenti, nelle situazioni locali e così via. E ’ cosa singolare che a quest’esigenza si siano dimostrate più sensibili la narrativa e la cinematografia che non la storiografia : una figura delicata e complessa, espressione di tutta una tradizione culturale ed ambientale che non si può liquidare con un tratto di penna, come quella dell’ indimenticabile colonnello tedesco del Generale Della Rovere non si è fin qui ripetuta in un’opera di storia.
Aggrovigliato viluppo è anche quello costituito dalle conseguenze della famosa « mossa » di Togliatti che poteva anche avere come effettivo obiettivo quello di screditare ed indebolire il ministero Badoglio, mostrandolo incondizionatamente succube della politica anglo- americana ed incapace d'una energica iniziativa autonoma nei confronti della monarchia, salva l'uscita definitiva del partito comunista dallo stato di semi- illegalità e di semi-clandestinità in cui
Recensioni 91era vissuto, si può dire, sin dall'imme- diato domani di Livorno. La politica comunista, lo ripetiamo, era legata tenacemente a determinate prospettive internazionali contingenti (la politica di potenza mediterranea dell’Unione Sovietica nella primavera 1944), ad un formalismo legalitario scrupolosamente osservato (l’ ingresso nel ministero) ed infine ad un remoto obiettivo di propaganda popolare di massa, da esercitarsi da quadri già addestrati ed efficienti (la polemica, una volta accantonato l’ostacolo della monarchia, contro un gabinetto nel quale le forze tradizionali del liberalismo erano largamente ed autorevolmente rappresentate, e potevano venir descritte come incapaci ad affermare il rinnovamento nazionale post-fascista e l’indipendenza dinanzi allo straniero). Può sembrare di trovarsi di fronte ad esigenze incoerenti e contraddittorie, affastellate fra di loro in precario equilibrio: e può essere così: ma può anche esservi un disegno organico, nella varietà ed ambiguità di piani sfuggenti caratteristiche della tattica comunista quale corrispettivo di una sostanza fortissima ostinatamente sviluppata e perseguita : e varrebbe la pena di esplorarlo: svolgendo ad esempio, per i suoi riflessi con l'epurazione, con la giustizia penale, con l’ indipendenza e la riforma della magistratura (tutti problemi centrali non solo della ricostruzione ma un po’ di tutta la vita democratica italiana) una ricerca monografica sul biennio dei guardasigilli comunisti Togliatti e Gullo, affiancata magari da una consimile sui rapporti e i conflitti, al controllo della finanza italiana, tra Scoccimarro ed i liberali Soleri e Corbino (e qui una piccola parentesi : una ricerca del genere andrebbe compiuta su un altro biennio, quello nel corso del quale ministri popolari hanno ininterrottamente presieduto all’agricoltura italiana, mettendo in raffronto l’azione legislativa del 1920-22 con i programmi del partito, con la tradizionale sollecitudine cattolica per i problemi agricoli, con la particolarissima situazione delle campagne nel primo dopoguerra).
Ma qui facciamo punto, che l’opera del Catalano davvero ci provoca e ci pungula con una serie di stimolanti spunti, che auguriamo poter essere raccolti dai giovanissimi, dall’opposizione di socialisti ed azionisti al primo ministero De Gasperi alla preparazione elet
torale del referendum, al « re di maggio » e così via. Catalano, che è uno storico ed un democratico militante, riconoscerà in questo fervore di lavoro che mi si è venuto delineando nella mente leggendo il suo libro, e che certamente era ben più limpido e pulsante in lui nello scriverlo, la lode più sincera e spontanea alla sua fatica, ed il premio migliore che egli potesse attendersene e — non ne dubitiamo — a buon diritto se ne attendeva.
Raffaele Colapietra.
Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Einaudi editore, Torino, 1961, pp. XL - 968, L . 6000.
L ’interesse che muove l'A ., per sua esplicita dichiarazione nella Prefazione, è un interesse da storico : apportare un contributo alla storia del fascismo, più precisamente dare un esempio concreto di quella « indagine per singoli aspetti » di tale storia, che egli giustamente ritiene sia ormai necessaria e matura. Che il fascismo possa e debba essere oggetto di serena indagine storica, come qualsiasi altro fenomeno o periodo delle vicende umane, ci pare non doversi neppure mettere in discussione; ma appunto perciò non bastano a soddisfare le molte e complesse esigenze della conoscenza storica le storie generali (tipo l’ottima Storia d ’Italia nel periodo fascista del Salvatorelli e del Mira) o alcune indagini particolari, vertenti soprattutto, come dice l’A ., su « l’approfondimento dei primi anni del fascismo, dall’intervento al delitto Matteotti in specie, e di aspetti particolari della politica estera fascista ».
Per capire, insomma, che cosa sia stato il fascismo in atto occorre studiare la « società italiana durante il fascismo»: partire quindi, soggiungiamo noi, non dalla teoria dell’ improvvisa invasione degli Hyksos, ma da quella opposta, ed unica esatta, che vede nel fascismo un prodotto della moderna storia d’ Italia. E vogliamo chiarire, di passaggio, che non intendiamo questa spiegazione nel senso « panfascistico » del Mack Smith, ma nel senso che la struttura della società italiana portava in se, come un germe latente, il fascismo, pronto a svilupparsi, come infatti avvenne, quando avesse trovato il terreno
92 Recensioni
di coltura propizio (la reazione della classe dirigente, politica ed economica, alla Rivoluzione d’ottobre ed alla crisi del dopoguerra). Il merito preliminare del De Felice è dunque di proporre questo metodo di studio della storia italiana nel periodo fascista, esemplificandolo, con scelta veramente indovinata, nella presente opera sugli ebrei italiani sotto il fascismo.
Gli ebrei infatti, come dice l’A. (sempre nella Prefazione) si prestano ancora meglio di altri settori della società italiana — p. es., la burocrazia, l’esercito, la borghesia o il proletariato in genere, etc. etc. — a illustrare i rapporti tra il fascismo e la società stessa. Pur avendo l’ ebraismo italiano « tutta una serie di sue peculiarità », « esso ha avuto però altrettanto indubbiamente con il fascismo dei rapporti ed un comportamento che possono dirsi tipici. In un certo senso, l’ ebraismo è stato una piccola grande città, con i suoi interessi ed i suoi maggiorenti, i suoi istituti amministrativi, ì suoi rapporti con il resto del paese e con l’estero, la sua vita politica e sociale ». Se poi si tiene presente, come del resto il De Felice fa, « lo spiccato carattere borghese dell’ebraismo italiano » (p. 87), il valore indicativo dei rapporti ebraismo-fascismo per il problema generale dei rapporti società italiana-fascismo ne risulta accresciuto, poiché è noto che il fascismo fu essenzialmente un fenomeno borghese.
Gli ebrei italiani, dunque, erano degli italiani come tutti gli altri loro concittadini; erano, in altri termini, degli italiani di religione ebraica (per coloro che la professavano) e con certe loro tradizionali caratteristiche di gruppo sociale, come tanti altri gruppi della estremamente varia e composita società italiana. Per il fatto di trovarsi a vivere in un paese nel quale « sin dalla seconda metà del XVIII secolo non esisteva più... una questione ebraica », la tendenza alla assimilazione venne enormemente favorita, sicché « gli ebrei italiani si inserirono rapidissimamente nella nuova società italiana» (pp. 16-7). Senza seguire nei particolari la convincente e documentata dimostrazione che di ciò dà l’A ., si può pertanto concludere che, quando apparve il fascismo, gli ebrei si comportarono, nè più nè meno, come gli altri italiani. E questo è un punto fermo acquisito dall’ inda
gine del De Felice, veramente capitale per le conseguenze che ne discendono.
Anzitutto, precisamente come la comune degli italiani cui si erano assimilati, gli ebrei non compresero il fascismo per quello che realmente era, come invece videro subito esigue minoranze e come noi oggi, a tragedia consumata, sappiamo benissimo. Al contrario, il fascismo trovò « tra gli ebrei un vasto seguito; forse più vasto di quanto si credeva »; ed il motivo è esattamente colto, subito dopo, dal De Felice, nel « carattere classista del fascismo delle ” origini ” » e nel già citato « carattere spiccatamente borghese dell’ebraismo italiano » (p. 87). Inconcreto, un agrario ferrarese, fosse ebreo o non, reagiva egualmente di fronte al fascismo: scorgeva in esso un elemento d ’« ordine » contro i <> sovversivi » e plaudiva, ed anche peggio, alle squadracce di Balbo e compagni. Se Balbo (e così gli altri capi fascisti) oggettivamente fu lo strumento cui i « padroni » commisero l’esecuzione delle basse opere a tutela dei loro interessi, si spiega il filosemitismo del quadrumviro, proveniente da una città del cui ceto padronale facevano parte numerosi ebrei. Il che, è doveroso aggiungere, non sminuisce il coraggio col quale Balbo si oppose alla legislazione antisemitica e si battè, nella seduta del Gran Consiglio del 6 ottobre, contro Mussolini e la quasi totalità dei membri del Gran Consiglio (gli unici altri a parlare contro furono Federzoni e De Bono).
Cosi vi furono tra gli ebrei da un canto finanziatori del fascismo, dall’ altro squadristi, partecipanti alla « marcia su Roma », almeno cinque « sansepol- cristi » (tra i quali Cesare Goldmann che procurò la sala dell’Unione industriale in Piazza S. Sepolcro a Milano) e tre « martiri fascisti ». Di contro a costoro, appunto come avveniva all'interno della borghesia italiana, si ebbero politici ed intellettuali che furono decisamente antifascisti; come gli ebrei, nel periodo postrisorgimentale, si erano dispersi « nei partiti politici italiani di tutte le tendenze » (p. 23), così ritroviamo ebrei nei partiti antifascisti (tranne, ovviamente, il cattolico). Ma i Treves ed i Modigliani, solo per fare dei nomi, non erano antifascisti in quanto ebrei, bensì in quanto socialisti; per nulla differenti, ancora una volta, dagli altri italiani socialisti (o comunisti, libe
Recensioni 93
rali, etc.) che si opponevano al fascismo. Che vi fosse una « massiccia presenza di ebrei tra gli antifascisti » (p. 88) dipende dal fatto che elevato era il numero degli intellettuali e politici ebrei presenti ed attivi nella sinistra italiana.
Questo da parte degli ebrei alle origini del fascismo. Da parte del fascismo e delle sue matrici ideologiche (nazionalismo, irrazionalismo, attivismo) vi era una componente antisemita? Oppure il fascismo si atteggiò verso gli ebrei in maniera non dissimile da quella con cui prese posizione riguardo ad altri gruppi della società italiana? 11 De Felice risponde nettamente nel secondo senso : « il fascismo... si è comportato con esso U’ebraismo italiano] in una maniera che possiamo pure definire tipica: diffidenza verso le vecchie strutture e i vecchi uomini, tentativo di sfruttarlo ai suoi fini (e controtentativo di essere a sua volta sfruttato per altri fini), azione periferica di fascistizzazione e quindi azione diretta al « centro » per impadronirsene.,.» (Pref., p. XXXVI).
E invero, se il fascismo era un prodotto della società italiana, non poteva non derivare da essa anche la quasi totale assenza di razzismo e di antisemitismo. Quanto al razzismo, « tanto la psicologia popolare quanto la cultura (neppure quella media e più provinciale) non hanno mai veramente conosciuto in Italia l’ eccitamento razziale ed il razzismo » (p. 30). Quanto invece all ’antisemitismo, la questione è più complessa: mentre, per tutto il secolo scorso, non vi fu in Italia un vero antisemitismo di massa come in altri paesi (cfr. p. 35), si ebbe però, per tutta la seconda metà dell’Ottocento, l’antise- mitismo cattolico (cfr. p. 35 e segg.), al quale con il Novecento (venne progressivamente affiancandosi quello dei nazionalisti e, via via, dei sindacalisti- rivoluzionari, dei fascisti » (p. 50). Di fatto, come giustamente osserva il De Felice, l’antisemitismo dei nazionalisti fu un motivo secondario ed accessorio della loro ideologia e della loro azione politica, soprattutto per l’ inesistenza d’un problema ebraico veramente vivo in Italia (cfr. pp. 50-1).
Ma in linea di principio il razzismo (e la sua specificazione, l’antisemitismo) è una componente connaturata all’ irrazionalismo nazionalistico, in quanto dottrina che nega l’ eguaglianza di tutti gli uomini e postula il diritto dei più forti,
la legge della violenza, la superiorità di alcuni individui o di una nazione sulla massa degli altri individui o sulle altre nazioni. Il fascismo, inteso in senso lato, è tutto insieme e indivisibilmente nazionalismo, imperialismo, razzismo: che l’essere inferiore sia il proletario, lo slavo dell’Europa orientale, il negro0 il giallo delle colonie, l’ebreo, non fa una sostanziale differenza; si tratta sempre d ’una tipica soprastruttura della fase estrema (e degenerata) del capitalismo, quando questo si ritiene minacciato di sopraffazione. Così nell’Italia delle « spedizioni punitive », così nella Germania nazista, così nell'Algeria dei paras, nell’Angola del moribondo colonialismo portoghese.
Pur non essendo questo il suo tema, forse il De Felice avrebbe dovuto almeno accennare a questa situazione di fondo; non per divagare dalla sua serrata ricostruzione documentaria in generalità, ma perchè, ci sembra, solo così si spiega il processo di involuzione che portò al razzismo ed all’antisemitismo in Italia. Non furono certo untorelli come il Preziosi che riuscirono infine a trascinare dalla propria Mussolini ed i dirigenti fascisti; fu invece lo sviluppo oggettivo della situazione, dalla guerra d’Etiopia a quella di Spagna all’alleanza con la Germania nazista, che ineluttabilmente produsse la svolta in senso razzistico ed antisemitico dal 1936 alle leggi infami del ’38. Per quanto poco contasse in un regime totalitario come il fascista l’opinione pubblica, è tuttavia sintomatico che la svolta sia stata preceduta da una campagna di stampa contro gli ebrei (cfr. pp. 238-57), guidata da un Farinacci, che certo non prendeva l’ imbeccata dal duce.
Fra le cause dell'evoluzione di Mussolini verso il razzismo e l’antisemitismo l ’A . mette in particolare rilievo l’ influenza dell’entourage del duce e soprattutto la nuova fase dei rapporti con1 nazisti (pp. 281 e segg.). Ora, appunto nell’ entourage si trovavano « molti fascisti della nuova generazione, non... esenti da forme più o meno marcate di antisemitismo » (p. 281); il che sarebbe da interpretarsi, secondo noi, nel senso che, mentre nella vecchia Italia delle origini del fascismo predominava ancora una mentalità del tutto estranea al razzismo e all’antisemitismo, nella nuova generazione invece, formatasi secondo l’ ideologia nazionalfascista, que-
94 Recensioni
sta aveva coerentemente dato i suoi frutti, anche quelli attossicati del razzismo e dell’antisemitismo. Si aggiunga l ’ influsso del nazismo ormai al potere e lo scoppio del razzismo fascista non apparirà più come un fulmine a ciel sereno, ma come il portato della logica inesorabile del fascismo, qualche cosa, insomma, che esso portava naturalmente nel seno e che prima o poi, sollecitato da una od altra occasione, doveva finire col manifestarsi.
Il De Felice scrive che « non vi è dubbio... che la decisione fu presa sostanzialmente da Mussolini e che su di essa queste pressioni non ebbero che un peso secondario » (p. 286); le pressioni sono quelle dei « vari Farinacci »); e che la decisione del duce « fu determinata essenzialmente dalla convinzione che per rendere granitica l’ alleanza ita- lo-tedesca fosse necessario eliminare ogni stridente contrasto nella politica dei due regimi » (ibidem). L'esattezza di queste asserzioni, che certamente riconosciamo, non toglie però valore al quadro generale entro il quale esse vanno collocate; non per una nostra pretesa di spiegare la storia con una logica sovra- storica, anziché con i fatti concreti, ma perchè quella che abbiamo chiamato la logica del fascismo era ben intrinseca alla realtà storica del fascismo. Come la storia della Germania nazista, insomma, non si spiega con il satanismo o la follia di un solo individuo, Hitler, così pure la storia dell’Italia fascista, compreso il razzismo e l’ antisemitismo, non si spiega con le decisioni del duce, sia pure motivate da un preciso calcolo politico.
Un fulmine a ciel sereno, invece, i provvedimenti del ’ 38 furono per gli ebrei italiani, appunto perchè, in quanto italiani, mai avrebbero potuto aspettarseli; e così egualmente avvenne per la stragrande maggioranza degli italiani.
Occorre ancora una volta osservare che, pure in questo caso, gli ebrei si dimostrarono italiani come tutti gli altri, cioè colti di sorpresa dalle decisioni dei dirigenti fascisti. Ma questo aspetto della politica fascista dimostra altresì che il fascismo, per quanto prodotto dalla società italiana, non si identificava con essa; ne era, sì, una malattia endogena, ma non letale, poiché l'immensa maggioranza degli italiani, in definitiva, non era nè nazionalista (se non alla superficie) nè imperialista nè, meno che mai, razzista. Perciò « per moltissimi italiani la campagna antisemita scatenata nel 1938 fu il primo vero choc politico dopo il delitto Matteotti, fu il primo fatto che veramente fece aprire loro gli occhi sul conto del fascismo e segnò l'inizio del loro divorzio da esso » (p. 376). E il divorzio, com’è risaputo, fu ben presto consumato, sino alla lotta violenta della Resistenza, con la quale l’Italia espulse da sè il morbo fascista.
Ma intanto le persecuzioni fasciste avevano umiliato e fatto soffrire i nostri fratelli ebrei, nell’ attesa che i nazisti, serviti dagli sgherri della « repubblica sociale », ne avviassero una parte verso il martirio senza ritorno dei campi di concentramento e dei forni crematori. Inutile insistere su queste vicende dolorose e disumane, che il De Felice narra ampiamente e ottimamente, con la severità dello storico che non può non condannare, proprio per essere oggettivo, il male senza scusante alcuna. Se pochi italiani, allora, si riscattarono aiutando gli ebrei a costo di rischi e della morte, a noi tutti, ebrei e non, tocca meditare la lezione che questo libro ci offre: ancora una volta la lezione, non moralistica ma realistica, che il fascismo, sia pure il più bonario, all’ italiana, finisce sempre in barbara tragedia.
Ferdinando V egas.