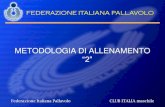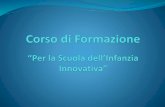PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA CLASSI TERZE · Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia...
Transcript of PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA CLASSI TERZE · Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia...

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 1
PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA CLASSI TERZE
LA PALLAVOLO - LA PALLACANESTRO - LA PALLAMANO
La storia - il campo - il gioco - regole di gioco - i falli/le infrazioni - i fondamentali individuali - i ruoli principali.
L’ATLETICA LEGGERA
La storia - il campo - le specialità dell’atletica: le corse, i salti, i lanci, le prove multiple.
L’ORIENTEERING O CORSA D’ORIENTAMENTO
La storia - lo svolgimento della gara.
RAPPORTO FRA ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE
L’esercizio fisico regolare come prevenzione di alcune malattie - gli effetti benefici indotti dall’attività motoria sui vari
apparati del corpo umano.
IL DOPING
Origini e storia del doping - le categoriedelle sostanze dopanti
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
LESIONI DEI TESSUTI: Contusione - Ferita - Emorragia dal naso.
LESIONI MUSCOLARI: Stiramento - Strappo - Crampo.
LESIONI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI: Distorsione - Lussazione - Frattura.
I PARAMORFISMI
Scoliosi - Lordosi - Cifosi - Piede Piatto
ESTRATTO DA "LINEE GUIDA PER UN CORRETTO STILE DI VITA"
ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE
CONSIGLI PER GLI STUDENTI
IL FAIR PLAY
CARTA DEL FAIR PLAY
INDICAZIONI PER LE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA
1. Materiale necessario:
Tuta o pantaloncini
scarpe da ginnastica con chiusura a strappo o con stringhe allacciate
maglietta di ricambio
asciugamano piccolo
sapone o salviette umidificate
Per motivi igienici le scarpe da ginnastica utilizzate per la lezione di Educazione Fisica devono essere messe
al momento di iniziare l’attività motoria in palestra e non “calzate” già da casa.
Per motivi igienici al termine della lezione si deve cambiare la maglietta che è stata a contatto con la pelle.
La dimenticanza di parte del materiale necessario potrebbe non permettere la partecipazione alla parte motoria
della lezione.
2. Esoneri
I genitori i cui figli presentino problemi di salute che possono limitare o impedire la pratica motoria, anche per una sola lezione,
devono informare l’insegnante tramite comunicazione scritta o, se preferiscono, tramite colloquio individuale.
Per la richiesta di esonero per diverse settimane e/o fino al termine dell’anno scolastico dalla parte motoria delle lezioni, è
necessario risolvere gli adempimenti del caso ( richiedere ai bidelli il modulo da compilare e allegare certificato medico da
consegnare in segreteria).
3. La valutazione dell’alunno in Educazione Fisica
Il giudizio dell’allievo sarà formato dalla valutazione dei 3 punti che seguono inseriti nelle competenze da acquisire:
Saper essere: rispetto delle regole, dei compagni/avversari, delle decisioni arbitrali, del risultato; partecipazione e
collaborazione dimostrate nelle varie attività proposte e assunzione di comportamenti adeguati di sicurezza
Saper fare: abilità motorie dimostrate nei test, nelle esercitazioni, nei giochi non sportivi e sportivi
Sapere: conoscenza dei contenuti “teorici” legati agli argomenti trattati attraverso la valutazione di verifiche scritte.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 2
DATI ANTROPOMETRICI E TEST
N.
1^ MEDIA 2^ MEDIA 3^ MEDIA
1 Peso
Kg. ………… Kg. ………… Kg. …………
2 Altezza
cm. ………… cm. ………… cm. …………
1
Velocità: 60/80 metri data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………
2
Resistenza: 1000 metri data …….…………
metri ……………...
data …….…………
metri ……………...
data …….…………
metri ……………...
3
Salto in lungo data ……………….
metri …..………….
data ……………….
metri …..………….
data ……………….
metri …..………….
4
Salto in alto data ……………….
metri …..………….
data ……………….
metri …..………….
data ……………….
metri …..………….
5
Getto della palla
medica/Lancio del vortex
data …….…………
metri ……………...
data ……………….
metri …..………….
data ……………….
metri …..………….
6
Salto in lungo da fermo data …….…………
cm. …….…………
data …….…………
cm. …….…………
data …….…………
cm. …….…………
7 Forza arti superiori: Tenuta
alla spalliera
data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………
8 Mobilità colonna vertebrale data …….…………
cm. …….…………
data …….…………
cm. …….…………
data …….…………
cm. …….…………
9 Percorso destrezza data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………
data …….…………
sec. …….…………

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 3
LA PALLAVOLO (Volley)
La storia
La pallavolo fu ideata nel 1895 da William Morgan, insegnante di Educazione fisica all’università Y.M.C.A. del Massachussets
(Stati Uniti d’America); lo scopo era quella di tenere allenati i giocatori di rugby e baseball durante il periodo invernale.
William Morgan cercava un gioco che escludesse ogni contatto fisico fra i partecipanti.
La pallavolo si diffuse rapidamente nei college americani, ed ebbe un notevole successo in molti paesi del sud-est asiatico; in
particolare in Giappone dove divenne sport nazionale.
In Europa la pallavolo venne introdotta dai soldati americani giunti in Francia durante la prima guerra mondiale.
Nel 1964 a Tokio, la pallavolo divenne sport olimpico.
Il campo
Il campo di gioco è un rettangolo lungo 18 metri e largo 9 metri; è diviso a metà da una rete e da una linea centrale tracciata al
suolo.
Ciascuna metà campo è divisa in due zone (attacco e difesa) da una linea tracciata a 3 metri dalla rete.
La rete posta sopra la linea centrale misura 9,5 metri di lunghezza ed 1 metro di larghezza; è alta 2,43 metri per gli uomini e 2,24
metri per le donne ( 12-13 anni: 2,24 per i maschi e 2,15 per le femmine; 13-15 anni: 2,35 per i maschi e 2,20 per le femmine).
Il gioco
Si fronteggiano due squadre composte ognuna da 6 giocatori in campo e 6 riserve in panchina.
Ogni squadra cerca di far cadere la palla (la palla misura 65 cm. di circonferenza e pesa da 260 a 280 grammi) nel campo
avversario colpendola con qualsiasi parte del corpo; la palla deve passare al di sopra della rete che divide le due squadre.
Sono consentite 6 sostituzioni per set, ma quando un giocatore entra in campo a sostituire un suo compagno, questi può rientrare
solo su chi ha preso il suo posto e non può più essere cambiato in quel set.
Vince la squadra che si aggiudica 3 set su 5.
Regole di gioco
La partita ha inizio con la squadra sorteggiata che effettua la battuta (il pallone in battuta deve essere colpito con una sola mano)
con il proprio giocatore che si colloca dietro la linea di fondo campo.
All’inizio i giocatori devono essere disposti in campo in un modo preciso; in caso contrario la squadra commette un’infrazione.
Se la squadra che batte conquista il punto, ha diritto anche alla battuta successiva e continua a battere con lo stesso giocatore.
La squadra che ottiene il punto e contemporaneamente toglie il diritto alla battuta (cambio palla) agli avversari, deve ruotare in
senso orario di un posto; in questo modo ogni volta che si toglie la battuta agli avversari cambia il giocatore che batte.
Come già detto vince la squadra che si aggiudica 3 set su 5.
Ciascun set termina quando una squadra conquista 25 punti con almeno 2 punti di vantaggio; nel caso di parità a 24 punti (o 14
pari nel 5° set), l’incontro prosegue fino a quando una squadra realizza un vantaggio di 2 punti.
Una squadra conquista il punto:
quando la palla cade a terra nel campo avversario

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 4
quando la squadra avversaria commette un infrazione
quando la squadra avversaria riceve una penalizzazione
quando la squadra avversaria manda la palla fuori dal terreno di gioco o comunque non riesce a mandare la palla nel
campo avversario.
Ciascuna squadra può usufruire di 2 sospensioni (time-out) di 30 secondi per set.
All’8° ed al 16° punto di ogni set (tranne il 5° set), è previsto un time-out tecnico.
Le infrazioni
Vi sono infrazioni a rete, di tocco, di posizione; vengono punite con la conquista del punto e il diritto alla battuta a favore della
squadra avversaria.
a rete:
infrazione di rete: toccare la rete con qualsiasi parte del corpo
invasione: invadere il campo avversario superando completamente con un piede la linea centrale o colpendo la palla
oltre la rete ( ad esclusione del “muro”).
di tocco:
doppia: un giocatore colpisce la palla con due diverse parti del corpo, oppure prima con una mano e poi con l’altra, o
tocca la palla due volte di seguito
quattro tocchi: la squadra colpisce la palla più di tre volte prima di rinviarla (ad esclusione del “muro”)
trattenuta: il pallone non viene respinto con un colpo veloce, ma viene trattenuto o accompagnato
di posizione:
al momento della battuta, uno o più giocatori non sono in posizione corretta (solo dopo la battuta è consentito spostarsi
nel campo); i giocatori di seconda linea (zona di difesa) non possono mandare la palla nel campo avversario saltando
all’interno della zona di attacco.
I fondamentali individuali
I fondamentali individuali, cioè i movimenti principali della pallavolo sono 5: la battuta, il bagher, il palleggio, la schiacciata, il
muro.
La battuta. È il fondamentale con cui si inizia il gioco, ma è da considerarsi un’azione di attacco per la possibilità di ottenere
subito il punto o per le difficoltà che si possono creare agli avversari. La palla viene colpita con una mano, con un movimento
del braccio che può effettuarsi dal basso (battuta di sicurezza) o dall’alto ( battuta a tennis o in salto).
Il bagher. È un fondamentale di difesa e di ricezione. Serve per ricevere su battuta, schiacciata, e in generale per ricevere palloni
che arrivano con traiettorie basse e veloci. Viene effettuato unendo le due braccia e toccando la palla con gli avambracci, al di
sopra dei polsi.
Il palleggio. È il fondamentale più usato. Serve per passare, respingere, alzare la palla. Il palleggio consiste in un tocco
simultaneo delle due mani al di sopra della testa, che permette di indirizzare la palla con precisione Il palleggiatore (alzatore) è
il regista delle azioni di attacco, come il play-maker della pallacanestro.
La schiacciata. È il fondamentale di attacco. Prevede una fase di rincorsa, stacco verso l’alto, salto e colpo con la mano aperta
e movimento rapido delle braccia; permette al giocatore di mandare la palla nel campo avversario con velocità, forza e precisione.
Il muro. È il fondamentale di difesa utilizzato per contrastare la schiacciata avversaria. Serve ad impedire che la palla colpita
dagli avversari superi la rete. Può essere effettuato da uno, due o anche tre difensori contemporaneamente. Il giocatore parte da
posizione vicina a rete e salta, ponendo le braccia tese e le mani rigide con dita aperte al di sopra della rete, cercando di porsi
sulla traiettoria della palla.
I ruoli principali
Alzatore o palleggiatore. È il regista della squadra, ed ha il compito di organizzare il gioco d’ attacco della squadra. È il
giocatore che di solito effettua il 2° dei tre tocchi consentiti per indirizzare la palla allo schiacciatore. È un giocatore che deve
essere abile nel palleggio, veloce, tatticamente intelligente.
Attaccante centrale o centro. È il giocatore più impegnato in zona d’attacco. Oltre a saper schiacciare deve partecipare a tutte
le azioni di muro. Deve possedere elevazione e rapidità.
Schiacciatore-opposto. . Il ruolo è coperto dal giocatore situato in posizione diametralmente opposta a quella del palleggiatore.
Schiacciatore-laterale. È, forse, il ruolo più faticoso di tutti perché richiede al giocatore sia di ricevere (anche quando è in prima
linea) che d'attaccare. Per questo è richiesta una certa completezza tecnica nell'esecuzione dei fondamentali.
Libero. Il libero è un giocatore specializzato nella difesa che può entrare in gioco al posto di un compagno di seconda linea; non
può battere, attaccare o murare. Gioca con una maglia di colore diverso da quello dei compagni, le sue sostituzioni sono illimitate
e non sono conteggiate come normali cambi (non rientrano nelle 6 sostituzioni per set).
PALLAVOLO

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 5
Esercizi di sviluppo della motricità degli arti inferiori e propedeutici al palleggio
1. valutazione della traiettoria della palla e spostamento antero-posteriore: a coppie, A lancia la palla e B dalla posizione di
partenza a circa 5 m. di fronte ad A si deve portare nella zona di caduta della palla prima che essa inizi la fase
discendente. Dopo aver afferrato il pallone B lo rilancia ad A ed arretra nella posizione di partenza prima che inizi la
fase discendente della traiettoria (concetto di posizione di lavoro, dalla quale si parte per qualsiasi tipo di spostamento
inerente una fase di gioco)
2. valutazione di una traiettoria angolare e spostamento laterale: A lancia la palla a dx o sx di B, che si deve spostare
lateralmente a passi laterali accostati e piazzarsi prima che inizi la fase discendente della parabola per afferrare poi la
palla
3. combinazione dei due esercizi precedenti.
Esercizi per il Palleggio
1. dopo aver dimostrato e spiegato l'esecuzione corretta del palleggio (il contatto con la palla deve avvenire con i polpastrelli
di tutte le dita, le dita hanno rispettivamente funzioni diverse: i due pollici hanno principalmente funzione di trattenere la
palla affinchè non sfugga dalle mani; il medio e l'indice quella di trattenere e spingere la palla elasticamente imprimendo
alla palla la spinta di volta in volta necessaria; l'anulare ed il mignolo assicurano la precisione della direzione del
palleggio. La palla va colpita davanti alla fronte con un'estensione coordinata degli arti superiori [che formano un angolo
di 90^ fra di loro] e inferiori, si deve tenere il peso prevalentemente sulla gamba anteriore), si fa provare l'imitazione del
palleggio prendendo e rilanciando la palla prima da soli e poi a coppie passandola al compagno di fronte
2. lanciare in alto la palla a due mani e palleggiarla una volta sopra il capo
3. come sopra ma con due o più palleggi
4. come sopra ma al segnale camminare continuando a palleggiare
5. a coppie: palleggiare a diverse altezze e distanze
6. a coppie: mentre A esegue il palleggio di controllo alto sopra il capo, B si sposta av. o ind., a dx o a sx., ed A deve
individuare la posizione assunta da B per inviargli il pallone con precisione. B restituisce in palleggio ad A e deve
tornare in posizione di lavoro e si riprende di seguito
7. a gruppi di tre disposti a triangolo rettangolo: A passa la palla a C in diagonale e si sposta con passi veloci laterali verso C
che gli restituisce la palla in palleggio, A passa la palla a B che si trova ora in diagonale rispetto ad A e si continua con A
che fa passaggi in diagonale spostandosi lateralmente dopo aver fatto il passaggio (cambiarsi di posizione dopo un tempo
prestabilito e ricordare a chi palleggia che negli spostamenti laterali il piede esterno va portato avanti).
Esercizi per la Battuta
1. dal basso o di sicurezza: dopo aver dimostrato e spiegato come si esegue la battuta dal basso (si esegue con la gamba sx
avanti; il pallone è sorretto dalla mano sx davanti al fianco dx e viene colpito col palmo della mano dx, staccandolo di
poco dal palmo della mano sx.) far eseguire il seguente esercizio a coppie: di fronte far rotolare il pallone a terra
(come se si lanciasse una boccia) sia con la mano dx che sx (attenzione alla posizione dei piedi).
2. a coppie: lanciarsi la palla oltre la rete con la dx e la sx tenendo fin dall’inizio il pallone sulla mano di lancio
3. battere su vari bersagli (tappeti o cerchi) disposti oltre la rete.Variare la distanza e l’altezza della rete
4. dopo aver effettuato la battuta portarsi velocemente in campo e raggiungere la linea dei tre metri prima che la palla cada
(concetto di recupero immediato della posizione di lavoro)
5. battuta a tennis: si esegue con la gamba sx avanti, pallone sostenuto col palmo della mano sx e il braccio dx (che
colpisce la palla) tenuto alto, quasi disteso. Quando il pallone viene lanciato davanti e sopra la spalla dx, il braccio dx
viene portato indietro e piegato all’altezza del gomito; in questa fase il peso del corpo passa sulla gamba dx (arretrata).
La palla viene colpita con il palmo della mano e con il braccio disteso, mentre per effetto della spinta della gamba
dx il peso del corpo passa sulla gamba sx Eserc.: a coppie, lanciare il pallone oltre la rete sia con il braccio dx
(piede sx avanti) che con il braccio sx. (piede dx avanti) seguendo la tecnica descritta
6. battere su vari bersagli (tappeti o cerchi) disposti oltre la rete.Variare la distanza e l’altezza della rete
7. come il 4.
Esercizi per il Bagher
1. questa tecnica per ricevere e rinviare il pallone viene utilizzata quando, come nel caso della battuta a tennis, il pallone
per la velocità e il tipo di traiettoria, non è più controllabile in palleggio. Lo spostamento, che deve compiersi in modo
tale da ricevere da fermi e con il pallone davanti al corpo, va effettuato con le stesse tecniche usate per il palleggio. E’
necessario mantenere la fronte rivolta verso il giocatore a cui si deve far pervenire la palla. Al momento della ricezione le
braccia devono essere distese e unite in extrarotazione, entrando in contatto con il pallone con una superficie larga e più
uniforme possibile. Il pallone va colpito con la faccia interna dell’avambraccio, appena sopra i polsi. Gli arti inferiori
devono estendersi al momento della ricezione in modo da spingere il pallone verso l’alzatore, mentre l’inclinazione

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 6
delle braccia varia di poco avendo queste una prevalente funzione di guida. Il busto è naturalmente sbilanciato in
avanti. Eserc.: a coppie A preme il pallone su B che deve opporre resistenza con le braccia e utilizzare le gambe
2. a coppie: A lancia il pallone a B che deve ricevere in bagher
3. a gruppi di tre: A lancia il pallone a B che deve ricevere ed inviare a C (cambiare i compiti)
4. a coppie: A lancia il pallone a B che nella fase ascendente della parabola si sposta verso la zona del presunto arrivo della
palla (dx., sx., av., ind.)
5. a gruppi di tre: A batte a tennis oltre la rete, B riceve in bagher ed invia a C.
Esercizi per la Schiacciata
1. la rincorsa può essere di uno o due o tre passi: per un destro è dx.-sx. o sx.-dx.-sx. o dx.-sx.-dx.-sx., per un mancino è
il contrario. Lo stacco per i destrimani è dx.-sn. E per i mancini vedi sopra. Il colpo sulla palla è per gli arti superiori
simile alla battuta a tennis con un movimento di “frustata” violenta del polso. Eserc.: tenendo il gomito flesso si colpisce
la palla verso terra “frustando” con il polso violentemente
2. si porta il gomito all’altezza della spalla: si flette il gomito completamente richiamando la mano verso l’alto, quindi si
estende l’avambraccio con forza frustando con il polso
3. come il 2 ma con il pallone tenuto alto sopra e davanti al capo: il braccio che colpisce deve estendersi completamente
4. senza pallone: appoggio dx.-sx. e saltare (per i mancini vedi sopra)
5. come il 4 ma con semicirconduzione delle braccia per dietro-basso-avanti e slancio delle stesse in alto
6. col pallone auto-alzata sopra il capo e, con salto da fermo, schiacciata nel campo opposto con rete inizialmente bassa
7. come il 6 ma con partenza a circa tre metri dalla rete
8. una fila di schiacciatori in posto 4 e l'insegnante che passa la palla con parabola alta
9. come sopra ma in posto 2
10. come 8 e 9 ma variando le parabole e con passaggio dall'allievo all'insegnante che di seguito alza.
Esercizi per il Muro
1. posizione di attesa con le gambe leggermente semipiegate e le braccia semiflesse con le mani all'altezza delle spalle
2. passo laterale a dx, riunire le gambe, stacco a piedi pari alzando entrambe le braccia (ripetere a sx.)
3. a coppie: A si piazza inizialmente a 2 m. dalla rete e batte con B che mura. A progressivamente si allontana dalla rete
(quanto maggiore è la distanza di A dalla rete, tanto maggiore dovrà essere il ritardo di B nel saltare (cambio di ruoli)
4. come l’8, 9 e 10 della schiacciata con l'allievo che va a muro partendo di fronte all'insegnante e al di là della rete
5. muro a due.
LA PALLACANESTRO (Basket)
La storia
La pallacanestro fu ideata nel 1891 dal reverendo James Naismith, professore di Educazione fisica presso lo Springfield College
del Massachusetts (Stati Uniti d’America).
L’intenzione del professore era quella di trovare un gioco che d’inverno potesse sostituire il baseball e il football americano,
sport praticati nel periodo estivo; l’ispirazione gli venne quando lanciò un foglio di carta appallottolato dentro il cestino dei
rifiuti.
Da allora sono cambiate molte regole, ma l’altezza dei canestri a 3,05 metri dal suolo è rimasta inalterata; l’altezza dei canestri
era dovuta al fatto che i “cestini” (i canestri) venivano appoggiati ai davanzali delle finestre della palestra di Springfield, che
erano proprio a quell’altezza (3,05 metri).
In Italia la pallacanestro venne introdotta nel 1907 dalla professoressa Noemi Pesciolini con il nome di palla al cesto; la prima
partita ufficiale si disputò a Milano nel 1919 e il primo campionato si disputò nel 1920.
In Italia la Federazione Italiana Pallacanestro nasce nel 1921, anche se la vera diffusione di questo sport inizia nel periodo del
dopoguerra, favorita dalla presenza dei soldati americani che la praticavano.
La pallacanestro diventa sport olimpico nel 1936, alle Olimpiadi di Berlino.
Il campo
Il campo di gioco è un rettangolo lungo da 26 a 28 metri e largo da 14 a 15 metri, delimitato da righe larghe 5 centimetri (la linea
perimetrale delimita il campo non facendone parte).
Al centro dei lati corti sono posti i canestri a 3,05 metri d’altezza; i canestri sono costituiti da un anello di 45 centimetri di
diametro con una retina attaccata.
A metà campo vi è un cerchio del diametro di 3,60 metri da cui ha inizio il gioco.
Due zone di forma rettangolare con larghezza di 4,8 metri e lunghezza di 5,8 metri (coincide con la linea del tiro libero) sono
tracciate sul campo alle estremità e delimitano la zona dei “3 secondi”; nella parte più stretta di ognuna di queste zone è tracciato
un cerchio con le stesse dimensioni di quello centrale.
Dal diametro di questi cerchi si effettuano i tiri liberi (distanza di 5,8 metri dalla linea perimetrale).

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 7
Un semicerchio del raggio di 6,75 metri che comprende l’intera zona rettangolare indica il limite del tiro da 3 punti.
Il gioco
Si fronteggiano due squadre composte ognuna da 5 giocatori in campo e 5 o 7 riserve in panchina (a seconda dei campionati).
Ogni squadra cerca di far entrare il pallone (la palla misura 75-78 cm. di circonferenza e pesa da 567 a 650 grammi) nel canestro
degli avversari, tirando con le mani da qualsiasi parte del campo (il pallone deve entrare nel canestro passando dall’alto verso il
basso); contemporaneamente ogni squadra cerca di impedire che l’altra si impossessi del pallone e provi a “fare canestro”.
Le riserve possono entrare in campo in qualsiasi momento della partita e non esiste un limite al numero di sostituzioni.
Il pallone può essere passato, tirato, palleggiato o rotolato. Non può essere trasportato o calciato ddeliberatamente.
Vince la squadra che al termine della partita ha realizzato il maggior numero di punti.
Regole di gioco
La partita ha inizio con una “rimessa a due” (contesa) nel cerchio di metà campo.
La palla viene lanciata dall’arbitro tra due giocatori che possono toccare la palla dopo che questa ha raggiunto il punto più alto
e cercano di indirizzarla ai propri compagni; gli altri giocatori si devono posizionare intorno al cerchio di centrocampo
indifferentemente nella propria o altrui metà campo.
La partita si gioca in 4 periodi (tempi) di 10 minuti effettivi ciascuno (effettivo significa che ogni volta che il gioco si interrompe
il cronometro viene fermato).
In caso di parità si disputano uno o più tempi supplementari di 5 minuti ciascuno per determinare la squadra vincitrice.
Ciascuna squadra può usufruire di 2 sospensioni (time-out: dura 1 minuto) nella prima metà gara (primo e secondo periodo) e di
3 nella seconda metà gara; durante ogni tempo supplementare si ha diritto ad 1 sospensione.
Gli intervalli sono di 15 minuti fra il secondo ed il terzo tempo; di 2 minuti per gli altri due intervalli e per eventuali
supplementari.
Alla squadra che fa entrare la palla nel canestro avversario verranno assegnati:
1 punto se il canestro viene realizzato con tiro libero a gioco fermo
2 punti se il canestro viene realizzato su azione
3 punti se il canestro viene realizzato da oltre 6,75 metri (linea dei tre punti).
La rimessa della palla in campo viene effettuata dopo un canestro (si effettua da dietro la linea di fondo campo), dopo
un’infrazione (si effettua dal punto più vicino all’infrazione, fuori dalla linea laterale), quando la palla esce (si effettua dal punto
in cui è uscita).
I falli
Il fallo personale implica un contatto irregolare con un avversario: bloccaggio, sfondamento, trattenuta, uso illegale delle mani,
spinta.
Ogni giocatore può commettere 4 falli personali, al 5° fallo viene sostituito.
I falli su un giocatore che sta tirando sono puniti con i tiri liberi.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 8
Se il fallo è commesso su un giocatore che sta tirando e il pallone va comunque nel canestro, il canestro viene convalidato ed è
concesso un tiro libero; se il fallo è commesso su un giocatore che sta tirando e il pallone non va nel canestro, vengono concessi
due tiri liberi o tre se il tiro è stato effettuato da oltre 6,75 metri.
I falli su un giocatore che non sta tirando sono puniti con la rimessa a favore della squadra del giocatore che ha subito il fallo.
Se una squadra commette più di 4 falli in un tempo di gioco, ogni ulteriore fallo è punito con due tiri liberi.
Il fallo antisportivo, è costituito da una intenzionale condotta irregolare nei confronti di un avversario; viene punito con due tiri
liberi a favore della squadra avversaria.
Il fallo tecnico, è costituito da un atteggiamento scorretto (proteste, linguaggio irrispettoso, ecc.); viene punito con due tiri liberi
a favore della squadra avversaria.
Le infrazioni
Le infrazioni riguardano il mancato rispetto del regolamento tecnico; vengono punite con la perdita del possesso di palla ed una
rimessa a favore della squadra avversaria.
Vi sono infrazioni con la palla e infrazioni di tempo:
con la palla:
non si può palleggiare con due mani contemporaneamente
non si possono fare più di due passi con la palla in mano senza palleggiare
non si può interrompere il palleggio e poi riprendere a palleggiare
non si può toccare volontariamente la palla con le gambe o i piedi, né con un pugno
chi difende non può toccare la palla al di sopra del canestro
lanciare la palla in alto e riprenderla prima che tocchi terra
saltare con la palla tra le mani e ricadere a terra senza averla tirata o passata
calpestare o superare le linee perimetrali
superare la metà campo e passarla nell’altra metà campo
di tempo:
un giocatore non può trattenere la palla senza palleggiare per più di 5 secondi
un giocatore non in possesso di palla non può rimanere più di 3 secondi nell’area avversaria, se la sua squadra ha la
palla
una squadra che rimette la palla dalla linea di fondo, ha 8 secondi per superare la metà campo con la palla
una squadra ha 24 secondi per concludere l’azione.
I fondamentali individuali
I fondamentali individuali, cioè i movimenti principali della pallacanestro sono 4: il palleggio, il passaggio, il tiro e la posizione
di difesa.
Il palleggio. Il palleggio è il fondamentale che permette di muoversi per il campo con la palla, facendola rimbalzare a terra. Il
palleggio va effettuato con una mano sola cercando di proteggere la palla dall’avversario con l’altro braccio e con il corpo; è
conveniente saper palleggiare sia con la mano destra che con la sinistra. La palla va fatta rimbalzare lateralmente e vicina al
corpo per non intralciare gli spostamenti e proteggerla dagli avversari. Si deve toccare la palla con le dita a mano aperta e
spingerla con un movimento morbido di tutto l’avambraccio, senza tenere il polso e le dita rigide e senza schiaffeggiarla. Il
palleggio si dice basso se effettuato all’altezza del ginocchio, normale se effettuato all’altezza della coscia, alto se effettuato
all’altezza della vita. Non è consentito (infrazione) palleggiare la palla più alta delle spalle.
Il passaggio. Il passaggio è il fondamentale che permette di spostare velocemente la palla per il campo dandola ad un compagno.
Può essere effettuato in vari modi in base alla distanza dal compagno a cui è diretto il passaggio ed alla eventuale azione di
disturbo degli avversari.
a due mani dal petto, diretto o schiacciato a terra (passaggio corto e veloce)
a due mani sopra il capo (passaggio medio-lungo)
ad una mano a baseball (passaggio lungo)
Conseguentemente al passaggio è importante come si riceve il pallone (ricezione). La ricezione si effettua preferibilmente con
due mani, distendendo le braccia verso la palla con le mani aperte. Al contatto con la palla, che deve avvenire con i polpastrelli,
le braccia devono flettersi accompagnando il pallone verso il petto; ciò consente di diminuire la velocità del pallone e di
proteggerlo dagli avversari.
Il tiro. Il tiro è il fondamentale che conclude l’azione di attacco. Può essere effettuato in vari modi in base alla distanza dal
canestro ed alla eventuale azione di disturbo degli avversari.
da fermi (tiro piazzato). Viene utilizzato soprattutto per eseguire i tiri liberi
in sospensione/elevazione. Viene utilizzato per allungare la traiettoria del pallone imprimendogli più forza e per tirare
da posizione più elevata
in entrata (si chiama anche tiro in corsa o terzo tempo). Viene utilizzato perché dà la possibilità di avvicinarsi a canestro
e tirare facendo due passi a terra con la palla in mano senza palleggiare.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 9
La posizione di difesa. Il difensore deve cercare di rimanere sempre fra l’avversario ed il proprio canestro da difendere, cercando
di non farsi superare. La posizione base del difensore è a gambe semipiegate e divaricate, busto leggermente inclinato in avanti,
braccia semiaperte e in avanti. Gli spostamenti laterali, detti anche scivolamenti, vanno effettuati mantenendo sempre la stessa
posizione base del difensore utilizzando una sorta di corsa laterale.
I ruoli principali
Play-Maker (costruttore del gioco). Detto anche l'"uno", ha il compito di impostare il gioco, è quindi il “regista” della squadra.
È un giocatore che deve essere veloce, abile nel palleggio e nel passaggio, tatticamente intelligente, con una buona visione di
gioco.
Guardia. Chiamato anche il "due", deve aiutare il play-maker nella costruzione del gioco e difendere sull’avversario più
pericoloso. Deve essere un buon tiratore, deve essere veloce e sapersi smarcare rapidamente.
Ala piccola. L'ala piccola, o il "tre", deve avere un'ottima capacità sia di penetrazione sia di tiro. Deve saper tirare bene da fuori,
saper penetrare la difesa avversaria, saper giocare vicino al canestro cercando di recuperare i rimbalzi.
Ala grande.L'ala grande, o il "quattro", gioca solitamente vicino al canestro per aiutare il centro nella conquista dei rimbalzi,
anche se è sovente dotata di un buon tiro da fuori e di una discreta mobilità.
Centro (pivot). Il centro o pivot (“perno della squadra”), detto anche "cinque" èdi statura alta e corporatura robusta (è
generalmente il giocatore più alto della squadra e preferibilmente il più massiccio dal punto di vista muscolare). Gioca vicino al
canestro e a lui si affidano i compiti di raccogliere i rimbalzi e iniziare il contropiede. Un centro deve possedere un buon
movimento spalle a canestro e un buon tiro dalla media distanza.
PALLACANESTRO
Introduzione: esercizi di ball-handling (manipolazione e sensibilizzazione digitale)
1. ritti, gambe divaricate: far girare la palla attorno al busto, al capo ed agli arti inferiori
2. lo stesso esercizio a gambe unite (flettendo ed estendendo le gambe)
3. ritti, palla tenuta avanti a braccia tese una mano sopra ed una sotto: cambiare velocemente la posizione delle mani senza
far spostare eccessivamente la palla (patata bollente)
4. ritti, palla tenuta davanti a braccia tese: lasciarla cadere, battere le mani dietro la schiena e riprenderla prima che
tocchi terra
5. divaricata sagittale con busto flesso e palla tenuta davanti al ginocchio dx o sx: lasciarla cadere, battere le mani dietro il
ginocchio e riprenderla prima che tocchi terra (cambiare ginocchio)
6. lo stesso esercizio ma con palla tenuta dietro il ginocchio, battendo le mani davanti
7. ritti, gambe divaricate e palla dietro la schiena: lanciarla in avanti e riprenderla al volo
8. lo stesso esercizio ma con la palla davanti
9. ritti, gambe divaricate e busto flesso con palla tenuta in mezzo alle gambe (una mano davanti ed una dietro): invertire la
posizione delle mani senza far cadere la palla
10. ritti, palla tenuta dietro il capo: lasciarla e riprenderla dietro la schiena prima che tocchi terra.
Esercizi per la prima regola: non si cammina e non si corre con la palla in mano (il palleggio)
1. a spasso con la palla: camminando sulle linee perimetrali del campo, gli allievi palleggiano di dx e di sx. Successivamente,
al segnale, tutti insieme entrano in campo palleggiando e cambiando la mano del palleggio a comando (palleggio alla vita e
di fianco ai piedi, non davanti ai piedi; non tenere gli occhi fissi sulla palla)
2. staffetta in palleggio: correre in palleggio verso un segnale, aggirarlo e tornare verso la
3. propria squadra (palleggio alto)
4. come sopra ma a slalom e avendo cura quando si passa ogni ostacolo, di cambiare mano e di usare sempre quella più lontana
dall'ostacolo (ostacolo = avversario)
5. tutti contro tutti: palleggiare liberamente e cercare di far perdere od uscire dal campo la palla agli avversari (palleggio basso
e protetto e senza guardare la propria palla mentre si palleggia)
6. gatti e topi: la squadra dei gatti è a metà campo e la squadra dei topi è sparsa liberamente. Al via dato dall'insegn. i gatti
partono in palleggio e cercano di prendere i topi che scappano in palleggio.Vince la squadra che ne cattura di più in un
determinato tempo.
Esercizi per la seconda regola: per vincere bisogna mandare la palla tante volte nel canestro (il tiro)
Tiro piazzato o da fermo
1. dopo aver dimostrato l'esecuzione e la posizione corretta far esercitare gli allievi inizialmente di fronte al muro a circa tre
metri secondo la seguente successione: 1. usare solo la mano preferita sensibilizzando la "frustata" ; 2. aggiungere la
mano che aiuta (T fra i due pollici); 3. usare anche le gambe coordinando l'azione degli arti superiori con quella degli arti
inferiori; 4.tiri a canestro

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 10
2. gara di tiro n. 1: due squadre in fila a tre metri dai rispettivi canestri. Si prendono due punti se si segna a canestro e se non
si segna si va a rimbalzo si tira da sotto; se si segna si prende un punto (ognuno ha due tiri al massimo a disposizione).
Durata della gara predeterminata
3. gara di tiro n. 2: come sopra ma senza la possibilità del secondo tiro (da un punto)
4. gara di tiro n. 3: come sopra ma da posizione angolata (poi cambiare angolo)
5. gara di tiro n. 4: tiri liberi dalla linea detta di "tiro libero".
Tiro in sospensione ed in elevazione
1. dopo la dimostrazione ed una breve esercitazione riproporre le gare precedenti
2. riproporre la gara di tiro n. 4 anche con partenza da metà campo in palleggio, arresto sulla linea di tiro libero e tiro da fermo,
in elevazione od in sospensione a propria scelta.
Tiro in corsa o terzo tempo
1. dopo aver dimostrato l'esecuzione corretta far provare gli allievi con partenza da dx e da sx
2. gare di tiro con partenza da dx., da sx., frontalmente.
Esercizi per la terza regola: non si gioca uno contro tutti (il passaggio)
1. dimostrazione dei vari tipi di passaggio con la spiegazione del perchè è meglio utilizzarne uno o l'altro a seconda della fase
di gioco
2. a coppie: passaggio a due mani dal petto curando la distensione delle braccia sia nel passaggio che nella ricezione al
petto (nel passaggio: flessione e distensione; nella ricezione: distensione e flessione) e l'uso delle gambe per aiutare il
passaggio
3. a coppie: eseguire il passaggio schiacciato a terra
4. a coppie: eseguire il passaggio a due mani sopra il capo
5. a coppie: eseguire il passaggio a baseball ad una mano
6. a coppie: eseguire il passaggio schiacciato a terra ad una mano
7. prestiamo la palla: formare più gruppi da 5 o 6 e disporli sul campo in modo che ogni gruppo abbia i suoi componenti a
zig-zag; al segnale il n.1 di ogni gruppo, che ha il possesso della palla, la passa al numero due e così via finchè la palla
non torna poi facendo il percorso inverso al numero 1. In seguito proporlo come gara: vince il gruppo più veloce
8. passaggi a coppie correndo lungo il perimetro del campo
9. a gruppi di 5: passaggi a stella (passare la palla al compagno non vicino)
10. passa e scappa: a gruppi di 4 disposti come segue, A e B formano una coppia con B dietro A e si trovano a tre metri circa
di fronte a C e D che si dispongono fra loro nello stesso modo di A e B. A passa a C e va subito a prendere il posto di B
mentre C dopo aver passato a B scala dietro D e così via di seguito.
Esercizi per la quarta regola: per vincere bisogna far segnare pochi canestri agli avversari
1. dopo aver dimostrato la corretta posizione di difesa o di partenza e aver spiegato che bisogna sempre trovarsi fra il tuo
avversario ed il canestro che si deve difendere, proseguire con un esercitazione singola per provare la posizione (talloni:
leggermente sollevati, piedi: larghezza delle spalle, ginocchia: flesse, bacino: basso, braccia: allargate con palmo rivolto in
avanti, busto: inclinato in avanti, testa: alta, spostamenti laterali: con passi laterali)
2. il duello: uno contro uno da metà campo (difesa: stare fra avversario e canestro, rubare la palla e diventare attaccante,
ostacolare il tiro, non urtare o spingere l'avversario; attacco: eludere la difesa, uso e finalità del palleggio, protezione della
palla, fare canestro)
3. il duello: due contro due come sopra
4. tre contro tre
5. quattro contro quattro.
LA PALLAMANO (Handball)
La storia
La pallamano nasce nel 1915 in Germania ad opera di Max Heiser, con il nome di torball (pallaporta).
Il gioco inizialmente veniva praticato in campi molto grandi, simili a quelli di calcio, con squadre composte da 11 giocatori.
Successivamente si afferma come sport da palestra; vengono quindi ridotte le dimensioni del campo ed il numero dei giocatori
passa a 7.
La pallamano si diffonde rapidamente nei paesi del nord Europa (Germania, Danimarca e Paesi Scandinavi).
Solo nel 1972 la pallamano diventa sport olimpico ai Giochi di Monaco, solo per gli uomini, e nel 1976 a Montreal anche per le
donne.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 11
In Italia, gli studenti dell’I.S.E.F. di Roma, presentarono ufficialmente la pallamano a Spoleto nel 1965; il primo campionato si
svolse nel 1969.
Il campo
Il campo di gioco è un rettangolo di 40 metri di lunghezza e 20 di larghezza, delimitato da righe larghe 5 cm. e diviso al centro
da una linea.
In ciascuna metà campo vi è un’area di porta, di forma semicircolare, con un raggio di 6 metri e, parallela ad essa a 3 metri di
distanza (cioè a 9 metri dalla linea di porta), una linea tratteggiata (detta anche linea di tiro franco) dalla quale vengono battute
le punizioni.
A 7 metri dalla porta vi è una linea, lunga un metro, dalla quale si tirano i rigori.
Vicino alla metà campo, lungo la linea laterale, vi è la zona di cambio; essa è lunga 9 metri ed è delimitata da due trattini.
La porta misura 3 metri di larghezza e 2 di altezza.
Il gioco
Si fronteggiano due squadre composte ognuna da 7 giocatori in campo e 5 riserve in panchina.
Ogni squadra cerca di far entrare il pallone (la palla ha una circonferenza ed un peso rispettivamente di 58-60 cm. e 425-475
grammi per i maschi, e 54-56 cm. e 325-400 grammi per le femmine) nella porta degli avversari tirando con l’aiuto delle mani,
delle braccia, della testa, del tronco, delle cosce e delle ginocchia; contemporaneamente ogni squadra cerca di impedire che
l’altra si impossessi del pallone e provi a “fare gol”.
Le riserve possono entrare in campo in qualsiasi momento della partita, purchè il cambio venga effettuato nell’apposita zona
centrale e il compagno sia uscito dal campo; non esiste un limite al numero di sostituzioni.
Il pallone può essere passato, tirato, palleggiato o rotolato.
Vince la squadra che al termine della partita ha realizzato il maggior numero di reti.
Le regole di gioco
La partita ha inizio con la squadra sorteggiata che, al centro del campo, effettua la rimessa in gioco al fischio dell’arbitro.
Affinché una rete sia valida il tiro deve essere effettuato dal di fuori dell’area dei 6 metri (un attaccante può andare all’interno
dell’area di porta solo in “sospensione”, l’importante è che lo stesso effettui il tiro prima di ricadere a terra) ed il pallone deve
superare interamente la linea di porta.
Un giocatore non può passare la palla al proprio portiere che si trova nell’area di porta.
Se il portiere devia la palla oltre la linea di fondo campo su un tiro avversario, il gioco riprende con una rimessa da parte del
portiere stesso; il portiere può fermare il pallone con qualsiasi parte del corpo e prendere parte attiva al gioco in tutto il campo.
La partita si gioca in 2 tempi di 30 minuti ciascuno, con un intervallo di 10 minuti (per le squadre giovanili da 12 a 16 anni i
tempi durano 25 minuti).
In caso di parità, si disputano 2 tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, con un intervallo di 1 minuto.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 12
I falli
Il fallo personale implica un comportamento irregolare con un avversario: bloccaggio, sfondamento, trattenuta, uso illegale delle
mani, spinta, finte pericolose.
Non è consentito:
strappare con una o entrambe le mani la palla all’avversario o colpirla quando la tiene tra le mani
portare pericolosamente la palla verso l’avversario con una finta
sbarrare la strada all’avversario o respingerlo con l’uso delle braccia, delle mani o delle gambe
cinturare, trattenere, spingere l’avversario
utilizzare il pugno per togliere la palla all’avversario.
Le infrazioni
Le infrazioni riguardano il mancato rispetto del regolamento tecnico; vengono punite con la perdita del possesso di palla ed una
rimessa a favore della squadra avversaria.
Vi sono infrazioni con la palla e infrazioni di tempo:
con la palla:
colpire la palla sotto il ginocchio
non si possono fare più di tre passi con la palla in mano senza palleggiare
toccare la palla due volte di seguito senza che abbia toccato il suolo
non si può interrompere il palleggio e poi riprendere a palleggiare
lanciarsi sulla palla che rotola o che è ferma a terra
di tempo:
un giocatore non può trattenere la palla senza palleggiare per più di 3 secondi
Per il portiere è vietato abbandonare l’area di porta con la palla in mano e toccare la palla fuori dall’area di porta mentre egli si
trova ancora all’interno di essa.
Le sanzioni
Un giocatore può essere ammonito per comportamento irregolare verso un avversario: in questo caso l’arbitro estrae il cartellino
giallo. Se il fallo si ripete, il giocatore colpevole può essere escluso dal gioco per due minuti. Alla terza ammonizione il giocatore
viene escluso per il resto della partita (espulsione con cartellino rosso), ma può essere sostituito. Un giocatore può essere espulso
anche al primo fallo, se particolarmente grave. Ogni fallo di gioco comporta una punizione, che può essere un rigore o un tiro
franco.
Il rigore si dà :
quando un giocatore passa volontariamente la palla al proprio portiere, che si trova nell’area di porta
quando un giocatore si trova nell’area di porta con l’intento di difendere
quando un giocatore tende ad impedire una rete utilizzando un comportamento irregolare
quando il portiere volontariamente trasferisce la palla dall’area di gioco alla propria area di porta.
Il tiro franco si dà in tutti gli altri casi e si effettua nel punto in cui è stato commesso il fallo, con i difensori sistemati a tre metri
di distanza; il tiro franco si esegue dalla linea dei 9 metri quando il fallo è commesso tra la linea dei 6 metri (area di porta) e la
linea dei 9 metri (linea di tiro franco).
I fondamentali individuali
I fondamentali individuali, cioè i movimenti principali della pallamano sono 3: il palleggio, il passaggio, il tiro.
Il palleggio. Il palleggio è il fondamentale che permette di muoversi per il campo con la palla, facendola rimbalzare a terra. Il
palleggio va effettuato con una mano sola cercando di proteggere la palla dall’avversario con l’altro braccio e con il corpo; è
conveniente saper palleggiare sia con la mano destra che con la sinistra. La palla va fatta rimbalzare lateralmente e vicina al
corpo per non intralciare gli spostamenti e proteggerla dagli avversari. Si deve toccare la palla con le dita a mano aperta e
spingerla con un movimento morbido di tutto l’avambraccio, senza tenere il polso e le dita rigide e senza schiaffeggiarla. Il
palleggio si dice basso se effettuato all’altezza del ginocchio, normale se effettuato all’altezza della coscia, alto se effettuato
all’altezza della vita. Il palleggio avviene soprattutto in movimento e non è un fondamentale molto usato nella pallamano, poiché
è un gioco basato in gran parte su passaggi e azioni veloci.
Il passaggio. Il passaggio è il fondamentale che permette di spostare velocemente la palla per il campo dandola ad un compagno.
Può essere effettuato in vari modi in base alla distanza dal compagno a cui è diretto il passaggio ed alla eventuale azione di
disturbo degli avversari.
a due mani dal petto, diretto o schiacciato a terra
a due mani sopra il capo
a una mano a baseball
a una mano sopra il capo
a una mano dal fianco
a una mano dal ginocchio

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 13
Conseguentemente al passaggio è importante come si riceve il pallone (ricezione). La ricezione si effettua preferibilmente con
due mani, distendendo le braccia verso la palla con le mani aperte. Al contatto con la palla, che deve avvenire con i polpastrelli,
le braccia devono flettersi accompagnando il pallone verso il petto; ciò consente di diminuire la velocità del pallone e di
proteggerlo dagli avversari.
Il tiro. Il tiro è il fondamentale che conclude l’azione di attacco. Può essere effettuato in vari modi in base alla distanza dal
canestro ed alla eventuale azione di disturbo degli avversari.
tiro in appoggio. È il tiro di base, i giocatori lo possono eseguire da fermi o con due o tre passi di rincorsa per imprimere
più forza alla palla.
in sospensione. Viene utilizzato per tirare da posizione più elevata quando gli avversari con la loro posizione ostacolano
la visione della porta.
in caduta. Viene utilizzato perché dà la possibilità di avvicinarsi alla porta e tirare spingendosi all’interno dell’area,
lanciando la palla prima di toccare il suolo con il corpo.
I ruoli principali
Portiere. È l’elemento cardine della difesa. Deve essere piuttosto alto, ma agile e veloce. Il portiere deve avere anticipazione
motoria, forte personalità e coraggio, essendo il responsabile del piazzamento della difesa. Può toccare la palla con qualsiasi
parte del corpo, può spostarsi all’interno della propria area ma può anche entrare in campo e giocare la palla.
Play-Maker (costruttore del gioco). Ha il compito di impostare il gioco, è quindi il “regista” della squadra. È un giocatore che
deve essere veloce, abile nel palleggio, nel passaggio e nel tiro, tatticamente intelligente.
Terzino. È quello che generalmente segna di più. Deve essere un buon tiratore sia in sospensione che dai 9 metri; deve essere
alto e potente.
Ala. Gioca vicino alla linea di fondo, deve saper tirare bene in tuffo ed in sospensione; deve essere agile, veloce e possedere una
buona elevazione.
Centro (pivot). È di statura alta e corporatura robusta. Deve sapersi smarcare e saper tirare in ogni modo.Gioca in mezzo agli
avversari al centro dello schieramento d’attacco.
PALLAMANO
Per il Palleggio, il Passaggio e la Difesa, il lavoro eseguito precedentemente per gli stessi fondamentali nella pallacanestro
è esauriente e non necessita di aggiunte; un discorso a parte va fatto per il tiro.
Il Tiro
Nell’esecuzione del tiro il braccio è alto al di sopra del capo, con gomito all’altezza della spalla, normalmente flesso e
lontano dal corpo. Il pallone, che riempie il palmo della mano è trattenuto dalle dita che non devono stringere troppo per
evitare contrazioni inutili. I piedi sono sx in avanti per chi tira di dx e viceversa. La preparazione del tiro è fatta con
le due mani.
1. a 6 m. dalla porta, palla tenuta in avanti a due mani: sollevarla al di sopra del capo, sempre con le due mani, rotazione
a dx del busto e spostamento in avanti della gamba sx., tiro ad una mano con la sx che “punta” in avanti verso la
direzione di tiro (tiro in doppio appoggio plantare)
2. come l’1 ma il tiratore parte in corsa da metà campo, il passaggio gli viene fatto dall’insegn. Quando ha raggiunto i 9
m. ed esegue il tiro prima della linea dei 6 m.
3. come l’1 ma saltando e tirando prima di ricadere nell’area di porta
4. (tiro in sospensione: saltare prima di tirare e tirare prima di ricadere al suolo, il ginocchio della gamba libera deve essere
richiamato verso l’alto e lateralmente)
5. come il 2 ma col tiro in sospensione.
L’ATLETICA LEGGERA
La storia
Camminare, correre, saltare, lanciare, sono i movimenti naturali dell’uomo su cui si basano le discipline sportive dell’Atletica
leggera.
Già nell’antichità questi movimenti naturali vennero regolamentati e trasformati in specialità dell’Atletica.
In Grecia dove la cura del fisico veniva vista come forma di bellezza, nel 776 a.C. vi fu la nascita di una grande manifestazione
sportiva, disputata per la prima volta ad Olimpia, che prese appunto il nome di Olimpiade.
Una forma di competizione sportiva che aveva il maggior numero di spettatori era il pentathlon, costituito da cinque gare
atletiche: la corsa, il salto, il lancio del disco, il lancio del giavellotto e la lotta.
Nel corso dei secoli l’Atletica ha conosciuto periodi in cui ha perso importanza, fino alla seconda metà del 1800 dove in
Inghilterra e negli Stati Uniti d’America si disputarono gare con l’introduzione di nuove specialità come il salto in alto ed il salto
con l’asta.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 14
Nel 1896, con l’avvento delle Olimpiadi moderne, l’Atletica ebbe la sua definitiva consacrazione, fino ad essere considerata la
regina degli sport olimpici.
Il campo
Le gare di Atletica si svolgono in un campo circondato da una pista lunga 400 metri, formata da un minimo di 6 corsie (larghe
1,22 metri); in pista si corre sempre in senso antiorario.
All’interno ed all’esterno della pista si trovano le zone per i salti ed i lanci.
In inverno le gare si svolgono anche al coperto (indoor), su piste che hanno una lunghezza che va dai 150 ai 300 metri.
Le specialità dell’atletica
Le corse
corse veloci. Sono gare di velocità:
a. 100, 200 e 400 metri. Nelle gare di corsa veloce ogni atleta deve correre nella corsia che gli è stata assegnata e non
può invadere, pena la squalifica, quella di un altro concorrente. La partenza delle gare veloci avviene dai “blocchi di
partenza” da una posizione con mani e piedi in appoggio sul terreno (quattro appoggi). Nelle gare di velocità è
consentita una sola partenza falsa (l’atleta che si muove prima del segnale dello “starter”); chi si muove prima dello
sparo alla seconda partenza viene squalificato. La gara dei 100 metri si disputa lungo il rettilineo della pista, per cui gli
atleti vengono allineati dietro la riga di partenza. Nei 200 metri i concorrenti delle corsie esterne (corsia 2, 3, ecc.)
partono più avanti di circa 4 metri rispetto alla corsia precedente, per compensare la maggiore lunghezza della curva;
nei 400 metri i concorrenti delle corsie esterne (corsia 2, 3, ecc.) partono più avanti di circa 8 metri rispetto alla corsia
interna, dovendo fare due curve.
b. staffette. La staffetta è una corsa veloce per squadre formate da 4 atleti (frazionisti) che devono percorrere ognuno una
distanza (frazione) passandosi un testimone (cilindro metallico che pesa 50 grammi, è lungo 28-30 cm. e ha un diametro
di 4 cm.) in una zona prestabilita di venti metri compresa tra la fine di una frazione e l’inizio della successiva (zona di
cambio). Se il testimone non arriva al traguardo o viene passato fuori zona, la squadra è squalificata. Le staffette sono
2: 4 per 100 e 4 per 400 metri maschile e femminile. Nella 4 per 400 si deve percorrere in corsia il primo giro (400
metri) più una curva (equivalente ad altri 100 metri); il primo frazionista quindi percorre l’intero “anello” in corsia e

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 15
passa il testimone al secondo frazionista, che solo alla fine della curva, può rientrare “alla corda” (correre alla corda
vuol dire utilizzare la parte più interna della pista).
c. corse ad ostacoli. Le corse veloci ad ostacoli sono 3: i 110 metri, i 100 metri ed i 400 metri. I 110 metri sono una
specialità maschile con 10 ostacoli alti 1,067 metri; i 100 metri sono una specialità femminile con 10 ostacoli alti 0,84
metri; i 400 metri sono maschili e femminili, con 10 ostacoli alti 0,914 metri per i maschi e 0,762 metri per le donne.
Se l’atleta fa cadere uno o più ostacoli non incorre in alcuna penalità.
mezzofondo. Sono considerate gare di mezzofondo gli800, i 1500 metri ed i 3000 siepi. Negli 800 metri gli atleti
compiono i primi 100 metri nella propria corsia di partenza dopodiché si va “alla corda”. Nei 1500 metri gli atleti (12
al massimo) partono in piedi lungo una linea posta all’inizio del secondo rettilineo. Vanno subito alla corda e compiono
i 3 giri di gara. I 3000 siepi sono una corsa ad ostacoli in cui l’atleta affronta complessivamente durante i 7 giri di pista
28 ostacoli (siepi) alti 0,9 metri e 7 fosse (ostacoli oltre i quali vi è una buca piena d’acqua, lunga 3,66 metri e profonda
da 70 cm. a 0 cm.).
fondo. Le specialità di fondo sono:
a. 5000 e 10000 metri.
b. la corsa campestre. La corsa campestre (detta anche cross) è una specialità chenon fa partedelle Olimpiadi, e si
corre su varie distanze comprese fra 4-12 chilometri. Si corre su terreni accidentati con erba,terra, fango, che affaticano
l’atleta e lo obbligano a frequenti cambi di ritmo.
maratona. La maratona si corre su strada lungo un tratto di 42,195 chilometri (più di 2 ore di corsa!). Lungo il percorso
si hanno a disposizione 7 spugnaggi (possibilità di rinfrescarsi) e 6 rifornimenti (possibilità di alimentarsi). Solo nel
1984 alle Olimpiadi di Los Angeles (Stati Uniti d’America) venne inserita la maratona femminile.
marcia. La marcia si corre su strada e si disputa sulla distanza di 20 chilometri (maschile e femminile) e di 50
chilometri (maschile). Nella marcia vi deve sempre essere un piede in appoggio al suolo (come quando si cammina),
cioè non vi può mai essere un momento in cui entrambi i piedi dell’atleta sono sollevati dal terreno (come nella corsa),
e vi deve essere anche il bloccaggio del ginocchio (arto inferiore teso); il contatto con il suolo avviene sempre con il
tallone.
I salti
Si possono distinguere i salti in orizzontale (salto in lungo e salto triplo) ed i salti in verticale (salto in alto e salto con l’asta).
Il regolamento di tutti i salti prevede che l’azione di stacco (ultimo appoggio che precede la fase di volo) si deve realizzare con
un piede solo.
Tutti i salti prevedono quattro fasi: rincorsa, stacco, volo, atterraggio.
salto in alto. Il salto in alto consiste nel superare un’asticella sorretta da due ritti (paletti di sostegno) al termine di una breve
rincorsa (la lunghezza minima della pedana di rincorsa deve essere di 15 metri). Ogni atleta dispone di tre tentativi per ogni
altezza da superare; il salto è nullo (non è valido) se l’asticella cade. Esistono diverse tecniche per superare l’asticella: forbice,
ventrale, fosbury (la più usata).
salto in lungo. Lo scopo del salto in lungo è atterrare il più lontano possibile dal punto in cui è avvenuto lo stacco (ultimo
appoggio prima del volo), dopo una rincorsa (la pedana di rincorsa è lunga 40-45 metri), in un’apposita buca piena di sabbia.
Ogni atleta dispone di tre salti per cercare il salto più lungo; il salto è nullo se l’atleta durante lo stacco tocca con il piede la parte
al di là della linea di battuta o di stacco (costituita da una tavoletta di legno, oltre la quale si pone una striscia di sabbia bagnata
o di plastilina).
salto triplo. Simile al salto in lungo per la rincorsa e lo stacco, prevede però tre appoggi compreso lo stacco (esempio: stacco di
piede sinistro, ancora sinistro, destro e atterraggio).
salto con l’asta. È l’unico salto che prevede l’aiuto di un apposito attrezzo, costituito da un’asta flessibile (generalmente in fibra
di vetro o di carbonio) lunga fino a 5 metri. Lo stacco avviene da una “cassetta di imbucata” che costituisce la zona di arresto
per l’asta. Solo dalle Olimpiadi di Sidney del 2000 è diventata una specialità anche femminile.
I lanci
Il peso, il disco, il giavellotto ed il martello, sono i lanci dell’atletica leggera; gli atleti devono mandare l’attrezzo il più lontano
possibile dalla pedana.
Il regolamento di tutti i lanci prevede che vi siano tre prove per stabilire la miglior misura; il lancio è nullo se l’attrezzo non
cade all’interno di un settore delimitato da righe bianche, e se si oltrepassa la pedana di lancio dopo il rilascio dell’attrezzo.
lancio del peso. Si tratta di lanciare una sfera metallica con una sola mano, rimanendo all’interno di una pedana circolare del
diametro di 2,135 metri. L’ attrezzo deve essere tenuto a contatto del collo e della spalla. Il peso varia a seconda della categoria
e del sesso (12-13 anni: 3-5 chilogrammi per i maschi e 3 chilogrammi per le femmine); l’attrezzo olimpico è di 7,257
chilogrammi per i maschi e 4 chilogrammi per le femmine.
lancio del disco. Consiste nel lanciare il più lontano possibile un disco (di legno o altro materiale adatto), che per gli uomini
pesa 2 chilogrammi ed ha un diametro di 219-221 cm. e per le donne pesa 1 chilogrammo ed ha un diametro di 180-182 cm. La
pedana di lancio è simile a quella del peso, ha il diametro di 2,50 metri ed è circondata da un apposita “gabbia” metallica alta
3,35 metri per prevenire incidenti.
lancio del giavellotto. Il giavellotto è un’asta appuntita della lunghezza massima di 2,70 metri, pesa 800 grammi per gli uomini
e 600 grammi per le donne. La pedana di lancio è lunga circa 30 metri. Per la categoria dei ragazzi (10-11 anni) si usa il vortex

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 16
(pesa 130 grammi e “fischia” quando viene lanciato), un attrezzo propedeutico al lancio del giavellotto; ha la forma di una pallina
ovale con una piccola coda ad un’estremità.
lancio del martello. L’attrezzo consiste in una sfera di ferro, collegata con un filo, lungo 1,22 metri, ad una maniglia triangolare.
Il peso dell’attrezzo è di 7,257 chilogrammi per gli uomini e 4 chilogrammi per le donne. Deve essere lanciato da una pedana
circolare di 2,135 metri di diametro (la stessa del lancio del peso), circondata da una gabbia di metallo alta 2,75 metri.
Le prove multiple
Sono costituite dall’insieme di più gare che devono essere svolte nell’arco di due giornate e danno origine ad una classifica unica
che deriva dalla somma dei punteggi conseguiti in ogni singola gara.
Vince l’atleta che ottiene il maggior punteggio al termine delle varie prove.
Le prove olimpiche sono rappresentate dal decathlon per gli uomini e dall’eptathlon per le donne.
Il decathlon comprende dieci gare: -primo giorno- 100 metri, salto in lungo, lancio del peso, salto in alto, 400 metri; -secondo
giorno- 110 metri ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta, lancio del giavellotto, 1500 metri.
L’eptathlon comprende sette gare: -primo giorno- 100 metri ostacoli, salto in alto, lancio del peso, 200 metri; -secondo giorno-
salto in lungo, lancio del giavellotto, 800 metri.
Atletica leggera
1. Salto in alto
1. con l’ausilio di una panca, gli alunni eseguono salti indietro da fermi, imitando l’atteggiamento in volo, con arrivo sul
tappatone (anche per il “ventrale”)
2. gli alunni eseguono una rincorsa a ginocchia alte (skip) quindi gli ultimi due appoggi (passo-stacco) e saltano sui tappetoni
(anche per il "ventrale")
3. ogni alunno iniziando la rincorsa con il piede di stacco situato sul proprio punto di partenza (distante circa 25-30 piedi
dall'asticella e spostato di 10-12 piedi rispetto a uno dei ritti) esegue, seguendo una linea di riferimento tracciata sul terreno,
6 passi (di cui 2 in rettilineo e 4 in curva) e poi stacca ricadendo al di qua dell'asticella
4. come il c) ma allungando la rincorsa (nel "fosbury" 8-10 passi possono considerarsi standard; nel "ventrale" la rincorsa
obliqua si aggira sui 7-9 passi).
2. Lancio della pallina
Per la corretta coordinazione ed esecuzione vanno benissimo alcune esercitazioni proposte per i giochi sportivi: ad es. la
battuta a tennis e la schiacciata nella pallavolo, e il tiro nella pallamano, presentano tutti gli elementi utili ad un corretto
apprendimento del lancio
ORIENTEERING O CORSA D’ORIENTAMENTO
La storia
L’orientamento nacque ufficialmente nel 1919 in Svezia.
Ben presto si diffuse negli altri paesi nordici e in Svizzera e, negli anni Sessanta, si estese oltre i confini europei.
Nel 1961 fu costituita la Federazione Internazionale di Orientamento.
In Italia la storia di questo sport è recente.
La prima gara ufficiale si disputò nel 1974.
Nel 1980 l’Italia è entrata ufficialmente a far parte della Federazione Internazionale.
Lo svolgimento della gara
Orienteering è una parola inglese che in italiano si traduce con il termine “orientamento” o, meglio ancora, “corsa
d’orientamento” e significa avanzare sul terreno da un punto all’altro con l’aiuto della carta topografica e della bussola,
determinando da soli le vie da percorrere, in base a scelte individuali, che tengano conto delle condizioni orografiche del terreno,
della rete di strade e sentieri, degli ostacoli, delle zone pericolose o vietate, cercando di valutare quale sia il percorso più veloce
e vantaggioso per raggiungere la meta prefissata.
Immaginiamo una corsa campestre in un bosco, dove il percorso non è segnato e mancano bandierine o corde di recinzione.
I concorrenti, che hanno a disposizione una cartina della zona e una bussola, devono passare per alcuni punti prestabiliti ove c’è
la punzonatura di controllo, e arrivare al traguardo nel minor tempo possibile.
Ognuno sceglie il tragitto che vuole (un comodo sentiero consente di correre veloce ma allunga la strada, mentre un percorso
all’interno del bosco è più breve ma anche più faticoso); a decidere saranno intelligenza, esperienza, spirito di osservazione,
carattere e forze.
Nelle gare di orientamento non è infatti la sola velocità a determinare il vincitore, vi è una combinazione di quattro fattori
importanti:

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 17
Interpretazione corretta dei simboli cartografici
Scelta del tracciato più veloce
Abilità nel servirsi della bussola
Tempo impiegato per effettuare il percorso.
Il percorso di solito va da 3 a 12 chilometri.
Riassumendo fare orientamento o orientarsi (con l’aiuto della carta topografica e della bussola) significa:
Muoversi in rapporto allo spazio in cui ci troviamo
Scegliere direzioni, punti di riferimento, valutare distanze per raggiungere determinate mete
Osservare i particolari che ci circondano per fissare con sicurezza la posizione durante il nostro avanzamento
Essere consapevoli del nostro movimento.
L’orientamento è uno sport completo, impegna contemporaneamente il fisico e la mente, sviluppa nei praticanti l’agilità, la
determinazione, la concentrazione, la sicurezza; aiuta a stabilire il giusto equilibrio fra prestazione atletica e benessere psichico
e fisico e, chi ama la natura e al tempo stesso l’attività motoria, può trovare nell’orientamento la forma di movimento ideale.
In Italia l’orienteering come disciplina sportiva fa parte della F.I.S.O. (Federazione Italiana Sport Orientamento) che è una
federazione associata alla F.I.D.A.L. (Federazione Italiana Di Atletica Leggera).
ORIENTEERING
1. in classe consegnare agli alunni la cartina della palestra “adattata” e formare gruppi da 4: gli alunni produrranno ognuno
sulla propria cartina un percorso con 8 punti compresi partenza ed arrivo; sulle cartine così completate andranno segnati i
nomi di tutti i 4 componenti il gruppo (mezza lezione impegnata)
2. in palestra a turno i gruppi svolgeranno un percorso prodotto da un altro gruppo (ogni alunno dovrà “trovare” due punti); i
gruppi non impegnati nello svolgimento del percorso, con le tre copie avanzanti controlleranno la corretta esecuzione dello
stesso.
3. dalla palestra ogni 30 secondi partirà un alunno con la cartina del cortile segnata da 8 punti compresi la partenza e l’arrivo;
avrà a disposizione 3,30 minuti per trovare gli 8 punti caratterizzati ognuno da una lanternina con una targa di una provincia.
ESERCIZI PER RUGBY E HOCKEY
RUGBY
1. staffetta col pallone (tocco il terreno e torno indietro)
2. staffetta come sopra con aggiunta per imparare la presa a terra
3. staffetta come sopra con aggiunta passaggio del pallone all’altezza della pancia
4. avanzamento a coppie con passaggio del pallone
5. 5 cerchi a quadrato, 5 palloni nel cerchio centrale, 4 concorrenti: vince chi porta uno alla volta tre palloni nel proprio cerchio
6. bandiera con un pallone
7. bandiera con tre palloni
8. partita con passaggio in avanti (7 tocchi?), mischia iniziale, fuori, “trasformazione” (punti?)
9. partita con passaggio regolare.
HOCKEY (anche con palline da tennis)
1. a coppie (far vedere come si impugna e come si controlla la mazza): una mazza per coppia, uno di fronte all’altro, 5 passaggi
a testa di dritto da breve distanza e poi da media e lunga (occhio al controllo della mazza sui passaggi lunghi!)
2. a coppie: una mazza per coppia, come l’1 ma di rovescio
3. a coppie: una mazza per coppia, A dietro B, parte B colpendo la pallina di dritto durante l’avanzamento e tornato indietro
consegna mazza e pallina ad A che comincia a sua volta
4. a coppie: una mazza per coppia, come il 3 ma di rovescio
5. a coppie: una mazza per coppia, come il 3 ma condurre la pallina attaccata alla mazza (non a colpi)
6. a coppie: una mazza per coppia, come il 5 ma di rovescio
7. 2 gruppi: quello con le mazze passa fra i compagni che fanno le statue
8. come il 7 ma le “statue” formano una fila e bisogna superarli facendo uno slalom fra di loro
9. a coppie: una mazza per coppia, uno di fronte all’altro, 5 tiri a testa da breve, media e lunga distanza (occhio al controllo
della mazza!) di dritto
10. a coppie: una mazza per coppia, come il 9 ma di rovescio.
RAPPORTO FRA ATTIVITÀ MOTORIA E SALUTE

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 18
Un tempo si ricorreva al medico solo in caso di malattia; il concetto di salute corrispondeva semplicemente a quello di assenza
di malanni.
Non ci si preoccupava di prevenire i problemi né si pensava di far ricorso all’attività motoria come strumento idoneo a mantenere
la salute e a evitare l’insorgere di disturbi connessi all’invecchiamento, che si ritenevano ineluttabili.
La tabella sotto individua le principali cause di morte nei paesi sviluppati riferita a qualche anno fa.
Cause di morte %
Tumori 24
Malattie infettive 3
Malattie dell’apparato respiratorio 10
Cause accidentali 6
Malattie dell’apparato cardio-circolatorio 57
Una buona forma fisica porta ad una miglior qualità della vita, a condizioni di maggior resistenza alle malattie ed a
situazioni straordinarie.
L’esercizio fisico regolare (meglio se a componente aerobica) previenee protegge da alcune malattie croniche e riduce i fattori
di rischio legati a:
Malattie cardiovascolari.
Ipertensione arteriosa. Migliora le condizioni di efficienza cardiaca riducendo inoltre in modo naturale la
pressione arteriosa
Diabete. Migliora l’utilizzazione del glucosio stabilizzando i valori glicemici vicino alla normalità, contrastando
validamente condizioni di diabete, sia giovanile che senile
Obesità. Favorisce un miglior utilizzo degli acidi grassi riducendo il tessuto adiposo, e contribuendo ad un più
agevole calo di peso
Osteoporosi. Fornisce una valida prevenzione alle sintomatologie osteoarticolari.
E’ possibile affermare che se si effettuasse una maggior attività fisica, la vita sarebbe probabilmente più lunga e
soprattutto migliore.
Da questo punto di vista è sufficiente rilevare come, quando si sottopongono agli alunni test di mobilità articolare, questa risulta
già a 12-13 anni scarsa in molti soggetti.
Se a 12 anni non si riesce flettendo il busto in avanti e mantenendo le gambe tese a toccarsi la punta dei piedi con le mani, cosa
succederà con l’avanzare degli anni?
L’esercizio fisico regolaremigliora:
La massa magra, la potenza e la forza muscolare
L’equilibrio, la coordinazione e la destrezza
La mobilità articolare e la densità ossea
La capacità aerobica e la resistenza
Il metabolismo glucidico e lipidico
La situazione posturale (paramorfismi della colonna vertebrale)
La fiducia nei propri mezzi
La socializzazione.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 19
Descriviamo ora gli effettivi benefici della regolare attività fisica sui vari apparati del corpo umano.
Sull’apparato osteo-articolare:
a) Stimola lo sviluppo in lunghezza
b) Favorisce una miglior nutrizione del tessuto osseo
c) Aumenta la resistenza e la robustezza
d) Irrobustisce le capsule articolari
e) Conserva la mobilità fisiologica
Sull’apparato muscolare:
a) Aumenta la sezione trasversale totale
b) Varia la forma del muscolo
c) Aumenta la capacità di sostenere sforzi prolungati
d) Aumenta il deposito di sostanze energetiche nel muscolo
Sull’apparato respiratorio:
a) Abbassa la frequenza respiratoria
b) Aumenta la capacità vitale
c) Riduce i tempi di recupero
d) Aumenta il tempo di apnea
Sull’apparato cardiovascolare:
a) Aumenta il volume e lo spessore delle pareti del cuore
b) Aumenta la gittata sistolica
c) Aumenta la gittata cardiaca
d) Migliora la capacità di trasporto dell’ossigeno
e) Riduce il numero delle pulsazioni a riposo
f) Riduce i tempi di recupero
g) Aumenta la capillarizzazione del cuore
h) Facilita il ritorno del sangue al cuore
Perché un’attività motoria sia efficace ed utile deve rispettare i seguenti criteri:
Frequenza di 2 - 3 volte alla settimana
Durata da 30 a 45 minuti
Pulsazioni dal 60 al 70% della frequenza cardiaca massima ( la frequenza cardiaca massima si calcola sottraendo a
220 l’età dell’atleta; per un atleta di 13 anni la frequenza cardiaca massima corrisponderà ad esempio a 207
pulsazioni al minuto e il 70% corrisponderà a 145 pulsazioni al minuto).
IL DOPING
La legge ed i regolamenti del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) definiscono doping l’impiego di sostanze e metodiche
proibite in grado di influenzare e modificare la prestazione sportiva.
È considerato doping e quindi proibito anche l’impiego di sostanze e metodiche atte a mascherare l’eventuale assunzione di
sostanze proibite.
Eticamente il doping è un imbroglio.
Vincere usando pratiche dopanti equivale a rubare la vittoria a chi si comporta correttamente e rispetta le regole.
Anche una tua vittoria potrebbe esserti rubata da un disonesto.
In ogni caso è bene sapere che nessuna pratica dopante può far diventare un atleta comune un campione, e che senza allenamento
non si ottiene nulla.
La quota di miglioramento legata al ricorso al doping è solo una frazione di quella che può provenire da un corretto allenamento
e da una corretta alimentazione.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 20
Le sostanze dopanti producono danni rilevanti all’organismo.
Alcuni organi subiscono danni spesso irreversibili.
Ogni anno si registrano morti legate al doping in tutto il mondo, ma questa è solo la punta dell’iceberg perché ben più consistente
è il numero dei danni fisici, anche irreversibili, causati dal ricorso a sostanze dopanti.
Aumento dei tumori, lesioni muscolari ed articolari, malattie ormonali, sterilità, sono solo alcune delle conseguenze dell’uso di
doping nello sport.
Per combattere l’uso del doping vengono effettuati controlli, realizzati con l’ausilio di analisi fisico-chimiche dell’urina
dell’atleta.
È allo studio l’introduzione di controlli anche sul sangue degli atleti che si devono sottoporre all’esame antidoping.
Origini e storia del doping
La pratica del doping ha origini molto antiche, anche se il termine inglese to dope, che significa “drogare”, compare solo alla
fine dell’800.
Già i Greci ed i Romani facevano infatti uso di sostanze estratte da piante, funghi o semi, ritenute capaci di migliorare le
prestazioni agonistiche.
Il primo caso accertato di morte per doping risale al 1886 con la morte per overdose (dose eccessiva) di droga del ciclista Arthur
Lington durante la corsa Bordeaux-Parigi.
Nel ventesimo secolo (quello scorso, ora siamo nel ventunesimo secolo) gli interessi economici legati allo sport diventarono
sempre più elevati: lo sport risultò un vero affare per chi lo gestiva e per chi lo praticava con successo ed il fenomeno doping si
diffuse in modo massiccio.
Negli anni 50 dello scorso secolo fecero la loro comparsa le anfetamine, che ebbero la loro massima diffusione negli anni 70 e,
poco dopo, i primi stimolanti artificiali; la loro funzione era di aumentare l’aggressività, la concentrazione, di migliorare la
resistenza allo sforzo riducendo la sensazione di stanchezza.
Intanto i casi di malattie legate al doping divennero sempre più numerosi.
Alle Olimpiadi di Roma del 1960 morirono due atleti: il ciclista danese Knut Jensen, stroncato da un collasso per eccesso di
anfetamine, e l’ostacolista Dick Howard, trovato morto per overdose di eroina.
Sulla scia emotiva di queste due morti, nel 1960 venne mosso il primo passo significativo nella lotta contro il doping, con
l’introduzione dei primi test antidoping e con il Concilio Europeo (comprendente 20 nazioni) che compilò un documento di
condanna dell’uso di sostanze dopanti nello sport.
Si dovette arrivare, però, alla tragica scomparsa del ciclista britannico Tommy Simpson durante il Tour de France del 1967, per
muovere passi più convincenti nella lotta al doping.
Nel 1968 il C.I.O. rese ufficiale la prima lista di sostanze proibite e nel 1971 pubblicò una lista dettagliata dei farmaci e delle
sostanze non utilizzabili dagli atleti, che con continue rettifiche e aggiornamenti è tuttora in vigore.
Negli anni 80 lo sviluppo delle tecniche di laboratorio contribuì a incrementare i tipi e la frequenza dei test antidoping; ma gli
atleti cominciarono ad assumere le sostanze dopanti lontano dal periodo di competizione e dai relativi controlli antidoping.
Si diffuse il doping ematico, ossia la somministrazione di globuli rossi (autoemotrasfusione), oppure di sostanze artificiali, per
migliorare il trasporto di ossigeno, con il rischio anche di provocare gravi danni cardio-circolatori.
Nel corso degli anni 80 ebbero grande diffusione anche gli steroidi anabolizzanti, in grado di far aumentare la massa muscolare,
ma accusati di causare tumori e impotenza.
Durante la guerra fredda, la competizione tra paesi dell’Est e dell’Ovest raggiunse i suoi massimi livelli.
I paesi dell’Est pianificarono, con le proprie federazioni, programmi di somministrazione scientifica dei farmaci ai propri atleti,
per dimostrare con le vittorie che erano superiori ai paesi dell’Ovest.
Gli effetti di queste sostanze erano fin troppo visibili: alterazioni ormonali provocavano la comparsa di caratteri maschili nelle
atlete e in generale danni organici irreversibili.
Il fenomeno si diffuse anche in Occidente, come dimostra la squalifica del velocista canadese Ben Johnson, accusato di aver
fatto uso di steroidi anabolizzanti alle Olimpiadi di Seul del 1988, e come dimostrano le continue squalifiche nei confronti di
atleti trovati “positivi” ai test antidoping.
Le categorie delle sostanze dopanti
Stimolanti
I più noti sono le anfetamine (e i loro derivati), la cocaina, e con effetti più blandi la caffeina e l’efedrina.
Le anfetamine, per esempio, vengono utilizzate perché favoriscono l’irrorazione sanguigna dei muscoli scheletrici; fanno
aumentare la concentrazione, l’aggressività e lo spirito agonistico, migliorano la resistenza allo sforzo e riducono la sensazione
di stanchezza.
Gli effetti collaterali di queste sostanze, che danno dipendenza e assuefazione, sono a carico del sistema nervoso: disturbi del
sonno, stato depressivo, inappetenza, mancanza di spirito autocritico.
Narcotici e analgesici
I più noti sono la morfina, l’eroina, il metadone e la pentazocina.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 21
Sono sostanze derivate dall’oppio, usate in medicina a scopo terapeutico in casi molto gravi, per la loro azione antidolorifica,
calmante e rilassante.
Queste sostanze vengono ricercate ad esempio dai lottatori e dai pugili, perché riducono le sensazioni di dolore e danno un
temporaneo stato di euforia.
L’effetto collaterale più grave di queste sostanze è la tossicodipendenza (dipendenza e assuefazione); altre conseguenze sono
disturbi gastrointestinali, vertigini, sonnolenza, difficoltà respiratorie e di concentrazione.
Steroidi anabolizzanti
I più noti sono il nandrolone, l’ossandrolone, il deidroepiandrosterone (DHEA).
Sono derivati sintetici del testosterone, ormone sessuale maschile responsabile dell’incremento della massa muscolare e della
forza.
Tra gli effetti collaterali vi sono sterilità e virilizzazione, rotture tendinee, infarto del miocardio, tumore del fegato, disturbi
psicologici.
Nelle donne, l’effetto più vistoso è la virilizzazione, per cui le atlete perdono i tratti della femminilità.
Diuretici
Alcuni farmaci sono l’acetazolamide, il mannitolo, il bumetamide.
Sono farmaci che favoriscono l’eliminazione di liquidi attraverso la diuresi (eliminazione dell’urina).
Vengono ricercate dai pugili e da altri atleti di sport con categorie di peso, perché queste sostanze permettono di rientrare
velocemente nei limiti imposti da una categoria.
Vengono anche utilizzati per diluire le urine e mascherare la presenza di sostanze proibite.
Gli effetti collaterali sono grave disidratazione e difficoltà nella termoregolazione.
Ormoni peptidici, glicoproteici e analoghi
I più noti sono la somatotropina (GH, meglio conosciuto come “ormone della crescita”) e l’eritropoietina (EPO).
L’ormone della crescita (GH) viene impiegato, perché consente di ottenere gli stessi effetti degli anabolizzanti, senza la
possibilità di essere scoperto; viene usato principalmente nell’atletica pesante e dai culturisti.
Gli effetti collaterali sono deformazioni ossee, insufficienze cardiache, diabete e neoplasie.
Molti di questi effetti si evidenziano molto tempo dopo l’assunzione e sono irreversibili.
L’eritropoietina (EPO) è un ormone che stimola la produzione di globuli rossi aumentando il trasporto di ossigeno ed il massimo
consumo di ossigeno; viene usato negli sport a base aerobica come ad esempio il ciclismo e lo sci di fondo.
Il sangue diviene sì più ricco di globuli rossi, ma anche molto più denso e quindi aumenta notevolmente il lavoro del cuore.
Gli effetti collaterali sono infarti, trombosi, tumori del midollo osseo e ipertensione arteriosa.
NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO
In palestra i traumi più frequenti sono dovuti a cadute, scontri con compagni, atterraggi mal eseguiti, pallonate accidentali,
problemi muscolari.
Si tratta generalmente di contusioni, distorsioni o lesioni muscolo-tendinee, più difficilmente di vere e proprie ferite o fratture.
Analizziamo i diversi casi.
LESIONI DEI TESSUTI
Contusione. Si chiama contusione il risultato di un violento urto che una parte del nostro corpo può subire contro un qualsiasi
elemento rigido (la parete, la spalliera, il gomito di un compagno).
Nella contusione non vi è rottura della cute ma un versamento di sangue sotto la pelle.
Come si presenta: la parte contusa appare dolorante e gonfia; il sangue uscito dai vasi provoca il livido, una macchia bluastra
che assume colore differente con il passare dei giorni (dal bruno al giallo-verdastro) guarendo spontaneamente in circa 6 giorni.
Cosa si deve fare: applicare subito ghiaccio o compresse di garza bagnate con acqua fredda. Il freddo provoca l’immediato
restringimento dei vasi sanguigni e limita il versamento (livido).
Ferita. È la rottura della pelle con fuoriuscita di sangue provocata da oggetti appuntiti o taglienti. Sidicono abrasioni o
escoriazioni quelle più superficiali provocate da sfregamento su superfici ruvide (le classiche “sbucciature” alle ginocchia o ai
gomiti).
Come si presenta: rottura della pelle con bruciore e fuoriuscita di sangue.
Cosa si deve fare: se la ferita è di lieve entità, basterà lavarla con una garza sterile imbevuta di disinfettante (in mancanza di
disinfettanti lavare con acqua e sapone neutro) agendo con movimenti semicircolari che vanno dal centro della ferita verso la
periferia per allontanare eventuali materiali estranei presenti sulla cute, che possono causare infezione. Copri poi la ferita con
una garza sterile, fissando la medicazione con una benda non troppo stretta o con un cerotto. Se la ferita è profonda e continua a
sanguinare, cerca di fermare l’emorragia sovrapponendo diversi strati di garza ben compressi sulla ferita (l’emorragia può essere
arteriosa o venosa: se arteriosa il sangue è rosso vivo e zampillante e va fermata con un laccio o un foulard legato a monte della
ferita, se è venosa il sangue è rosso scuro e colante e per fermarla basta applicare una fasciatura che comprima bene la ferita).

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 22
Emorragia dal naso o epistassi
È la classica perdita di sangue dal naso che si produce a seguito di un colpo (una pallonata o un qualsiasi trauma) al naso o anche
semplicemente per un forte starnuto o un intenso sforzo muscolare o per l’eccessivo caldo.
Come si presenta: vi è una fuoriuscita di sangue dal naso, a volte anche discretamente abbondante. Normalmente non vi è nulla
di preoccupante, ma se il naso presentasse un evidente gonfiore o la sua normale forma fosse alterata potrebbe essere il sintomo
di una frattura del setto nasale.
Cosa si deve fare: comprimere la narice sanguinante per alcuni minuti, applicare ghiaccio (in sua assenza acqua fredda) sulla
fronte per provocare il restringimento dei vasi sanguigni, inclinare la testa leggermente in avanti.
LESIONI MUSCOLARI
Stiramento. Lo stiramento è il grado più semplice di lesione muscolare, dovuta a una tensione eccessiva del muscolo con
conseguente rottura di alcune fibre che lo compongono.
Come si presenta: il dolore è forte ed improvviso, non provoca immediata incapacità di movimento e risulta quasi assente a
riposo, ma ricompare con il movimento, impedendo di continuare l’attività.
Cosa si deve fare: impacchi freddi e sospensione dell’attività; il muscolo recupera la sua piena funzionalità con 5-6 giorni di
riposo del muscolo interessato.
Strappo. È la rottura di numerose fibre muscolari dovuta a eccessivo stiramento.
Come si presenta: improvviso e acutissimo dolore che si accentua al minimo movimento. La lesione si caratterizza per la presenza
di un avvallamento lungo il decorso del muscolo, prodotto dall’allontanamento delle fibre muscolari e obbliga a completa
immobilità della parte interessata.
Cosa si deve fare: applicare subito ghiaccio, da tenere per le prime 48 ore. La muscolatura dovrà essere tenuta in assoluto riposo
per 8-10 giorni.
Crampo. È una improvvisa e acuta contrazione involontaria del muscolo causata solitamente da un eccessivo affaticamento in
situazione di sudorazione abbondante, oppure dal freddo o da posizioni inusuali mantenute a lungo.
Come si presenta: il muscolo appare duro e dolorante e si ha una temporanea incapacità di movimento.
Cosa si deve fare: se non si risolve spontaneamente puoi rilassare il muscolo allungandolo gradualmente oppure puoi intervenire
con una pressione costante eseguita localmente.
LESIONI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI
Distorsione. È il primo scalino a livello di gravità, dei traumi a carico delle articolazioni. È il temporaneo allontanamento dei
capi articolari dalla propria sede naturale, seguito da immediato ritorno spontaneo in sede. Lo spostamento dei capi articolari
causa la distensione e spesso la rottura dei tessuti circostanti (i legamenti e le capsule articolari) e dei vasi sanguigni,
determinando diversi livelli di gravità del trauma.
Come si presenta: forte dolore e gonfiore, limitazione del movimento dell’articolazione interessata.
Cosa si deve fare: applicare del ghiaccio o dell’acqua fredda per ridurre il dolore e il gonfiore, immobilizzare l’articolazione.
Lussazione. È lo spostamento permanente dei capi articolari fuori della propria sede. Quando i rapporti articolari non sono
totalmente persi e rimangono dei punti di contatto, si parla di sub-lussazione. Generalmente è dovuta a un colpo molto violento
e comporta la rottura grave della capsula articolare e dei legamenti.
Come si presenta: fortissimo dolore, incapacità di movimento e gonfiore. L’articolazione appare deformata per lo spostamento
dei capi articolari e per il gonfiore dovuto all’edema.
Cosa si deve fare: applicare del ghiaccio, immobilizzare l’articolazione e portare il soggetto in ospedale.
Frattura. È la rottura di un osso. Può essere causata da un trauma diretto (martello che colpisce un dito) o indiretto (rottura del
femore per caduta); può essere chiusa quando l’osso non fuoriesce dalla cute o esposta se vi è fuoriuscita dell’osso dalla cute,
complicata se ha danneggiato vasi e nervi circostanti, composta o scomposta.
Come si presenta:il sintomo fondamentale è il dolore, che aumenta con il passare del tempo. Altri sintomi sono tumefazione e
incapacità di movimento.
Cosa si deve fare: applicare del ghiaccio, evitare di muovere l’infortunato, coprire le eventuali ferite aperte con garze sterili,
immobilizzare l’arto con mezzi d’emergenza (stecche improvvisate, cuscini, coperte) e fasciare.
I PARAMORFISMI O DIFETTI DI ATTEGGIAMENTO DEL CORPO
Una particolare attenzione va posta dai 6 a i 13 alle posizioni e portamenti viziati che, a causa dello scheletro in formazione e
della ipotonicità muscolare, possono causare le prime apparizioni di paramorfismi.
Cifosi o dorso curvo
Cos’è. È un’accentuazione della curva dorsale della colonna vertebrale che dà una forma arrotondata al dorso ed impoverisce la
statura.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 23
Com’è. È poco funzionale ed antiestetica, dato che fissa le spalle in avanti, porta alle scapole alate, irrigidisce la gabbia toracica,
riduce la mobilità delle spalle e l’efficienza respiratoria.
Perché. Si hanno cattive abitudini posturali e i muscoli dorsali deboli.
Lordosi o atteggiamento lordotico Cos’è. È un’accentuazione dellacurva lombare della colonna vertebrale con l’addome che sporge in avanti (posizione della donna
in gravidanza).
Com’è. Dolorosa ed antiestetica. L’addome è spinto in avanti, le spalle indietro e i glutei sono evidenti.
Perché. I muscoli addominali sono deboli, probabilmente si è soprappeso. Attenzione a quando si atterra dopo un salto, per non
gravare troppo sulla parte lombare della colonna vertebrale.
Scoliosi o atteggiamento scoliotico Cos’è. È una deviazione laterale della colonna vertebrale.
Com’è. A una, a due, a più curve, e riduce la mobilità della gabbia toracica e l’efficienza motoria. Se è molto accentuata fa
ruotare i corpi vertebrali che possono causare deformazioni del torace. Perché. Si sta troppo in posizione ancata quando si è in
piedi o ci si appoggia sul banco in posizione laterale o si porta lo zaino sempre sulla stessa spalla.
Piede piatto
Cos’è. È un abbassamento della volta plantare.
Com’è. È un piede che prende contatto col suolo con tutta la pianta, determina una camminata senza distensione del piede e
riduce la capacità di spinta e la circolazione sanguigna.
Perché. Sihanno i legamenti dell’arco plantare deboli o si pesa troppo.Si deve essere cauti nel saltare per non caricare troppo i
piedi anche nell’atterraggio.
ESTRATTO DA "LINEE GUIDA PER UN CORRETTO STILE DI VITA"
ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE
All’attività fisica è sempre stato attribuito uno spazio importante nella vita del singolo e della collettività:
fin dalle epoche più antiche, in ogni area della Terra gli uomini hanno dedicato molto del loro tempo a
forme di attività motorie (addestramento militare, gare sportive, palestra, terme, giochi, tornei, danze..)
nelle quali, pur con finalità diverse, corpo e movimento giocavano un ruolo fondamentale. Ma appartiene
all’epoca moderna la consapevolezza scientifica che tale attività, se praticata in modo regolare, non solo
favorisce la migliore funzionalità degli apparati del nostro corpo ma incide in modo significativo sulla
qualità della vita, sullo stato di salute e sul benessere globale della persona, anche nella sua dimensione
psicologica. Al contrario la sedentarietà è considerata, a tutti gli effetti ed in relazione ai risultati di studi e
ricerche pubblicate a livello internazionale, come un rilevante fattore di rischio per l’insorgenza di patologie
importanti e per la conseguente incidenza sui livelli di mortalità della popolazione adulta. Per attività fisica
non si deve intendere necessariamente la pratica di uno sport o l’effettuazione di faticosi allenamenti, ma
anche, più semplicemente ed alla portata di tutti, un’attività moderata, purché costantemente ripetuta.
L’azione del camminare può corrispondere a questa esigenza di attività fisica minima giornaliera in quanto
conciliabile con le esigenze quotidiane in particolare quelle della persona adulta, e praticabile in ogni spazio
e ambiente, senza alcun onere di carattere economico. Quindi un’attività per tutti.
CAMMINARE PERCHÈ. Consente di bruciare calorie in eccesso e, quindi, di mantenere il peso-forma
o di perdere peso. Aiuta cioè a prevenire l’obesità e il sovrappeso. Stimola la respirazione: il movimento
della cassa toracica rappresenta una sorta di massaggio per gli organi interni (fegato, reni, stomaco).
Previene l’osteoporosi: l’azione muscolare stimola la produzione di matrice ossea importante per aumentare
la resistenza e ridurre i rischi di fratture. Stimola la circolazione arteriosa e venosa, ad es. la pianta del piede
viene sottoposta ad un continuo massaggio. Previene l’insorgenza di malattie dell’apparato cardiaco, come
l’infarto, una delle prime cause di morte in età adulta. Stimola il sistema immunitario ed il sistema endocrino
Riduce i livelli di colesterolo, in particolare quello cattivo (LDL) Aiuta a mantenere o ridurre il livello della
pressione arteriosa. CAMMINARE COME. Cammina ogni giorno regolarmene almeno il tempo minimo
utile per riequilibrare la bilancia alimentazione-movimento. Per aumentare i benefici della camminata
aumenta progressivamente la durata. Per aumentare i benefici della camminata aumenta progressivamente
l’andatura: prima lenta poi sempre più veloce. Usa calzature che avvolgano bene il piede, comode,
correttamente allacciate, con una suola elastica per attutire il contatto del tallone al suolo.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 24
Fai attenzione all’azione dei piedi: appoggia prima il calcagno, sposta l’appoggio sulla parte laterale, spingi
sull’avampiede in direzione dell’alluce Nei limiti consentiti dalle tue esigenze quotidiane, scegli percorsi
in ambienti meno inquinati Se scegli la mattina per il tuo trekking fai una colazione nutriente , ma leggera.
Controlla la postura: testa eretta con lo sguardo in avanti, busto verticale, spalle rilassate e braccia che
oscillano liberamente in modo coordinato agli arti inferiori. È sufficiente camminare per almeno 30 minuti
al giorno per bruciare le calorie in eccesso. A seconda delle età e delle opportunità possono essere
considerati attività fisica anche il gioco, la possibilità di svolgere, in alcuni momenti della giornata, semplici
esercizi di mobilizzazione o di allungamento (stretching), salire le scale e spostarsi a piedi quando non sia
assolutamente necessario l’uso dell’auto o dei mezzi pubblici. Anche le attività classicamente svolte per i
lavori di casa fanno bruciare calorie. così come il ballo. Certo, andare in palestra è importante, ma tenendo
sempre bene a mente che dedicare un’ora o due alla settimana alla frequenza di un corso di ginnastica e poi
vivere da sedentari non rappresenta uno stimolo adeguato né sufficiente per adottare un corretto stile di
vita. I 30 minuti consigliati di attività moderata al giorno consentono un consumo di almeno 150 kcal. Si
tratta di un livello minimo, ma che già rappresenta un passo significativo verso il riequilibrio della bilancia
energetica tra entrate e uscite; va sottolineato che tale consumo calorico, anche se modesto, viene
considerato sufficiente a ridurre drasticamente il rischio di patologie. Occorre poi considerare le altre
valenze positive che caratterizzano l’attività fisica, siano esse correlate all’allenamento e al miglioramento
delle capacità motorie che agli aspetti psicologici e relazionali fondamentali per il nostro benessere e per
un corretto sviluppo della persona. Il movimento, inoltre, incide positivamente sui fattori che determinano
stress, ansia, depressione, allentando tensioni o riducendo stati di astenia che incidono negativamente sulla
visione della vita. Se svolto in compagnia, il movimento diventa poi fattore di socializzazione, divertimento,
svago. Il piacere è infatti per molti una componente rilevante della motivazione alla pratica motoria.
L’attività fisica contribuisce al consumo energetico riducendo i rischi derivanti dalle possibili patologie
collegate al sovrappeso; ma certamente i suoi benefici effetti vanno ben oltre, perché si riflettono su tutte
le funzioni del nostro organismo e sulla maggiore efficacia degli apparati. Il nostro corpo, infatti, si
caratterizza per le capacità di adattamento: in caso di prolungata inattività si determina un deterioramento
di tutta una serie di funzioni, mentre un movimento regolare attiva meccanismi tali da svilupparne sempre
più le capacità.
Apparato muscolare e articolare
Sedentari
- Riduzione della capacità muscolare
- Maggior incidenza di infortuni articolari
- Ossa più fragili
- Rischio di insorgenza di paramorfismi e dolori vertebrali.
Fisicamente attivi
- Miglior tono muscolare, articolazioni più salde
- Migliore sintesi dei sali di calcio nelle ossa lunghe, ossa più forti
- Insorgenza ridotta di paramorfismi giovanili e del mal di schiena in età adulta
Apparato cardio-circolatorio
Sedentari
- Pressione arteriosa più alta, maggior incidenza di infarto del miocardio
Fisicamente attivi
- Brachicardia, cioè ridotto numero di battiti al minuto, e pressione arteriosa più bassa
Apparato respiratorio
Sedentari
- Respiro più corto e frequente, affanno anche a sollecitazioni molto basse
Fisicamente attivi
- Bradipnea, cioè ridotto numero degli atti respiratori a riposo, per via di un miglior utilizzo dei volumi
polmonari.
- Recupero più rapido dopo uno sforzo
Apparato digestivo
Sedentari

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 25
- Ridotta motilità intestinale, stitichezza
- Rischio specifico di sovrappeso per aumento della massa grassa
Fisicamente attivi
- Corretta funzionalità intestinale.
- Rapporto peso-statura nella norma
- Corretto metabolismo dei grassi
SUGGERIMENTI
Una vita in movimento… i livelli del benessere.
Il primo livello, molto importante, è rappresentato dalla ricerca di tutte le opportunità di movimento che
vengono offerte dalla vita quotidiana:
- camminare per almeno 30 - 60’ al giorno
- andare a scuola o al lavoro senza utilizzare l’auto o i mezzi pubblici
- utilizzare le scale invece che l’ascensore
- collaborare nei lavori di casa e nelle faccende domestiche
- andare a fare la spesa
Un secondo livello può essere rappresentato da un programma di esercizi ed attività a corpo libero,
realizzabili anche individualmente e in ambienti non specifici (a casa, a scuola, sulla sedia o davanti al
banco, durante l’intervallo in classe o in cortile, in palestra), tre o quattro volte alla settimana, anche solo
per pochi minuti. Ottimi sono gli esercizi di stretching, con i quali si possono mobilizzare le varie parti del
corpo e mantenere una buona elasticità muscolare e flessibilità articolare.
Un terzo livello (da ripetere almeno due - quattro volte alla settimana) può essere rappresentato dal gioco
di movimento:
i giochi
- possono sempre essere adattati all’ambiente in ci si trova (meglio se all’aperto, in un cortile o nel
parco, o dove possibile)
- possono essere organizzati a seconda del numero di giocatori, si possono realizzare anche senza nessun
attrezzo particolare (non esiste solo il calcio…).
Un quarto livello è quello dell’attività fisica vera e propria, motoria e sportiva, organizzata in palestra o
negli ambienti appositamente dedicati (di solito almeno due volte alla settimana). A questo livello possono
essere collocate le attività organizzate all’interno della scuola, nelle ore di educazione motoria, sia le
attività sportive praticate dagli alunni al di fuori degli orari scolastici.
Il quinto livello può essere rappresentato dalle opportunità di effettuare uscite negli ambienti naturali,
per fare… qualsiasi cosa consenta l’ambiente stesso.
CONSIGLI PER GLI STUDENTI
Il banco
Ecco alcuni consigli utili per la salvaguardia dell’integrità funzionale e la prevenzione contro una serie
importante di patologie tipiche della sedentarietà:
1. Non state seduti in appoggio sulla parte anteriore della sedia, sbilanciati indietro con le spalle: è una
posizione dannosissima per la colonna lombare che viene stirata e flessa in modo opposto rispetto alla
posizione naturale.
2. Occupate completamente il piano di seduta della sedia spingendo il più possibile l’appoggio dei glutei
all’indietro. In questo modo la colonna soffre meno dell’inversione di curva lombare, comunque inevitabile
in posizione seduta.
3. Verificate che il piano del banco vi permetta di appoggiarvi agevolmente sopra gli avambracci flessi
all’altezza del gomito. Facendo questa prova scoprirete che raramente il banco è alto; molto spesso invece
è basso. Se non potete cambiarlo provate a mettere degli spessori sotto i piedini.
4. Quando ascoltate le lezioni evitate di coricarvi lateralmente sul banco. Usate invece l’appoggio dei gomiti
sul piano del banco per .scaricare. sulle spalle un po’ del lavoro della schiena.
5. Cercate di non rimanere seduti troppo a lungo e alzatevi spesso dal banco anche solo per 1-2 minuti (ad
esempio al cambio dell’ora). Quando siete in piedi allungate le braccia sopra il capo e fate esercizi di
allungamento.

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 26
6. A casa: cercate posizioni di studio diverse da quelle tenute a scuola. Per scrivere siete obbligati a stare
seduti, ma per studiare e/o leggere un libro potete anche distendervi.
7. Dopo alcune ore di studio non rimanete inutilmente davanti al monitor del computer o al televisore.
Uscite e dedicatevi ad attività di movimento (anche solo camminare di buon passo) per almeno 30’ al
giorno.
Lo zaino
- Fare molta attenzione, al momento dell’acquisto dello zaino, che esso possieda le seguenti caratteristiche:
bretelle larghe, schienale imbottito, maniglia per sollevarlo, cintura per allacciarlo alla vita.
Come preparare lo zaino:
- disponendo libri in altezza e in ordine di pesantezza a partire dallo schienale
- compattando il più possibile il materiale inserito
- regolando le bretelle in modo omogeneo per distribuire equamente il peso sulle due spalle e ad una
lunghezza tale da mantenere lo zaino al disopra della linea delle anche.
Come indossare lo zaino
- indossare lo zaino piegati sulle ginocchia, dopo averlo posto in posizione rialzata
- allacciare la cintura in vita in modo che lo zaino aderisca alla colonna vertebrale.
DOCUMENTO CONI-FIGC SULLO SPORTIVO
SEI UN VERO SPORTIVO SE …
COME ATLETA:
pratichi lo sport per passione
lo pratichi disinteressatamente
segui i consigli di coloro che hanno esperienza
accetti senza obiezioni le decisioni della giuria o dell’arbitro
vinci senza presunzione e perdi senza amarezza
preferisci perdere piuttosto che vincere con mezzi sleali
anche fuori dello stadio ed in qualunque azione della tua vita ti comporti con spirito sportivo o con lealtà
COME SPETTATORE:
applaudi il vincitore ma incoraggi il perdente; poni da parte ogni pregiudizio sociale o nazionale
rispetti la decisione della giuria o dell’arbitro anche se non la condividi
sai trarre utili lezioni dalla vittoria o dalla sconfitta
ti comporti in maniera dignitosa durante la gara anche se sta giocando la tua squadra
agisci sempre e in ogni occasione, tanto dentro quanto fuori dello stadio con dignità e sentimento sportivo.
SPORT E VITA SOCIALE: ALLENARSI AL RISPETTO DELLE REGOLE Per allenarmi a vivere bene devo innanzitutto conoscere ciò che sono, ma anche imparare le regole sociali ed ambientali e
rispettarle, altrimenti non potrò partecipare, cioè prendere parte , alla vita quotidiana. Non conoscere le regole, significa, infatti,
non poter agire nell’ambiente sociale che ci circonda. Se non conosco le regole della pallacanestro non posso prendere parte al
gioco; allo stesso modo, se non conosco e non rispetto le regole sociali non mi integrerò, non sarò un cittadino consapevole e
rispettoso dei diritti degli altri. Esistono regole dettate dalla necessità di coesistere, di vivere insieme con gli altri, in mezzo agli
altri ed all’ambiente che ci circonda. Ecco dunque che il rispetto delle regole apprese nell’attività sportiva può allargarsi al
rispetto dell’ambiente in cui si vive. Su una pista di atletica tutti i corridori girano in senso antiorario, non è ammissibile che un
atleta corra in senso opposto; così come in autostrada è impensabile che si vada contromano e si pretenda di essere nel giusto.
Fair play
Nel Codice Europeo di Etica Sportiva, elaborato nel maggio 1992 dai Paesi dell’Unione Europea e adottato ufficialmente dal
Consiglio d’Europa vi è inserita la definizione del fair play (il gioco leale). Fair play significa molto di più che il semp lice
rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di
pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la
lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo
sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione. Il fair play è un

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 27
concetto positivo. Il Codice riconosce lo sport quale attività socio-culturale che arricchisce la società e l’amicizia tra le nazioni,
a condizione di essere praticata lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che, praticata in modo leale, offre agli
individui l’opportunità di conoscere se stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi personali,
acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Con la
sua vasta gamma di società sportive e di operatori volontari, lo sport è occasione di partecipazione e di assunzione di
responsabilità. Inoltre, un coinvolgimento consapevole in alcune attività può contribuire a promuovere la sensibilità nei riguardi
dell’ambiente.
CARTA DEL FAIR PLAY
1. Fare di ogni incontro sportivo, importa poco la posta in palio e la rilevanza dell'avvenimento, un momento
privilegiato, una sorta di festa;
2. Conformarmi alle regole ed allo spirito dello sport praticato;
3. Rispettare i miei avversari come me stesso;
4. Accettare la decisione degli arbitri e dei giudici sportivi, sapendo che come me, hanno diritto all'errore, ma fanno di
tutto per non commetterlo;
5. Evitare la cattiveria e le aggressioni nei miei atti, nelle mie parole o nei miei scritti;
6. Non usare artifizi né inganni per ottenere il successo;
7. Restare degno nella vittoria come nella sconfitta;
8. Aiutare ognuno, con la mia presenza, la mia esperienza e la mia comprensione;
9. Soccorrere ogni sportivo ferito o la cui vita è in pericolo;
10. Essere realmente un ambasciatore dello sport, aiutando a far rispettare intorno a me i principi qui affermati.
Le singole persone hanno le seguenti responsabilità:
- comportamento personale
1. avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per i bambini e i giovani; non premiare in alcun modo
i comportamenti sleali, nè adottarli personalmente, nè chiudere gli occhi su quelli di altri; applicare sanzioni appropriate
contro ogni comportamento sleale;
2. garantire che il proprio livello di formazione e di qualificazione sia adatto ai bisogni dei bambini in funzione dei diversi livelli
di impegno sportivo;
- azioni verso i giovani
1. garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini o dei giovani atleti vengano prima di ogni altra considerazione
come il successo - anche per interposta persona - o la reputazione della scuola, della società sportiva, dell'allenatore o del
genitore;
2. far vivere ai bambini un'esperienza di sport che li incoraggi a partecipare per tutta la vita ad una sana attività fisica;
3. evitare di trattare i bambini semplicisticamente come piccoli adulti, essere coscienti delle trasformazioni fisiche e psicologiche
implicate nella maturazione giovanile e di come questi cambiamenti influiscono sulla prestazione sportiva;
4. evitare di imporre a un bambino aspettative sproporzionate alle sue possibilità;
5. mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di fare sport, e non esercitare pressioni indebite contrarie al diritto del bambino
di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
6. dedicare un interesse uguale ai giovani con maggiore o minore talento; sottolineare e premiare, oltre che i successi agonistici
più evidenti, la progressione individuale e l'acquisizione di capacità personali;
7. incoraggiare i più piccoli a elaborare propri giochi con proprie regole, ad assumere il ruolo di allenatore, giudice
di gara e arbitro oltre che quello di partecipante; a elaborare propri incentivi e sanzioni per il fair play o per atti
di slealtà, ad assumersi la responsabilità personale delle proprie azioni;

Educazione Fisica 3^ Media - Prof. Flavio Miscioscia Pag. 28
8. fornire ai giovani e alle loro famiglie la maggiore informazione possibile sui rischi e sui benefici potenziali relativi
al raggiungimento di elevate prestazioni sportive.
Conclusione
Il fair play é essenziale se si vuole riuscire a promuovere e sviluppare lo sport e la partecipazione. La lealtà nello sport - il fair
play - è benefica per l'individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso.
Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il FAIR PLAY, IL MODO VINCENTE (chi gioca lealmente è sempre vincitore).
L’ELOGIO DELL’IMPEGNO Da sempre lo sport è stato usato come metafora e immagine della vita. Ne sono un esempio espressioni come: “le tappe della
vita” - “il mondo del pallone” - “la vita è una corsa ad ostacoli” - “la vita come una gara”. Ma la parola che meglio simboleggia
il rapporto vita-sport è impegno.
Leggiamo una testimonianza sul significato profondo di questo termine, che sintetizza lo spirito con cui dobbiamo affrontare la
vita.
Lettera ai giovani di Rita Levi Montalcini (1909 - 2012, è stata una neurologa e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per
la medicina nel 1986; testo liberamente tratto)
… Un atteggiamento ottimista e sereno vi aiuterà in tutti i momenti della vita. Il periodo dell’adolescenza è il più bello ma anche
il più difficile. La sfiducia nelle proprie capacità è causa di angoscia e di dubbi sulle proprie potenzialità. Tuttavia la mia lunga
esperienza e il quotidiano contatto con i giovani mi hanno convinta che gli adolescenti differiscono gli uni dagli altri nell’impegno
con il quale affrontano il compito che è stato dato loro e che si sono prefissi. “I care” (io mi impegno) è il motto che il grande
educatore Don Lorenzo Milani affisse sulla porta nella scuola che aveva istituito nel paese di Barbiana. L’impegno è infatti la
più potente molla che permette di superare i più ardui ostacoli. Ricordatevi che la vita non va mai vissuta nel disimpegno.
Le difficoltà che si devono affrontare e superare sono quelle dell’inserimento in un mondo dai molteplici aspetti come quello
odierno. L’impegno, la fiducia in voi stessi, la serenità ed il coraggio nell’affrontare le difficoltà, sono le doti che io mi augurerei
ognuno di voi possedesse.