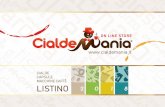Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili
-
Upload
parco-nazionale-dellappennino-tosco-emiliano -
Category
News & Politics
-
view
415 -
download
2
description
Transcript of Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili

1.1 Analisi socio-economica del territorio dei Comuni del Parco
1.1.0 Sintesi
L’obiettivo di questa sezione è fornire elementi utili soprattutto ad un confronto critico tra i dati e le riflessioni che emergono dai singoli territori (Lunigiana, Garfagnana, Appennino reggiano, Appennino parmense) finalizzato ad individuare i punti di convergenza, le principali differenze ed ad evidenziare le possibili connessioni, le carenze da colmare, le sinergie da favorire.
In questo capitolo, coerentemente a quanto espresso nel “Documento di indirizzo al Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili” approvato dalla Comunità di Parco e dal Consiglio Direttivo, non sono stata svolte nuove indagini e ricerche, ma si rileggono sotto l’aspetto economico e sociale le conoscenze che sono state acquisite nella fase di elaborazione del Piano per il Parco ed si mettono a sintesi e confronto gli indicatori utilizzati dagli strumenti di pianificazione socio economica recentemente realizzati dalle quattro Province e dalle Province, Comunità Montane, GAL, CCIAA ed altri Enti Pubblici, istituti di ricerca e associazioni di categoria che hanno svolto analisi economiche e sociali sul territorio dei Comuni del Parco.
Ne consegue che non sempre si è potuto ottenere elaborati di sintesi completi o che facciano riferimento a contesti e periodi uniformi, tuttavia si ritiene che il grado di risposta ottenuto sia sufficientemente chiaro ed efficace per indirizzare correttamente le scelte e le strategie del PPES.
L’analisi ha affrontato tre macro-aspetti:• L’accessibilità, non solo viaria, ma più in generale le possibilità che questo territorio ha di essere in connessione con i flussi economici e sociali nazionali, continentali e globali;• Il contesto sociale, che cerca di fotografare sia la situazione demografica della popolazione residente sia la mappa dei servizi disponi li sul territorio che rappresentano elementi fondamentali per le dinamiche sociali;• Il contesto economico, cercando di mettere in evidenza in particolar modo le correlazioni che tale contesto ha sul tessuto sociale e di approfondire le dinamiche dei due settori (turismo ed agricoltura) che maggiormente si interfacciano con la mission del Parco Nazionale di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio.
Pur avendo presenti i limiti e le approssimazioni già evidenziati, l’analisi svolta evidenzia alcuniaspetti, alcuni già noti altri più “sorprendenti”, che possono essere utile base conoscitiva per ladefinizione degli obiettivi del PPES (capitolo 2) e la selezione delle progettualità da inserire nella “banca progetti” (capitolo 3).
Dall’analisi della accessibilità del territorio, indicatore fondamentale sia per lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile sia per il mantenimento di relazioni sociali ed economiche tra i crinale ed i distretti circostanti, emergono dati contrastanti. Se capoluoghi dei Comuni della Lunigiana e Corniglio appaiono sono ben collegati ad autostrade e ferrovie e distano poco più di un ora dagli aeroporti di Parma e Pisa (base di molte compagnie low cost e pertanto molto interessanti come punto di approdo di turisti stranieri potenzialmente interessati all’offerta turistica del Parco), gli altri capoluoghi dei Comuni del Parco ed ancor di più il crinale in generale appaino estremamente lontani da questi fondamentali nodi di comunicazione. Emblematica è la situazione del Comune di Ligonchio che dista quasi 2 ore dall’aeroporto più vicino, quasi un ora e mezzo da un casello autostradale e da una stazione, eccezion fatta per quella di Piazza al Serchio sulla linea Aulla - Lucca che dista circa 40 minuti. Proprio la linea Aulla-Lucca, pur essendo un collegamento poco frequentato è da ritenere un asse strategico per lo sviluppo socio-economico del Parco, sia per la valenza storica ed ambientale della tratta, sia perché attraversa molti Comuni del Parco “avvicinandosi” in più punti al crinale, sia perché è già oggetto di importanti esperienze di successo nell’ambito turistico (Treno dei sapori della Garfagnana) ed ospita, nella stazione di Rometta, la Piazza dei Parchi, ultima opera del maestro Cascella, che sarà destinata ad ospitare periodici eventi per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici dei Parchi di Mare e diAppennino.

I collegamenti pubblici tra ferrovie e aeroporto ed il crinale sono rari, organizzati prevalentemente lungo le direttrici dei passi e raramente offrendo la possibilità di connessioni tra valli parallele. In coincidenza dei confini amministrativi, inoltre, le rare linee si interrompono senza prevedere coincidenze e connessioni. È evidente che il modello di mobilità pubblica collettiva nel Parco Nazionale è organizzato per le esigenze dei pendolari (o meglio di quei pochi pendolari che non possono utilizzare l’automobile) più che dei turisti.È comunque un Parco “lontano” (che di per se non è esclusivamente un disvalore) poiché solo l’area dei gessi Triassici (Villa Minozzo - Castelnovo ne' Monti) tra quelle interne al perimetro può vantare nel raggio di in 30 minuti d’auto più di 200.000 di residenti.
Nonostante l’importanza delle considerazioni precedentemente fatte si ritiene che la carenza più grave in termini di “accessibilità” del territorio del crinale sia la quasi totale assenza di connessioni internet veloci e a banda larga. Questo ritardo infrastrutturale, nell’era delle comunicazione e dell’accesso, isola il territorio forse più che la distanza da autostrade e ferrovie. La mancata possibilità di fruire dei servizi del world wide web è un limite sia allo sviluppo economico del territorio, soprattutto per il settore turistico e per la commercializzazione diretta dei prodotti agroalimentari tipici, ma è anche un significativo ostacolo per giovani famiglie che vorrebbero stabilirsi sul crinale a cui sono negate anche le possibilità di telelavorare e di fruire di servizi on-line che ormai in molti casi possono efficacemente sopperire a molte esigenze della gestione domestica e della socialità (servizi bancari, telefonia e comunicazione, acquisti, attività culturali, aggiornamento e formazione, consulenza e assistenza).
Sono infatti il saldo naturale ed il saldo migratorio i dati più preoccupanti tra quelli raccolti. In generale negli ultimi anni si assiste a un continuo svuotamento delle popolazioni di montagna ed in particolare nei comuni di crinale comportando conseguenze riguardo alla composizione per età della popolazione, alla sua attività, produttività e anche creatività e innovazione ovvero le basi fondamentali per programmare uno sviluppo socio-economico sostenibile e duraturo per questi territori. Se complessivamente nei Comuni del Parco Nazionale è stato perso “solo” l’1,64% della popolazione dal 1999 al 2007, non si può evidenziare come alcuni Comuni abbiano subito un vero e proprio crollo demografico: Monchio delle Corti -15,71%, Giuncuganano -13,31, Ligonchio - 13,22%, Corniglio -8,10%. Ad essere in positivo sono comunque solo quattro Comuni su 16, con aumenti significativi nei comuni che hanno accesso al fondo valle o che offrono centri dotati di servizi (Castelnovo ne' Monti +7,12%, Licciana Nardi + , San Romano in G. +2,49%, Fivizzano +0,7%) che appaiono in grado di attrarre sia popolazione da a territori, sia i giovani nati nei Comuni circostanti. Questo scivolamento verso valle è testimoniato anche dall’analisi della distribuzione anagrafica. I Comuni di crinale hanno una percentuale di under 25 inferiore alla media degli altri territori (Ligonchio 12,91%, Collagna 15,52%, Ramiseto 16,12%, Comano 15,52%, Monchio delle Corti 10,91%, Corniglio 13,54% ) a fronte invece di percentuali di over 80 più alte della media (Ligonchio 15,20%, Collagna 12,2%, Ramiseto 13,80%, Comano 14,08%, Monchio delle Corti 13,38%, Corniglio 15,05% ): a Ligonchio, Monchio delle Corti e Corniglio si registrano più residenti over 80 di quanti ve ne siano under 25 .
L’area del Parco dimostra però una buona attrattività, dal momento che gli immigrati superano gli emigrati in quasi tutti i casi, soprattutto in Garfagnana, il saldo migratorio positivo non comunque sufficientemente a sopperire alla perdita di popolazione dovuto all’invecchiamento alla bassa natalità. In parte si tratta anche di immigrazione straniera, ne 2007 il 5,32% della popolazione dei Comuni del Parco è straniera (compresi anche i cittadini della UE) con punte numericamente significative nei Comuni di Castelnovo ne' Monti (925), di Fivizzano (283), di Licciana Nardi (265) e di Villa Minozzo (244%). Estremamente alto, quantomeno in percentuale, il valore del Comune di Comano (10,12%, 79 persone).
Conseguenza non meno importante di questo spopolamento è la diminuzione del ruolo di presidio del territorio: complessivamente si contano 35,7 abita per km2 (media nazionale 199,3) ma nei Comuni di crinale (Collagna, Comano, Corniglio, Ligonchio, Monchio delle Corti e Ramiseto) gli abitanti per km2 non sono più di 15. Mediamente nel territorio del Parco “solo” il 44% delle abitazioni (per la precisione della superficie delle abitazioni) è abitata da residenti, il

resto del patrimonio immobiliare è in parte abbandonato, in parte fruito da persone di passaggio ed in parte (consistente) si tratta di seconde case.
Oltre alla bassa densità il presidio del territorio è messo a rischio dalla tendenza alla concentrazione della popolazione nei centri abitati maggiori (mediamente il 75,43% dei nuclei famigliari con punte del 97,38% a Collagna, il 91,88% a Busana, l’89,59% a Licciana Nardi). Nel Parco il 17,47% nei così detti “nuclei abitati” (gruppi di case contigue e vicine, con almeno 5 famiglie e con distanza massima di 30 metri fra una casa e l’altra) con punte del 48,58% a Comano, del 35,76 a Corniglio e del 32,62% a Ramiseto, mediamente il 7,1% dei nuclei famigliari vive in “case isolate sparse”, percentuale che varia molto tra valori alti (Giuncugnano 18,45%, Bagnone 17,43%, Villa Minozzo 12,96) e valori molto bassi (Collagna 0,81%, Busana 1,59%, Corniglio 1,86%). La dispersione territoriale è però anche causa di difficoltà di gestione di alcuni servizi pubblici, su tutti quelli della sanità, la raccolta dei rifiuti ed i trasporti collettivi.
La bassa percentuale di laureati e diplomati (seppure il dato disponibile si riferisca solo ai Comuni della Lunigiana e dell’Appennino parmense) non deve, a nostro parere, essere letto come una incapacità del territorio di “produrre” giovani che raggiungono i gradi più alti dell’istruzione, piuttosto di offrire loro forme di occupazione adeguate alle aspettative professionali che il loro percorso formativo gli offre, generando nella maggior casi flussi migratori.
La forza lavoro (quindi gli abitanti dai 15 ai 64 anni, generalmente considerati in età da lavoro) nei comuni del Parco è mediamente solo il 47,74% della popolazione (tasso di attività), ovvero in media ogni abitante lavorativamente attivo nei Comuni l Parco deve provvedere anche almantenimento di un'altra persona. Il tasso di disoccupazione è mediamente basso pari al 3,3% ma con punte che superano il 9 a Comano, Licciana Nardi, Fivizzano.
La maggior parte degli occupati sono nel settore del commercio (comprensivo delle imprese turistiche), ma significativo è anche l’impiego nell’agricoltura (il 37% della superficie dei Comuni del Parco è terreno agricolo a fronte della media italiana pari al 9%) che in alcuni Comuni è un settore molto significativo (Ramiseto 36,57%, Villa Monozzo 27,16%, Giuncugnano 27,12%, Fivizzano 28,55%) ad eccezione dei due Comuni parmensi in cui non risulta occupazione in agricoltura. Le aziende agricole del Pacro sono per lo più di grosse dimensioni, in quasi la metà dei casi superiori ai 100 ettari di estensione (media nazionale 1%) mentre solo nel 9% dei casi si tratta di aziende che hanno un estensione inferiore a 5 ettari (media nazionale 78%). Complessivamente si contano poco più di 4000 aziende agricole nei Comuni del Parco, nel 98% dei casi si tratta di aziende a conduzione diretta per lo più gestite con solo manodopera familiare.
La superficie maggiore è occupata dalle coltivazioni foraggiere avvicendate, che occupano una superficie di 8009,26 ettari. Seguono le coltivazioni con 594,97, di cui 218,56 dedicate al frumento. A completare il quadro ci sono 136,16 ettari di coltivazioni ortive, prevalentemente di piccole aziende e per questo molto numerose pur a fronte di una ridotta superficie occupata (464 aziende orticole per una media di meno di 0,3 ettari per unità).E’ da notare come le coltivazioni ortive siano concentrate soprattutto nei Comuni di Licciana Nardi e Giuncugnano, mentre sono estremamente più ridotte negli altri Comuni. La Lunigiana prevale sia per il numero di aziende in assoluto che per le coltivazioni cerealicole, mentre l’Appennino Reggiano, insieme a quello Parmense prevale per quanto riguarda le coltivazioni foraggere.
I dati circa le forme di utilizzazione dei terreni agricoli nella loro forma aggregata ci danno delle informazioni importanti circa l’incidenza della produzione nell’area del Parco rispetto al territorio italiano. La quota destinata ai seminativi (quasi 9000 ettari) è pressoché irrilevante contro il milione e mezzo di ettari della superficie agricola italiana. Cambiano i termini se invece si considerano per esempio i prati permanenti e pascoli. Per il primo caso, i seminativi, parliamo di un’incidenza dello 0,57%, mentre nel secondo caso, l’incidenza è dell’1,96%. Ancora più evidente è il divario di questa incidenza per altri due significativi settori: quanto riguarda l’arboricoltura da legno l’incidenza del Parco e pressoché irrilevante (0,07%), mentre per quanto riguarda l’area destinata a bosco, l’incidenza del Parco Nazionale dell’Appennino

Tosco-Emiliano supera il 4% in termini di contributi al territorio nazionale.
Nell’area dei Comuni del Parco: prevale l’allevamento suini con 17982 capi di cui oltre 12000 inComune di Castelnovo ne' Monti, seguito dai bovini con 13854 capi (di cui 2/3 circa vacche) per un terzo siti nel Comune di Castelnovo ne'Monti.
Nei Comuni del Parco è molto diffusa la produzione di prodotti agroalimentari tipici certificati, vi è un discreto numero (13) di prodotti DOP ma soprattutto di Prodotti certificati come Tradizionali. La Lunigiana è l’area con un numero maggiore di prodotti agroalimentari tipici (29) ma in termini di produzione e fatturato sono i Comuni emiliani a prevalere grazie alle produzioni DOP del Parmigiano Reggiano e del prosciutto di Parma.
L’andamento del settore turistico vede forti differenze tra i vari territori e anche tra i singoli Comuni.
Delle oltre 235mila presenza complessivamente registrate, 183mila vengono fatte nei comuni dell’Appennino reggiano ed in particolare nel Comune di Busana (74mila) e Collagna (36mila), solo 20mila presenze vengono registrate dai cinque comuni della Lunigiana (di cui solo 14mila dal solo Fivizzano), 22mila dai 3 comuni della Garfagnana (oltre 11mila in ne di Villa Collemandina), circa 9mila dei comuni parmensi (Corniglio quasi 7mila). In Emilia la maggior parte degli arrivi e presenza (circa il 95%) si tratta di turisti italiani, in Lunigiana i turisti stranieri sono invece circa la metà stranieri ed in Garfagnana un quarto. Il rapporto fra presenze e arrivi, dunque la durata media dei soggiorni, è in media di 4,72 per il Parco. Appennino Reggiano e Garfagnana, rispettivamente con 5,24 e 5,26, presentano i valori più alti nella lunghezza dei soggiorni, mentre l’area parmense (2,44) e la Garfagnana (3,02) presentano un indice marcatamente più basso. Complessivamente si contano circa 250 strutture ricettive per un totale di 7400 posti letto di cui circa l’8% in agriturismo (percentuale che sale al 26% in Garfagnana e scende a circa il 2,7% in Appennino emiliano, arriva al 71,5% in Comune di Bagnone e si azzera a Ligonchio). Ogni posto letto è occupato mediamente 34 giorni all’anno (meno di un giorno alla settimana), anche in questo caso con forti oscillazioni: a Castelnovo ne' Monti ogni posto letto è occupato 103 giorni all’anno (a Collagna 84 a Busana 63), mentre a Licciana nardi solo 4 giorni all’anno (Filattiera 8, Comano 7,5).
Dall’analisi di alcuni tra i principali servizi sociali, economici e ricreativi emerge come Castelnovo ne' Monti e Fivizzano siano i soli centri in grado di concentrare una serie significativa di servizi, ma anche come in generale il territorio sia ben infrastrutturato per quanto riguarda scuole, farmacie, banche e stazioni di rifornimento (ad eccezione della zona nei pressi del Passo del Lagastrello), mentre lo sia molto meno per quanto riguarda gli ospedali ed i cinema/teatri.