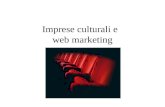nomadismi culturali
-
Upload
marta-ki-morabito -
Category
Documents
-
view
407 -
download
2
Transcript of nomadismi culturali
a cura di Matilde
La coincidenza di territorio, cultura, popolo, stata una delle pi forti e diffuse motivazioni ideali e politiche per la nascita e la costruzione dello stato nazionale. Da qualche tempo tuttavia assistiamo ad un totale sovvertimento del rapporto tra gli spazi territoriali e gli spazi sociali. Nuove forme di migrazioni internazionali, nuovi sistemi di comunicazione, nuovi flussi finanziari, nuove entit politi- che, costituiscono relazioni che attraversano i vecchi confini e assumono come ambito per le loro pratiche socioculturali una multipolarit territoriale. Cos voler studiare le nuove relazioni tra cultura e territorio implica porre laccento sui processi del nomadismo contempora- neo nei suoi effetti a livello globale, a livello locale, a livello virtuale e a livello di esperienza quotidiana: come sogno e come vissuto. Partendo da una tipologia delle nuove forme di nomadismi descritti nelle loro tensioni e nelle loro contraddizioni, il volume raccoglie una serie di saggi che cercano di illustrare gli andamenti dei nomadismi incessanti che percorrono il nostro mondo, le modalit distintive con cui essi alimentano e al tempo stesso subiscono la complessit della contemporaneit, ponendo attenzione ad unetnografia dei traffici moderni dellincorporeo ma anche dei vissuti identitari e delle pratiche statali e parastatali che li avvolgono.
N O M A D IS C O N T E M P O R A N IMNOMADISMI CONTEMPORANEI
R a p p o r t i t r a c o m u n i t l o c a l i, s t a t i - n a z i o n e e f l us s i c u l t u r a l i gl obali M. C a lla ir G a lli Z. A. F ra n c e s c h iI. G. P a z z a g , B. R ic c io L. , , li , Urru
a cura di
Matilde Callari Galli
Callari
GuaraldiUniversitaria
Matilde Callari Galli insegna Antropologia culturale presso lUniversit di Bologna. Tra le sue opere: Antropologia culturale e processi educativi (La Nuova Italia, Firenze 1993); Lo spazio dellincontro (Meltemi, Roma 1996); In Cambogia. Pedagogia del totalitarismo (Meltemi, Roma 1997); Pensare la diversit. Per uneducazione alla complessit umana (con M. Ceruti e T. Pievani, Meltemi, Roma 1998); Se i bambini stanno a guardare (con G. Harrison, Clueb, Bologna 1999); Formare alla complessit (con F. Cambi e M. Ceruti, Carocci, Roma, 2002); La Tv dei bambini. I bambini della Tv (con G. Guerzoni, A. M. Giannotti, C. Rossi, BUP, Bologna 2003).
Galli
Second a edizione
15,00 euro
Guaraldi Universitaria
Antropologi a culturale
Guaraldi UniversitariaAntropologia culturalea cura di I. G. Pazzagli
Seconda edizione: febbraio 2004 Prima ristampa: gennaio 2005 2004 by Guaraldi s.r.l. Sede legale: piazza Ferrari 22, Palazzo Fabbri Scala C 47900 Rimini Redazione: via Spica 1 (Rimini) 0541/52120 www.guaraldi.it E-mail: [email protected] ISBN 88-8049-220-9
MATILDE CALLARI GALLI (a cura di)
NOMADISMI CONTEMPORANEIRapporti tra comunit locali, stati-nazione e flussi culturali globali
con contributi di M. Callari Galli, Z. A. Franceschi, I. G. Pazzagli, B. Riccio, L. Urru
Guaraldi
Indice
Introduzione:
ETNOGRAFIA NOMADICA di Matilde Callari Galli INOMADISMI DELLA CONTEMPORANEIT
p. 7
di Matilde Callari Galli1. Una premessa 2. La contaminazione degli spazi 3. Per una mappa dei nomadismi della contemporaneit 3.1. L analisi culturale 3.2. Processimigratori: ambiguit e prospettive 3.3. Le cultura della diaspora 3.4. Le culture dellemigrazione 3.5. I nomadismi turistici
p. 17 p. 19 p. 20 p. 24 p. 24 p. 26 p. 29 p. 32 p. 38
A VOLTE RITORNANO Fantasma e nomadismi nippo-occidentali di Luigi Urru1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I fantasmi e il lavoro dellimmaginazione Lantropologiae lo spaesamento della modernit Cultura di massa e adesione alla realt Esotismi, appropriazioni,transiti Dallo yojhan al kombini Il sakkaa per reinventare la societ In-conclusione
p. 51 p. 57 p. 62 p. 66 p. 70 p. 76 p. 78 p. 80
MEMORIA
CULTURALE , COSTRUZIONE IDENTI TARIA IN CONTESTO EUROPEO
ED EXTRA -EUROPEO ALLINIZIO DEL SECOLO
XX.p. 83 p. 85 p. 87 p. 92
Una storia di vita di Zelda Alice Franceschi1. Premessa 2. LEuropa a partire dallEuropa.LEuropa dopo lEuropa 3. Oltre la biografia,al di l dellidentit
Indice
4. Il ricordo della memoria, loblio: il narrare della storia 5. Viaggio e immigrazione: storie contemporanee, vecchie e nuove questioni 6. Conclusioni
p. 98 p. 102 p. 108
MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI : IL Riflessioni antropologiche di Bruno Riccio
DECLINO DELLO STATO NAZIONALE
?p. 117 p. 119 p. 121 p. 127 p. 131 p. 136 p. 140
1. Introduzione 2. Lantropologiadelle migrazioni e letnografia della transnazionalit 3. I senegalesi in Italia come esempio di transnazionalit 4. Le ambivalenti politiche migratorie italiane allinterno della FortezzaEuropa 5. Vedere come lo stato:Lo sguardo sedentarista nei confronti delle migrazioni transnazionali 6. Riflessioni conclusive: etnografia translocale ed istituzionale
CONTESTI
UMANITARI E PERIFERI E EMERGENTI
: LA
COOPERAZIONE
INTER -
NAZIONALE E I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEIT
di Ivo Giuseppe Pazzagli1. Premessa 2. La complessit dei nuovi contesti 3. Lantropologiae la cooperazioneallo sviluppo 3.1. Dallantropologiaimpegnata nei processidi sviluppo allantropologiadello sviluppo 3.2. I nuovi scenari della cooperazione e il ruolo delle Ong 4. I nuovi contesti della cooperazionee dellintervento umanitario: il caso del conflitto nella ex Iugoslavia 4.1. La scena italiana in rapporto alla crisi balcanica 4.2. La scena balcanicanella lettura degli operatori di CooperazioneItaliana 5. Conclusioni
p. 147 p. 149 p. 150 p. 150 p. 153 p. 155 p. 158 p. 161 p. 163 p. 166
INTRODUZIONE Etnografia nomadica di Matilde Callari Galli
La coincidenza di territorio, cultura, popolo, stata una delle pi forti e diffuse motivazioni ideali e politiche per la nascita e la costruzione dello stato nazionale: essa ha costituito ispirazione per opere letterarie e imprese belliche, per ribellioni e conflitti; stata la base di analisi politologiche, economiche, sociologiche e antropologiche; ha animato rimpianti e nostalgie tenaci sino a superare lo spazio di una vita. Da qualche tempo tuttavia assistiamo ad un totale sovvertimento del rapporto tra gli spazi territoriali e gli spazi sociali che sembra aver spazzato via la fiducia che linguaggi, pratiche culturali, relazioni sociali, espressioni simboliche, manufatti siano radicati, come origini e come successive modificazioni, a luoghi geograficamente identificabili. Nelle ultime decadi del secondo millennio tanto questa coincidenza quanto lo stato nazionale hanno subito numerosi e svariati attacchi da pi fronti: i violenti conflitti etnici scoppiati nei Balcani, in Somalia, in Indonesia, hanno svelato che lo stato nazionale un coacervo di gruppi diversi, spesso in conflitto fra loro, spesso pi simile ad una comunit immaginata (Anderson, 1983) che ad un tessuto di comunanze; molti stati nazionali sono scossi da tensioni separatiste cruent e ma anche e contemporaneament e altri sono messi in discussione da autorit locali che lottano per rafforzare le loro prerogative e da autorit sovranazionali quali lUnione Europe a o lASEAN, il GATT (General Agreement on Trade and Tariffa) o il WTO (World Trade Organization). Come scrive Habermas, da un punto di vista politico una delle idee pi importanti elaborate negli ultimi se9
Matilde Callari Galli
coli del secondo millennio, la nozione della sovranit degli stati-nazioni stata messa in discussione e si differenziata fra autorit locali, micro-regionali, nazionali, macro-regionali e globali (Habermas 1999). Nuove forme di migrazioni internazionali, nuovi sistemi di comunicazione, nuovi flussi finanziari, nuove entit politiche, costituiscono relazioni che attraversano i vecchi confini e assumono come ambito per le loro pratiche socioculturali una multipolarit territoriale. Storicamente tali entit integrate, dislocate territorialmente su vaste aree e composte di stili di vita, di relazioni sociali, di orientamenti ideologici, di sistemi simbolici, di manufatti che se non potevano essere definiti comuni potevano tuttavia essere tutti iscritti in uno schema di comprensione e di elaborazione comune, sono sempre esistiti: per duemila anni la Chiesa Cattolica stata unorganizzazione attiva a livello del mondo conosciuto e dotata di strutture e dinamiche multilocali e molti grandi imperi del passato possono essere ricondotti, in modo pi o meno diretto a questo modello. Oggi ci troviamo di fronte ad una espansione di idee generali, di stili di vita, di evocazioni di tradizioni lontane, di mode e costumi su base multilocale che riguarda lintero pianeta e che coinvolge, sia pure con modalit ed intensit diverse, la maggioranza dei gruppi umani. Essa dovuta ad una molteplicit di fattori, diversi ma spesso strettamente interrelati: nuovi sistemi di comunicazione, nuove tecnologie di trasporto , movimenti reali e virtuali di milioni di individui spinti ad immaginare o a raggiungere nuove patrie da ragioni molteplici e spesso concomitanti guerre, carestie, persecuzioni politiche, ricerca di maggior benessere e di libert ma anche di novit, di divertimento, di studio e di scambi intellettuali e su tutto, a confondere ed insieme ad amalgamare, una circolazione, anchessa globale e multilocale, dinamica e vertiginosa di immagini, di idee, di oggetti, di usi e costumi. (Giddens 2000; Callari Galli 2000; Callari Galli, Ceruti, Cambi 2003) La dislocazione multivocale di vissuti e di progetti su interi continenti e contemporaneament e la coesistenza, nella stessa10
Etnografia nomadica
area, di una gamma variegata di differenze mutanti e per la loro fluidit di difficile definizione, ha pesantemente indebolito il modello della coincidenza tra cultura e territorio, trasformando in un fenomeno che riguarda lintero pianeta una situazione che nel passato era limitata spazialmente e temporalmente: soprattutt o ha esteso come modello, almeno, e come chance di vita allintera umanit collegamenti, informazioni, mobilit un tempo riservate a gruppi ristretti. Anche se, come vogliono David Morley e Kevin Robins non tutti siamo soggettivit nomadiche e frammentate, anche se non tutti viviamo nello stesso universo post-moderno, anche se un numero ridotto di individui vive sino in fondo e con completezza i processi della globalizzazione, anche se la vita della maggioranza dellumanit a tuttoggi dominat a dagli aspetti localistici ancora ampiamente presenti nella nostra epoca e largamente diffusi nel pianeta, anche se miliardi di invidi nei loro vissuti reali vedono ridursi sempre pi le chances di vita, destinati a vivere nei microterritori nei quali sono nati (Morley, Robins 1995: 218), le lites di tutto il pianeta politiche e finanziarie ma anche culturali e scientifiche assumono ogni giorno di pi, come modelli da vivere, da elaborare, da pro- porre, da imporre, i processi della globalizzazione. Cos le dif- ferenze nel nostro pianeta assumono andamenti diversi dal passato, non sopportano pi opposizioni binarie che divido- no, in modo stabile e netto, le culture dominanti da quelle su- balterne, i centri del potere colonizzatore dalle periferie dei colonizzati. In queste condizioni completamente nuove, la cultura, sia quella legata al mondo delle arti sia quella diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, ha cambiato tempi e luoghi della sua produzione: se ancora essa si connette a quanto nel pas- sato questo o quel luogo ha elaborato, ha diffuso, ha imposto dagli stili di vita ai valori, dalle arti al consumo e allo scam- bio di merci, dalle costellazioni di fede e di pratiche rituali al- le organizzazioni sociali e politiche nuovi luoghi, tran- snazionali e deterritorializzati quali genere, classe, etnicit si affiancano, si sovrappongono, confliggono per fornire allu- manit intera quei filtri attraverso i quali le dimensioni cul-
11
Matilde Callari Galli
turali, intese quali sistemi di significati socialmente organizzati ed espressi in forme definite, sono accettate e condivise di- venendo parte della percezione del proprio gruppo e delle al- terit che continuano a sussistere e a prodursi. I confini della colonizzazione continuano ad essere territoriali ed economici ma essi vengono mescolati, sovvertiti, resi dinamici dalla produzione di un immaginario non solo letterario come nel caso dellorientalismo esotico evidenziato dagli studi di Edward Said ma dipendente da forme di comunicazione sempre pi mobili. Ed ecco la wired identity vissuta nel traffico transnazionale di narrazioni e di immagini (Erny 1996; 2001), ecco una nuova mappa del potere mondiale costruita lungo le linee delle telecomunicazioni (Morley, Robins 1995), ecco lindividuo postmoderno che vive nellera della tecnomitica (Wark 1994), ricevendo informazioni, mutevoli e mobili, che cadono dal cielo, integrandole nelle interpretazioni locali e aspettandosi che gli orientament i cambino da luogo a luogo, di giorno in giorno. Davanti a questo ribollire di cambiamenti che investono molte delle certezze elaborate nei secoli precedenti dalle scienze sociali occidentali, lantropologia costretta a mettere in discussione insieme ai suoi orizzonti concettuali e alle sue pratiche metodologiche i suoi stessi fini, forse le sue stesse basi epistemologiche, rifiutando insieme le ansie universaliste degli esploratori delle leggi universali dellevoluzione della cultura e i relativismo dei cercatori di usi e costumi particolari, spesso esotici e stravaganti, stimolatori di curiosit, sempre postulati come autosufficienti e chiusi in s stessi. (Adam, Borel, Calame, Kilani 2002) Per non cadere nella trappola metodologica di postulare la possibilit di ricostruire la realt basandoci su opposizioni binarie, costretti a scegliere tra lesame delle informazioni non materiali e le chances di vita, tra la deterritorializzazione della cultura e i localismi pi radicati ed esasperati, abbiamo bisogno di recuperare nello sguardo antropologico quello strabismo a lungo invocato nella disciplina che invitava i suoi cultori ad essere insieme gli astronomi di un tempo con i loro lunghi cannocchiali puntati sulluniverso e gli orologiai12
Etnografia nomadica
dei secoli scorsi con le loro piccole lenti fissati su meccanismi minuti e circoscritti. E forse trasportando sul piano meto- dologico un invito che quando fu formulato era soprattutto geografico, a guardare lontano per studiare luomo (Lvi- Strauss 1978:71, 1984; Borel 1993). Questo progetto non ha un piano prestabilito da offrire, non intende proporsi come un paradigma concluso n come uno schema di riferimento teorico completo ed esaustivo. Piuttost o vuol essere unagenda per costruire sequenze di ricerche, su cui annotare nuove prospettive, nuovi luoghi e nuovi ambiti, senza rinunciare agli strumenti propri del passato della disciplina ma ponendone in primo piano alcuni, sviluppandoli maggiormente in confronto ad altri e al tempo stesso provando nuove strategie, applicando nuove tecniche, proponendo nuovi orientamenti e nuove prospettive. In questa linea mi sembra che si ponesse, anni fa, George Marcus quando proponeva unetnografia multisituata nel sistema Mondo, in cui la parola dordine per il ricercatore non pi stare, radicarsi, risiedere, ma seguire: seguire i migranti, seguire le produzioni dei prodotti, seguire le metafore, le narrazioni, seguire la vita, le biografie, seguire i conflitti (Marcus 1995: 98-105). Cos voler studiare le nuove relazioni tra cultura e territorio implica porre laccento sui processi del nomadismo contemporaneo nei suoi effetti a livello globale, a livello locale, a livello virtuale e a livello di esperienza quotidiana: come so- gno e come vissuto; implica studiare problemi che appaiono nella loro complessit solo se ci proponiamo di analizzare in- sieme livelli troppo spesso considerati separati nel dare il predominio alluno o allaltro: i processi globali che investo- no regioni ampie come pi continenti e gli aspetti locali, micro-regionali e nazionali. Ad applicare opposizioni binarie otteniamo risultati parziali, mai pienamente attendibili, spesso falsificanti i dinamismi sociali: infatti se diamo valore solo al primo livello quello globalizzante la dimensione spaziale sembra perdere la sua pregnanza a causa di appariscenti quanto superficiali ed effimeri processi di omogeneizzazione. Se invece13
Matilde Callari Galli
consideriamo la cultura della contemporaneit come unarticolazione processuale e dinamica tra globalizzazione e localismi, se seguendo Appadurai consideriamo la linfa vitale che la globalizzazione riceve dai processi di indigenizzazione dei suoi messaggi, allora lattenzione al territorio, allo stato nazionale, alla comunit divengono ancora e sempre rilevanti. E la critica epistemologica da tempo ci ha resi consapevoli che linterpretazione non deve risultare dalla somma di analisi parziali. Con lorientamento teorico che guarda alla complessit del fenomeno lintero piano metodologico muta: le unit danalisi non sono delimitate e identificate automaticamente nei gruppi locali o negli stati nazionali del passato, ma divengono configurazioni emergenti di pratiche sociali, di simboli, di stili di vita stabili nel tempo se non nello spazio. E conseguentemente dobbiamo prima di volerle comprendere e spiegare, cercare di identificarle e di descriverle. Questo volume raccoglie una serie di saggi che cercano di illustrare gli andamenti dei nomadismi incessanti che percorrono il nostro mondo, le modalit distintive con cui essi alimentano e al tempo stesso subiscono la complessit della contemporaneitt; rivolge anche la sua attenzione alle modalit con cui larcipelago di istituzioni che sembrano resistere ad essi si oppone ai cambiamenti e alle fusioni che sono in grado di provocare. Abbiamo avuto modo di presentare e di discutere questo ampio ambito problematico in un panel dedicato ai nomadismi della contemporaneit, da me coordinato nellambito di un Convegno Internazionale, organizzato dallIstituto per lEuropa centro-orientale e balcanica dellUniversit di Bologna, intitolato Nazionalismo, identit e cooperazione regionale. Compatibilit ed incompatibilit e svoltosi a Forl dal 4 al 9 giugno del 2002. Partendo da una tipologia delle nuove forme di nomadismi descritti nelle loro tensioni e nelle loro contraddizioni, si presentano letture metodologiche dei loro dinamismi, di quelli transnazionali e di quelli globali, di quelli reali e di quelli virtuali, ponendo lattenzione ad unetnografia dei14
Etnografia nomadica
traffici moderni dellincorporeo ma anche dei vissuti identitari e delle pratiche statali e parastatali che li avvolgono. Cultura, processi identitari, articolazioni delle differenze tra richiami al passato e nuove rappresentazioni, costituiscono lo scenario teorico comune su cui gli autori collocano le loro analisi e le loro riflessioni, tesi a mettere in luce, partendo dalle etnografie dei nuovi nomadismi, le loro logiche contaminate, i loro andamenti mutevoli, talvolta irregolari, le loro ibride sovrapposizioni, le lacerazioni ma anche le complicit che essi aprono.
Bibliografia: Abls M., 2001 [1983]. Politica gioco di spazi, Meltemi, Roma. Anderson B., 1996. Comunit immaginate, Manifestolibri, Roma. Appadurai A., 1996. Diversity and Disciplinarity as Cultural Artifacts, in Nelson C., Gaonkar D., (a cura di.), Disciplinarity and Dissent in Cultural Studies, Routledge, London. Borel M. J., 1993. Luniversal et le relatif: note sur lobjet anthro- pologique, in Berthoud G., Centlivees F., Giordano C., Kilani M., (a cura di.), Universalisme et relativisme. Contribution a un dbat dactualit Ed. Universitaires, , Fribourg. Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, B. Mondadori, Milano. Callari Galli M., Ceruti M., Cambi F., 2003. Formare alla complessit, Carocci, Roma. Erny J. N., 1996. On the Limits of Wired Identity in the Age of Global Media, in Identities, 2, n. 4, pp. 419-28. Erny J. N., 2001. Media Studies and Cultural Studies: a Symbiotic Conergence, in Miller T., (a cura di), A Companion to Cultural Studies, Blackwell, Malden-Oxford. Giddens A., 2000. Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna. Habermas J., 1999. Bestialitat und Humanitat, in Die Zeit, n. 18, p. 1. Lvi-Strauss C., 1978. Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano. Lvi-Strauss C., 1984. Lo sguardo da lontano, Einaudi, Torino. Marcus G., 1995. Ethnography in/of the World System: the15
Matilde Callari Galli
Emergence of multi-situated Ethnography, in Annual Review of Anthropology, vol. 24, pp. 95-117. Morley D., Robins K., 1995. Spaces of Identity: Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries, Routledge, London. Pandolfi M., 2002. Moral Entrepreneurs , souverainets mouvant et barbels. Le bio-politique dans les Balkans postcommunistes, in Anthropologie et Socits, vol. 26, n. 1, pp. 29-50. Wark M., 1994. Virtual Geography: Living with Global Media Events, Indiana University Press, Bloomington.
16
I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEIT di Matilde Callari Galli
Pi che unarte di apprendere, larte del viaggio , mi sembra, unarte di dimenticare, di dimenticare tutte le questioni di pelle, di odore, di gusto e tutti i pregiudizi (). Pi che di accrescere le nostre conoscenze si tratta oggi di spogliarcene. M. Leiris, Zbrage, p. 56
1. Una premessa Una lunga storia di nomadismo, svolto cacciando in piccoli gruppi, attraversando per centinai di millenni i paesaggi diversi del nostro pianeta, costituisce per la nostra specie una eredit difficile da dimenticare, per molti antropologi impossibile da cancellare. E la storia del sedentarismo, dei costruttori di citt, intensa e produttrice di un incredibile fervore di innovazioni e di cambiamenti culturali, appare breve un attimo, un battito di ciglia di una divinit se proiettata sullo sfondo dei milioni di anni che lhanno preceduta. Al suo interno, inoltre, possibile cogliere una tensione costante che tiene vivo, a livelli diversi, il desiderio del muoversi, lansia del nuovo, la ricerca di nuovi spazi, la scoperta di nuove modalit di interazione con paesaggi, comunit, culture. E i livelli parlano di migrazioni di piccoli gruppi o di intere popolazioni, di orde feroci che conquistano e abbattono imperi, di caravelle che scoprono nuovicontinenti, di confini naturali continuamente violati da una ricerca intellettuale avida e sempre insoddisfatta, da applicazioni tecnologiche sempre pi audaci nello spostare i limiti considerati dal proprio tempo insuperabili. Tutto questo ribollire di gruppi che si incontrano, si scontrano, si mescolano e si distruggono, subisce nel corso degli ultimi secoli un aumento sempre pi vigoroso dovuto ad una concomitanza di fattori: un aumento demografico mai verificatosi, nel nostro pianeta, in queste proporzioni, lo sviluppo differenziale dei diversi modi di produzione, lattrazione eser19
Matilde Callari Galli
citata in tutti i continenti dalle aree urbane, il potenziamento dei mezzi di comunicazione. E considerare i processi culturali in atto nella contemporaneit significa riconoscere che la dinamica culturale dellintero pianeta oggi condizionata, se non determinata, dal movimento pressoch costante di masse di individui: ogni anno quasi seicento milioni di individui varcano un confine internazionale per seguire le mode e le occasioni dei turismi di massa, mentre sono centinaia di milioni le persone donne e uomini soli, famiglie, intere comunit che emigrano per motivi economici, si ritrovano esuli o profughi a seguito di conflitti e deportazioni o scelgono sem- plicemente di vivere allestero, disegnando cos i loro destini allinterno di spazi tanto vasti quant o il pianeta; o ancora, per le loro attivit professionali, costellano la loro vita quotidiana con continui e ripetuti spostamenti. 2. La contaminazione degli spazi Sarebbe appropriato domandarsi perch gran parte del pensiero occidentale abbia per secoli rimosso questa realt sostituendol a con la convinzione di uno stato di natura che vede la nostra specie essere naturalmente sedentaria: dalla letteratura alle scienze sociali e al senso comune il viaggio, lo spostamento considerato una situazione eccezionale, che rompe equilibri e produce turbamenti. Ed anche quan- do sia considerato con favore riferito sempre ad individui o ad eventi che riguardan o momenti passeggeri, comunque straordinari, della storia individuale o del gruppo: Ulisse, leroe che con le sue avventure sembra annunciare lirre- quietezza della modernit, costretto alle sue peregrinazioni dal volere di dei avversi e insegue con tenacia temeraria il ri- torno alla sua petrosa isola. E la trasformazione del mito omerico, raccontata nel viaggio dantesco, appare pi come un destino fatale che come una scelta deliberata. In campo antropologico mi sembra che anche lo sforzo di Marvin Har- ris di presentare ironicamente la scelta della sedentariet come una necessit resa obbligatoria dalla volont dei cac20
I nomadismi della contemporaneit
ciatori di abbandonare i sanguinosi e dolorosi metodi di controllo delle nascite cui li costringeva la loro economia non adatta a gruppi di larghe dimensioni sia rimasto, al suo apparire, alquanto inascoltato. Dalla convinzione di una sedentariet naturale, pi postulata che dimostrata, scaturisce un approccio tutto particolare allanalisi del nomadismo in base alla quale esso considerat o uninterruzione di una situazione in cui le singole culture si sviluppano attraverso il loro lungo radicamento in un determinat o territorio. Con questa visione la stessa dinamica culturale pressoch interamente riportata allinterno del grupp o esaminato: come ha scritto James Clifford, le radici precedon o sempre gli itinerari (1999: 3). Se invertiamo la prospettiva e postuliamo che il nomadismo, il viaggio non abbiano un carattere di eccezionalit ma siano momenti basilari della dinamica culturale, il territorio, i confini, le identit dei gruppi divengono prodotti culturali, non pi entit naturali ma elementi costruiti dalle pratiche dei contatti e degli spostamenti dei diversi gruppi nel corso della loro storia. La centralit del nomadismo emerge soprattutto alla fine del XX secolo in seguito al virulento sviluppo dei processi di globalizzazione che sembrano travolgere ogni regione del nostro pianeta; ed i processi innovativi propri della nostra contemporaneit, il loro affastellarsi affannoso, fanno esplodere quella coincidenza tra cultura e territorio che stata alla base del modello teorico e politico accettato e affermato dallOccidente soprattutto nei secoli XIX e XX. Le parole che indicano i caratteri del processo di globalizzazione individuate da Anthony Giddens riguardano principalmente il livello economico sottolineando le interazioni finanziarie che accomunano paesi lontani e diversi, la diffusione mondiale delle tecnologie moderne, le nuove forme della divisione e dellorganizzazione della forza lavoro, lemergen- za di un ordine militare mondiale. A queste dimensioni tuttavia se ne sono aggiunte altre, di carattere pi nettamente culturale che con le loro interazioni, con le loro ricadute rendono il quadro ancora pi dinamico e complesso: la cre21
Matilde Callari Galli
scita di reti e di corporazioni transnazionali; nuove tecnologie di informazione e di comunicazione che hanno contribuito ad una intensificazione della compressione spazio/temporale che ha avuto un impatto disorientante e distruttivo sulle pratiche politico/economiche usuali; un aumento vertiginoso negli spostamenti, nelle emigrazioni, nei viaggi internazionali con conseguenti e parallele trasformazioni nella vita sociale e culturale della maggioranza dei gruppi umani. Gli effetti di questi processi innovatori sono sfuggenti e contradditori. Se alcuni analisti sottolineano la prospettiva della nascita di una cultura globale cosmopolita sorretta dalla nascita di culture transnazionali, altri individuano una grande superficialit nel cosmopolitismo contemporaneo, una omogeneit tutta apparente, determinata dalladeguamento generalizzato a modelli consumistici rispondenti alla produzione economica capitalista la McDonaldizzazione del mondo (Barber 1998). E al di sotto di questa coltre si individua un mondo interdipendente a causa dei processi globali che tuttavia continua a produrre localismi esasperati, valorizzazioni di comunit etniche che sembrano sfidare le pi ampie unit politiche in cui sono incorporate rivendicando per s stesse diritti e riconoscimenti propri di nazioni e di stati; la riscoperta di radici e di storie che minacciano non solo le nuove unit transnazionali ma le stesse unit nazionali degli ultimi secoli. (Bhabha 1997). Ad un esame circostanziato appare infondata e approssimativa lipotesi sia della univocit della diffusione nel mondo di un unico modello consumistico sia linevitabilit dei processi di omogeneizzazione culturale ad essa conseguente. La dinamica interculturale della contemporaneit assai pi complessa di queste semplificazioni riduzionistiche. Come scrive Appadurai appena le forze innovative provenienti da diverse metropoli sono portate allinterno di nuove societ, esse tendono, in un modo o nellaltro, a subire un processo di indigenizzazione: questo vero della musica come degli stili abitativi, dei procedimenti scientifici come del terrorismo, degli spettacoli come delle norme costituzionali. In poche parole le singole culture possono riprodursi o ri22
I nomadismi della contemporaneit
costruire la loro specificit sottoponendo le forme culturali transnazionali ad un processo di indigenizzazione (Appadurai 1996: 19). Cos dobbiamo riuscire a sintonicizzarci, per usare unespressione di Robertson, tanto allistituzionalizzazione globale della vita-mondiale quanto alla localizzazione della globalit (Robertson 1999). In termini antropologici, applicando cio questo schema di riferimento alle nostre ricerche che muovono sempre da contesti circoscritti e specifici per poi accedere a pi ampie generalizzazioni, il concetto di deterritorializzazione mostra una sua intima e profonda dinamicit. Nella contemporaneit i processi e i prodotti culturali si svincolano dalla loro aderenza ad un determinato spazio, perdono le connotazioni territoriali , divengono mobili, a volte volatili, per iscriversi sempre e comunque in un particolare luogo. E appare suggestivo il suggerimento di Jonathan Inda e Renato Rosaldo di dividere in due il termine de/territorializzazione per indicare che dal punto di vista antropologico lo sforzo quello di dimostrar e che la deterritorializzazione contiene sempre una riterritorializzazione: questo significa, essi scrivono, che per noi la radice della parola limita lazione del prefisso, cos che mentre il de strappa la cultura dal luogo, la territorializzazione presente in un modo o nellaltro per riportarcela. Cos nessun processo di deterritorializzazione ha luogo senza una qualche forma di riterritorializzazione (Inda, Rosaldo 2002: 12). Usando altre parole, forse necessario non vivere in termini oppositivi globale e locale ma immaginare un incessante processo di deterritorializzazione che investe tanto il processo di globalizzazione quanto le forme che assume il localismo (Cavarero 2001; Callari Galli, Cambi, Ceruti 2003); linvito a cessare di usare concetti quali etnicit e identit per riaffermare i vecchi miti della premodernit, e a considerarli, invece, come processi dinamici che si costruiscono attraverso le pratiche dei contatti culturali. E si deve alla riflessione di Michel Foucaul t aver intuito che lo spazio, nella nostra contemporaneit, ci si offre sotto forma di relazioni23
Matilde Callari Galli
di dislocazione (Foucault 1994: 13): la dislocazione che sostituisce sia la localizzazione propria della concezione spaziale medievale che lestensione con cui il pensiero galileiano laveva sostituita. Cos il tempo storico che aveva costituito il fulcro dellorganizzazione politica e culturale del XIX se- colo con le sue diadi sviluppo/sottosviluppo, progresso/tradizione, per Foucault nella contemporaneit sosti- tuito proprio dallo spazio: non pi quindi una grande storia che si sviluppa nel tempo ma una rete che incrocia dei punti e intreccia la sua matassa. 3. Per una mappa dei nomadismi della contemporaneit 3.1. L analisi culturale Non semplice individuare il contributo che le discipline antropologiche possano dare alla lettura di queste nuove realt culturali, ancora fluide e colme di contraddizioni. Una strada proposta negli ultimi anni sottopone ad una critica serrata lidea profondamente radicata nel pensiero e nel vissuto dellOccidente contemporaneo che considera i modelli di comunit e le attrazioni verso il localismo quali entit naturali ed innate: in effetti mi sembra che applicando anche ad essi i principi epistemologici della nostra metodologia sia possibi- le ricondurl i alla loro culturalit, considerandoli risultati di pratiche politiche e sociali che formano le identit. Se accet- tiamo di sfuggire alle trappole della metafisica della sedenta- riet (Malkki 1997: 61) del resto totalmente contraria ai ri- sultati delle nostre ricerche e dei nostri studi sulla storia della nostra specie se non consideriamo come ovvii e inevitabili il radicamento e lattaccamento alla comunit, se rifiutiamo di accettare acriticamente che le potenzialit affettive e i principi identitari scaturiscano unicamente ed automaticamente dalle esperienze legate ai luoghi in cui si vive e dalle relazioni quotidiane degli incontri faccia a faccia, vedremo con chiarezza che lesperienza apparentemente immediate e dirett a della vi- ta comunitaria, in realt costituita da un ben pi ampio ap-
24
I nomadismi della contemporaneit
parato di relazioni sociali e spaziali. Ed oggi sempre pi numerosi sono gli studi culturali che mirano a fondare unanalisi della contemporaneit ponendo al centro dei loro interessi la diffusione dei fenomeni della globalizzazione, accompagnati, sostenuti, contraddetti da una cultura ad un tempo globale e frammentata, deterritorializzata e localistica. In particolare, attraggono la loro attenzione lintreccio del locale e del globale, la connessione tra globalizzazione e lemergenza di nuove forme di esclusione e di ineguaglianza, la relazione tra la transnazionalizzazione dei contesti specifici e la riarticola- zione contestuale dei flussi transnazionali umani, finanziari, di immagini, idee, informazioni (Appadurai 1996; Aug 1998; Callari Galli 1998; 2000). Sempre pi i nuovi nomadismi che percorrono la societ contemporanea divengono oggetto privilegiato ed emergente della ricerca e della riflessione culturale: da fonti diverse assistiamo ad un fiorire di nuovi concetti o ad una rivisitazione di vecchie terminologie, quali quella di diaspora, di trasmissione culturale, di turismo, di migrazione, di identit, usate tutti per render conto di ci che sembra un nuovo modello e un nuovo modo di vivere quel nomadismo che proprio da sempre della nostra specie. Sempre pi numerosi sono gli studi antropologici che abbandonand o lo schema teorico che ipotizza una dinamica culturale che si svolga interamente tra sistemi socioculturali unitari e saldamente legati ad un territorio , preferiscono parlare di culture ibride (Canclini 1989), di orizzonti culturali (Appadurai 1992), di contaminazioni (Callari Galli 1995; 1999; 2000), di logiche meticce (Amselle 1990), di strade (Clifford 1997), per non parlare di alcune anticipazioni che immaginavano ampi panorami in cui iscrivere vasti aggregati di popolazioni diverse sotto molti aspetti culturali ma riunificate proprio dai loro nomadismi (Lewis 1973), (Harrison, Callari Galli 1971). James Clifford auspica che lanalisi antropologica sappia contemplare accanto ai centri, ai villaggi, alle negoziazioni interne al gruppo anche i luoghi di passaggio, le mediazioni con i viaggiatori, gli spazi continuamente spostati e attraversati. Con questa prospettiv a si confondono i limiti tra25
Matilde Callari Galli
centro e periferie, nuovi attori sociali emergono come protagonisti delle dinamiche culturali: traduttori, missionari, esploratori, amministratori degli aiuti internazionali, turisti, gruppi migranti, rifugiati, lavoratori pendolari e stagionali (Bhabha 1994; 1997; Mudimbe 1988). Non si pu, tuttavia, riposare tranquillamente su questi concetti: se la teoria della purezza originaria di questa o quella cultura priva di ogni fondatezza storica e con la sua falsit appare densa di pericoli sul piano concettuale e politico, porre alla base dellinterpretazione della contemporaneit libridismo quale unica condizione (Inda, Rosaldo 2002) non spiega i caratter i differenziali, rispetto al passato, che presenta lo scambio culturale causato e determinato dagli attuali processi di globalizzazione. Forse sarebbe opportuno inserire categorie pi accurate che seguendo ad esempio le suggestioni di Michail Bachtin distinguano un ibridismo organico, proprio di tutti gli incontri culturali avvenuti in tutte le epoche, da un ibridismo intenzionale che tramite linserimento nei processi di ibridazione della ricerca di shock non solo estetico come voleva Bachtin ma pi genericamente culturale dia maggior conto della immediatezza, direi quasi della voracit, dei processi di ibridazione attuali. Soprattutt o queste categorie dovrebbero consentire di esaminare i diversi ibridismi, le diverse contaminazioni, riferendole ai diversi contesti in cui si verificano e che si consideri, nellesplicitare le loro dinamiche, il ruolo esercitato dal differenziale di potere esistente tra le di- verse parti in contatto (Amhad 1995; Tomlinson 2001). 3.2. Processimigratori:ambiguit e prospettive I massicci movimenti di essere umani attraverso i confini internazionali che si stanno verificando da qualche anno, sono man mano divenuti uno dei problemi pi ambigui da un punto di vista teorico e pi difficile da affrontare da un punto di vista pratico-politico. Trascurati per lungo tempo anche dai demografi e dagli scienziati sociali sono ormai considerati un tema che implica livelli di analisi e di interpretazione e che investe molti livelli, da quelli etici a quelli26
I nomadismi della contemporaneit
legislativi, da quelli culturali ed economici a quelli della sicurezza sociale e a quelli dei diritti umani. Vorrei prima di procedere ad una loro sia pur rapida presentazione introdurre una precisazione di carattere soprattutto quantitativo che allontani o ridimensioni latmosfera di crisi e di allarme che circonda la rappresentazione sociale ampiamente diffusa sui processi migratori. I risultati delle analisi dinamiche e longitudinali compiute a livello mondiale nella sfera delle migrazioni internazionali, includenti sia i movimenti volontari che quelli forzati, non forniscono prove di aumenti numerici cos vertiginosi da giustificare lo stato di allarme ampiamente diffuso nei discorsi politici, nei mezzi di comunicazione di massa e nel linguaggio usuale e quotidiano. E questo vale tanto per i rilievi compiuti nel presente quanto nelle proiezioni realisticamente aperte sullimmediato futuro (Zolberg, Benda 2001). Alla luce di questo dato i discorsi pieni di allarme sui processi migratori che dalle aree della povert, del bisogno e della violenza si stanno riversando nelle aree del benessere e della democrazia appaiono colmi di una irrazionalit che non pu essere considerata solo una semplice esagerazione e una inutile e falsa percezione della realt. Come ha evidenziato Amartya Sen commentando i molti discorsi che circolano sulla cosiddett a bomba demografica, la mentalit caratterizzata da una stato di emergenza basato su una idea approssimata e falsa che prevede un imminente cataclisma conduce a risposte affannose che sono profondamente controproducenti (1994: 71). In realt la sensazione dilagante di vivere oggi una crisi nei processi migratori internazionali ha profondamente influenzato ogni possibilit di politiche alternative. In particolare spesso invocata per giustificare draconiane misure tese a proteggere i confini nazionali anche a danno di altre considerazioni quali i doveri umanitari nei confronti dei rifugiati, le politiche generose nei confronti delle riunificazioni familiari e lo stesso rispetto dei diritti umani. Visioni pi equilibrate dei flussi numerici sia dei processi migratori globali sia dei gruppi di rifugiati e analisi circostanziate delle cause che li determinano ci forniscono indi27
Matilde Callari Galli
rizzi pi appropriati e meno crudeli sui quali elaborare progetti e programmi futuri. Ed essi si organizzano intorno a due orientamenti principali: alleviare le condizioni economiche e politiche che alimentano i processi migratori verso i paesi del benessere e prevenire o rendere meno esplosivi i conflitti che generano i gruppi dei rifugiati. Rispetto al primo orientamento molti studi insistono sulla necessit di introdurre politiche economiche di sostegno nelle aree che producono il maggior numero di migranti basate sulla crescita, in esse, del libero mercato; questi studi tuttavia introducono la consapevolezza che esse necessitano di tempo, di sviluppo di politiche educative e di campagne di istruzione mirata: inoltre nellimmediato si auspica anche la nascita di accordi multilaterali che vedano regolare i flussi migratori sia nei paesi di arrivo che nei paesi di partenza basandosi non solo su fattori strettamente occupazionali ma introducendo anche negli accordi una forte carica di attenzione e di rispetto dei diritti umani in ambedue le aree, in quelle di partenza e in quelle di arrivo. Rispetto al secondo orientamento innanzi tutto dobbiamo precisare che negli ultimi anni i rifugiati non sembrano pi rappresentare una minaccia immediata per le democrazie del benessere per una serie di fattori: innanzi tutto il numer o dei rifugiati che cercano asilo in esse sembra essersi stabilizzato e molti di essi rimangono nelle regioni di residenza o nei loro immediati confini. Tuttavia il fatto che essi manchino di quella forma di aiuti che a buon diritto si aspetterebbero di ricevere dai propri governi va certamente considerato che proprio i loro governi sono spesso la causa della loro fuga crea, nei loro confronti, pesanti obbligazioni alla comunit internazionale considerata nella sua totalit. Se non si vuole concedere il diritto di asilo accogliendoli nei propri confini, non cessano i doveri di garantire il rispetto dei diritti umani nei loro confronti mentre si contraggono obblighi nei confronti delle aree che, bene o male, li accolgono e si deve proseguire il sostegno ad una politica che li reinserisca nei loro contesti nel momento in cui la situazione nel loro paese lo permetta.28
I nomadismi della contemporaneit
3.3. Le diaspora
culture
della
Robin Cohen ha osservato che il concetto di diaspora a lungo usato nelle scienze sociali, nelle opere letterarie e nelle analisi politiche ha una definizione ancora imprecisa e uno spessore teorico alquanto inconsistente (Cohen 1992). Restando fedele al riferimento biblico, attualmente il concetto di diaspora generalmente usato per definire la dislocazione di gruppi che in seguito a conflitti, persecuzioni politiche e religiose sono costretti ad abbandonare i loro luoghi di residenza abituale, mentre per cultura della diaspora si intend e la rete di relazioni che in conseguenza di queste dislocazioni unisce vaste aree geografiche e culturali anche assai difformi per caratteri, storia e specificit economiche e politiche. Laumento in termini numerici del fenomeno, la sua presenza in regioni assai distanti le une dalle altre, le interdipendenze che esso stabilisce con aspetti determinanti della politica e delleconomia internazionale hanno prodotto, in questi ultimi anni, un vistoso aumento delle riflessioni su di esso. Muovendo dalla definizione generica che lo indicava come un prodotto di comunit che sebbene fossero sparse in vaste aree mantenevano al loro interno profondi legami sociali e forti sentimenti identitari, gli studi oggi mettono in luce le relazioni che le culture diasporiche mantengono con le comunit di origine (Safran 1991) ma evidenziano anche quelle che stabiliscono con le comunit che li hanno accolti (Clifford 1994) e non trascurano di riflettere sulle reti che si stabiliscono fra le diverse culture diasporiche (Haller 2000). A questo proposito mi sembra molto rilevante porre alla base delle nostre ricerche una domanda finora poco presente nelle sue molteplici implicazioni: come si mescola la cultura tradizionale alle nuove pratiche che costruiscono lorizzonte culturale della diaspora ? Quanti sono, fra i popoli dei campi, gli individui che si nutron o dellimpianto ideologico che li fa re-inventare un loro passato indipendente e felice e quanti di essi, invece, non sono gi partecipi di una cultura interstiziale, carica di contaminazioni e di meticciati?29
Matilde Callari Galli
molto importante sottolineare che investigare le strategie e le pratiche discorsive messe in atto dai singoli gruppi che vivono la diaspora rivela che lesperienza della dispersione e dellesilio rafforza anche i legami con il mondo pi vasto, fornendo visioni unitarie e complesse sia del locale che dellaltrove, sia della durezza presente che del rimpianto nostalgico. Inoltre eventi che pongono in pericolo lidentit nazionale, come accadde ad esempio nel 1990 allo scoppio della guerra in Croazia, possono avere leffetto di rivitalizzare e in un certo senso reinventare una identit comune tra tutti gli esiliati, i rifugiati, gli emigrati che a molti livelli informali, ufficiosi ma anche ufficiali intensificano i loro legami transnazionali (Al-Ali 2002: 25). A partire dal 1990, in Croazia, nei discorsi ufficiali il termine diaspora (dijaspora) usato per unificare due concetti sino ad allora ben distinti: quello che definiva i lavoratori temporaneamente allestero e quello che definiva con il termine apparentemente neutro ma colmo di connotazioni negative di emigranti (emi- granti) i fuoriusciti dalla Jugoslavia per motivi politici. (Po- vrzanovic Frykan 2002: 20) Numerosi sono gli stati nazionali che in questi ultimi anni hanno tentato, di stabilire, a livello istituzionale, legami con i gruppi che possiamo far rientrare nellambito in verit, ampio, fluido e piuttosto vago della cultura diasporica. Troviamo documenti di questi tentativi in realt culturali e politiche assai diverse che indirizzano i loro sforzi quasi unitariamente agli immigrati, ai fuoriusciti, ai gruppi scacciati da eventi bel- lici o da costrizioni politiche. Robert Smith, esaminando i tentativi messi in atto dal governo messicano per sviluppare le- gami stabili con i suoi cittadini che legalmente o meno sono immigrati negli Stati Uniti, individua, per queste azioni, tre ra- gioni che in linea di massima possono essere ritenute valide anche in molti altri contesti: impadronirsi di parte delle risor- se finanziarie prodott e nel nuovo paese, controllare i legami che si sono sviluppati tra la societ civile del luogo di origine e gli emigrati, riorganizzare lidentit nazionale che potrebbe essere indebolita per i contatt i stabiliti con la nuova cultura. (Smith 1998: 224 cit. in Koser 2002: 34).
30
I nomadismi della contemporaneit
Un problema ancora poco esplorato riguarda la reale volont delle diverse comunit diasporiche di ritornare permanentemente nel paese di origine. A questo livello di analisi pu innanzi tutto risultare produttivo discutere le ipotesi che presentano le culture diasporiche come luogo di processi unificanti, mettendo in dubbio tanto quelle che appartengono alle politiche degli stati e dei rappresentanti delle comunit che quelli pi o meno accurati suggeriti dagli studiosi. Molte sono le ricerche che smentiscono il luogo comune in base al quale vivere lontano dalla propria comunit nazionale implichi automaticamente perdere la propria identit, le proprie tradizioni e la propria cultura: tuttavia lesperienza della dislocazione si struttura in base a tante variabili, talmente influenzata dalla politica locale nei confronti dei diversi tipi di nuovi ospiti(immigrati, rifugiati, clandestini) e insieme dalla politica internazionale nei confronti dei paesi di provenienza che i nuovi milieu culturali che si formano sono aperti a svariate soluzioni, spesso fluide e contingenti. Come ha scritto Stuart Hall, lesperienza della diaspora non definita dallessenza e dalla purezza ma dalla consapevolezza di una necessaria eterogeneit e diversit: da una concezione dellidentit che vive non in opposizione alla differenza ma con essa e attraverso essa; definita dallibridit (Hall 1989: 809). Va comunque ricordato che attraverso luso dei media, attraverso i collegamenti con gli stati nazionali e con gli organismi internazionali, le comunit diasporiche, e in generale le comunit transnazionali, possiedono buoni livelli di potere politico ed anche economico, buone capacit di costituire punti di aggregazione che superano le stesse appartenenze nazionali e/o etniche: e allora sovente esse sono o possono essere attori e agenti di cambiamenti politici sia nel loro paese di origine che in quello di accoglienza. E questa dinamica complessa e variamente articolata anche allinterno della stessa comunit diasporica, dimostra lerrore non solo teorico ma anche politico di riportare a modelli unici e generalizzanti le culture diasporiche, di considerare unitaria31
Matilde Callari Galli
mente le loro potenzialit quali agenti di cambiamento e di interpretare in modo univoco le finalit delle loro attivit. 3.4. Le culture dellemigrazione Per quanto riguarda lanalisi del fenomeno migratorio la nostra contemporaneit mostra differenze profonde con il passato. Le migrazioni sono oggi, come ieri, determinate da ragioni composite che affiancano, senza escludersi a vicenda, la ricerca di benessere alla necessit di sfuggire alla violenza della guerra e della persecuzione politica. E forse a questo livello le differenze con il passato sono pi quantitative che qualitative; grandi grupp i umani hanno sempre vissuto quasi contemporaneamente la diaspora della speranza, la diaspora del terrore, la diaspora della disperazione (Appadurai 1997). Le immagini dei treni del Kosovo non possono non richiamare alla nostra memoria i treni piombati dellOlocausto ma anche le navi di cittadini inglesi strappati alle carceri per popolare la riva fatale (Hughes 1990). Cos come i vestiti laceri, le scarpe sfondate, i fagotti di stracci dei kosovari della contemporaneit, ricordano i vestiti laceri, le scarpe sfondate, i fagotti di stracci documentati nel museo di Ellis Island, nella baia di New York, a ricordo della diaspora, anchessa carica di dolore e di speranza, che popol gli Stati Uniti dAmerica. Quello che oggi completamente nuovo che questi movimenti, queste diaspore, si muovono allinterno di un sistema di comunicazione ignoto nel passato, che d forma al desiderio e alloltraggio ma al tempo stesso anche agli adattamenti, alle scelte, alle ribellioni. Sono le trasmissioni televisive che portan o nelle nostre case e nelle nostre coscienze la marcia disperata di un popolo scacciato perch etnicamente non congeniale ad un territorio, sono le trasmissioni televisive che muovono i nostri antichi rimorsi costringendosi oggi, a differenza di ieri, a non poterci nascondere dietro lalibi della non conoscenza. Ma anche i vissuti delle vittime e dei carnefici sono attraversati, in parte determinati, comunque influenzati, dalla creazione di un immaginario collettivo32
I nomadismi della contemporaneit
che paradossalmente, proprio in un conflitto che pone alla sua base i principi di territorialit e di appartenenza etnica, trascende completamente gli spazi delle singole nazioni. Sono le trasmissioni televisive che spesso orientano e spingono individui e gruppi verso lesperienza migratoria: la rete che avvolge il nostro pianeta con le trasmissioni satellitari riempie tutti i continenti di immagini di ricchezza, di vita felice e libera aperta a tutti, e per quanto sia falsa e mistificante stato ed tuttora un fattore che d forma ed unifica il desiderio collettivo di milioni di individui: sovente poi i racconti stessi degli individui che vivono questa esperienza confermano agli occhi di chi non ancora partito il sogno: per non confessare le umiliazioni e i fallimenti di cui spesso la via dellemigrazione costellata, per allontanare dai propri familiari il dolore provato, per convincersi che la scelta fatta aveva una sua validit e una sua ragione. Allargando la nostra ottica, lintero spazio migratorio stravolto dallesistenza dei mezzi di comunicazione, dagli aeroplani ai fax, dalle trasmissioni televisive alle poste elettroniche, alle navigazioni in Internet: gli immigrati indiani guardano, in Gran Bretagna o in Italia, le telenovelas prodotte ne loro paese di origine, ricevono visite frequenti di parenti e amici; i tassisti pakistani percorrono le strade di Sydney ascol- tando le cassette delle preghiere registrate nelle lontane moschee del mondo musulmano, comunicano quotidiana- mente con le loro comunit; le antenne paraboliche che affol- lano le finestre dei centri di accoglienza predisposti in Emilia-Romagna per gli immigrati maghrebini portano, nelle loro povere stanze, le immagini e le voci dei loro paesi: pro- prio mentre si muore per una citt, per un villaggio, un cam- po, limmaginario collettivo si allarga, raggiunge spettatori appassionati che introdurranno in spazi culturali completa- mente diversi le immagini trasmesse nei loro paesi di origine. V poi un altro versante assai importante da aprire e, sia pure succintamente, da trattare: ed quello dellinfluenza che i mezzi di comunicazione di massa esercitano sul bacino di informazione e sullimmaginario collettivo che i cittadini di un paese oggetto di immigrazione posseggono sul feno33
Matilde Callari Galli
meno: anche se da tempo gli studiosi dei milieu mediatici ci raccomandano grande prudenza nello stabilire effetti diretti e univoci tra immagini, informazioni e comportamenti degli utenti, molti studi dimostrano che i mezzi di comunicazione prima fra tutti la televisione la cui recezione, per la sua fruibilit, assai pi facile ed immediata di altri mezzi, quali i quotidiani, la fotografia e i film hanno avuto un ruolo determinante nel costruire un alone di alterit intorno agli immigrati, riunendoli tutti in unaura di estraneit, di sospetto rispetto alle loro vere intenzioni, sottolineando le loro devianze ed etichettandoli tutti spesso indiscriminatamente come potenziali delinquenti. Il caso delle influenze che la televisione italiana ha avuto e continua ad avere sullimmaginario che si negli ultimi anni costruito sugli immigrati albanesi pu essere un esempio di questa azione. Unenfasi eccessiva definita unossessione nazionale (Wood, King, 2001: 15) sul rapporto tra migrazione e criminalit, una continua descrizione degli effetti negativi della migrazione e delle difficolt di inserimento nella societ italiana e di contatto con gli italiani stessi, allontanano la maggioranza degli italiani dal considerare in termini strutturali questi effetti dellemigrazione: non li collegano, cio, con il mercato del lavoro nero e con un sistema corrotto e malavitoso largamente presente nel nostro paese prima dellarrivo degli immigrati albanesi ma finiscono con il considerare un prodotto dellimmigrazione lintera area dellillecito e della devianza (Campani 2001). interessante notare che mentre questo immaginario collettivo si andava formando in Italia, le nostre trasmissioni, piene di benessere, di gioia di vivere, di vacanza continue e dorate, avevano grande influenza fra i giovani che vivevano nelle citt dellAlbania e che su queste immagini da terra promessa costruivano non solo il loro progetto emigratorio ma i presuppost i critici per abbattere il regime di Enver Hoxha : soprattutto costituivano lorizzonte onirico, limmaginario per desiderare di costruire una nuova soggettivit politica e personale che li sottraesse alloscuro e triste clima del totalitarismo in cui erano immersi. (N. Mai 2001)34
I nomadismi della contemporaneit
3.4.1. Nuove domande per nuovi approccimetodologici Tutte le societ producono stranieri: ma ognuna ne produce un tipo particolare. Mi sembra che queste parole di Zygmut Bauman possano essere una buona introduzione alla ricerca di nuovi orientamenti epistemologici per i fenomeni migratori, a patto, forse che siamo disposti ad introdurre una precisazione: per produzione bisogna intendere una processualit che riguardi alla pari noi e gli altri. In altre parole lantropologia della contemporaneit pone una totale identificazione tra il soggetto e loggetto del suo interesse, tra noi e gli altri e rifiuta di identificare noi con noi stessi, noi stessi in quanto italiani e autoctoni attribuendo tutte le categorie dellalterit allimmigrato, allo straniero. In questa logica divisoria tanto la tesi che limmigrazione sia un fenomeno altamente positivo dal punt o di vista dellarricchimento culturale ed economico del paese ospite quanto quella apparentemente opposta che considera il fenomeno migratorio un danno e un rischio da ridurre e contenere al massimo, condividono a guardar bene la stessa posizione teorica, nonostante che ovviamente le rispettive pratiche politiche risultino poi contrapposte e nemiche. Ambedue in realt considerano limmigrazione un fenomeno unitario, privo di riferimenti contestuali, senza processualit n dinamiche relazionali. Ed invece lo scenario della contemporaneit con le sue miscele di trasversalit e di deterritorializzazione, di spaesamenti e di localismi esasperati richiede un profondo cambiamento nello studio e nelle politiche dei rapporti interculturali: se intendiamo svolgere un ruolo propositivo e attivo in un mondo transnazionale, popolato da culture sempre meno dipendenti da modelli culturali ed educativi unitari e coesi, dobbiamo elaborare nuovi strumenti per rivolgerci ai nuovi vissuti collettivi, articolati e complessi, commistioni dinamiche di realt e fantasia. Ogni qualvolta che ci si avvicini ad esaminare o a gestire lincontro con una cultura diversa si dovrebbe rifiutare lidea di trovarsi di fronte ad una totalit culturale elaborata35
Matilde Callari Galli
localmente e costituita da un coeso sistema di pratiche ripetitive ed autoriproducentesi, mai sfiorato da influenze e attrazioni esterne. Se parto da questa idea di cultura coesa, prodotta unitariamente in un determinato territorio, il problema di come accogliere il gruppo di immigrati che preme lungo le coste del nostro mar Adriatico consiste soprattutto nel valutare come il loro arrivo cambier la nostra cultura e come lincontro con noi muter la loro: in questottica la politica verso gli immigrati deve essere tutta rivolta a mantenere un ordine culturale ipotizzato pi che contestualizzato ed individuato. Quale cultura siamo pronti ad elargire loro? Quali fra i molti aspetti che compongono il nostro milieu culturale siamo disposti a mostrar loro e a rendere loro accessibili? Quale la cultura dei kosovari in fuga, quale quella degli albanesi e quale quella dei curdi e dei magrebini e degli iraniani riuniti sui motoscafi della disperazione da eventi diversi, da occasioni tutte drammatiche ma determinate pi dalla casualit cha da un piano prestabilito? Quanti di essi condividono, al momento del loro arrivo, tradizioni avite o invece non sono gi partecipi di una cultura interstiziale e carica di contaminazioni e meticciati? Quanto labbandono di queste aspirazioni verso una cultura nuova, comunque altra da quella da cui fuggono, non sar determinato proprio dalla insistenza da noi formulata e modulat a in mille modi sulla differenza? Per quanto essa possa inizialmente ammantarsi di tolleranza e di accettazione, inevitabilmente carica di distanza e di diffidenza lincontro, risveglia richiami di un passato che la durezza delle nuove condizioni di vita e di lavoro potr far apparire degno di rimpianto. In effetti questa visione dei contatti culturali postula la possibilit di separare con un taglio netto gruppi e prodotti culturali, cancellare dalle nostre analisi e dai nostri interventi le relazioni, i richiami le risonanze che costituiscono la realt ibrida delle pratiche sociali. Ed oggi il nuovo universo della comunicazione ha fatto emergere con grande evidenza le continue mediazioni, gli intrecci degli scambi, gli36
I nomadismi della contemporaneit
andirivieni dei prestiti che costituiscono la vera e multiforme realt della produzione culturale. Solo riconoscere che oggi il mondo interconnesso ed interdipendente , ci permette di individuare i limiti di gran parte delle politiche immigratorie che con le loro separazioni, con le loro distinzioni, nei loro aspetti pi estremi possono esser lette ed interpretate come un potente mezzo per mantenere gli equilibri di potere esclusivamente in favore di un noi che rischia di essere sempre pi assediato, isolato e lontano dalla realt. Inoltre a legare ed ancorare la cultura ad un determinato spazio si aprono una serie di interrogativi di carattere generale ai quali mi sembra che sia sempre pi urgente cercare di dare una risposta. Quale cultura per i molti individui che abitano tutti i confini di tutti gli stati nazionali del mondo? E quale cultura per i milioni di individui che dallinizio del XX secolo hanno abbandonato i loro spazi in seguito allemigrazione, alla deportazione, alla fuga da sistemi violenti e repressivi o dalla furia delle guerre? A qual punto della sua storia un gruppo pu esser definito subcultura? E questa definizione comprensiva di tutti i suoi aspetti, di tutti i suoi caratteri o solo di alcuni? E cosa dire della sostenibilit di questo concetto quando ci troviamo di fronte ad alcune subculture che in seguito alla fine del coloniasmo politico sono divenute culture dominante rispetto allorganizzazione territoriale e istituzionale ma non rispetto al loro potere economico? Aprendo il tradizionale concetto di cultura a queste problematiche si affermano oggi le analisi che si interrogano sui nuovi aspetti che assumono il cambiamento sociale e le trasformazioni culturali che avvengono non pi in spazi disgiunti ma in spazi interconnessi. la riterritorializzazione dello spazio scrivono Akil Gupta e James Ferguson che ci obbliga a riconcettualizzare, sin dalle loro fondamenta, le politiche delle comunit, della solidariet e della differenza culturale (Gupta, Ferguson 1997: 37). Allanalisi del rapporto tra una cultura che eleva laltro allo stato del s o che abbassa il s alla dignit dellaltro, si sosti37
Matilde Callari Galli
tuisce unanalisi della cultura vista come luogo di differenziazioni e contaminazioni, con un dilagare di discriminazioni, con laffermarsi di omologazioni, con linsorgere di nuove differenze che raggiungono ritmi mai sperimentati prima dora. In questa prospettiva una pratica antropologica che voglia assumere allinterno dei suoi apparati teorici e delle sue pratiche metodologiche le nuove interdipendenze che caratterizzano lattuale commercio tra culture, che non voglia ignorare le frammentazioni e le fratture violente che si inseguono senza sosta nellattuale organizzazione spazio temporale, dovrebbe con decisione abbandonare i suoi tradizionali percorsi, porre al centro della sua riflessione i nuovi meticciati, le nuove contaminazioni culturali, scegliere come luogo privilegiato di attenzione le aree di confine, le aree incerte di nomadismo contemporaneo, rifiutando la centralit che la modernit affidava ad ununica cultura, ad un unico dominio. E forse trovare dei luoghi labili, fra i popoli della diaspora, dellesilio, delle migrazioni i suoi nuovi pensieri, le sue nuove parole. 3.5. I nomadismi turistici Sinora ho parlato dellansia di andare, di essere scacciati, di es- sere in pericolo, di arrivare e ricordare, di dimenticare e cam- biare. Ho considerato luoghi e tempi, immaginari vasti quan- to il mondo e accettazioni della materialit dura e dolorosa del percorso, di nomadismi reali e di nomadismi virtuali fatti nel- langolo di mondo che chiamo mio appartamento. Potrei aprire il mio intervento a molti altri esempi, rendendo il quadro meno sommario, pi complesso. Fra tutte le possibilit scelgo, in questa parte conclusiva, di accennare ad una forma di nomadismo che vorrei definire liminale, di soglia: e tratter del turismo, vale a dire di quegli spostamenti nello spazio che sono temporanei, a volte saltuari, a volte ciclici, legati, almeno apparentemente, alla scelta, al desiderio e che sembrano poter essere, per la loro apparente futilit, anche dimenticati. E che invece assumono per il38
I nomadismi della contemporaneit
numero di persone che coinvolgono, per le connessioni con settori assai rilevanti della societ contemporanea sempre maggior rilievo sia dal punto di vista dellanalisi culturale che dal punto di vista dei cambiamenti che introducono nel pa- norama mondiale. 3.5.1. Turismo ed analisi culturale della contemporaneit Il turismo rappresenta ad un livello pratico e teorico il convivere di molti aspetti contraddittori propri della nostra contemporaneit: unesperienza effimera ed aleatoria ma al tempo stesso ripetuta pi e pi volte nello spazio di un anno e di una vita: cos tanto occupa gli spazi e i tempi sia del mondo del benessere che del mondo della privazione, cos profondamente entra nelle abitudini diffuse tra centinaia di milioni di individui da poter essere considerato un elemento permanente della societ attuale nonostante che si svolga con ritmi sempre pi brevi e temporanei; avvicina ma al tempo stesso contrappone gruppi umani profondamente diversi; sottolinea la falsit della sua esperienza ma al tempo stesso ricerca quasi nevroticamente autenticit e tenuit; per molti aspetti unesperienza solitaria e individuale che al tempo stesso coinvolge negli stessi spazi e negli stessi tempi moltitudini tra loro ignote. Da qualche decennio ormai le scienze umane hanno rivolto la loro attenzione allanalisi del fenomeno turistico: divenuto una delle maggiori industrie del mondo ha rivelato le sue implicazioni molteplici e differenziate che sempre pi dimostrano legami profondi con gli apparati culturali del contatto fra gruppi diversi per storia, tradizioni, lingue, stili di vita e visioni del mondo. E sempre di pi appare profonda la relazione che lega le aspettative e le ripulse delle comunit coinvolte nel fenomeno turistico quella che accoglie e quella che visita ai problemi centrali nella riflessione antropologica contemporanea: innanzi tutto al concetto di cultura con i suoi corollari di eredit e di autenticit culturale, profondamente mutato da una realt in cui deterritorializzazione e localismo si susseguono e si alternano39
Matilde Callari Galli
senza posa. E legato inoltre ai processi identitari che perdono il loro carattere unitario invasi da un susseguirsi costante di identificazioni superficiali e labili; ed infine alla circolarit dei rapporti che legano centro e periferie in uno scambio di elementi culturali globale ma allo stesso tempo dotato di un alto gradiente di differenziazione e di disuguaglianza (Callari Galli, Ceruti, Pievani 1998). Nellambito degli studi sul turismo, il dibattito si focalizza sugli effetti che le diverse forme di turismo hanno sia sulle co- munit/luoghi di attrazione turistica sia sulle comunit/luoghi da cui muovono i turisti. Il turismo, cos come stato prati- cato nella maggior parte delle regioni del mondo, e come continua ancora ad essere praticato, introduce violenti cam- biamenti nella vita dei paesi che ospitano, spesso travolge i loro costumi, i loro valori etici e religiosi, il loro ambiente ecologico, i loro insediamenti urbani. Tanto pi il turismo contemporaneo coinvolge aree caratterizzate da differenziali di potere nei loro aspetti economici, politici e sociali, tanto pi sembra balzare in primo piano la carica predatoria che anima oggi come ieri il rapporto tra le diversit gestito dai grandi della terra. Per rispettare tuttavia lo schema della complessit che ho posto sin dallinizio a base di questo intervento, va subito aggiunto che anche le comunit di origine dei turisti sono mutate, sia pure ad un livello pi superficiale, per la ricerca esoticache travalica il breve e comunque limitato arco di tempo del soggiorno e prosegue immettendo nelle nostre citt abitudini alimentari, oggetti, vestiti, cerimonie e feste altre da noi, che saldandosi con altri rapporti interculturali alcuni dei quali ben pi radicati e drammatici hanno profondamente stravolto i nostri gusti e lo stesso nostro rapporto con lalterit (Abram, Waldren, McLeod 1997). 3.5.2. Leggere il turismo contemporaneo Se si accetta questo commistione continua del fenomeno turistico, difficile applicare al suo interno separazioni e distinzioni nette, dividendo con taglio il turista dal non40
I nomadismi della contemporaneit
turista, il turista stagionale da quello estemporaneo. La stessa distinzione introdotta molti anni fa da Smith (1989 [1978]) tra turista ed ospite appare oggi inadeguata e impedendo molte ulteriori suddivisioni si dimostra poco utile per unanalisi antropologica accurata. Ad esempio, numerosi autori con le loro ricerche hanno dimostrato che lo stesso termine paese ospite in realt unisca persone che con il turista hanno rapporti profondamente differenziati, comprendendo individui che traggono benefici dal turismo, altri che lavorano in strutture adibite allaccoglienza, altri che con i turisti hanno rapporti occasionali e sporadici e altri ancora che ignorano la presenza dei turisti nel loro paese (Harrison 1992). Del resto le difficolt che incontriamo ad identificare una comunit ospitante ricalcano in gran parte le difficolt che incontriamo oggi a definire con chiarezza una comunit, ad individuare i suoi confini, a descrivere le sue caratteristiche, a stabilire la sua aderenza ad un determinato territorio. Il lungo dibattito che ha opposto negli anni 80 numerosi antropologi affannati ad identificare o a negare la possibilit di individuare i confini simbolici di una comunit (Cohen 1985) sembra oggi essersi risolto abbandonando i modi tradizionali di considerare la presenza di una comunit nel territorio, cessando di considerarla una entit ma cercando invece come avvenuto per il concetto di cultura di valorizzare le sue forme espressive e le sue relazioni. Molte, dunque, sono le difficolt che incontriamo nel disegnare una tipologia delle diverse forme di turismo presenti oggi nel mondo: ci troviamo di fronte ad una massa di individui centinaia di milioni che ogni anno, per periodi di tempo variabili, con modalit diverse si allontanano dalle proprie case per visitare regioni dai caratteri alquanto disparati: partono da luoghi diversi e raggiungono luoghi diversi, avendo scopi diversi. Anche ci che sembrerebbe unificarli il viaggiare se esaminato nella sua radicalit li accomuna ad altri milioni di individui, sino a coinvolgere lintera nostra specie che lungo il suo percors o evolutivo ha scelto, per la maggioranza del tempo, il nomadismo e non la sedentariet.41
Matilde Callari Galli
Ed allora, invece di inseguire le macrodistinzioni presenti nella letteratura per distinguere le diverse forme del turismo (Smith 1989; Smith e Eadington 1992; Graburn 1995) e che mio avviso sono deboli per leccessivo livello di generalizzazione che contengono e per la loro provvisoriet, preferisco esporre caratteri, potenzialit, rischi dellapplicazione al fenomeno turistico del concetto di cultura. 3.5.2.1. Turismo culturale ed eredit storico-
Il turismo a causa dei potenti interessi economici che in grado di convogliare sui suoi progetti riesce anche ad influenzare, e talvolta addirittura a determinare, la percezione che una comunit ha della sua eredit culturale: indicare un tratto culturale, un oggetto, un monumento o unidea come parte delleredit di un gruppo, attribuirli ad una determinata epoca, significa partecipare alla costruzione sociale del suo passato, significa illuminare un universo simbolico, oscurandon e inevitabilmente altri: dando un determinato ordine al passato, in realt si prefigura lordine del presente. Esercitare il controllo del passato significa svolgere importanti ruoli nei processi identitari: cos scegliendo una determinata versione di un evento storico si legittimano relazioni sociali che travalicano lambito delle relazioni quotidiane al cui ordine sembrano appartenere le relazioni turistiche svolgono importanti funzioni nei processi politici, nella suddivisione del potere fra i diversi gruppi che costituiscono la comunit. Una buona esemplificazione di questo processo ci fornito dalle ricerche che John Allcock ha svolto in Macedonia e in Croazia (Allcock 1995). Nel primo caso la scelta di presentare ai turisti i resti di alcuni edifici sacri attribuendoli alla fede e alla ritualit cristiana tacendo che per secoli essi erano divenuti luoghi di culto islamici ha un alto significato simbolico ed assume forti valenze identitarie e politiche: infatti unaperta rivendicazione dellantichit e della continuit delleredit cristiana in una regione in cui esistono tensioni con i gruppi musulmani di origine albanese, unaffermazione, indiretta ma42
I nomadismi della contemporaneit
molto esplicita, dellestraneit, rispetto lattuale identit della nazione macedone, dei cinque secoli della notte turca. Nel secondo caso Allcock presenta la costruzione di un folklore nazionale croato, elaborato per fini turistici ma che in realt ha avuto lobiettivo di dimostrare lesistenza di una eredit culturale, antica e coerente, che attribuisca unit ad una regione storicamente attraversata per secoli da popoli diversi e dominat a da stati politicamente e culturalmente assai differenziati. Ambedue i casi esaminati da Allcock sono strettamente collegati allo sforzo delle autorit macedoni e croate di dare legittimit alle politiche dei nuovi stati che si sono costituiti dopo la fine della federazione iugoslava. Non molto rilevante che in un caso si sia operato su un sito storico-archeologico e nellaltro su produzioni di beni materiali ed immateriali, quali prodotti artigianali, motivi musicali, letteratura orale, ricostruzione di danze e cerimonie. Quello che in questa sede rilevante notare il ruolo privilegiato che lorganizzazione del turismo, dovrei dire la struttura del turismo, in grado di svolgere in questi complessi processi: da un lato nella comunicazione turistica processi ideologici, quali la creazione di una determinata eredit storica o linvenzione di radici identitarie comuni a gruppi oggi diversi sotto molti aspetti, trovano possibili forme di espressione e di validit: la presentazione di un monumento, di un sito archeologico, di una celebrazione cerimoniale, di un prodott o artigianale, nelle parole delle guide, nelle descrizioni dei tour operators e dei depliants turistici assume valore di verit storica, diviene nota, accettata e diffusa tanto tra i turisti quanto tra gli abitanti delle localit interessate. Dallaltro lato le espressioni usate per questa divulgazione si servono di una retorica ad alto valore divulgativo ma che generalmente sfugge al vaglio e allanalisi critica delle fonti e quindi della realt storica. Sulle nuove verit, sui valori simbolici che cos assumono oggetti e luoghi, sulle nuove memorie rappresentate per i turisti, si articolano nuovi processi identitari, si sviluppano nuove appartenenze, si riformulano alleanze e affinit.43
Matilde Callari Galli
Inoltre le dimensioni del fenomeno turistico nella contemporaneit, il suo spandersi nei diversi continenti, il suo penetrare in gruppi e classi sociali profondamente diverse, le sue dinamiche che rendono difficile distinguere tra consumatori e produttori del fenomeno, non ci consentono pi di considerarlo un processo di comunicazione che si svolge tra culture diverse, separate da confini netti ed individuabili: in realt produzione turistica e consumo di luoghi, di incontri, di merci, fanno parte di un medesimo processo. Cos leredit del passato presentata al turista si riverbera e agisce nella determinazione dei processi identitari di chi ha costruito ad uso turistico questa eredit, trasforma il suo territorio, i suoi segni e i suoi prodott i ma modella anche la percezione che delle identit e della storia hanno i visitatori di quel paese. Il richiamo al concetto di cultura elaborato dalla ricerca antropologica mi sembra evidente: la cultura considerata un ventaglio di possibilit tra le quali il gruppo sceglie quali usare e quali scartare nel continuo processodi strutturare e ristrutturar e il suo presente e il suo passato, la cultura che in questa sua operazionalit coinvolge e attraversa settori dalla lunga tradizione, elementi nuovi e tratti apparentemente marginali. 3.5.2.2. Studi turistici a livello universitario Le categorie antropologiche divengono cos utili sia se si voglia interpretare unattivit complessa e articolata quale il turismo contemporaneo sia se, per sottrarlo allimprovvisazione e alla casualit, si vogliano progettare corsi di studi che preparino esperti per la sua gestione e per la sua programmazione. I riferimenti alle discipline antropologiche e laccento su un turismo attento alle implicazioni culturali caratterizza due corsi di studio che da qualche tempo coordino, per lUniversit di Bologna, sul tema del turismo: il primo un corso di Master sullo Sviluppo turistico attivato in Cambogia, il secondo un corso di specializzazione post-laurea in Turismo culturale attivo nellarea adriatica, in particolare in quella che comprend e la rete universitaria Uniadrion.44
I nomadismi della contemporaneit
Pi che addentrarmi nella descrizione particolareggiata degli impianti dei due corsi, cercher ora sinteticamente di presentare pi che le loro specificit i caratteri che li accomunano. Si rivolgono ambedue a studenti che hanno conseguito al- meno un primo livello di laurea; hanno previsto, per lam- missione ai corsi, una selezione basata sia sui percorsi di studio e di lavoro compiuti, sia su una serie di prove; ambe- due hanno lobiettivo di formare esperti in pianificazione e programmazione delle attivit turistiche affiancando, du- rante gli anni di corso, attivit didattiche e di ricerca; anche se in misura differente, ambedue sfruttano i collegamenti via informatica; la durata di quello svolto in Cambogia di cinque semestri, di quello rivolto allarea adriatica di otto. Si basano su una collaborazione fra regioni diverse e universit appartenenti a paesi diversi: luno coinvolge oltre lU- niversit di Bologna, la Royal University of Phnom Penh e lUniversity of Technology of Sydney, il secondo oltre lUni- versit di Bologna, le Universit degli Stati che affacciandosi sul mar Adriatico partecipano della rete Uniadrion (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania). Le aree disciplinari coinvol- te nei programmi di insegnamento e di ricerca sono oltre quelle antropologiche, quelle sociologiche, economiche, geo- grafiche, linguistiche, della comunicazione, con riferimenti giuridici ed informatici. Lanalisi culturale, sia dei flussi turi- stici che delle potenzialit presenti nelle diverse localit in un certo senso riunisce ed unifica i contributi delle singole discipline che dai loro specifici punti di vista mettono a fuoco i vantaggi ma anche i rischi dello sviluppo turistico, particolarmente quando si svolge in aree che per lungo tempo sono state sottratte ad esso e che al tempo stesso sono state recentemente teatro di conflitti aspri e dolorosi. Le domande a cui si cerca di rispondere, con questi studi e con queste ricerche, sono complesse e pi che soluzioni ci aspettiamo, dalla collaborazione tra docenti e studenti appartenenti a tradizioni tante diverse, spunti, suggerimenti, percorsi. Quali caratteri possono assumere i rischi della distruzione e dellinquinamento dellambiente, della lacerazione dei rapporti sociali e del travisamento delle culture tradizionali ge-
45
Matilde Callari Galli
neralmente connessi con il turismo di massa, in aree, quali quelle oggetto dei due corsi, che tentano di ricostruire paesaggi e citt, relazioni sociali e ritmi di vita profondamente turbati da eventi diversi ma in tutti i casi drammatici e profondamente incisi nella memoria e nel territorio? In che modo pu un turismo culturale e sostenibile partecipare positivamente a questa ricostruzione? In che modo lincontro e lo sguardo turistico possono contribuire alla creazione di luoghi/modi in cui si sfugga tanto alla rivendicazione localistica ed esasperata dellorgoglio regionalista quanto al vuoto cosmopolitismo di unautenticit teatrale, rappresentata per i turisti ai fini di un guadagno facile ed immediato? Il turismo culturale non una panacea che possa risolvere tutti i problemi ma soprattutto non pu essere visto come un nuovo modo per attrarre un maggior numero di turisti e una maggiore quantit di denaro. Potrebbe invece essere unopportunit per conoscere con pi accuratezza il mondo in cui viviamo, per sviluppare le nostre sensibilit, per far parlare le nostre emozioni; dovrebbe poter migliorare la qualit della vita delle comunit coinvolte ospitanti ed ospitate rendendole pi consapevoli dellimportanza di viaggiare e di accogliere, di saper apprezzare il paesaggio, gli incontri, le nuove esperienze. Lo sviluppo del turismo culturale potrebbe divenire unopportunit per valorizzare il nostro passato, la nostra storia, la nostra eredit ma al tempo stesso un modo per poter partecipare ad una cultura in grado di uscire da s stessa per comunicare con le molte diversit che oggi percorrono a livello reale e/o virtuale il mondo. Da un lato, sottolineando le caratteristiche e le possibilit del turismo culturale, ogni comunit sollecitata e spinta a conservare e valorizzare i propri beni culturali; dallaltro ogni programmazione e ogni gestione del turismo deve prestare grande attenzione agli orientamenti generali di una cultura mondiale che ogni giorno, con i suoi spostamenti, con i suoi nomadismi, aumenta il suo livello di interdipendenza e di globalit. Tra queste due tensioni va svolta, a livello di ricerca, di didattica e di politica culturale, una continua opera di mediazione af46
I nomadismi della contemporaneit
finch laccresciuta visibilit delle comunit locali e delle loro potenzialit produca nuovi processi identitari, svincolati dalle pesanti ipoteche del passato e dai condizionamenti del presente ma aperti al dialogo, allincontro con le molte differenze che oggi percorrono il nostro pianeta.
Bibliografia: Abram S., Waldren J., Macleod D.V., (a cura di), 1997. Tourists and Tourism, Berg, New York. Al-Ali N., Koser K., 2002. Transnationalism, international migration and home, in Al-Ali N., Koser K., (a cura di), New approach to migrations?, Routledge, London. Allcock J. B., 1995. International tourism and the appropriatio n of history in the Balkans, in Lanfant M. F., Allcock J. B., Brune r E. M., (a cura di), International tourism: identity and change, Sage, London. Ahmad, 1995. The politics of literary postcoloniality, in Race and Class, 36/3, pp. 1-20. Amselle J.L., 1990. Logique mtisse, Payot, Paris (tr. it.: Logiche meticce, Bollati Boringhieri, Torino, 1999. Appadurai A., 1992. Global ethnoscapes: notes and queries for a transnationalanthropology, in Fox R. (a cura di), Recapturing anthropology: working in the present, School of American Research, Santa Fe. Appadurai A., 1996. Disgiunzione e differenza nelleconomia culturale globale, in FeatherstoneM. (a cura di) Cultura globale, SEAM, Milano. Appadurai A., 2000. Modernit in polvere, Meltemi, Roma. Aug M., 1993. Nonluoghi, Eluthera, Milano. Aug M., 1998. La guerra dei sogni, Eluthera, Milano. Barber B., 1998. Guerra santa contro Mc mondo, Nuova Pratiche Editrice, Milano. Bhabha H., 1994. The location of culture, Routledge, London. Bhabha H. (a cura), 1997. Nazione e narrazione, Meltemi, Roma. Callari Galli M., 1995. Orientamenti antropologici per la cultura contemporanea, in Pluriverso, n. 1. Callari Galli M., 1996. Lo spazio dellincontro Meltemi, Roma. ,47
Matilde Callari Galli
Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, Bruno Mondadori, Milano. Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T., 1998. Pensare la diversit, Meltemi, Roma. Callari Galli M., 2001. Dal casco coloniale al videotape. Antropologia culturale e turismo nella societ contemporanea, in Africa e Orienti, n. 3/4, 2001. Callari Galli M., Riccio B., (a cura), 2001. Dossier: Sguardi antropologici sul turismo, in Africa e Orienti, n. 3/4, 2001. Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M., 2003. Formare alla complessit, Carocci, Roma. Campani G., Migrants and media: the Italian case, in King R., Wood N., (a cura di), Media and Migration, Routledge, London. Canclini N. G., 1998 [1989]. Culture ibride, Guerini, Milano. Cavarero, 2001. Il locale assoluto, in MicroMega, n. 5. Clifford J., 1994. Diasporas, in Cultural Anthropology, n. 9 (3). Clifford J., 1999. Strade. Viaggio e tradizione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, Torino. Cohen R., 1992. The Diaspora of a diaspora. the case of the Caribbean, in Social Sciente Information, n. 31. Foucault M., 1994. Eterotopie. Eterotopie, luoghi e non-luoghi metropolitani, in Millepiani, Mimesis, Milano. Giddens A., 2000. Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna. Graburn N., 1995. The past in the present in Japan: nostalgia and neotraditionalism in contemporary Japanese domestic tourism, in Butler R., Pearce D., (a cura di), Change in tourism: people, places, processes Routledge, London. , Grillo R., (a cura di), 1980. Nation and Statein Europe: AnthropologicalPerspectives,Academic Press, London. Grillo R., 1998. Pluralism and the Politics of Difference: State, Culture and Ethnicity in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford. Grillo R. D., Riccio B., Salih R., 2000. Here or There? Contrasting Experiences of Transnationalism: Moroccan and Senegalese in Italy, CDE/Sussex University Working Paper, Brigton. Grillo R. D., Pratt J., (a cura di), 2002. The Politics of Recognizing Difference. Multiculturalism Italian Style, Ashgate, Basingstoke. Guerzoni G., 2001. Multispaces: il turismo culturale tra eredit culturale e formazione. Il caso della Bulgaria, in Africa e Orienti, n. 3/4.
48
I nomadismi della contemporaneit
Haller D., 2000. Gelebte Grenze Gibraltar Transnationalismus, Lokalitat, und Identitat in kulturanthropologischer Perspektive, Deutscher Universitatverlag, Wiesbaden. Harrison D., (a cura di), 1992. Tourism in the less developed countries, Belhaven, London. Harrison G., Callari Galli M., 1971. N leggere n scrivere, Feltrinelli, Milano. Hughes R., 1990. La riva fatale, Adelphi, Milano. Inda J. X., Rosaldo R., 2002. The Anthropology of globalization, Blackwell, London. Leirs M., 1992. Zbrage, Gallimard, Paris. Lewis O., 1973. La cultura della povert e altri saggi di antropologia, Il Mulino, Bologna. Koser K., 2002. From refugees to transnational communities? , in Al-Ali N. A., Koser K., (a cura di), New approac to migrations?, h Routledge, London. Mai N., 2001. Italy is beautiful: the role of Italian television in Albanian migration to Italy, in King R., Wood N., (a cura di), Media and Migration, Routledge, London. Malkki L. H., 1997. National Geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identit among scholars and refugees, in, Gupta A., Ferguson J., (a cura di), Culture, Power, Place, Duke University Press, Durham. Martelli F., 1998. Capire lAlbania, Il Mulino, Bologna. Pandolfi M., 2000. Lindustrie humanitaire: une souverainet mouvante et supra-Coloniale. Reflxion sur lexprience des Balkans, Multitudes, Autom. Pandolfi M., 2002. Moral Entrepreneurs, souverainets et barbeles. Le bio-politique dans les Balkans postcommunistes, in Pandolfi M., Abls M., (a cura di), Politiques jeux despaces, numero speciale di Anthropologie et Societ, vol. 26, n. 1. Povrzanovic Frykman M., 2002. Homeland lost and gained. Croatian diaspora and refugees in Sweden, in Al-Ali N. A, Koser K., (a cura di), New Approach to Migrations?, Routledge, London. Riccio B., 2000. The Italian construction of immigration: sedentarist and corporatist narratives facing transnational migration in Emilia-Romagna, in Greverus I. M., Romhild R., Welz G. (a cura di), The Mediterraneans. Transborder movements and diasporas. Anthropologica Journal of European Cultures, vol. 9, n. 2. l Robertson R., 1999. Globalizzazione, Asterios, Trieste.49
Matilde Callari Galli
Safran W., 1991. Diasporas in modern societies. Myths of homeland and return, in Diaspora, n.1. Sen A., 1994. Population, Delusion and Reality, in New York Re- view of Books, 22 September, 1994, pp. 62/71. Smith V., 1989. Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press, Philadekphia, (Blackell, Oxford, 1978). Smith V., Eadington W. R., (a cura di), 1992. Tourism Alternatives, University of Pennsylvania Press, Philadelphia. Tomlinson J., 2001. Sentirsi a casa nel mondo, Feltrinelli, Milano. Wood N., King R., Media and Migration. An Overview, in King R., Wood N., (a cura di), 2001. Media and Migration, Routledge, London. Zolberg A. R., Benda P. M., (a cura di), 2001. Global Migrants, Global Refugees, Berghahn Books, New York.
50
A VOLTE RITORNANO Fantasma e nomadismi nippo-occidentali di Luigi Urru
Luomo che si definisse in congruenza a una patria sarebbe un animale che ha fatto propria la prerogativa vegetale di mettere radici. Peter Sloterdijk
stato Walter Benjamin a darci una delle allegorie pi potenti dellesperienza della modernit. In un famos