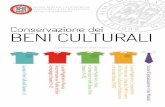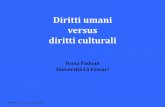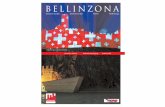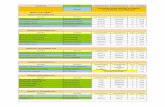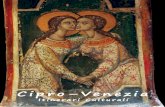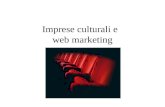Master Eventi Culturali Arti Cinema Spettacolo MEC Master Eventi Culturali Arti Cinema Spettacolo.
nomadismi-culturali
Transcript of nomadismi-culturali

ª
a cu
ra d
i Mat
ilde
Cal
lari
Ga
lliN
OM
AD
ISM
I C
ON
TE
MP
OR
AN
EI
GuaraldiUniversitaria
La coincidenza di territorio, cultura, popolo, è stata una delle più forti e diffuse motivazioni ideali e politiche per la nascita e la costruzione dello stato nazionale. Da qualche tempo tuttavia assistiamo ad un totale sovvertimento del rapporto tra gli spazi territoriali e gli spazi sociali. Nuove forme di migrazioni internazionali, nuovi sistemi di comunicazione, nuovi flussi finanziari, nuove entità politi- che, costituiscono relazioni che attraversano i vecchi confini e assumono come ambito per le loro pratiche socioculturali una multipolarità territoriale. Così voler studiare le nuove relazioni tra cultura e territorio implica porre l’accento sui processi del nomadismo contempora- neo nei suoi effetti a livello globale, a livello locale, a livello virtuale e a livello di esperienza quotidiana: come sogno e come vissuto.Partendo da una tipologia delle nuove forme di nomadismi descritti nelle loro tensioni e nelle loro contraddizioni, il volume raccoglie una serie di saggi che cercano di illustrare gli andamenti dei nomadismi incessanti che percorrono il nostro mondo, le modalità distintive con cui essi alimentano e al tempo stesso subiscono la comples- sità della contemporaneità, ponendo attenzione ad un’etnografia dei traffici moderni dell’incorporeo ma anche dei vissuti identitari e delle pratiche statali e parastatali che li avvolgono.
Matilde Callari Galli insegna Antropologia culturale presso l’Università di Bologna. Tra le sue opere: Antropologia culturale e processi educativi (La Nuova Italia, Firenze1993); Lo spazio dell’incontro (Meltemi, Roma 1996); InCambogia. Pedagogia del totalitarismo (Meltemi, Roma1997); Pensare la diversità. Per un’educazione alla complessità umana (con M. Ceruti e T. Pievani, Meltemi, Roma 1998); Se i bambini stanno a guardare (con G. Harrison, Clueb, Bologna 1999); Formare alla complessità (con F. Cambi e M. Ceruti, Carocci, Roma, 2002); La Tv dei bambini. I bambini della Tv (con G. Guerzoni, A. M. Giannotti, C. Rossi, BUP, Bologna 2003).
N O M A D IS MI C O N T E M P O R A N E IR a p p o r t i t r a c o m u n i t à l o c a l i,s ta t i - naz ione e “ f luss i cul tu ra l i global i ” M. C a lla ri G a l l i, Z. A. F ra n c e s c h i, I. G. P a zz a g li, B. R ic c io, L. Urru
a cura di Matilde Callari Galli
Second a edizione

ì
a cu
ra d
i Mat
ilde
Cal
lari
Ga
lliN
OM
AD
ISM
I C
ON
TE
MP
OR
AN
EI
15,00 euro Guaraldi Universitaria Antropologi a culturale

a cu
ra d
i Mat
ilde
Cal
lari
Ga
lliN
OM
AD
ISM
I C
ON
TE
MP
OR
AN
EI
Guaraldi UniversitariaAntropologia culturalea cura di I. G. Pazzagli

a cu
ra d
i Mat
ilde
Cal
lari
Ga
lliSeconda edizione: febbraio 2004
Prima ristampa: gennaio 2005
© 2004 by Guaraldi s.r.l.Sede legale: piazza Ferrari 22, Palazzo Fabbri Scala C
47900 RiminiRedazione: via Spica 1 (Rimini) 0541/52120
ww w .guaraldi.it E-mail: [email protected]
ISBN 88-8049-220-9

MATILDE CALLARI GALLI
(a cura di)
NOMADISMI CONTEMPORANEI Rapporti tra comunità locali, stati-nazione
e “flussi culturali globali”
con contributi diM. Callari Galli, Z. A. Franceschi, I. G. Pazzagli, B. Riccio, L. Urru
Guaraldi


Indice
Introduzione:ETNOGRAFIA NOMADICA
di Matilde Callari Galli p. 7
I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEITÀ
di Matilde Callari Galli p. 17
1. Una premessa p. 192. La contaminazione degli spazi p. 203. Per una mappa dei nomadismi della contemporaneità p. 24
3.1. L’ analisi culturale p. 243.2. Processi migratori: ambiguità e prospettive p. 263.3. Le cultura della diaspora p. 293.4. Le culture dell’emigrazione p. 323.5. I nomadismi turistici p. 38
A VOLTE RITORNANO
Fantasma e nomadismi nippo-occidentalidi Luigi Urru p. 51
1. I fantasmi e il lavoro dell’immaginazione p. 572. L’antropologia e lo spaesamento della modernità p. 623. Cultura di massa e adesione alla realtà p. 664. Esotismi, appropriazioni, transiti p. 705. Dallo yojôhan al kombini p. 766. Il sakkaa per reinventare la società p. 787. In-conclusione p. 80
MEMORIA CULTURALE , COSTRUZIONE IDENTITARIA IN CONTESTO EUROPEO
ED EXTRA-EUROPEO ALL’INIZIO DEL SECOLO XX.Una storia di vita
di Zelda Alice Franceschi p. 83
1. Premessa p. 852. L’Europa a partire dall’Europa. L’Europa dopo l’Europa p. 873. Oltre la biografia, al di là dell’identità p. 92

Indice
4. Il ricordo della memoria, l’oblio: il narrare della storia p. 985. Viaggio e immigrazione:
storie contemporanee, vecchie e nuove questioni p. 1026. Conclusioni p. 108
MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI : IL DECLINO DELLO STATO NAZIONALE ?Riflessioni antropologiche
di Bruno Riccio p. 117
1. Introduzione p. 1192. L’antropologia delle migrazioni e l’etnografia della transnazionalità p. 1213. I senegalesi in Italia come esempio di transnazionalità p. 1274. Le ambivalenti politiche migratorie italiane
all’interno della “Fortezza Europa” p. 1315. “Vedere come lo stato”: Lo sguardo sedentarista
nei confronti delle migrazioni transnazionali p. 1366. Riflessioni conclusive: etnografia translocale ed istituzionale p. 140
CONTESTI UMANITARI E PERIFERI E EMERGENTI : LA COOPERAZIONE INTER -NAZIONALE E I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEITÀ
di Ivo Giuseppe Pazzagli p. 147
1. Premessa p. 1492. La complessità dei nuovi contesti p. 1503. L’antropologia e la cooperazione allo sviluppo p. 150
3.1. Dall’antropologia impegnata nei processi di sviluppoall’antropologia dello sviluppo p. 153
3.2. I nuovi scenari della cooperazione e il ruolo delle Ong p. 1554. I nuovi contesti della cooperazione e dell’intervento umanitario:il caso del conflitto nella ex Iugoslavia p. 158
4.1. La scena italiana in rapporto alla crisi balcanica p. 1614.2. La scena balcanica nella lettura degli operatori
di Cooperazione Italiana p. 1635. Conclusioni p. 166

INTRODUZIONEEtnografia nomadica
di Matilde Callari Galli


La coincidenza di territorio, cultura, popolo, è stata una delle più forti e diffuse motivazioni ideali e politiche per la nascita e la costruzione dello stato nazionale: essa ha costi- tuito ispirazione per opere letterarie e imprese belliche, per ribellioni e conflitti; è stata la base di analisi politologiche, economiche, sociologiche e antropologiche; ha animato rim- pianti e nostalgie tenaci sino a superare lo spazio di una vita.
Da qualche tempo tuttavia assistiamo ad un totale sov- vertimento del rapporto tra gli spazi territoriali e gli spazi
sociali che sembra aver spazzato via la fiducia che linguaggi, pratiche culturali, relazioni sociali, espressioni simboliche, manufatti siano radicati, come origini e come successive modificazioni, a luoghi geograficamente identificabili. Nel- le ultime decadi del secondo millennio tanto questa coinci- denza quanto lo stato nazionale hanno subito numerosi e svariati attacchi da più fronti: i violenti conflitti etnici scop- piati nei Balcani, in Somalia, in Indonesia, hanno svelato che lo stato nazionale è un coacervo di gruppi diversi, spes- so in conflitto fra loro, spesso più simile ad una “comunità immaginata” (Anderson, 1983) che ad un tessuto di comu- nanze; molti stati nazionali sono scossi da tensioni separati- ste cruente ma anche e contemporaneament e altri sono messi in discussione da autorità locali che lottano per raffor- zare le loro prerogative e da autorità sovranazionali quali l’Unione Europea o l’ASEAN, il GATT (General Agree- ment on Trade and Tariffa) o il WTO (World Trade Orga- nization). Come scrive Habermas, da un punto di vista po-
litico una delle idee più importanti elaborate negli ultimi se-
9

Matilde Callari Galli
coli del secondo millennio, – la nozione della sovranità degli stati-nazioni – è stata messa in discussione e si è differen- ziata fra autorità locali, micro-regionali, nazionali, macro-re- gionali e globali” (Habermas 1999).
Nuove forme di migrazioni internazionali, nuovi sistemi di comunicazione, nuovi flussi finanziari, nuove entità politiche, costituiscono relazioni che attraversano i vecchi confini e assumono come ambito per le loro pratiche socioculturali una multipolarità territoriale.
Storicamente tali entità integrate, dislocate territorialmen- te su vaste aree e composte di stili di vita, di relazioni socia- li, di orientamenti ideologici, di sistemi simbolici, di manu- fatti che se non potevano essere definiti comuni potevano tuttavia essere tutti iscritti in uno schema di comprensione e di elaborazione comune, sono sempre esistiti: per duemila anni la Chiesa Cattolica è stata un’organizzazione attiva a li- vello del mondo conosciuto e dotata di strutture e dinamiche multilocali e molti grandi imperi del passato possono essere ricondotti, in modo più o meno diretto a questo modello.
Oggi ci troviamo di fronte ad una espansione di idee ge- nerali, di stili di vita, di evocazioni di tradizioni lontane, di mode e costumi su base multilocale che riguarda l’intero pianeta e che coinvolge, sia pure con modalità ed intensità diverse, la maggioranza dei gruppi umani. Essa è dovuta ad una molteplicità di fattori, diversi ma spesso strettamente in- terrelati: nuovi sistemi di comunicazione, nuove tecnologie di trasporto , movimenti reali e virtuali di milioni di individui spinti ad immaginare o a raggiungere “nuove patrie” da ra- gioni molteplici e spesso concomitanti – guerre, carestie, persecuzioni politiche, ricerca di maggior benessere e di li- bertà ma anche di novità, di divertimento, di studio e di scambi intellettuali – e su tutto, a confondere ed insieme ad amalgamare, una circolazione, anch’essa globale e multilo- cale, dinamica e vertiginosa di immagini, di idee, di oggetti, di usi e costumi. (Giddens 2000; Callari Galli 2000; Callari Galli, Ceruti, Cambi 2003)
La dislocazione multivocale di vissuti e di progetti su interi continenti e contemporaneament e la coesistenza, nella stessa
10

Etnografia nomadica
area, di una gamma variegata di differenze mutanti e per la loro fluidità di difficile definizione, ha pesantemente indebo- lito il modello della coincidenza tra cultura e territorio, tra- sformando in un fenomeno che riguarda l’intero pianeta una situazione che nel passato era limitata spazialmente e tempo- ralmente: soprattutt o ha esteso – come modello, almeno, e come chance di vita – all’intera umanità collegamenti, infor- mazioni, mobilità un tempo riservate a gruppi ristretti. Anche se, come vogliono David Morley e Kevin Robins “non tutti siamo soggettività nomadiche e frammentate, anche se non tutti viviamo nello stesso universo post-moderno”, anche se un numero ridotto di individui vive sino in fondo e con com- pletezza i processi della globalizzazione, anche se la vita della maggioranza dell’umanità è a tutt’oggi dominata dagli aspet- ti localistici ancora ampiamente presenti nella nostra epoca e largamente diffusi nel pianeta, anche se miliardi di invidi nei loro vissuti reali vedono ridursi sempre più le chances di vita, destinati a vivere nei microterritori nei quali sono nati (Mor- ley, Robins 1995: 218), le élites di tutto il pianeta – politiche e finanziarie ma anche culturali e scientifiche – assumono ogni giorno di più, come modelli da vivere, da elaborare, da pro- porre, da imporre, i processi della globalizzazione. Così le dif- ferenze nel nostro pianeta assumono andamenti diversi dal passato, non sopportano più opposizioni binarie che divido- no, in modo stabile e netto, le culture dominanti da quelle su- balterne, i “centri” del potere colonizzatore dalle “periferie” dei colonizzati.
In queste condizioni completamente nuove, la cultura, sia quella legata al mondo delle arti sia quella diffusa dai mezzi di comunicazione di massa, ha cambiato tempi e luoghi della sua produzione: se ancora essa si connette a quanto nel pas- sato questo o quel luogo ha elaborato, ha diffuso, ha imposto– dagli stili di vita ai valori, dalle arti al consumo e allo scam- bio di merci, dalle costellazioni di fede e di pratiche rituali al- le organizzazioni sociali e politiche – nuovi “luoghi”, tran- snazionali e deterritorializzati quali genere, classe, etnicità – si affiancano, si sovrappongono, confliggono per fornire all’u- manità intera quei filtri attraverso i quali le dimensioni cul-

11

Matilde Callari Galli
turali, intese quali sistemi di significati socialmente organizzati ed espressi in forme definite, sono accettate e condivise di- venendo parte della percezione del proprio gruppo e delle al- terità che continuano a sussistere e a prodursi.
I confini della colonizzazione continuano ad essere terri- toriali ed economici ma essi vengono mescolati, sovvertiti, re- si dinamici dalla produzione di un immaginario non solo letterario – come nel caso dell’orientalismo esotico eviden- ziato dagli studi di Edward Said – ma dipendente da forme di comunicazione sempre più mobili. Ed ecco la “wired identity” vissuta nel traffico transnazionale di narrazioni e di immagini (Erny 1996; 2001), ecco una nuova mappa del po- tere mondiale costruita lungo le linee delle telecomunica- zioni (Morley, Robins 1995), ecco l’individuo postmoderno che vive nell’era della tecnomitica (Wark 1994), ricevendo informazioni, mutevoli e mobili, che cadono dal cielo, inte- grandole nelle interpretazioni locali e aspettandosi che gli orientament i cambino da luogo a luogo, di giorno in giorno.
Davanti a questo ribollire di cambiamenti che investono molte delle certezze elaborate nei secoli precedenti dalle scienze sociali occidentali, l’antropologia è costretta a met- tere in discussione insieme ai suoi orizzonti concettuali e al- le sue pratiche metodologiche i suoi stessi fini, forse le sue stesse basi epistemologiche, rifiutando insieme le ansie uni- versaliste degli esploratori delle leggi universali dell’evolu- zione della cultura e i relativismo dei cercatori di usi e co- stumi particolari, spesso esotici e stravaganti, stimolatori di curiosità, sempre postulati come autosufficienti e chiusi in séstessi. (Adam, Borel, Calame, Kilani 2002)
Per non cadere nella trappola metodologica di postulare la possibilità di ricostruire la realtà basandoci su opposizioni binarie, costretti a scegliere tra l’esame delle informazioni non materiali e le chances di vita, tra la deterritorializzazione della cultura e i localismi più radicati ed esasperati, abbiamo bisogno di recuperare nello sguardo antropologico quello “strabismo” a lungo invocato nella disciplina che invitava i suoi cultori ad essere insieme gli astronomi di un tempo con i loro lunghi cannocchiali puntati sull’universo e gli orologiai
12

Etnografia nomadica
dei secoli scorsi con le loro piccole lenti fissati su meccanismi minuti e circoscritti. E forse trasportando sul piano meto- dologico un invito che quando fu formulato era soprattutto geografico, “a guardare lontano per studiare l’uomo” (Lévi- Strauss 1978:71, 1984; Borel 1993).
Questo progetto non ha un piano prestabilito da offrire, non intende proporsi come un paradigma concluso né come uno schema di riferimento teorico completo ed esaustivo. Piuttost o vuol essere un’agenda per costruire sequenze di ri- cerche, su cui annotare nuove prospettive, nuovi luoghi e nuovi ambiti, senza rinunciare agli strumenti propri del pas- sato della disciplina ma ponendone in primo piano alcuni, sviluppandoli maggiormente in confronto ad altri e al tempo stesso provando nuove strategie, applicando nuove tecni- che, proponendo nuovi orientamenti e nuove prospettive.
In questa linea mi sembra che si ponesse, anni fa, George Marcus quando proponeva un’“etnografia multisituata nel sistema Mondo”, in cui la parola d’ordine per il ricercatore non è più stare, radicarsi, risiedere, ma “seguire”: seguire i migranti, seguire le produzioni dei prodotti, seguire le me- tafore, le narrazioni, seguire la vita, le biografie, seguire i conflitti (Marcus 1995: 98-105).
Così voler studiare le nuove relazioni tra cultura e territo- rio implica porre l’accento sui processi del nomadismo con- temporaneo nei suoi effetti a livello globale, a livello locale, a livello virtuale e a livello di esperienza quotidiana: come so- gno e come vissuto; implica studiare problemi che appaiono nella loro complessità solo se ci proponiamo di analizzare in- sieme livelli troppo spesso considerati separati nel dare il predominio all’uno o all’altro: i processi globali che investo- no regioni ampie come più continenti e gli aspetti locali, micro-regionali e nazionali.
Ad applicare opposizioni binarie otteniamo risultati par- ziali, mai pienamente attendibili, spesso falsificanti i dina- mismi sociali: infatti se diamo valore solo al primo livello – quello globalizzante – la dimensione spaziale sembra perde- re la sua pregnanza a causa di appariscenti quanto superfi- ciali ed effimeri processi di omogeneizzazione. Se invece
13

Matilde Callari Galli
consideriamo la cultura della contemporaneità come un’ar- ticolazione processuale e dinamica tra globalizzazione e lo- calismi, se seguendo Appadurai consideriamo la linfa vitale che la globalizzazione riceve dai processi di indigenizzazione dei suoi messaggi, allora l’attenzione al territorio, allo stato nazionale, alla comunità divengono ancora e sempre rile- vanti. E la critica epistemologica da tempo ci ha resi consa- pevoli che l’interpretazione non deve risultare dalla somma di analisi parziali. Con l’orientamento teorico che guarda alla complessità del fenomeno l’intero piano metodologico muta: le unità d’analisi non sono “delimitate” e identificate automaticamente nei gruppi locali o negli stati nazionali del passato, ma divengono configurazioni emergenti di prati- che sociali, di simboli, di stili di vita stabili nel tempo se non nello spazio. E conseguentemente dobbiamo prima di volerle comprendere e spiegare, cercare di identificarle e di descriverle.
Questo volume raccoglie una serie di saggi che cercano di illustrare gli andamenti dei nomadismi incessanti che per- corrono il nostro mondo, le modalità distintive con cui essi alimentano e al tempo stesso subiscono la complessità della contemporaneittà; rivolge anche la sua attenzione alle mo- dalità con cui l’arcipelago di istituzioni che sembrano resi- stere ad essi si oppone ai cambiamenti e alle fusioni che sono in grado di provocare. Abbiamo avuto modo di presentare e di discutere questo ampio ambito problematico in un “pa- nel” dedicato ai “nomadismi della contemporaneità”, da me coordinato nell’ambito di un Convegno Internazionale, or- ganizzato dall’Istituto per l’Europa centro-orientale e balca- nica dell’Università di Bologna, intitolato “Nazionalismo, identità e cooperazione regionale. Compatibilità ed incom- patibilità” e svoltosi a Forlì dal 4 al 9 giugno del 2002.
Partendo da una tipologia delle nuove forme di nomadismi descritti nelle loro tensioni e nelle loro contraddizioni, si presentano letture metodologiche dei loro dinamismi, di quelli transnazionali e di quelli globali, di quelli reali e di quelli virtuali, ponendo l’attenzione ad un’etnografia dei
14

Etnografia nomadica
traffici moderni dell’incorporeo ma anche dei vissuti identi- tari e delle pratiche statali e parastatali che li avvolgono.
Cultura, processi identitari, articolazioni delle differenze tra richiami al passato e nuove rappresentazioni, costitui- scono lo scenario teorico comune su cui gli autori collocano le loro analisi e le loro riflessioni, tesi a mettere in luce, par- tendo dalle etnografie dei nuovi nomadismi, le loro logiche contaminate, i loro andamenti mutevoli, talvolta irregolari, le loro ibride sovrapposizioni, le lacerazioni ma anche le com- plicità che essi aprono.
Bibliografia:
Abélès M., 2001 [1983]. Politica gioco di spazi, Meltemi, Roma. Anderson B., 1996. Comunità immaginate, Manifestolibri, Roma. Appadurai A., 1996. “Diversity and Disciplinarity as Cultural Ar-
tifacts”, in Nelson C., Gaonkar D., (a cura di.), Disciplinarity andDissent in Cultural Studies, Routledge, London.
Borel M. J., 1993. “L’universal et le relatif: note sur l’objet anthro- pologique”, in Berthoud G., Centlivees F., Giordano C., Kilani M., (a cura di.), Universalisme et relativisme. Contribution a un débat d’actualitè, Ed. Universitaires, Fribourg.
Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, B. Mondadori, Milano.
Callari Galli M., Ceruti M., Cambi F., 2003. Formare alla com- plessità, Carocci, Roma.
Erny J. N., 1996. “On the Limits of “Wired Identity” in the Age ofGlobal Media”, in Identities, 2, n. 4, pp. 419-28.
Erny J. N., 2001. “Media Studies and Cultural Studies: a Sym- biotic Conergence”, in Miller T., (a cura di), A Companion to Cultural Studies, Blackwell, Malden-Oxford.
Giddens A., 2000. Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna. Habermas J., 1999. “Bestialitat und Humanitat”, in Die Zeit, n.
18, p. 1.Lévi-Strauss C., 1978. Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano. Lévi-Strauss C., 1984. Lo sguardo da lontano, Einaudi, Torino. Marcus G., 1995. “Ethnography in/of the World System: the
15

Matilde Callari Galli
Emergence of multi-situated Ethnography”, in Annual Review ofAnthropology, vol. 24, pp. 95-117.
Morley D., Robins K., 1995. Spaces of Identity: Global Media, Elec- tronic Landscapes and Cultural Boundaries, Routledge, London.
Pandolfi M., 2002.” ‘Moral Entrepreneurs’ , souverainetés mouvant et barbelés. Le bio-politique dans les Balkans postcommuni-stes”, in Anthropologie et Sociétés, vol. 26, n. 1, pp. 29-50.
Wark M., 1994. Virtual Geography: Living with Global MediaEvents, Indiana University Press, Bloomington.
16

I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEITÀ
di Matilde Callari Galli


“Più che un’arte di apprendere, l’arte del viaggio è, mi sembra, un’arte di dimenticare, di dimenticare tutte le questioni di pelle, di odore, di gusto e tutti i pregiudizi (…). Più che di accrescere le nostre cono- scenze si tratta oggi di spogliarcene.”
M. Leiris, Zébrage, p. 56
1. Una premessa
Una lunga storia di nomadismo, svolto cacciando in piccoli gruppi, attraversando per centinai di millenni i paesaggi di- versi del nostro pianeta, costituisce per la nostra specie una eredità difficile da dimenticare, per molti antropologi im- possibile da cancellare. E la storia del sedentarismo, dei “co- struttori di città”, intensa e produttrice di un incredibile fer- vore di innovazioni e di cambiamenti culturali, appare breve– un attimo, un battito di ciglia di una divinità – se proiettata sullo sfondo dei milioni di anni che l’hanno preceduta.
Al suo interno, inoltre, è possibile cogliere una tensione costante che tiene vivo, a livelli diversi, il desiderio del muo- versi, l’ansia del nuovo, la ricerca di nuovi spazi, la scoperta di nuove modalità di interazione con paesaggi, comunità, culture. E i livelli parlano di migrazioni di piccoli gruppi o di intere popolazioni, di orde feroci che conquistano e abbat- tono imperi, di caravelle che scoprono nuovicontinenti, di confini “naturali” continuamente violati da una ricerca in- tellettuale avida e sempre insoddisfatta, da applicazioni tec- nologiche sempre più audaci nello spostare i limiti conside- rati dal proprio tempo insuperabili.
Tutto questo ribollire di gruppi che si incontrano, si scon- trano, si mescolano e si distruggono, subisce nel corso degli ultimi secoli un aumento sempre più vigoroso dovuto ad una concomitanza di fattori: un aumento demografico mai verifi- catosi, nel nostro pianeta, in queste proporzioni, lo sviluppo differenziale dei diversi modi di produzione, l’attrazione eser-
19

Matilde Callari Galli
citata in tutti i continenti dalle aree urbane, il potenziamento dei mezzi di comunicazione. E considerare i processi culturali in atto nella contemporaneità significa riconoscere che la di- namica culturale dell’intero pianeta è oggi condizionata, se non determinata, dal movimento pressochè costante di mas- se di individui: ogni anno quasi seicento milioni di individui varcano un confine internazionale per seguire le mode e le occasioni dei turismi di massa, mentre sono centinaia di mi- lioni le persone – donne e uomini soli, famiglie, intere comu- nità – che emigrano per motivi economici, si ritrovano esuli o profughi a seguito di conflitti e deportazioni o scelgono sem- plicemente di vivere all’estero, disegnando così i loro destini all’interno di spazi tanto vasti quanto il pianeta; o ancora, per le loro attività professionali, costellano la loro vita quotidiana con continui e ripetuti spostamenti.
2. La contaminazione degli spazi
Sarebbe appropriato domandarsi perché gran parte del pen- siero occidentale abbia per secoli rimosso questa realtà so- stituendol a con la convinzione di uno stato di natura che ve- de la nostra specie essere “naturalmente” sedentaria: dalla letteratura alle scienze sociali e al “senso comune” il viaggio, lo spostamento è considerato una situazione eccezionale, che rompe equilibri e produce turbamenti. Ed anche quan- do sia considerato con favore è riferito sempre ad individui o ad eventi che riguardan o momenti passeggeri, comunque straordinari, della storia individuale o del gruppo: Ulisse, l’eroe che con le sue avventure sembra annunciare l’irre- quietezza della modernità, è costretto alle sue peregrinazioni dal volere di dei avversi e insegue con tenacia temeraria il ri- torno alla sua “petrosa” isola. E la trasformazione del mito omerico, raccontata nel viaggio dantesco, appare più come un destino fatale che come una scelta deliberata. In campo antropologico mi sembra che anche lo sforzo di Marvin Har- ris di presentare ironicamente la “scelta “ della sedentarietà come una necessità resa obbligatoria dalla volontà dei cac-
20

I nomadismi della contemporaneità
ciatori di abbandonare i sanguinosi e dolorosi metodi di controllo delle nascite cui li costringeva la loro economia non adatta a gruppi di larghe dimensioni sia rimasto, al suo apparire, alquanto inascoltato.
Dalla convinzione di una sedentarietà “naturale”, più po- stulata che dimostrata, scaturisce un approccio tutto partico- lare all’analisi del nomadismo in base alla quale esso è consi- derato un’interruzione di una situazione in cui le singole cul- ture si sviluppano attraverso il loro lungo radicamento in un determinat o territorio. Con questa visione la stessa dinamica culturale è pressochè interamente riportata all’interno del gruppo esaminato: come ha scritto James Clifford, “le radici precedon o sempre gli itinerari” (1999: 3).
Se invertiamo la prospettiva e postuliamo che il nomadi- smo, il “viaggio” non abbiano un carattere di eccezionalità ma siano momenti basilari della dinamica culturale, il terri- torio, i confini, le identità dei gruppi divengono prodotti culturali, non più entità “naturali” ma elementi costruiti dal- le pratiche dei contatti e degli spostamenti dei diversi grup- pi nel corso della loro storia.
La centralità del nomadismo emerge soprattutto alla fine del XX secolo in seguito al virulento sviluppo dei processi di globalizzazione che sembrano travolgere ogni regione del nostro pianeta; ed i processi innovativi propri della nostra contemporaneità, il loro affastellarsi affannoso, fanno “esplo- dere” quella coincidenza tra cultura e territorio che è stata alla base del modello teorico e politico accettato e affermato dall’Occidente soprattutto nei secoli XIX e XX.
Le parole che indicano i caratteri del processo di globaliz- zazione individuate da Anthony Giddens riguardano princi- palmente il livello economico sottolineando le interazioni fi- nanziarie che accomunano paesi lontani e diversi, la diffusio- ne mondiale delle tecnologie moderne, le nuove forme della divisione e dell’organizzazione della forza lavoro, l’emergen- za di “un ordine militare mondiale”. A queste dimensioni tuttavia se ne sono aggiunte altre, di carattere più nettamente culturale che con le loro interazioni, con le loro “ricadute” rendono il quadro ancora più dinamico e complesso: la cre-
21

Matilde Callari Galli
scita di reti e di corporazioni transnazionali; nuove tecnologie di informazione e di comunicazione che hanno contribuito ad una “intensificazione della compressione spazio/temporale” che ha avuto un impatto disorientante e distruttivo sulle pra- tiche politico/economiche usuali; un aumento vertiginoso negli spostamenti, nelle emigrazioni, nei viaggi internaziona- li con conseguenti e parallele trasformazioni nella vita sociale e culturale della maggioranza dei gruppi umani.
Gli effetti di questi processi innovatori sono sfuggenti e contradditori. Se alcuni analisti sottolineano la prospettiva della nascita di una cultura globale cosmopolita sorretta dal- la nascita di “culture transnazionali”, altri individuano una grande superficialità nel cosmopolitismo contemporaneo, una omogeneità tutta apparente, determinata dall’adegua- mento generalizzato a modelli consumistici rispondenti alla produzione economica capitalista – la McDonaldizzazione del mondo (Barber 1998). E al di sotto di questa coltre si in- dividua un mondo interdipendente a causa dei processi glo- bali che tuttavia continua a produrre localismi esasperati, va- lorizzazioni di comunità etniche che sembrano sfidare le più ampie unità politiche in cui sono incorporate rivendicando per sé stesse diritti e riconoscimenti propri di nazioni e di stati; la riscoperta di “radici” e di storie che minacciano non solo le nuove unità transnazionali ma le stesse unità nazionali degli ultimi secoli. (Bhabha 1997).
Ad un esame circostanziato appare infondata e approssi- mativa l’ipotesi sia della univocità della diffusione nel mondo di un unico modello consumistico sia l’inevitabilità dei pro- cessi di omogeneizzazione culturale ad essa conseguente. La dinamica interculturale della contemporaneità è assai più complessa di queste semplificazioni riduzionistiche. Come scrive Appadurai “appena le forze innovative provenienti da diverse metropoli sono portate all’interno di nuove so- cietà, esse tendono, in un modo o nell’altro, a subire un processo di indigenizzazione: questo è vero della musica co- me degli stili abitativi, dei procedimenti scientifici come del terrorismo, degli spettacoli come delle norme costituzionali. In poche parole le singole culture possono riprodursi o ri-
22

I nomadismi della contemporaneità
costruire la loro specificità sottoponendo le forme culturali transnazionali ad un processo di indigenizzazione” (Appa- durai 1996: 19). Così dobbiamo riuscire a sintonicizzarci, per usare un’espressione di Robertson, “tanto all’istituzio- nalizzazione globale della vita-mondiale quanto alla localiz- zazione della globalità” (Robertson 1999).
In termini antropologici, applicando cioè questo schema di riferimento alle nostre ricerche che muovono sempre da contesti circoscritti e specifici per poi accedere a più ampie generalizzazioni, il concetto di deterritorializzazione mo- stra una sua intima e profonda dinamicità. Nella contem- poraneità i processi e i prodotti culturali si svincolano dalla loro aderenza ad un determinato spazio, perdono le conno- tazioni territoriali , divengono mobili, a volte volatili, per iscriversi sempre e comunque in un particolare luogo. E appare suggestivo il suggerimento di Jonathan Inda e Re- nato Rosaldo di dividere in due il termine de/territorializ- zazione per indicare che dal punto di vista antropologico lo sforzo è quello di dimostrar e che la deterritorializzazione contiene sempre una riterritorializzazione: “questo significa, essi scrivono, che per noi la radice della parola limita l’a- zione del prefisso, così che mentre il ‘de’ strappa la cultura dal luogo, la ‘territorializzazione’ è presente in un modo o nell’altro per riportarcela. Così nessun processo di deterri- torializzazione ha luogo senza una qualche forma di riterri- torializzazione” (Inda, Rosaldo 2002: 12).
Usando altre parole, forse è necessario non vivere in ter- mini oppositivi globale e locale ma immaginare un inces- sante processo di deterritorializzazione che investe tanto il processo di globalizzazione quanto le forme che assume il lo- calismo (Cavarero 2001; Callari Galli, Cambi, Ceruti 2003); l’invito è a cessare di usare concetti quali etnicità e identità per riaffermare i vecchi miti della premodernità, e a consi- derarli, invece, come processi dinamici che si costruiscono attraverso le pratiche dei contatti culturali. E si deve alla ri- flessione di Michel Foucaul t aver intuito che lo spazio, nella nostra contemporaneità, “ci si offre sotto forma di relazioni
23

Matilde Callari Galli
di dislocazione” (Foucault 1994: 13): è la dislocazione che sostituisce sia la localizzazione propria della concezione spa- ziale medievale che l’estensione con cui il pensiero galileiano l’aveva sostituita. Così il tempo storico che aveva costituito il fulcro dell’organizzazione politica e culturale del XIX se- colo con le sue diadi “sviluppo/sottosviluppo”, “progres- so/tradizione”, per Foucault nella contemporaneità è sosti- tuito proprio dallo spazio: non più quindi una grande storia che si sviluppa nel tempo ma una “rete che incrocia dei punti e intreccia la sua matassa”.
3. Per una mappa dei nomadismi della contemporaneità
3.1. L’ analisi culturale
Non è semplice individuare il contributo che le discipline an- tropologiche possano dare alla lettura di queste nuove realtà culturali, ancora fluide e colme di contraddizioni. Una strada proposta negli ultimi anni sottopone ad una critica serrata l’idea – profondamente radicata nel pensiero e nel vissuto dell’Occidente contemporaneo – che considera i modelli di comunità e le attrazioni verso il localismo quali entità natura- li ed innate: in effetti mi sembra che applicando anche ad essi i principi epistemologici della nostra metodologia sia possibi- le ricondurl i alla loro culturalità, considerandoli risultati di pratiche politiche e sociali che formano le identità. Se accet- tiamo di sfuggire alle trappole della “metafisica della sedenta- rietà” (Malkki 1997: 61) – del resto totalmente contraria ai ri- sultati delle nostre ricerche e dei nostri studi sulla storia della nostra specie – se non consideriamo come ovvii e inevitabili il radicamento e l’attaccamento alla comunità, se rifiutiamo di accettare acriticamente che le potenzialità affettive e i principi identitari scaturiscano unicamente ed automaticamente dalle esperienze legate ai luoghi in cui si vive e dalle relazioni quo- tidiane degli incontri “faccia a faccia”, vedremo con chiarezza che l’esperienza apparentemente immediate e diretta della vi- ta comunitaria, in realtà è costituita da un ben più ampio ap-

24

I nomadismi della contemporaneità
parato di relazioni sociali e spaziali. Ed oggi sempre più nu- merosi sono gli studi culturali che mirano a fondare un’anali- si della contemporaneità ponendo al centro dei loro interessi la diffusione dei fenomeni della globalizzazione, accompa- gnati, sostenuti, contraddetti da una cultura ad un tempo glo- bale e frammentata, deterritorializzata e localistica. In parti- colare, attraggono la loro attenzione l’intreccio del locale e del globale, la connessione tra globalizzazione e l’emergenza di nuove forme di esclusione e di ineguaglianza, la relazione tra la transnazionalizzazione dei contesti specifici e la riarticola- zione contestuale dei flussi transnazionali – umani, finanziari, di immagini, idee, informazioni (Appadurai 1996; Augé 1998; Callari Galli 1998; 2000).
Sempre più i nuovi nomadismi che percorrono la società contemporanea divengono oggetto privilegiato ed emergen- te della ricerca e della riflessione culturale: da fonti diverse assistiamo ad un fiorire di nuovi concetti o ad una rivisita- zione di vecchie terminologie, quali quella di “diaspora”, di trasmissione culturale, di “turismo”, di migrazione, di iden- tità, usate tutti per render conto di ciò che sembra un nuovo modello e un nuovo modo di vivere quel nomadismo che è proprio da sempre della nostra specie. Sempre più numero-
si sono gli studi antropologici che abbandonand o lo schema teorico che ipotizza una dinamica culturale che si svolga in- teramente tra sistemi socioculturali unitari e saldamente le- gati ad un territorio , preferiscono parlare di culture “ibride”
(Canclini 1989), di “orizzonti culturali” (Appadurai 1992), di “contaminazioni” (Callari Galli 1995; 1999; 2000), di “logi- che meticce” (Amselle 1990), di “strade” (Clifford 1997), per non parlare di alcune anticipazioni che immaginavano ampi panorami in cui iscrivere vasti aggregati di popolazioni diverse sotto molti aspetti culturali ma riunificate proprio dai loro nomadismi (Lewis 1973), (Harrison, Callari Galli 1971).
James Clifford auspica che l’analisi antropologica sappia contemplare accanto ai “centri”, ai villaggi, alle negoziazioni interne al gruppo anche i luoghi di passaggio, le mediazioni con i viaggiatori, gli spazi continuamente spostati e attra- versati. Con questa prospettiva si confondono i limiti tra
25

Matilde Callari Galli
“centro” e “periferie”, nuovi attori sociali emergono come protagonisti delle dinamiche culturali: traduttori, missionari, esploratori, amministratori degli aiuti internazionali, turisti, gruppi migranti, “rifugiati”, lavoratori pendolari e stagio- nali (Bhabha 1994; 1997; Mudimbe 1988).
Non si può, tuttavia, riposare tranquillamente su questi con- cetti: se la teoria della “purezza originaria” di questa o quella cultura è priva di ogni fondatezza storica e con la sua falsità appare densa di pericoli sul piano concettuale e politico, por- re alla base dell’interpretazione della contemporaneità l’ibri- dismo quale unica condizione (Inda, Rosaldo 2002) non spie- ga i caratter i differenziali, rispetto al passato, che presenta lo scambio culturale causato e determinato dagli attuali processi di globalizzazione. Forse sarebbe opportuno inserire categorie più accurate che seguendo ad esempio le suggestioni di Mi- chail Bachtin distinguano un ibridismo organico, proprio di tutti gli incontri culturali avvenuti in tutte le epoche, da un ibridismo intenzionale che tramite l’inserimento nei processi di ibridazione della ricerca di shock – non solo estetico come voleva Bachtin ma più genericamente culturale – dia mag- gior conto della immediatezza, direi quasi della voracità, dei processi di ibridazione attuali. Soprattutt o queste categorie dovrebbero consentire di esaminare i diversi ibridismi, le di- verse contaminazioni, riferendole ai diversi contesti in cui si verificano e che si consideri, nell’esplicitare le loro dinamiche, il ruolo esercitato dal differenziale di potere esistente tra le di- verse parti in contatto (Amhad 1995; Tomlinson 2001).
3.2. Processi migratori: ambiguità e prospettive
I massicci movimenti di essere umani attraverso i confini internazionali che si stanno verificando da qualche anno, sono man mano divenuti uno dei problemi più ambigui da un punto di vista teorico e più difficile da affrontare da un punto di vista pratico-politico. Trascurati per lungo tempo anche dai demografi e dagli scienziati sociali sono ormai considerati un tema che implica livelli di analisi e di inter- pretazione e che investe molti livelli, da quelli etici a quelli
26

I nomadismi della contemporaneità
legislativi, da quelli culturali ed economici a quelli della si- curezza sociale e a quelli dei diritti umani.
Vorrei prima di procedere ad una loro sia pur rapida pre- sentazione introdurre una precisazione di carattere soprat- tutto quantitativo che allontani o ridimensioni l’atmosfera di crisi e di allarme che circonda la rappresentazione sociale ampiamente diffusa sui processi migratori. I risultati delle analisi dinamiche e longitudinali compiute a livello mondia- le nella sfera delle migrazioni internazionali, includenti sia i movimenti volontari che quelli forzati, non forniscono prove di aumenti numerici così vertiginosi da giustificare lo stato di allarme ampiamente diffuso nei discorsi politici, nei mezzi di comunicazione di massa e nel linguaggio usuale e quotidia- no. E questo vale tanto per i rilievi compiuti nel presente quanto nelle proiezioni realisticamente aperte sull’immedia- to futuro (Zolberg, Benda 2001).
Alla luce di questo dato i discorsi pieni di allarme sui pro- cessi migratori che dalle aree della povertà, del bisogno e della violenza si stanno riversando nelle aree del benessere e della democrazia appaiono colmi di una irrazionalità che non può essere considerata solo una semplice esagerazione e una inutile e falsa percezione della realtà. Come ha evidenziato Amartya Sen commentando i molti discorsi che circolano sulla cosiddett a “bomba demografica”, “la mentalità caratte- rizzata da una stato di emergenza basato su una idea appros- simata e falsa che prevede un imminente cataclisma conduce a risposte affannose che sono profondamente controprodu- centi (1994: 71)”. In realtà la sensazione dilagante di vivere oggi “una crisi nei processi migratori internazionali” ha profondamente influenzato ogni possibilità di politiche al- ternative. In particolare è spesso invocata per giustificare dra- coniane misure tese a proteggere i confini nazionali anche a danno di altre considerazioni quali i doveri umanitari nei confronti dei rifugiati, le politiche generose nei confronti del- le riunificazioni familiari e lo stesso rispetto dei diritti umani.
Visioni più equilibrate dei flussi numerici sia dei processi migratori globali sia dei gruppi di “rifugiati” e analisi circo- stanziate delle cause che li determinano ci forniscono indi-
27

Matilde Callari Galli
rizzi più appropriati e meno crudeli sui quali elaborare pro- getti e programmi futuri. Ed essi si organizzano intorno a due orientamenti principali: alleviare le condizioni econo- miche e politiche che alimentano i processi migratori verso i paesi del “benessere” e prevenire o rendere meno esplosivi i conflitti che generano i gruppi dei rifugiati.
Rispetto al primo orientamento molti studi insistono sulla necessità di introdurre politiche economiche di sostegno nelle aree che producono il maggior numero di migranti ba- sate sulla crescita, in esse, del libero mercato; questi studi tuttavia introducono la consapevolezza che esse necessitano di tempo, di sviluppo di politiche educative e di campagne di istruzione mirata: inoltre nell’immediato si auspica an- che la nascita di accordi multilaterali che vedano regolare i flussi migratori sia nei paesi di arrivo che nei paesi di par- tenza basandosi non solo su fattori strettamente occupazio- nali ma introducendo anche negli accordi una forte carica di attenzione e di rispetto dei diritt i umani in ambedue le aree, in quelle di partenza e in quelle di arrivo.
Rispetto al secondo orientamento innanzi tutto dobbia- mo precisare che negli ultimi anni i “rifugiati” non sem- brano più rappresentare una minaccia immediata per le democrazie del “benessere” per una serie di fattori: innan- zi tutto il numero dei rifugiati che cercano asilo in esse sembra essersi stabilizzato e molti di essi rimangono nelle regioni di residenza o nei loro immediati confini. Tuttavia il fatto che essi manchino di quella forma di aiuti che a buon diritto si aspetterebbero di ricevere dai propri governi – va certamente considerato che proprio i loro governi sono spesso la causa della loro “fuga” – crea, nei loro confronti, pesanti obbligazioni alla comunità internazionale conside- rata nella sua totalità. Se non si vuole concedere il diritto di asilo accogliendoli nei propri confini, non cessano i doveri di garantire il rispetto dei diritti umani nei loro confronti mentre si contraggono obblighi nei confronti delle aree che, bene o male, li accolgono e si deve proseguire il soste- gno ad una politica che li reinserisca nei loro contesti nel momento in cui la situazione nel loro paese lo permetta.
28

I nomadismi della contemporaneità
3.3. Le culture della diaspora
Robin Cohen ha osservato che il concetto di diaspora a lun- go usato nelle scienze sociali, nelle opere letterarie e nelle analisi politiche ha una definizione ancora imprecisa e uno spessore teorico alquanto inconsistente (Cohen 1992).
Restando fedele al riferimento biblico, attualmente il con- cetto di diaspora è generalmente usato per definire la dislo- cazione di gruppi che in seguito a conflitti, persecuzioni politiche e religiose sono costretti ad abbandonare i loro luoghi di residenza abituale, mentre per cultura della dia- spora si intende la rete di relazioni che in conseguenza di queste dislocazioni unisce vaste aree – geografiche e cultu- rali – anche assai difformi per caratteri, storia e specificità economiche e politiche.
L’aumento in termini numerici del fenomeno, la sua pre- senza in regioni assai distanti le une dalle altre, le interdipen- denze che esso stabilisce con aspetti determinanti della poli- tica e dell’economia internazionale hanno prodotto, in questi ultimi anni, un vistoso aumento delle riflessioni su di esso. Muovendo dalla definizione generica che lo indicava come un prodotto di comunità che sebbene fossero sparse in vaste aree mantenevano al loro interno profondi legami sociali e forti sentimenti identitari, gli studi oggi mettono in luce le re- lazioni che le culture diasporiche mantengono con le comu- nità di origine (Safran 1991) ma evidenziano anche quelle che stabiliscono con le comunità che li hanno accolti (Clifford1994) e non trascurano di riflettere sulle reti che si stabili- scono fra le diverse culture diasporiche (Haller 2000). A que- sto proposito mi sembra molto rilevante porre alla base delle nostre ricerche una domanda finora poco presente nelle sue molteplici implicazioni: come si mescola la cultura tradizio- nale alle nuove pratiche che costruiscono l’orizzonte cultura- le della diaspora? Quanti sono, fra i popoli dei “campi”, gli individui che si nutron o dell’impianto ideologico che li fa “re-inventare” un loro passato indipendente e felice e quanti di essi, invece, non sono già partecipi di una cultura “inter- stiziale”, carica di contaminazioni e di meticciati?
29

Matilde Callari Galli
È molto importante sottolineare che investigare le strategie e le pratiche discorsive messe in atto dai singoli gruppi che vivono la diaspora rivela che l’esperienza della dispersione e dell’esilio rafforza anche i legami con il mondo più vasto, fornendo visioni unitarie e complesse sia del “locale” che dell’“altrove”, sia della durezza presente che del rimpianto nostalgico. Inoltre eventi che pongono in pericolo l’identità nazionale, come accadde ad esempio nel 1990 allo scoppio della guerra in Croazia, possono avere l’effetto di rivitalizza- re e in un certo senso reinventare una identità comune tra tutti gli esiliati, i rifugiati, gli emigrati che a molti livelli – informali, ufficiosi ma anche ufficiali – intensificano i loro le- gami transnazionali (Al-Ali 2002: 25). A partire dal 1990, in Croazia, nei discorsi ufficiali il termine “diaspora (dijaspora)” è usato per unificare due concetti sino ad allora ben distinti: quello che definiva i “lavoratori temporaneamente all’estero” e quello che definiva con il termine apparentemente neutro – ma colmo di connotazioni negative – di “emigranti (emi- granti)” i fuoriusciti dalla Jugoslavia per motivi politici. (Po- vrzanovic Frykan 2002: 20)
Numerosi sono gli stati nazionali che in questi ultimi anni hanno tentato, di stabilire, a livello istituzionale, legami con i gruppi che possiamo far rientrare nell’ambito – in verità, am- pio, fluido e piuttosto vago – della cultura diasporica. Trovia- mo documenti di questi tentativi in realtà culturali e politiche assai diverse che indirizzano i loro sforzi quasi unitariamente agli immigrati, ai fuoriusciti, ai gruppi scacciati da eventi bel- lici o da costrizioni politiche. Robert Smith, esaminando i tentativi messi in atto dal governo messicano per sviluppare le- gami stabili con i suoi cittadini che legalmente o meno sono immigrati negli Stati Uniti, individua, per queste azioni, tre ra- gioni che in linea di massima possono essere ritenute valide anche in molti altri contesti: impadronirsi di parte delle risor- se finanziarie prodott e nel nuovo paese, controllare i legami che si sono sviluppati tra la società civile del luogo di origine e gli emigrati, riorganizzare l’identità nazionale che potrebbe es- sere indebolita per i contatt i stabiliti con la nuova cultura. (Smith 1998: 224 cit. in Koser 2002: 34).

30

I nomadismi della contemporaneità
Un problema ancora poco esplorato riguarda la reale vo- lontà delle diverse comunità diasporiche di ritornare per- manentemente nel paese di origine. A questo livello di analisi può innanzi tutto risultare produttivo discutere le ipotesi che presentano le culture diasporiche come luogo di processi unificanti, mettendo in dubbio tanto quelle che apparten- gono alle politiche degli stati e dei rappresentanti delle co- munità che quelli più o meno accurati suggeriti dagli stu- diosi. Molte sono le ricerche che smentiscono il luogo co- mune in base al quale vivere lontano dalla propria comunità nazionale implichi automaticamente perdere la propria iden- tità, le proprie tradizioni e la propria cultura: tuttavia l’e- sperienza della dislocazione si struttura in base a tante va- riabili, è talmente influenzata dalla politica locale nei con- fronti dei diversi tipi di nuovi “ospiti”(immigrati, rifugiati, clandestini) e insieme dalla politica internazionale nei con- fronti dei paesi di provenienza che i nuovi milieu culturali che si formano sono aperti a svariate soluzioni, spesso fluide e contingenti. Come ha scritto Stuart Hall, “l’esperienza del- la diaspora non è definita dall’essenza e dalla purezza ma dalla consapevolezza di una necessaria eterogeneità e diver- sità: da una concezione dell’“identità” che vive non in op- posizione alla differenza ma con essa e attraverso essa; è de- finita dall’ibridità” (Hall 1989: 809).
Va comunque ricordato che attraverso l’uso dei media, at- traverso i collegamenti con gli stati nazionali e con gli orga- nismi internazionali, le comunità diasporiche, e in generale le comunità transnazionali, possiedono buoni livelli di potere politico ed anche economico, buone capacità di costituire punti di aggregazione che superano le stesse appartenenze nazionali e/o etniche: e allora sovente esse sono – o possono essere – attori e agenti di cambiamenti politici sia nel loro paese di origine che in quello di accoglienza. E questa dina- mica complessa e variamente articolata anche all’interno del- la stessa comunità diasporica, dimostra l’errore – non solo teorico ma anche politico – di riportare a modelli unici e ge- neralizzanti le culture diasporiche, di considerare unitaria-
31

Matilde Callari Galli
mente le loro potenzialità quali agenti di cambiamento e di interpretare in modo univoco le finalità delle loro attività.
3.4. Le culture dell’emigrazione
Per quanto riguarda l’analisi del fenomeno migratorio la no- stra contemporaneità mostra differenze profonde con il pas- sato. Le migrazioni sono oggi, come ieri, determinate da ra- gioni composite che affiancano, senza escludersi a vicenda, la ricerca di benessere alla necessità di sfuggire alla violenza della guerra e della persecuzione politica. E forse a questo li- vello le differenze con il passato sono più quantitative che qualitative; grandi gruppi umani hanno sempre vissuto qua- si contemporaneamente “la diaspora della speranza, la dia- spora del terrore, la diaspora della disperazione” (Appadurai1997). Le immagini dei treni del Kosovo non possono non richiamare alla nostra memoria i treni piombati dell’Olo- causto ma anche le navi di cittadini inglesi strappati alle car- ceri per popolare la “riva fatale” (Hughes 1990). Così come i vestiti laceri, le scarpe sfondate, i fagotti di stracci dei ko- sovari della contemporaneità, ricordano i vestiti laceri, le scarpe sfondate, i fagotti di stracci documentati nel museo di Ellis Island, nella baia di New York, a ricordo della diaspora, anch’essa carica di dolore e di speranza, che popolò gli Stati Uniti d’America.
Quello che oggi è completamente nuovo è che questi mo- vimenti, queste diaspore, si muovono all’interno di un siste- ma di comunicazione ignoto nel passato, che dà forma al de- siderio e all’oltraggio ma al tempo stesso anche agli adatta- menti, alle scelte, alle ribellioni. Sono le trasmissioni televi- sive che portano nelle nostre case e nelle nostre coscienze la marcia disperata di un popolo scacciato perché “etnicamen- te” non congeniale ad un territorio, sono le trasmissioni te- levisive che muovono i nostri antichi rimorsi costringendosi oggi, a differenza di ieri, a non poterci nascondere dietro l’a- libi della non conoscenza. Ma anche i vissuti delle vittime e dei carnefici sono attraversati, in parte determinati, comun- que influenzati, dalla creazione di un immaginario collettivo
32

I nomadismi della contemporaneità
che paradossalmente, proprio in un conflitto che pone alla sua base i principi di territorialità e di appartenenza etnica, trascende completamente gli spazi delle singole nazioni.
Sono le trasmissioni televisive che spesso orientano e spin- gono individui e gruppi verso l’esperienza migratoria: la rete che avvolge il nostro pianeta con le trasmissioni satellitari riempie tutti i continenti di immagini di ricchezza, di vita fe- lice e libera aperta a tutti, e per quanto sia falsa e mistifican- te è stato ed è tuttora un fattore che dà forma ed unifica il desiderio collettivo di milioni di individui: sovente poi i rac- conti stessi degli individui che vivono questa esperienza con- fermano agli occhi di chi non è ancora partito il sogno: per non confessare le umiliazioni e i fallimenti di cui spesso la via dell’emigrazione è costellata, per allontanare dai propri fa- miliari il dolore provato, per convincersi che la scelta fatta aveva una sua validità e una sua ragione.
Allargando la nostra ottica, l’intero “spazio migratorio” è stravolto dall’esistenza dei mezzi di comunicazione, dagli ae- roplani ai fax, dalle trasmissioni televisive alle poste elettro- niche, alle “navigazioni” in Internet: gli immigrati indiani guardano, in Gran Bretagna o in Italia, le telenovelas prodotte ne loro paese di origine, ricevono visite frequenti di parenti e
amici; i tassisti pakistani percorrono le strade di Sydney ascol- tando le “cassette” delle preghiere registrate nelle
lontane moschee del mondo musulmano, comunicano quotidiana- mente con le loro comunità; le antenne
paraboliche che affol- lano le finestre dei “centri di accoglienza” predisposti in Emilia-Romagna per gli
immigrati maghrebini portano, nelle loro povere stanze, le immagini e le voci dei loro paesi: pro- prio mentre si muore
per una città, per un villaggio, un cam- po, l’immaginario collettivo si allarga, raggiunge spettatori appassionati che
introdurranno in spazi culturali completa- mente diversi le immagini trasmesse nei loro paesi di origine. V’è poi un
altro versante assai importante da aprire e, sia pure succintamente, da trattare: ed è quello dell’influenza che i
mezzi di comunicazione di massa esercitano sul bacino di informazione e sull’immaginario collettivo che i cittadini di
un paese oggetto di immigrazione posseggono sul feno-
33

Matilde Callari Galli
meno: anche se da tempo gli studiosi dei milieu mediatici ci raccomandano grande prudenza nello stabilire effetti diretti e univoci tra immagini, informazioni e comportamenti degli utenti , molti studi dimostrano che i mezzi di comunicazione– prima fra tutti la televisione la cui recezione, per la sua fruibilità, è assai più facile ed immediata di altri mezzi, qua- li i quotidiani, la fotografia e i film – hanno avuto un ruolo determinante nel costruire un alone di “alterità” intorno agli immigrati, riunendoli tutti in un’aura di estraneità, di so- spetto rispetto alle loro “vere” intenzioni, sottolineando le loro devianze ed etichettandoli tutti – spesso indiscrimina- tamente – come potenziali delinquenti.
Il caso delle influenze che la televisione italiana ha avuto e continua ad avere sull’immaginario che si è negli ultimi anni costruito sugli immigrati albanesi può essere un esempio di questa azione. Un’enfasi eccessiva – definita “un’ossessione nazionale” (Wood, King, 2001: 15) – sul rapporto tra mi- grazione e criminalità, una continua descrizione degli effetti negativi della migrazione e delle difficoltà di inserimento nella società italiana e di contatto con gli italiani stessi, al- lontanano la maggioranza degli italiani dal considerare in termini strutturali questi effetti dell’emigrazione: non li col- legano, cioè, con il mercato del lavoro nero e con un sistema corrotto e malavitoso largamente presente nel nostro paese prima dell’arrivo degli immigrati albanesi ma finiscono con il considerare un prodotto dell’immigrazione l’intera area del- l’illecito e della devianza (Campani 2001).
È interessante notare che mentre questo immaginario col- lettivo si andava formando in Italia, le nostre trasmissioni, piene di benessere, di gioia di vivere, di vacanza continue e dorate, avevano grande influenza fra i giovani che vivevano nelle città dell’Albania e che su queste immagini da terra promessa costruivano non solo il loro progetto emigratorio ma i presuppost i critici per abbattere il regime di Enver Hoxha: soprattutto costituivano l’orizzonte onirico, l’imma- ginario per desiderare di costruire una nuova soggettività politica e personale che li sottraesse all’oscuro e triste clima del totalitarismo in cui erano immersi. (N. Mai 2001)
34

I nomadismi della contemporaneità
3.4.1. Nuove domande per nuovi approcci metodologici
“Tutte le società producono stranieri: ma ognuna ne produ- ce un tipo particolare”. Mi sembra che queste parole di Zyg- mut Bauman possano essere una buona introduzione alla ricerca di nuovi orientamenti epistemologici per i fenomeni migratori, a patto, forse che siamo disposti ad introdurre una precisazione: per produzione bisogna intendere una processualità che riguardi alla pari “noi” e gli “altri”. In altre parole l’antropologia della contemporaneità pone una totale identificazione tra il soggetto e l’oggetto del suo interesse, tra “noi” e gli “altri” e rifiuta di identificare “noi” con noi stes- si, noi stessi in quanto italiani e autoctoni attribuendo tutte le categorie dell’alterità all’immigrato, allo straniero. In questa logica divisoria tanto la tesi che l’immigrazione sia un feno- meno altamente positivo dal punto di vista dell’arricchi- mento culturale ed economico del paese ospite quanto quel- la apparentemente opposta che considera il fenomeno mi- gratorio un danno e un rischio da ridurre e contenere al massimo, condividono – a guardar bene – la stessa posizione teorica, nonostante che ovviamente le rispettive pratiche po- litiche risultino poi contrapposte e nemiche. Ambedue in realtà considerano l’immigrazione un fenomeno unitario, privo di riferimenti contestuali, senza processualità né dina- miche relazionali.
Ed invece lo scenario della contemporaneità con le sue miscele di trasversalità e di deterritorializzazione, di “spae- samenti” e di localismi esasperati richiede un profondo cam- biamento nello studio e nelle politiche dei rapporti intercul- turali: se intendiamo svolgere un ruolo propositivo e attivo in un mondo transnazionale, popolato da culture sempre meno dipendenti da modelli culturali ed educativi unitari e coesi, dobbiamo elaborare nuovi strumenti per rivolgerci ai nuovi vissuti collettivi, articolati e complessi, commistioni dinami- che di realtà e fantasia.
Ogni qualvolta che ci si avvicini ad esaminare o a gestire l’incontro con una cultura diversa si dovrebbe rifiutare l’i- dea di trovarsi di fronte ad una totalità culturale elaborata
35

Matilde Callari Galli
localmente e costituita da un coeso sistema di pratiche ri- petitive ed autoriproducentesi, mai sfiorato da influenze e attrazioni esterne.
Se parto da questa idea di cultura coesa, prodotta unita- riamente in un determinato territorio, il problema di come accogliere il gruppo di immigrati che preme lungo le coste del nostro mar Adriatico consiste soprattutto nel valutare co- me il loro arrivo cambierà la nostra cultura e come l’incontro con noi muterà la loro: in quest’ottica la politica verso gli im- migrati deve essere tutta rivolta a mantenere un ordine cul- turale ipotizzato più che contestualizzato ed individuato.
Quale cultura siamo pronti ad elargire loro? Quali fra i molti aspetti che compongono il nostro milieu culturale sia- mo disposti a mostrar loro e a rendere loro accessibili? Qua- le è la cultura dei kosovari in fuga, quale quella degli albanesi e quale quella dei curdi e dei magrebini e degli iraniani riu- niti sui “motoscafi della disperazione” da eventi diversi, da occasioni tutte drammatiche ma determinate più dalla ca- sualità cha da un piano prestabilito? Quanti di essi condivi- dono, al momento del loro arrivo, tradizioni avite o invece non sono già partecipi di una cultura “interstiziale” e carica di contaminazioni e meticciati? Quanto l’abbandono di que- ste aspirazioni verso una cultura nuova, comunque “altra” da quella da cui fuggono, non sarà determinato proprio dal- la insistenza da noi formulata e modulata in mille modi sulla “differenza”? Per quanto essa possa inizialmente ammantarsi di tolleranza e di accettazione, inevitabilmente carica di di- stanza e di diffidenza l’incontro, risveglia richiami di un pas- sato che la durezza delle nuove condizioni di vita e di lavoro potrà far apparire degno di rimpianto.
In effetti questa visione dei contatti culturali postula la possibilità di separare con un taglio netto gruppi e prodotti culturali, cancellare dalle nostre analisi – e dai nostri inter- venti – le relazioni, i richiami le risonanze che costituiscono la realtà ibrida delle pratiche sociali. Ed oggi il nuovo uni- verso della comunicazione ha fatto emergere con grande evidenza le continue mediazioni, gli intrecci degli scambi, gli
36

I nomadismi della contemporaneità
andirivieni dei prestiti che costituiscono la vera e multiforme realtà della produzione culturale.
Solo riconoscere che oggi il mondo è interconnesso ed in- terdipendente , ci permette di individuare i limiti di gran parte delle politiche immigratorie che con le loro separa- zioni, con le loro distinzioni, nei loro aspetti più estremi possono esser lette ed interpretate come un potente mezzo per mantenere gli equilibri di potere esclusivamente in fa- vore di un “noi” che rischia di essere sempre più assediato, isolato e lontano dalla realtà.
Inoltre a legare ed ancorare la cultura ad un determinato spazio si aprono una serie di interrogativi di carattere gene- rale ai quali mi sembra che sia sempre più urgente cercare di dare una risposta.
Quale cultura per i molti individui che abitano tutti i con- fini di tutti gli stati nazionali del mondo? E quale cultura per i milioni di individui che dall’inizio del XX secolo hanno ab- bandonato i loro spazi in seguito all’emigrazione, alla de- portazione, alla fuga da sistemi violenti e repressivi o dalla furia delle guerre? A qual punto della sua storia un gruppo può esser definito “subcultura”? E questa definizione è com- prensiva di tutti i suoi aspetti, di tutti i suoi caratteri o solo di alcuni? E cosa dire della sostenibilità di questo concetto quando ci troviamo di fronte ad alcune subculture che in se- guito alla fine del coloniasmo politico sono divenute culture dominante rispetto all’organizzazione territoriale e istituzio- nale ma non rispetto al loro potere economico?
Aprendo il tradizionale concetto di cultura a queste pro- blematiche si affermano oggi le analisi che si interrogano sui nuovi aspetti che assumono il cambiamento sociale e le trasformazioni culturali che avvengono non più in spazi di- sgiunti ma in spazi interconnessi. “È la riterritorializzazione dello spazio – scrivono Akil Gupta e James Ferguson – che ci obbliga a riconcettualizzare, sin dalle loro fondamenta, le politiche delle comunità, della solidarietà e della differenza culturale” (Gupta, Ferguson 1997: 37).
All’analisi del rapporto tra una cultura che eleva l’altro allo stato del sè o che abbassa il sè alla dignità dell’altro, si sosti-
37

Matilde Callari Galli
tuisce un’analisi della cultura vista come luogo di differenzia- zioni e contaminazioni, con un dilagare di discriminazioni,
con l’affermarsi di omologazioni, con l’insorgere di nuove dif- ferenze che raggiungono ritmi mai sperimentati prima d’ora.
In questa prospettiva una pratica antropologica che voglia assumere all’interno dei suoi apparati teorici e delle sue pra- tiche metodologiche le nuove interdipendenze che caratte- rizzano l’attuale “commercio tra culture”, che non voglia ignorare le frammentazioni e le fratture violente che si inse- guono senza sosta nell’attuale organizzazione spazio tempo- rale, dovrebbe con decisione abbandonare i suoi tradiziona- li percorsi, porre al centro della sua riflessione i nuovi me- ticciati, le nuove contaminazioni culturali, scegliere come luogo privilegiato di attenzione le aree di confine, le aree in- certe di nomadismo contemporaneo, rifiutando la centra- lità che la modernit à affidava ad un’unica cultura, ad un
unico dominio.E forse trovare dei luoghi “labili”, fra i popoli della dia-
spora, dell’esilio, delle migrazioni i suoi nuovi pensieri, le sue nuove parole.
3.5. I nomadismi turistici
Sinora ho parlato dell’ansia di andare, di essere scacciati, di es- sere in pericolo, di arrivare e ricordare, di dimenticare e cam- biare. Ho considerato luoghi e tempi, immaginari vasti quan- to il mondo e accettazioni della materialità dura e dolorosa del percorso, di nomadismi reali e di nomadismi virtuali fatti nel- l’angolo di mondo che chiamo mio appartamento.
Potrei aprire il mio intervento a molti altri esempi, ren- dendo il quadro meno sommario, più complesso. Fra tutte le possibilità scelgo, in questa parte conclusiva, di accennare ad una forma di nomadismo che vorrei definire “liminale”, “di soglia”: e tratterò del turismo, vale a dire di quegli sposta- menti nello spazio che sono temporanei, a volte saltuari, a volte ciclici, legati, almeno apparentemente, alla scelta, al desiderio e che sembrano poter essere, per la loro apparente futilità, anche dimenticati. E che invece assumono – per il
38

I nomadismi della contemporaneità
numero di persone che coinvolgono, per le connessioni con settori assai rilevanti della società contemporanea – sempre maggior rilievo sia dal punto di vista dell’analisi culturale che dal punto di vista dei cambiamenti che introducono nel pa- norama mondiale.
3.5.1. Turismo ed analisi culturale della contemporaneità
Il turismo rappresenta – ad un livello pratico e teorico – il convivere di molti aspetti contraddittori propri della nostra contemporaneità: è un’esperienza effimera ed aleatoria ma al tempo stesso ripetuta più e più volte nello spazio di un anno e di una vita: così tanto occupa gli spazi e i tempi sia del mondo del benessere che del mondo della privazione, così profondamente entra nelle abitudini diffuse tra centinaia di milioni di individui da poter essere considerato un elemento permanente della società attuale nonostante che si svolga con ritmi sempre più brevi e temporanei; avvicina ma al tempo stesso contrappone gruppi umani profondamente di- versi; sottolinea la falsità della sua esperienza ma al tempo stesso ricerca quasi nevroticamente autenticità e tenuità; per molti aspetti è un’esperienza solitaria e individuale che al tempo stesso coinvolge negli stessi spazi e negli stessi tempi moltitudini tra loro ignote.
Da qualche decennio ormai le scienze umane hanno ri- volto la loro attenzione all’analisi del fenomeno turistico: divenuto una delle maggiori “industrie” del mondo ha rive- lato le sue implicazioni molteplici e differenziate che sempre più dimostrano legami profondi con gli apparati culturali del contatto fra gruppi diversi per storia, tradizioni, lingue, stili di vita e visioni del mondo. E sempre di più appare profonda la relazione che lega le aspettative e le ripulse del- le comunità coinvolte nel fenomeno turistico – quella che ac- coglie e quella che visita – ai problemi centrali nella rifles- sione antropologica contemporanea: innanzi tutto al con- cetto di cultura con i suoi corollari di eredità e di autenticità culturale, profondamente mutato da una realtà in cui de- territorializzazione e localismo si susseguono e si alternano
39

Matilde Callari Galli
senza posa. E legato inoltre ai processi identitari che perdo- no il loro carattere unitario invasi da un susseguirsi costante di identificazioni superficiali e labili; ed infine alla circolarità dei rapporti che legano “centro” e “periferie” in uno scam- bio di elementi culturali globale ma allo stesso tempo dotato di un alto gradiente di differenziazione e di disuguaglianza (Callari Galli, Ceruti, Pievani 1998).
Nell’ambito degli studi sul turismo, il dibattito si focalizza sugli effetti che le diverse forme di turismo hanno sia sulle co- munità/luoghi di attrazione turistica sia sulle comunità/luoghi da cui muovono i turisti. Il turismo, così come è stato prati- cato nella maggior parte delle regioni del mondo, e come continua ancora ad essere praticato, introduce violenti cam- biamenti nella vita dei paesi che ospitano, spesso travolge i loro costumi, i loro valori etici e religiosi, il loro ambiente ecologico, i loro insediamenti urbani.
Tanto più il turismo contemporaneo coinvolge aree carat- terizzate da differenziali di potere nei loro aspetti economici, politici e sociali, tanto più sembra balzare in primo piano la carica predatoria che anima – oggi come ieri –il rapporto tra le diversità gestito dai “grandi della terra”.
Per rispettare tuttavia lo schema della complessità che ho posto sin dall’inizio a base di questo intervento, va subito ag- giunto che anche le comunità di origine dei turisti sono mu- tate, sia pure ad un livello più superficiale, per la ricerca “eso- tica”che travalica il breve – e comunque limitato – arco di tempo del soggiorno e prosegue immettendo nelle nostre città abitudini alimentari, oggetti, vestiti, cerimonie e feste “altre da noi”, che saldandosi con altri rapporti interculturali – alcuni dei quali ben più radicati e drammatici – hanno profonda- mente stravolto i nostri gusti e lo stesso nostro rapporto con l’alterità (Abram, Waldren, McLeod 1997).
3.5.2. Leggere il turismo contemporaneo
Se si accetta questo “commistione” continua del fenomeno turistico, è difficile applicare al suo interno separazioni e distinzioni nette, dividendo con taglio il “turista” dal “non
40

I nomadismi della contemporaneità
turista”, il turista stagionale da quello estemporaneo. La stessa distinzione introdotta molti anni fa da Smith (1989 [1978]) tra “turista” ed “ospite” appare oggi inadeguata e impedendo molte ulteriori suddivisioni si dimostra poco uti- le per un’analisi antropologica accurata. Ad esempio, nu- merosi autori con le loro ricerche hanno dimostrato che lo stesso termine “paese ospite” in realtà unisca persone che con il turista hanno rapporti profondamente differenziati, comprendendo individui che traggono benefici dal turismo, altri che lavorano in strutture adibite all’accoglienza, altri che con i turisti hanno rapporti occasionali e sporadici e altri ancora che ignorano la presenza dei turisti nel loro paese (Harrison 1992).
Del resto le difficoltà che incontriamo ad identificare una “comunità ospitante” ricalcano in gran parte le difficoltà che incontriamo oggi a definire con chiarezza una comu- nità, ad individuare i suoi confini, a descrivere le sue carat- teristiche, a stabilire la sua aderenza ad un determinato ter- ritorio. Il lungo dibattito che ha opposto negli anni ’80 nu- merosi antropologi affannati ad identificare o a negare la possibilità di individuare i confini simbolici di una comunità (Cohen 1985) sembra oggi essersi risolto abbandonando i modi tradizionali di considerare la presenza di una comunità nel territorio, cessando di considerarla una entità ma cer- cando invece – come è avvenuto per il concetto di cultura – di valorizzare le sue forme espressive e le sue relazioni.
Molte, dunque, sono le difficoltà che incontriamo nel dise- gnare una tipologia delle diverse forme di turismo presenti oggi nel mondo: ci troviamo di fronte ad una massa di indi- vidui – centinaia di milioni – che ogni anno, per periodi di tempo variabili, con modalità diverse si allontanano dalle proprie case per visitare regioni dai caratteri alquanto dispa- rati: partono da luoghi diversi e raggiungono luoghi diversi, avendo scopi diversi. Anche ciò che sembrerebbe unificarli – il viaggiare – se esaminato nella sua radicalità li accomuna ad altri milioni di individui, sino a coinvolgere l’intera nostra specie che lungo il suo percorso evolutivo ha scelto, per la maggioranza del tempo, il nomadismo e non la sedentarietà.
41

Matilde Callari Galli
Ed allora, invece di inseguire le macrodistinzioni presenti nella letteratura per distinguere le diverse forme del turismo (Smith 1989; Smith e Eadington 1992; Graburn 1995) e che mio avviso sono deboli per l’eccessivo livello di generalizza- zione che contengono e per la loro provvisorietà, preferisco esporre caratteri , potenzialità, rischi dell’applicazione al fe- nomeno turistico del concetto di cultura.
3.5.2.1. Turismo ed eredità storico-culturale
Il turismo a causa dei potenti interessi economici che è in grado di convogliare sui suoi progetti riesce anche ad in- fluenzare, e talvolta addirittura a determinare, la percezione che una comunità ha della sua eredità culturale: indicare un tratto culturale, un oggetto, un monumento o un’idea come parte dell’eredità di un gruppo, attribuirli ad una determi- nata epoca, significa partecipare alla costruzione sociale del suo passato, significa illuminare un universo simbolico, oscu- randone inevitabilmente altri: dando un determinato ordine al passato, in realtà si prefigura l’ordine del presente. Eser- citare il controllo del passato significa svolgere importanti ruoli nei processi identitari: così scegliendo una determinata versione di un evento storico si legittimano relazioni sociali che travalicano l’ambito delle relazioni quotidiane al cui or- dine sembrano appartenere le relazioni turistiche svolgono importanti funzioni nei processi politici, nella suddivisione del potere fra i diversi gruppi che costituiscono la comunità.
Una buona esemplificazione di questo processo ci è forni-to dalle ricerche che John Allcock ha svolto in Macedonia e in Croazia (Allcock 1995).
Nel primo caso la scelta di presentare ai turisti i resti di al- cuni edifici sacri attribuendoli alla fede e alla ritualità cri- stiana tacendo che per secoli essi erano divenuti luoghi di culto islamici ha un alto significato simbolico ed assume for- ti valenze identitarie e politiche: è infatti un’aperta rivendi- cazione dell’antichità e della continuità dell’eredità cristiana in una regione in cui esistono tensioni con i gruppi musul- mani di origine albanese, è un’affermazione, indiretta ma
42

I nomadismi della contemporaneità
molto esplicita, dell’estraneità, rispetto l’attuale identità del- la “nazione” macedone, dei “cinque secoli della notte turca”.
Nel secondo caso Allcock presenta la “costruzione” di un folklore nazionale croato, elaborato per fini turistici ma che in realtà ha avuto l’obiettivo di dimostrare l’esistenza di una eredità culturale, antica e coerente, che attribuisca unità ad una regione storicamente attraversata per secoli da popoli di- versi e dominata da stati politicamente e culturalmente assaidifferenziati.
Ambedue i “casi” esaminati da Allcock sono strettamente collegati allo sforzo delle autorità macedoni e croate di dare legittimità alle politiche dei nuovi stati che si sono costituiti dopo la fine della federazione iugoslava. Non è molto rile- vante che in un caso si sia operato su un sito storico-archeo- logico e nell’altro su produzioni di beni materiali ed immate- riali, quali prodotti artigianali, motivi musicali, letteratura orale, ricostruzione di danze e cerimonie. Quello che in que- sta sede è rilevante notare è il ruolo privilegiato che l’orga- nizzazione del turismo, dovrei dire la struttura del turismo, è in grado di svolgere in questi complessi processi: da un lato nella comunicazione turistica processi ideologici, quali la creazione di una determinata eredità storica o l’”invenzione” di “radici” identitarie comuni a gruppi oggi diversi sotto molti aspetti, trovano possibili forme di espressione e di vali- dità: la presentazione di un monumento, di un sito archeolo- gico, di una celebrazione cerimoniale, di un prodott o artigia- nale, nelle parole delle guide, nelle descrizioni dei “tour ope- rators” e dei depliants turistici assume valore di verità storica, diviene nota, accettata e diffusa tanto tra i turisti quanto tra gli abitanti delle località interessate. Dall’altro lato le espres- sioni usate per questa divulgazione si servono di una retorica ad alto valore divulgativo ma che generalmente sfugge al va- glio e all’analisi critica delle fonti e quindi della realtà storica. Sulle nuove verità, sui valori simbolici che così assumono oggetti e luoghi, sulle nuove memorie rappresentate per i tu- risti, si articolano nuovi processi identitari, si sviluppano nuo- ve appartenenze, si riformulano alleanze e affinità.
43

Matilde Callari Galli
Inoltre le dimensioni del fenomeno turistico nella contem- poraneità, il suo spandersi nei diversi continenti, il suo pene- trare in gruppi e classi sociali profondamente diverse, le sue dinamiche che rendono difficile distinguere tra “consumato- ri” e “produttori ” del fenomeno, non ci consentono più di considerarlo un processo di comunicazione che si svolge tra culture diverse, separate da confini netti ed individuabili: in realtà produzione turistica e consumo di luoghi, di incontri, di merci, fanno parte di un medesimo processo. Così l’eredità del passato presentata al turista si riverbera e agisce nella de- terminazione dei processi identitari di chi ha costruito ad uso turistico questa eredità, trasforma il suo territorio, i suoi segni e i suoi prodott i ma modella anche la percezione che delle identità e della storia hanno i visitatori di quel paese.
Il richiamo al concetto di cultura elaborato dalla ricerca antropologica mi sembra evidente: la cultura considerata un ventaglio di possibilità tra le quali il gruppo sceglie quali usare e quali scartare nel continuo processodi strutturare e ristrutturar e il suo presente e il suo passato, la cultura che in questa sua “operazionalità” coinvolge e attraversa settori dalla lunga tradizione, elementi nuovi e tratti apparente- mente marginali.
3.5.2.2. Studi turistici a livello universitario
Le categorie antropologiche divengono così utili sia se si voglia interpretare un’attività complessa e articolata quale il turismo contemporaneo sia se, per sottrarlo all’improvvisazione e alla casualità, si vogliano progettare corsi di studi che preparino esperti per la sua gestione e per la sua programmazione.
I riferimenti alle discipline antropologiche e l’accento su un turismo attento alle implicazioni culturali caratterizza due corsi di studio che da qualche tempo coordino, per l’U- niversità di Bologna, sul tema del turismo: il primo è un corso di Master sullo “Sviluppo turistico” attivato in Cam- bogia, il secondo un corso di specializzazione post-laurea in “Turismo culturale” attivo nell’area adriatica, in partico- lare in quella che comprend e la rete universitaria Uniadrion.
44

I nomadismi della contemporaneità
Più che addentrarmi nella descrizione particolareggiata de- gli impianti dei due corsi, cercherò ora sinteticamente di pre-
sentare più che le loro specificità i caratteri che li accomunano. Si rivolgono ambedue a studenti che hanno
conseguito al- meno un primo livello di laurea; hanno previsto, per l’am- missione ai corsi, una selezione basata
sia sui percorsi di studio e di lavoro compiuti , sia su una serie di prove; ambe- due hanno l’obiettivo di formare
esperti in pianificazione e programmazione delle attività turistiche affiancando, du- rante gli anni di corso, attività
didattiche e di ricerca; anche se in misura differente, ambedue sfruttano i collegamenti via informatica; la
durata di quello svolto in Cambogia è dicinque semestri, di quello rivolto all’area adriatica di otto.
Si basano su una collaborazione fra regioni diverse e uni- versità appartenenti a paesi diversi: l’uno coinvolge oltre l’U- niversità di Bologna, la Royal University of Phnom Penh e l’University of Technology of Sydney, il secondo oltre l’Uni- versità di Bologna, le Università degli Stati che affacciandosi sul mar Adriatico partecipano della rete Uniadrion (Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania). Le aree disciplinari coinvol- te nei programmi di insegnamento e di ricerca sono oltre quelle antropologiche, quelle sociologiche, economiche, geo- grafiche, linguistiche, della comunicazione, con riferimenti giuridici ed informatici. L’analisi culturale, sia dei flussi turi- stici che delle potenzialità presenti nelle diverse località in un certo senso riunisce ed unifica i contributi delle singole di- scipline che dai loro specifici punti di vista mettono a fuoco i vantaggi ma anche i rischi dello sviluppo turistico, partico- larmente quando si svolge in aree che per lungo tempo sono state sottratte ad esso e che al tempo stesso sono state recen- temente teatro di conflitti aspri e dolorosi. Le domande a cui si cerca di rispondere, con questi studi e con queste ri- cerche, sono complesse e più che soluzioni ci aspettiamo, dalla collaborazione tra docenti e studenti appartenenti a tradizioni tante diverse, spunti, suggerimenti, percorsi.
Quali caratteri possono assumere i rischi della distruzione e dell’inquinamento dell’ambiente, della lacerazione dei rap- porti sociali e del travisamento delle culture tradizionali ge-

45

Matilde Callari Galli
neralmente connessi con il turismo di massa, in aree, quali quelle oggetto dei due corsi, che tentano di ricostruire pae- saggi e città, relazioni sociali e ritmi di vita profondamente turbati da eventi diversi ma in tutti i casi drammatici e profondamente incisi nella memoria e nel territorio? In che modo può un turismo culturale e sostenibile partecipare po- sitivamente a questa “ricostruzione”? In che modo l’incontro e lo sguardo turistico possono contribuire alla creazione di luoghi/modi in cui si sfugga tanto alla rivendicazione locali- stica ed esasperata dell’orgoglio regionalista quanto al vuoto cosmopolitismo di un’“autenticità” teatrale, rappresentata per i turisti ai fini di un guadagno facile ed immediato?
Il turismo culturale non è una panacea che possa risolvere tutti i problemi ma soprattutto non può essere visto come un nuovo modo per attrarre un maggior numero di turisti e una maggiore quantità di denaro. Potrebbe invece essere un’opportunità per conoscere con più accuratezza il mondo in cui viviamo, per sviluppare le nostre sensibilità, per far parlare le nostre emozioni; dovrebbe poter migliorare la qualità della vita delle comunità coinvolte – ospitanti ed ospitate – rendendole più consapevoli dell’importanza di viaggiare e di accogliere, di saper apprezzare il paesaggio, gli incontri, le nuove esperienze.
Lo sviluppo del turismo culturale potrebbe divenire un’op- portunità per valorizzare il nostro passato, la nostra storia, la nostra eredità ma al tempo stesso un modo per poter parte- cipare ad una cultura in grado di uscire da sé stessa per co- municare con le molte diversità che oggi percorrono – a li- vello reale e/o virtuale – il mondo. Da un lato, sottolineando le caratteristiche e le possibilità del turismo culturale, ogni comunità è sollecitata e spinta a conservare e valorizzare i propri “beni culturali”; dall’altro ogni programmazione e ogni gestione del turismo deve prestare grande attenzione agli orientamenti generali di una cultura mondiale che ogni giorno, con i suoi spostamenti, con i suoi nomadismi, au- menta il suo livello di interdipendenza e di globalità. Tra queste due tensioni va svolta, a livello di ricerca, di didattica e di politica culturale, una continua opera di mediazione af-
46

I nomadismi della contemporaneità
finché l’accresciuta visibilità delle comunità locali e delle lo- ro potenzialità produca nuovi processi identitari, svincolati dalle pesanti ipoteche del passato e dai condizionamenti del presente ma aperti al dialogo, all’incontro con le molte dif- ferenze che oggi percorrono il nostro pianeta.
Bibliografia:
Abram S., Waldren J., Macleod D.V., (a cura di), 1997. Tourists and Tourism, Berg, New York.
Al-Ali N., Koser K., 2002. Transnationalism, international migra- tion and home, in Al-Ali N., Koser K., (a cura di), New approach to migrations?, Routledge, London.
Allcock J. B., 1995. International tourism and the appropriatio n of history in the Balkans, in Lanfant M. F., Allcock J. B., Bruner E. M., (a cura di), International tourism: identity and change, Sage, London.
Ahmad, 1995. “The politics of literary postcoloniality”, in Race andClass, 36/3, pp. 1-20.
Amselle J.L., 1990. Logique métisse, Payot, Paris (tr. it.: Logiche meticce, Bollati Boringhieri, Torino, 1999.
Appadurai A., 1992. “Global ethnoscapes: notes and queries for a transnationalanthropology”, in Fox R. (a cura di), Recapturing anthropology: working in the present, School of American Re- search, Santa Fe.
Appadurai A., 1996. “Disgiunzione e differenza nell’economia culturale globale”, in FeatherstoneM. (a cura di) Cultura globale, SEAM, Milano.
Appadurai A., 2000. Modernità in polvere, Meltemi, Roma. Augè M., 1993. Nonluoghi, Elèuthera, Milano.Augé M., 1998. La guerra dei sogni, Elèuthera, Milano.Barber B., 1998. Guerra santa contro Mc mondo, Nuova Pratiche
Editrice, Milano.Bhabha H., 1994. The location of culture, Routledge, London. Bhabha H. (a cura), 1997. Nazione e narrazione, Meltemi, Roma. Callari Galli M., 1995. “Orientamenti antropologici per la cultura
contemporanea”, in Pluriverso, n. 1.Callari Galli M., 1996. Lo spazio dell’incontro, Meltemi, Roma.
47

Matilde Callari Galli
Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, Bruno Monda- dori, Milano.
Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T., 1998. Pensare la diversità,Meltemi, Roma.
Callari Galli M., 2001. “Dal casco coloniale al videotape. Antro- pologia culturale e turismo nella società contemporanea”, in Africa e Orienti, n. 3/4, 2001.
Callari Galli M., Riccio B., (a cura), 2001. Dossier: Sguardi antro- pologici sul turismo, in Africa e Orienti, n. 3/4, 2001.
Callari Galli M., Cambi F., Ceruti M., 2003. Formare alla com- plessità, Carocci, Roma.
Campani G., “Migrants and media: the Italian case”, in King R., Wood N., (a cura di), Media and Migration, Routledge, London.
Canclini N. G., 1998 [1989]. Culture ibride, Guerini, Milano. Cavarero, 2001. “Il locale assoluto”, in MicroMega, n. 5.Clifford J., 1994. “Diasporas”, in Cultural Anthropology, n. 9 (3). Clifford J., 1999. Strade. Viaggio e tradizione alla fine del secolo XX ,
Bollati Boringhieri, Torino.Cohen R., 1992. “The Diaspora of a diaspora. the case of the Ca-
ribbean”, in Social Sciente Information, n. 31.Foucault M., 1994. “Eterotopie”. Eterotopie, luoghi e non-luoghi
metropolitani, in Millepiani, Mimesis, Milano.Giddens A., 2000. Il mondo che cambia, Il Mulino, Bologna. Graburn N., 1995. “The past in the present in Japan: nostalgia and
neotraditionalism in contemporary Japanese domestic tourism”, in Butler R., Pearce D., (a cura di), Change in tourism: people, places, processes, Routledge, London.
Grillo R., (a cura di), 1980. “Nation” and “State” in Europe: Anth- ropological Perspectives, Academic Press, London.
Grillo R., 1998. Pluralism and the Politics of Difference: State, Cul- ture and Ethnicity in Comparative Perspective, Clarendon Press, Oxford.
Grillo R. D., Riccio B., Salih R., 2000. Here or There? Contrasting Experiences of Transnationalism: Moroccan and Senegalese in Italy, CDE/Sussex University Working Paper, Brigton.
Grillo R. D., Pratt J., (a cura di), 2002. The Politics of Recognizing Difference. Multiculturalism Italian Style, Ashgate, Basingstoke.
Guerzoni G., 2001. “Multispaces: il turismo culturale tra eredità culturale e formazione. Il caso della Bulgaria”, in Africa e Orien-ti, n. 3/4.

48

I nomadismi della contemporaneità
Haller D., 2000. Gelebte Grenze Gibraltar – Transnationalismus, Lokalitat, und Identitat in kulturanthropologischer Perspektive, Deutscher Universitatverlag, Wiesbaden.
Harrison D., (a cura di), 1992. Tourism in the less developed coun- tries, Belhaven, London.
Harrison G., Callari Galli M., 1971. Né leggere né scrivere, Feltri- nelli, Milano.
Hughes R., 1990. La riva fatale, Adelphi, Milano.Inda J. X., Rosaldo R., 2002. The Anthropology of globalization,
Blackwell, London.Leirs M., 1992. Zébrage, Gallimard, Paris.Lewis O., 1973. La cultura della povertà e altri saggi di antropologia,
Il Mulino, Bologna.Koser K., 2002. “From refugees to transnational communities?” , in
Al-Ali N. A., Koser K., (a cura di), New approach to migrations?, Routledge, London.
Mai N., 2001. “Italy is beautiful”: the role of Italian television in Albanian migration to Italy, in King R., Wood N., (a cura di), Media and Migration, Routledge, London.
Malkki L. H., 1997. “National Geographic: The rooting of peoples and the territorialization of national identità among scholars and refugees”, in, Gupta A., Ferguson J., (a cura di), Culture, Power, Place, Duke University Press, Durham.
Martelli F., 1998. Capire l’Albania, Il Mulino, Bologna.Pandolfi M., 2000. “L’industrie humanitaire: une souveraineté
mouvante et supra-Coloniale. Reflèxion sur l’expèrience des Balkans”, Multitudes, Autom.
Pandolfi M., 2002. “Moral Entrepreneurs”, souverainetés et bar- beles. Le bio-politique dans les Balkans postcommunistes, in Pandolfi M., Abélès M., (a cura di), Politiques jeux d’espaces, numero speciale di Anthropologie et Societé, vol. 26, n. 1.
Povrzanovic Frykman M., 2002. “Homeland lost and gained. Croatian diaspora and refugees in Sweden”, in Al-Ali N. A, Ko- ser K., (a cura di), New Approach to Migrations?, Routledge, London.
Riccio B., 2000. “The Italian construction of immigration: seden- tarist and corporatist narratives facing transnational migration in Emilia-Romagna, in Greverus I. M., Romhild R., Welz G. (a cura di), The Mediterraneans. Transborder movements and dia- sporas. Anthropological Journal of European Cultures, vol. 9, n. 2.
Robertson R., 1999. Globalizzazione, Asterios, Trieste.
49

Matilde Callari Galli
Safran W., 1991. “Diasporas in modern societies. Myths of ho- meland and return”, in Diaspora, n.1.
Sen A., 1994. “Population, Delusion and Reality”, in New York Re- view of Books, 22 September, 1994, pp. 62/71.
Smith V., 1989. Hosts and Guests: the Anthropology of Tourism, University of Pennsylvania Press, Philadekphia, (Blackell, Oxford, 1978).
Smith V., Eadington W. R., (a cura di), 1992. Tourism Alternatives, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
Tomlinson J., 2001. Sentirsi a casa nel mondo, Feltrinelli, Milano. Wood N., King R., “Media and Migration. An Overview”, in King
R., Wood N., (a cura di), 2001. Media and Migration, Routledge,London.
Zolberg A. R., Benda P. M., (a cura di), 2001. Global Migrants, Global Refugees, Berghahn Books, New York.
50

A VOLTE RITORNANOFantasma e nomadismi nippo-occidentali
di Luigi Urru


L’uomo che si definisse in congruenza a una patria sarebbe un animale che ha fatto propriala prerogativa vegetale di mettere radici.
Peter Sloterdijk
È stato Walter Benjamin a darci una delle allegorie più po- tenti dell’esperienza della modernità. In un famoso saggio egli interpreta il quadro Angelus Novus di Paul Klee come ri- tratto dell’“angelo della storia”:
Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’an- gelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso ri- volto verso il passato. Dove ci appare una catena di even- ti, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben tratte- nersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tem- pesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tem- pesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui nel cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta. [1962: 80].
Due sono pertanto, secondo Benjamin, i tratti salienti del- la modernità/progesso . In primo luogo, la devastazione “sen- za tregua” che distingue il suo passaggio, e che il desiderio di “ricomporre l’infranto” da parte di quella figura angelica che è la storia non mitiga minimamente. In secondo luogo, il moto impetuoso e irresistibile verso un futuro tanto oscuro quanto lo è l’esperienza che ne è concessa: à rebours, di spal- le. Una esperienza, questa, fattibile solo post quem, dopo cioè che la devastazione ha avuto luogo. È dunque un movi- mento inarrestabile, cieco e travolgente a costituire per Benjamin la caratteristica saliente dei tempi moderni: e uno sguardo alla situazione del mondo contemporaneo – in par-
53

Luigi Urru
te ancora impelagato nel progetto della modernità – sembra, almeno provvisoriamente, dargli ragione. La modernità (ma sarebbe meglio dire le modernità, poiché non si tratta di un prodotto esclusivo dell’Occidente) ha fatto tabula rasa di ciò che ha incontrato sul proprio cammino. Una visione apocalittica senza dubbio, questa che Benjamin ci conse- gna. E qui s’intenda doppiamente il termine. L’evidenza fi- lologica afferma che la parola apocalisse non significa altro che “rivelazione”. Benjamin ha appunto la franchezza di ri- velare il lato sconvolgente della modernità. Anche in questo breve testo egli non smentisce la sua migliore caratteristica di “sfaldatore di drappi”; se essere moderni significa supporci in una condizione che promette successo, felicità, avventura, potere, sviluppo e trasformazione dell’individuo e della so- cietà, Benjamin squarcia questo velo immaginifico e in poche righe ci mostra la nudità del re:
la modernità indagata nei suoi “cascami” rivelatori, e solo in apparenza insignificanti, […] sospinge [Benjamin] a coglier[n]e e a svelar[n]e i “sogni”, i suoi miti più o meno segreti, le sue “immagini” nascostamente depositate e pur tuttavia documentabili negli stili e nei luoghi del suo “abi- tare”. (Remotti 1996: 140).
Apocalisse infatti, così vogliono l’accezione corrente e il di- zionario – siamo al secondo significato del termine – vuole anche dire “catastrofe”, “capovolgimento”, “fine traumatica dei tempi”. Sotto il drappo della modernità squarciato dal critico tedesco – lo svelamento dell’incantesimo – stanno appunto le rovine che essa stessa produce.
Questo mondo infranto, reduce, simultaneamente disin- cantato, spaesato e liberato nella constatazione della perdita, costituisce la materia del presente scritto, in una prospettiva, tuttavia, che non intende rendersi debitrice verso Benjamin e la malinconica irreparabilità sottesa alle sue affermazioni oltre ciò che impone lo spunto d’avvio. La prospettiva che si avan- za qui mira piuttosto a dare liceità vitale e feconda a quei frammenti, analizzando alcune peculiari, forse effimere con- figurazioni che essi assumono nella contemporaneità. Non si
54

Alle volte ritornano
tratterà di una esposizione sistematica e gli esempi verranno scelti, con una disinvoltura che si spera non risulti fastidiosa, attingendo a un panorama culturale geograficamente molto lontano dell’Europa, quello delle odierne metropoli giappo- nesi, a cominciare da Tokyo, dove ho avuto modo di sog- giornare a più riprese nel corso degli anni 2002 e 2003.
Attraverso un esame del perdurante gioco dei reciproci esotismi tra il Giappone e l’Occidente, e con una particolare attenzione ai fenomeni della cultura di massa in contesto urbano, nelle pagine che seguono si sosterrà la tesi secondo cui l’avvento di una modernità planetaria ha indotto uno spaesamento di duplice natura. Si mostrerà quindi come es- so non solo induca forme di disagio per un passato perduto (e ora mitizzato in nostalgici recuperi), quanto piuttosto sti- moli creativamente inedite articolazioni identitarie indivi- duali e collettive.
In primo luogo, spaesati (alle volte svagatamente spaesati) sono gli attori sociali delle culture altre che hanno scelto o si sono visti imporre la modernità per le proprie pratiche e i propri sistemi simbolici; essi sempre più partecipano a una condizione di ibridità processuale intrisa di nostalgia per un passato fantasmatico. Ecco quanto afferma Marilyn Ivy ri- guardo gli sconvolgimenti causati dall’avvento di una mo- dernità nipponica:
Nel momento in cui l’industria culturale cerca di persua- dere i giapponesi che ogni cosa è al propri o posto e nulla è andato perduto, sorge contemporaneament e il dubbio, espresso alle volte in modi oscuri, che questo lavoro di persuasione non sarebbe necessario se non ci fossero per- dite da lamentare. Ecco dunque i consumanti e consuma- bili piaceri della nostalgia, intesa come un ambiguo va- gheggiamento che cancella la differenza temporale tra sog- getto e oggetto del desiderio, e partecipa non solo dell’im- possibilità ma anche della fondamentale mancanza di vo- lontà di recuperare ciò che si è perso. Poiché la perdita del- la nostalgia – e cioè la perdita del desiderio per ciò che non è più in quanto lo si è ritrovato – può essere più spiacevole della perdita originaria. (1995: 10. Enfasi originale).
55

Luigi Urru
Negli ambiti più diversi del Giappone odierno si osserva in effetti un ostinato richiamo alle origini e alla tradizione: nel- la celebrazione turistica di simboli nazionali e di luoghi di memoria storica, siano essi i palazzi dell’antica capitale Kyo- to o il cono innevato del monte Fuji; nell’interesse per gli studi etnologici e folcloristici che articolano i momenti di continuità di una identità nazionale oltre le scompostezze in- dotte dalla modernità; nelle campagne pubblicitarie che sfruttano e nutrono la nostalgia per i bei tempi andati e i suoi riti collettivi.
In secondo luogo, spaesato è lo stesso discorso antropolo- gico che, negli angoli di mondo attraverso i quali ha tradi- zionalmente plasmato la propria impresa conoscitiva, rin- viene una alterità edulcorata, sminuita, globalizzata e co- munque nutrita di immagini fantasmagoriche che si rifanno proprio a quell’Occidente che pensava di aver lasciato a ca- sa. Ciò costituirebbe per alcuni autori la morte della disci- plina, uscita dal proprio episteme e ormai priva di una seria ragion d’essere. E tuttavia, secondo Matilde Callari Galli, un elemento distintivo dell’antropologia è “l’attenzione alla va- riabilità, agli aspetti più ambigui del comportamento cultu- rale, alle zone più opache dei rapporti simbolici e della vita quotidiana” (1999: 127-8). L’antropologia trova la via entro il labirinto della contemporaneità se aderisce alla molteplicità delle pratiche quotidiane, alla banalità ordinaria di ciò che succede tutti i giorni a latitudini diverse, anche quando tutto questo ha perduto l’evidenza trasparente dell’alterità imme- diatamente percepibile. È ancora sempre nel quotidiano (in- triso di modernità o sopravvissutole), nei nonnulla che pas- sano invisibili e automatici, nelle apparenti banalità di ogni giorno, che organizziamo l’identità e la memoria, l’apparte- nenza e il disincanto, il locale e il globale. Ciò che l’indagine antropologica si trova oggi a indagare è così diventato un gioco di riflessi erratici, un nomadismo di rappresentazioni, desideri, nostalgie dell’identità e dell’alterità di volta in volta variamente addomesticati, incorporati e ricreati in contesti locali. È un apparire e svanire di “fantasmi”, nella forma di perdite, recuperi e simulazioni dalle traiettorie non facili ep-
56

Alle volte ritornano
pure efficaci nello sparigliare troppo immediate opposizioni dicotomiche tra il sé e l’altro, il qui e l’altrove, il tradizionale e il moderno, il reale e l’immaginario, l’originale e la copia, l’Oriente e l’Occidente. Le nozioni stesse di identità e alte- rità, che sino a oggi hanno fondato gran parte del discorso antropologico, mostrano la propria debolezza in un mondo dove la modernità, o i suoi frammenti, sono pressoché ubi- qui a tutto il pianeta. Come afferma Denise Brahimi in con- clusione al suo studio “sui paradossi del japonisme”:
La nozione di differenza è molto forte, ma essa non agisce nei confronti delle due entità occidentale e nipponica per- ché né l’una né l’altra sono identificabili con ciò che costi- tuirebbe la loro peculiare identità. Ciascuna è piuttosto composta da una interna varietà, e nell’una e nell’altra si ritrovano elementi di somiglianza dei quali non si può davvero affermare quanto siano occidentali o nipponici. (1992: 205-6. Enfasi originale).
1. I fantasmi e il lavoro dell’immaginazione
Approfittando dell’indeterminatezza che accompagna le ri- ghe appena citate, appare utile a questo punto elaborare la nozione di “fantasma” introdotta poco sopra: essa percor- rerà l’ordito di questo saggio in modi ricorrenti e impreve- dibili e si ispirerà nei suoi tratti fondamentali allo studio che le ha riservato Giorgio Agamben. Che avverte:
Noi moderni, forse per l’abitudine ad accentuare l’aspetto razionale e astratto dei processi conoscitivi, abbiamo ces- sato da un pezzo di stupirci del misterioso potere dell’im- magine interiore, di questo inquieto popolo di “meticci” (come lo chiamerà Freud) che anima i nostri sogni e do- mina la nostra veglia forse più di quanto siamo disposti ad ammettere. (1977: 90).
Il ricorso alla nozione di fantasma non si basa tuttavia esclusivamente sulla consapevolezza della parzialità alla qua- le si espone il pensiero razionale. Come si vedrà, il fantasma
57

Luigi Urru
è strategicamente pertinente all’analisi antropologica della contemporaneità perché, in modo simile a quello delle dot- trine platoniche, aristoteliche e medievali commentate dal fi- losofo italiano, “permette di dare ragione di tutta una serie di fenomeni altrimenti inspiegabili” (1977: 31). Il fantasma innanzi tutto evidenzia l’importanza, decisiva nel mondo contemporaneo, dei “traffici dell’incorporeo”: la circolazio- ne, cioè, di immaginari (spesso peraltro associati a specifici, materiali beni di consumo) che plasmano le nostre esperien- ze, emozioni, desideri. Esso poi contribuisce a definire con maggiore accuratezza la natura stessa di questi immaginari come forme fittizie (da intendersi etimologicamente dal lati- no facio) che partecipano di realtà e fantasia, che anzi co- struiscono il sé e l’altro mescolando realtà e fantasia, e costi- tuiscono serbatoi di risorse a cui attingere per l’azione, la de- finizione identitaria, l’acquisizione di status e di potere.
Proprio la flessibilità degli odierni traffici dell’incorporeo dà luogo al pieno dispiegamento delle potenzialità dell’immagi- nazione: a livello del singolo individuo che definisce la propria identità e attribuisce un senso all’esistenza che sta vivendo, e a livello collettivo nel processo di articolazione delle identità nazionali e sovranazionali. Non più oppio dei popoli, non fu- ga da una realtà regolata da più stringenti meccanismi mate- riali, neanche passatempo delle classi agiate dedite all’ozio né esercizio di intelletto poetico, l’immaginazione
è diventata un territorio organizzato di pratiche sociali, una forma di lavoro […] e di negoziazione tra attori socia- li (gli individui) e campi di possibilità definiti globalmente. […]. L’immaginazione è ormai essenziale per ogni forma di azione, è essa stessa un fatto sociale, una componente chia- ve del nuovo ordine della società. (Appadurai 1996: 31).
È dunque attraverso il lavoro dell’immaginazione che la contemporaneità occidentale e nipponica si popola di una ridda di reciproci fantasmi, le cui apparizioni assumono for- me tangibili (essenzialmente uomini e merci) oppure impal- pabili ma non meno durevoli (immagini, miti, canzoni, sogni, fantasie, capitali) le quali se da un lato rimandano ad alterità
58

Alle volte ritornano
lontane, perse o anelate, dall’altro compongono queste ulti- me entro scenari locali significativi e ineffabili. Significativi, perché gli individui vi articolano sensatamente le loro vite; ineffabili, perché anche una brillante analisi antropologica si trova impacciata ad articolare parole che esauriscano il mi- stero dell’alterità nel suo fascino e sconcerto.
“Il fantasma si pone […] sotto il segno del desiderio” scri- ve Agamben (1977: 86): dovrebbe essere assente e invece al- le volte ritorna; sospeso com’è tra presenza ed evanescenza, esso agisce da tramite verso un altrove e un altrimenti; la ra- pidità e l’imprevedibilità delle apparizioni, bilanciate dalla ri- correnza nello spazio e nel tempo, come anche l’agile mobi- lità che non incontra ostacoli fanno del fantasma un ele- mento trasversale per antonomasia, capace di camuffare la sua corporeità inconsistente sotto molteplici “lenzuola”. Il fantasma appare e agisce in modi diversi a seconda delle si- tuazioni e anzi ogni tentativo di descriverlo in termini di una forma compiuta che resiste al tempo è destinato a fallire; la sua stessa esistenza non è certificata: messa in dubbio da- gli scettici, esagerata nei suoi effetti imprevedibili da chi ne ha fatto esperienza, essa per lo più soggiace inconsapevol- mente alla ordinarietà delle abitudini e dei discorsi mediati- ci: fantasmi del passato nei cataloghi del Museo di Edo- Tokyo, fantasmi di sogni esotici negli alberghett i “tipici” (ryokan) della capitale frequentati da turisti occidentali in cerca del Giappone autentico, fantasmi di una comunità na- zionale nella contemplazione dei ciliegi in fiore (hanami) e di una comunità di quartiere nella nudità condivisa ai bagni pubblici (sentô), fantasmi di un altrove nelle code per ac- quistare al depâto (grande magazzino) i croissant al burro della parigina Maison Kayser.
Illusorio eppur potente, elastico, cedevole e tenace a un tempo, mediatore inaffidabile per definizione, il fantasma (o per essere più chiari: la nozione di fantasma) è utile nel dare risalto alla grana fine – fantasmatica, appunto – di un processo di globalizzazione da più parti invocato come tota- lizzante, irreversibile e definitorio di inizio millennio.
La visione del sistema globale che qui si propone non è
59

Luigi Urru
tuttavia quella univoca del trionfo ubiquo di modelli cultu- rali occidentali e neppure quella refrattaria all’analisi, e da al- cuni critici considerata come un corollario della precedente, di un indifferenziato pastiche postmoderno valido a ogni la- titudine. Il processo di globalizzazione non consiste nel me- ro trasferimento di merci, immagini e capitali da un centro (l’Occidente) a una periferia colonizzata o comunque su- bordinata (il resto del mondo). In questo senso è lecito af- fermare che la globalizzazione è già avvenuta con l’articola- zione su scala planetaria di un sistema di produzione e con- sumo capitalista. La globalizzazione della contemporaneità va piuttosto osservata nella varietà delle risposte culturali e politiche di una periferia che non accetta più di essere tale, nei processi di ibridazione processuale, diversi da contesto a contesto, innescati proprio dall’avvento di una cornice di ri- ferimento unitaria. Oggi la globalizzazione attenua l’aspetto unidirezionale del trasferimento centro/periferia e diviene in- terconnessione, rete, rizoma senza assi privilegiati e bonacce planetarie, quanto invece flussi multidirezionali, la nascita di centri antagonisti, sfaldamenti, parodie, fantasmi, che in ul- tima analisi – e paradossalmente – inducono una provincia- lizzazione dell’Occidente. Se infatti è innegabile che il para- digma capitalista è tutt’uno con una secolare disparità di potere e di accesso alle risorse tra Occident e e colonie, è pur vero che nella sua estensione a tutto il pianeta esso perde giocoforza unità e omogeità, si articola variamente, acco- moda tradizioni indigene o ne sollecita la riscoperta, fino al punto di snaturarsi nella riorganizzazione di contesti locali. L’asistematico sistema globale, sopra tutto per ciò che ri- guarda la sua componente estremo orientale, è piuttosto “ri- colmo di ironia e di resistenze, alle volte camuffate come forme di passività e appetito senza fondo del mondo asiatico per le cose d’Occidente” (Appadurai 1996: 29).
La disseminazione di modelli occidentali non ha l’effetto di eliminare in un colpo le differenze culturali; al contrario, essa è spesso accompagnata da un parallelo processo di costru- zione della differenza, non fosse altro che in forme nostalgi- che per un passato idealizzato. E anche quando la nostalgia
60

Alle volte ritornano
non gioca la parte che le potrebbe spettare, le risposte alla globalizzazione possono allontanare anziché avvicinare al- l’Occidente. Il Giappone degli anni Novanta, per esempio, è stato percorso da tutta una serie di slogan a sfondo politico- identitari o che, nella maggior parte dei casi, caldeggiavano un ribaltament o rispetto al classico “Datsua nyûô” (Fuggi l’Asia, entra in Occidente ) coniato verso la fine del secolo prece- dente. Tali slogan reclamavano in effetti un allontanamento dall’Occidente e un riavvicinamento al continente asiatico:
Il più famoso è “Datsuô nyûo” (Fuggi l’Occidente, entra in Asia) […]. Altri, che hanno la premura di non chiamare in causa gli Stati Uniti, caldeggiano un “Nyûô nyûa” (Entra in Occidente e in Asia) […]oppure “Han’ô nyûa” (Entra in Asia insieme all’Occidente). (Iwabuchi, 2002: 14).
Sembra dunque che la globalizzazione come la osservia- mo nel nostro tempo non necessariamente costituisca un pe- ricolo per la sopravvivenza delle differenze culturali; e nel ca- so in cui queste appaiano alleggerite sarà allora il senso di straniamento prodott o da una inaspettata somiglianza a inte- ressare l’antropologo. Il rischio della globalizzazione risiede piuttosto nella retorica che l’accompagna, adottata tanto dai suoi sostenitori quanto dai suoi detrattori: come se essa fosse l’unica possibile lente interpretativ a per mettere a fuoco le di- namiche della contemporaneità. Di questo passo la globaliz- zazione si avvia a diventare una “grande narrazione” (una ideologia) al pari di quelle che hanno sostanziato il dibattito intellettuale e il clima politico del XX secolo. Con il rischio però di replicarne i vizi e dimenticarne le virtù:
Il problema della tesi della globalizzazione è che ignora differenze locali che non possono essere ridotte a semplici “varianti” di un sistema onnicomprensivo. Sebbene io non neghi che la presenza dei capitali delle multinazionali sia sempre più pervasiva e stia trasformando in modo radica- le vari paesi non occidentali, non credo tuttavia che i teo- rici occidentali possano appellarsi a questo dato di fatto per sostenere che la poliedricità del mondo sia infine stata sussunta entro i parametri di una sola totalità […]. […]
61

Luigi Urru
ignorando l’eterogeneità delle voci dell’Altro, i teorici che hanno una visione totalizzante della storia tendono a soc- combere a una qualche sorta di imperialismo, neo-colo- nialismo, od orientalismo. (Yoshimoto 1989: 8).
La stessa ipotesi dell’assoluta novità del processo di glo- balizzazione, non è affatto consistente. Si è già accennato sopra quanto la globalizzazione tragga alimento dalla per- durante asimmetria di potere e di accesso alle risorse tra i paesi occidentali e il resto del mondo. Essa cioè perpetua i fantasmi di una secolare sudditanza coloniale. Per ciò che ri- guarda il Giappone, inoltre, è bene tenere presenti le osser- vazioni di Flavia Monceri; la studiosa nota che già tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, cioè circa cent’anni fa, in- tellettuali nipponici di elevata caratura come Nitobe Inazô e Okakur a Kakuzô non solo elaborarono lucide riflessioni sui cambiamenti in atto nei rapporti tra il loro paese e l’Occi- dente e vi offrirono, ciascuno a suo modo, approcci origina- li, ma sopra tutto già ragionavano entro il contesto globale di un sistema mondo dove Oriente e Occidente non potevano più fingere di non conoscersi. Lacunosa è piuttosto la nostra conoscenza di questi fatti e in particolare delle risposte crea- tive che le società altre hanno dato e danno tuttora alle sol- lecitazioni di una cultura occidentale “che è frutto di una particolare configurazione storica […] mentre continua a essere intesa come il punto di approdo di una linea di svi- luppo unica e irreversibile” (Monceri 2000: 19).
2. L’antropologia e lo spaesamento della modernità
La modernizzazione del Giappone non è che la storia di una somiglianza. Sull’arcipelago [giapponese] è sorta una modernità allo stesso tempo emula e rivale di quella occi- dentale. Una modernità singolare, inopinatamente sorta al- l’estremo opposto del pianeta, ha spossessato l’Occidente del monopolio che pensava di detenere e ne ha preso alla sprovvista il modo di pensare. (Pons 1988: 9).
62

Alle volte ritornano
L’avvento della modernità in Giappone è il resoconto di una forzatura: come è noto, è la presenza di navi americane al largo dei porti nipponici a indurre le autorità del paese, a metà Ottocento, a porre fine a oltre due secoli di chiusura delle frontiere. Questo periodo di isolamento, durato dal1639 al 1853 e chiamato sakoku, non fu tuttavia un periodo di oscurantismo. Secondo Philippe Pons esso rappresentò anzi il “secolo dei Lumi” del Giappone, un lungo momento creativo, durante il quale prese forma una peculiare cultura urbana e popolare, affrancatasi in larga misura dall’estetica alambiccata dell’aristocrazia e da un certo pessimismo in- dotto dal buddismo. In altri termini, andò elaborandosi un particolare approccio estetico al mondo, si affermarono co- stumi e uno spirito prammatico e ribelle indici di un “uma- nesimo” e un’arte di vivere che impregnano ancora forte- mente la mentalità metropolitana contemporanea (1988: 55).
In ogni caso, la data del 1868 (anno della riapertura offi- ciale delle frontiere e della reistituzione al trono dell’impe- ratore Meiji) inaugura per il Giappone una intensità di con- tatti con il mondo esterno e di cambiamenti sociali che avrebbe avuto del prodigioso. Come prodigiosi sarebbero state più tardi la ripresa nel periodo immediatamente suc- cessivo alla seconda guerra mondiale e la kodo keizai seicho (fulminea crescita economica) della fine degli anni Settanta e Ottanta – ora sgonfiata e ribattezzata baburu (bubble) keizai. Mi soffermerò più avanti sulla effettiva bontà di una scelta interpretativa che assegna al mutamento culturale giappo- nese, e a certe sue fasi storicamente individuabili, un carat- tere eccezionale e per ciò stesso enigmatico. Qui vorrei in- vece discutere gli effetti che l’eccezionalità del supposto pro- digio nipponico ha comunque avuto sui tentativi di com-prensione antropologica.
Marilyn Ivy afferma, in apertura del suo intenso volume, che “parlare del Giappone della fine del XX secolo spariglia le ovvietà dell’ordine mondiale. […]. Il Giappone sembra ubiquo, nomadico, transnazionale” (1995: 1). Il Giappone destabilizza la classica accoppiata Oriente / Occidente, man- da a gambe all’aria il nostro senso dello spazio e del tempo,
63

Luigi Urru
fa vacillare le capacità di orientamento tacitamente ispirate a uno schema di supremazia occidentale di retaggio coloniale. L’ingresso del Giappone, a un certo punto della sua storia, nel discorso della modernità mette ora in discussione la cen- tralità stessa dell’Occidente sulla mappa del pianeta, certifi- ca che la modernità può assumere forme lontanissime da quelle concepite e storicamente vissute in Occidente e con- segna quest’ultimo a un passato del quale resta solo l’illusio- ne fantasmatica di essere il centro del mondo. Tanto più che, come ha mostrato Philippe Pons, la singolarità dell’e- sperienza giapponese della modernità è dovuta a un latente sostrato ben più antico dell’apertura delle frontiere cento- cinquant’anni fa: “Le radici intellettuali e culturali del Giap- pone moderno affondano […] nei secoli XVII e XVIII, nel- l’epoca degli shôgun Tokugawa […] il vero periodo di “in- cubazione” della modernità nipponica” (1988: 17). Se dun- que la scoperta della modernità giapponese relativizza la posizione dell’Occidente sullo schacchiere planetario, an- cora più interessanti appaiono gli effetti che essa esercita sulla concezione stessa di alterità la quale è tradizionalmente apparsa come una componente irrinunciabile del discorso antropologico:
L’ascesa del Giappone ai primi posti fra le potenze mon- diali è d’imbarazzo a qualsiasi tesi radicata nel progetto il- luminista [occidentale] e ciò nonostant e è profondamente inbricata nell’Occidente. Come tale [il Giappone] permane in una cronica posizione di mai completa alterità né mai completa identità a se stesso. (Perry 1998: 81. Enfasi mia).
È chiaro quanto l’incontro della modernità giapponese con l’antropologia sia stato un fattore di turbamento, d’inquietu- dine, di spaesamento. Nemmeno all’interno di un pacchiano discorso orientalista la società giapponese ha mai potuto essere considerata “selvaggia” o “primitiva”, società “senza stato”, “senza scrittura” , “senza storia” – tutte espressioni, sia detto per inciso, che a lungo hanno designato gli oggetti di indagine prediletti dagli antropologi . Certo, anche in Giappone l’an- tropologia ha cercato di ritagliarsi un angolo tutto suo, ini-
64

Alle volte ritornano
zialmente occupandosi di comunità rurali e di villaggi di pe- scatori come testimoniano le etnografie di John Embree, A Ja- panese Village. Suye Mura, pubblicata nel 1946, e di Edward Norbeck, Takashima. A Fishing Community, del 1954. Si os- servi tuttavia il paradosso, destabilizzante per l’ortodossia del- la disciplina: ben prima dei ricercatori occidentali, furono gli stessi studiosi giapponesi a fare del Giappone un oggetto di indagine antropologica, a osservarlo con uno “sguardo da lontano” e a ricavare descrizioni sistematiche della propria cultura attraverso lunghe ricognizioni sul campo. Se a metà Novecento le missioni antropologiche occidentali, sponsoriz- zate da università statunitensi , anacronisticamente ignoravano la componente urbana e l’impianto nazionale della società giapponese, già circa mezzo secolo prima un’équipe di studio tutta nipponica aveva invece dato prova di una acuta consa- pevolezza dei cambiamenti in corso e aveva redatto l’“epopea” etnografica di un Giappone che andava in frantumi di fronte alla modernità. Yanagida Kunio e i suoi collaboratori, oggi po- sti a capostipite degli studi etno-antropologic i nipponici, per anni percorsero l’arcipelago in lungo e in largo compilando, nei primi decenni del secolo scorso, ben tredici dizionari ra- gionati, noti come Bunrui minzoku goishû, su consuetudini matrimoniali, riti funebri, prescrizioni e tabu, tipologie abita- tive urbane e domestiche, ricorrenze festive stagionali, culti e religioni, educazione dei bambini e struttura della famiglia. In anticipo sulle ricerche occidentali, l’équipe di Yanagida mo- strò di possedere una sensibilità nutrita di fondamentali cate- gorie della modernità: per gli argomenti scelti, per il metodo adottato e sopra tutto per la lucidità riguardo l’urgenza di in- dagare un paese che cambiava a ritmi sostenuti. Chiaramente, l’impresa di Yanagida contribuì non poco a creare il tenace fantasma di un “Giappone com’era” dove la vita scorreva si- cura nei solchi dell’identità e della tradizione, prima dell’av- vento di una modernità a cui oggi, in Giappone, nessuno ri- nuncerebbe pur deprecandone gli effetti devastanti.
Non meno tenaci sono i fantasmi emersi dalle opere di antropologi occidentali, sopra tutto quando, e si pensi per esempio al best seller di Ruth Benedict Il crisantemo e la
65

Luigi Urru
spada (che discuterò oltre), hanno sfoggiato, applicandole al Giappone, le ambizioni olistiche che in altri angoli di mondo hanno contraddistinto l’impresa conoscitiva dell’antropolo- gia; il risultato è stato ovvio e paralizzante: studi onnicom- prensivi della società nipponica (ammettendo che qualcosa del genere esista) sono solo possibili al prezzo di un generico appiattimento dell’analisi; il semplice fatto geografico giap- ponese (un paese di oltre tremila isole sventagliate per venti gradi di latitudine) dovrebbe bastare a tener lontana la ten- tazione di considerare la società dell’arcipelago un amalgama culturale omogeneo e incoraggiare invece un approccio che ne esplori la variabilità delle sue contemporanee configura- zioni. Forse, allora, non è un caso che i lavori dei due de- cenni che hanno preceduto e seguito la Seconda Guerra Mondiale e che eludevano il confronto con la modernità né consideravano il più ampio, già globale contesto nel quale agiva il Giappone dell’epoca, abbiano pagato il caro prezzo della inconsistenza dei propri assunti teorici, come ha poi os- servato Brian Moeran (1990: 342-343).
3. Cultura di massa e adesione alla realtà
Solo quando gli antropologi hanno iniziato a fare decisa- mente i conti con il potenziale destabilizzante che la società giapponese, intesa nella sua peculiare via alla modernità e al- la contemporaneità, poteva avere sulla stessa disciplina an- tropologica, sui suoi concetti, strumenti e metodi, solo allo- ra, e cioè non più di vent’anni fa, dal Giappone sono inizia- ti ad arrivare contributi molto originali.
Per rimanere a un esempio piuttosto recente si consideri il volume collettaneo Japanese Popular Culture. Gender, Shifting Boundaries and Global Cultures curato da Dolores Martinez. Vi si trovano saggi sul sumo, il karaoke, il pubblico femmini- le delle corse ippiche, il lancio del calcio come sport di massa, gli eroi delle anìme (cartoni animati) e le serie televisive mat- tutine. L’analisi della pop culture nipponica è a tutto campo, e l’adesione alla realtà precede sia la reverenza per le consue-
66

Alle volte ritornano
tudini accademiche della disciplina (gli antropologi non sono avvezzi a occuparsi di pop culture, anzi la guardano con un certo fastidio), sia i riflessi condizionati che le sono propri (gli antropologi giustificano poi il fastidio per la pop culture af- fermando che non è autentica). L’obiettivo è almeno triplice e va oltre la conoscenza dettagliata di alcuni aspetti della so- cietà giapponese che si acquisisce leggendo il libro. Innanzi tutto la pop culture serve agli estensori dei saggi per sostan- ziare discussioni ben più ampie che giungono a illuminare i modi in cui si costruisce l’identità nazionale:
si può ben dire che la pop culture […] sia una arena di ne- goziazione nella quale la tradizione, il presente, il futuro, l’identità giapponese e le identità relative a status e a clas- se sociale si riflettono, trovano alimento, sono ridotte in frammenti e poi ricreate, o anzi create ex-novo. In altre parole, la pop culture rappresenta il mezzo migliore per analizzare i processi attraverso cui si costituisce ciò che va comunemente sotto il nome di “cultura nazionale”. (Mar- tinez, 1998: 14. Enfasi originale).
In secondo luogo, alla luce della pop culture nipponica, il concetto stesso di cultura, così centrale per l’antropologia, subisce contraccolpi non irrilevanti:
pratiche sociali che potremmo etichettare come espres- sioni di una cultura alta o d’élite, in Giappone sono di- ventate sempre più prerogativa di un immenso ceto me- dio. Le donne giapponesi prendono lezioni di cerimonia del tè, balletto e musica classica; sono essenzialmente loro a tenere alto l’interesse per ricercati prodotti culturali im- portati dall’Occidente siano essi il teatro, la musica, la danza o l’opera. Quando svariati milioni di persone par- tecipano a pratiche sociali “d’élite”, non dovremmo forse chiamare queste ultime con un altro nome, e cioè pratiche popolari, e anzi considerarle elementi di una cultura di massa? (Martinez 1998: 5).
Infine, il volume solleva un ulteriore interrogativo. Anche per l’analisi di fenomeni ubiqui e trasversali, apparentemen- te distintivi di un pianeta omogeneizzato come appunto
67

Luigi Urru
quelli che ricadono sotto il nome di pop culture, occorrono cautele quando si prendano in considerazione contesti non occidentali. In giapponese sono almeno due le traduzioni plausibili dell’espressione inglese. Minshû bunka (cultura popolare) si definisce per opposizione a una cultura aristo- cratica della quale nega l’implicita connotazione gerarchica; il suo uso possiede vaghe sfumature politiche. Taishû bunka (cultura di massa) presuppone invece l’idea di largo consu- mo in una società dall’impianto democratico. Secondo Phi- lippe Pons, al cui lavoro si rimanda per una discussione ap- profondita della questione,
nel Giappone moderno questi due tipi di cultura tendono a confondersi, e il secondo a inglobare e progressivamen- te a snaturare il primo senza tuttavia disgregarlo comple- tamente. (1988: 54).
Alla distinzione tra minshû e taishû bunka si aggiunga il fatto che, per ciò che attiene la letteratura di consumo o di massa (e l’italiano qui mostra una impermeabilità alla tradu- zione analoga al giapponese), esiste ancora un’altra espres- sione: chûkan bunka, o cultura mediana, di mezzo.
L’esempio sin qui discusso mostra che anche solo l’e- spressione pop culture, nomadica e globale per antonoma- sia, si disfa e si rifrange in modi che variano localmente; il suo passaggio da Occidente a Oriente, e ritorno, produce fantasmi: immagini impreviste, non tangibili ma reali e con effetti reali tanto per il contesto sociale che le produce quanto per l’analisi sociale di tale contesto. L’interessante feedback per l’antropologia è non solo di permanere in quella condizione di disagio spaesante della traduzione che ne costituisce la vocazione e che più di un antropologo ha descritto (o ha inutilmente tentat o di nascondere, a secon- da dei casi) in lavori ormai classici. Ribadita è pure la fun- zione critica della disciplina verso quella modernità con radici nel razionalismo illuminista che ne è la matrice. Ana- lizzare antropologicamente la modernit à oltre le soglie del- l’Occidente significa eroderne i significati più intimi: le
68

Alle volte ritornano
pretese di universalità e di insuperabile specificità nel pa- norama delle culture umane. Come ha scritto Appadurai,
la modernità appartiene a quella minuta famiglia di teorie che a un tempo dichiara e desidera la propria applicabilità universale. La novità insita nella modernità (o l’idea che essa sia una novità di nuovo tipo) discende da questa sor- ta di dualità. Qualunque siano stati gli altri effetti del pro- getto illuminista, esso mirava a creare persone che deside- rassero esser diventate moderne. (1997: 1).
Gli uomini ai quattro angoli del pianeta, e senza ombra di dubbio in Giappone, sono (diventati) moderni, e anche gra- zie alla pop culture: ciò non significa tuttavia che la nostra modernità equivalga a quelle altrui e a quella nipponica in particolare; le contemporanee configurazioni della moder- nità sono l’esito di relazioni più complesse di ordinarie equi- valenze; anziché affermarla oppure negarla esse semplice- mente eludono la presenza di un unico centro. Si consideri ancora la pop culture nipponica: essa esporta in tutto il mon- do e con tale efficacia da essere posta in una nuova categoria a sé stante, il J-pop. Il fenomeno non è nuovo se si ricorda che nei tardi anni Settanta i ragazzini italiani guardavano i cartoni animati di Goldrake, Uomo Tigre e Jig robot d’ac- ciaio alla Tv dei ragazzi. Tuttavia, venti anni dopo la perva- sività e il successo del J-pop in alcune aree del pianeta hanno avuto dello spettacolare. Secondo Iwabuchi Koichi, al giorno d’oggi anìme, manga, giochi elettronici, moda, musica, tra- smissioni tv e personaggi dello spettacolo giapponesi cattu- rano l’interesse dei giovani del sud-est asiatico assai più degli idoli pop e dei serial televisivi americani (2002: 2). Del resto, anche in Occidente i Pokémon spopolano tra bambini e adolescenti mentre i nomi di dj-Krush e Ryuichi Sakamoto non sono affatto sconosciuti ai frequentatori di lounge mu- sicali; intanto Miyazaki Hayao ha vinto uno dopo l’altro l’Orso d’oro al festival del cinema di Berlino e l’Oscar per il cartone animato Spirited Away. Che il J-pop sia una copia fantasmatica di un originale americano oppure no, è co- munque piuttosto chiaro che la sua crescente affermazione a
69

Luigi Urru
livello planetario è un sintomo della attuale natura cangiante e decentrata dei centri di disseminazione culturale.
4. Esotismi, appropriazioni, transiti
Il pensiero comune vuole che il Giappone sia un paese enig- matico, al punto che la storia dei cinque secoli trascorsi dal primo sbarco sull’arcipelago del gesuita Francesco Saverio può essere provvisoriamente sussunta sotto l’etichetta di un perpetuo reciproco fraintendimento. Basta andare alle cro- nache dell’epoca per rendersene conto (e sorridere di quan- to sia burlona a volte la percezione della diversità):
Durante il regno dell’Imperatore Gonara-no-i n (1527-1557), scrive un cronista giapponese un secolo circa più tardi, l’ottocentesimo sovrano dall’Imperatore Junmu in- torno all’era Koji, arrivò un mercante “namban” [barbaro del sud, selvaggio], una creatura a cui era difficile dare un nome, che sembrava avere una forma umana a prima vista, ma che poteva altresì essere preso per un folletto dal naso lungo, o per un demone dal lungo collo di quel tipo che ha l’abitudine di travestirsi da prete buddista per tirare brutti tiri alla gente. A una più attenta osservazione ri- velò trattarsi di una creatura chiamata “Padre”. La prima cosa che si notava era la lunghezza spropositata del naso! Era come una conghiglia senza verruche piantata in faccia, come se fosse una ventosa. Quant’erano grandi i suoi oc- chi! Erano come due telescopi, dalle iridi però gialle. La testa era minuta; le mani e i piedi avevano lunghi artigli. Era più alto di sette piedi ed era di colore nero, tranne il naso che era rosso; i denti erano più lunghi di quelli di un cavallo, e i capelli color grigio topo. Sopra la fronte vi era una tonsura della dimensione di una tazza di saké rove- sciata. Il suo parlare era incomprensibile all’udito; la voce somigliava allo stridio di un barbagianni. Tutti correvano a vederlo, turbando le strade per l’affollamento. Pensavano che questo fantasma fosse più terribile del più feroce mo- stro” [Ronald 1995: 325-7. Enfasi mie].
Da parte occidentale i tentativi di comprendere “l’incom- prensibile l’alterità nipponica” non hanno incontrato mag-
70

Alle volte ritornano
gior successo e sono spesso naufragati in formule disarman- ti ed essenzialiste, come se esistesse un set di caratteristiche nazionali nipponiche refrattario al cambiamento storico e alle contaminazioni culturali. Lo sguardo occidentale sul Sol Levante ha oscillato tra la contemplazione estetizzante e l’orrore smagato raramente sfuggendo a etichette orientaliste d’effetto: i monaci meditabondi nel vuoto di giardini zen, le geisha sempre troppo frettolosamente scambiate per prosti- tute, gli attori mascherati sui palchi del kabuki, o ancora gli aviatori lanciati in missioni suicide. Come l’Italia all’estero è il paese degli spaghetti, della pizza e della mafia, così la no- stra conoscenza del Giappone non va oltre l’origami, l’ike- bana e i samurai. Di fatto, il Giappone ha suscitato reazioni ambigue, di spavento e di fascino, almeno quanto ambigua, affascinata e spaventata, è stata l’immagine che ne hanno dato i resoconti occidentali. Si vedano per esempio queste ri- ghe di Ruth Benedict:
I giapponesi sono aggressivi e pacifici, pronti all’azione militare e dediti alla contemplazione estetica, insolenti e cortesi, rigidi e concilianti, sottomessi e risentiti non appe- na li si canzoneggi, leali e infidi, impavidi e timidi, conser- vatori e pront i ad accogliere il nuovo. (Benedict 1974: 2).
Il mito della impenetrabilità, e anzi della irriproducibile specificità nipponica, alimentato dalla dissonante compre- senza di crisantemi e di spade, si è poi sostanziato in vario modo con riferimenti alla irrazionalità e assenza di emozioni dei giapponesi, alla omogeneità culturale e all’armonia so- ciale, al fatalismo del pensiero filosofico e alla raffinatezza del- le espressioni artistiche. Non si obietterà qui alla plausibilità di queste attribuzioni. I fantasmi che hanno guidato sinora la discussione muovono in altra direzione. La cosa curiosa, in- fatti, è che i giapponesi hanno deciso di appropriarsi dei di- scorsi altrui sulla loro unicità, al punto che ormai “immagini essenzialiste del Giappon e echeggiano all’interno delle rap- presentazioni che loro stessi si danno in forme quotidiane, ac- cademiche, e per il mercato di massa” (Ivy 1995: 2).
Fenomeni del genere non sono ovviamente limitati al so-
71

Luigi Urru
lo Giappone. In ambito antropologico, sopra tutto france- se e italiano, ha suscitato maggiore eco del caso nipponico quello dei Dogon del Mali che hanno fatto propria, e usano a fini turistici, l’identità loro assegnata da Marcel Griaule nella classica monografia Dio d’acqua. La situazione giap- ponese, tuttavia, mostra una più complessa articolazione se non altro perché l’appropriazione di modelli altrui è legata, con un ruolo in parte fondante, all’idea di identità nazio- nale. Come ha scritto Mark Hobart a proposito di un altro contesto etnografico:
Che ne è delle osservazioni che i nostri osservati fanno su di noi? Dal momento che essi non costituiscono un grup- po omogeneo, non si potrà rispondere in modo univoco. Ma esiste una mezza risposta comunque sicura. Le prati- che [sociali] che noi [oggi] osserviamo sono innanzi tutto quelle indotte da coloro che ci hanno preceduto [sul cam- po]. Gli abitanti di Bali leggono Clifford Geertz come te- sto universitario per scoprire la propria identità e i modi per rintracciarla. (1996: 13).
Dalle riflessioni sulla propria specificità sollecitate dal con- fronto con l’Occidente e in particolare dal discorso occiden- tale sul Giappone, è andato sviluppandosi per tutto il corso degli ultimi cento anni un intero genere letterario e di studio: testi in giapponese, scritti da giapponesi per un pubblico giapponese; si tratta dell’infinito dibattito che va sotto il nome di nihonjinron (discorso sulla nipponicità), presente a ogni li- vello sociale in forme estremamente varie e “immensamente diffuse” (Ivy 1995: 2), e che recentemente, in virtù della sua portata, è stato oggetto di esame antropologico “come feno- meno culturale […] propri o allo stesso modo dello sciama- neismo, delle strutture di parentela o dell’etnicità” (Befu2001: 13). Fumetti manga pensati per lettori sarariman (i col- letti bianchi del Giappone), saggi tascabili acquistabili alle edicole delle stazioni, inchieste giornalistiche, tesi di dottorato e testi accademici affermano la peculiarità dell’identità nip- ponica con toni alle volte parecchio enfatici e inclini al na- zionalismo; per questi autori alcune caratteristiche di fondo,
72

Alle volte ritornano
al limite genetiche, differenzierebbero i giapponesi dal resto dell’umanità: la psiche giapponese sarebbe fondamental- mente alogica e relazionale (un’ipotesi che già si rinveniva in varie opere filosofeggianti pubblicate prima della seconda guerra mondiale), il giapponese sarebbe la lingua più diffici- le al mondo (e ciò precluderebbe a qualsiasi straniero la pos- sibilità di apprenderla) , il corso storico non avrebbe inferto cambiamenti sostanziali a una società giapponese omogenea da tempi immemorabili che anzi realizzerebbe una perfetta sovrapponibilità di lingua, popolo e cultura.
L’appropriazione nipponica del japonisme occidentale, che rimane sullo sfondo del dibattito come presenza fantasmati- ca, ha a sua volta suscitato svariate reazioni: disappunto, fa- stidio, sarcasmo, sconcerto. Tra i primi ad accettare onesta- mente la sfida posta dal nihonjinron vi sono gli antropologi: è grazie a vari lavori sul campo che oggi disponiamo di una chiave interpretativa plausibile per un fenomeno che si pre- sentava come un inventario di affermazioni scoordinate e al limite dell’isteria nazionalista. Anche riguardo le spinose questioni sulla “eccezionalità” nipponica, l’antropologia più recente si è mantenuta fedele al suggerimento di Ludwig Wittgenstein “Denke nicht, beobachte” (Non pensare ma os- serva), e ha confermato la propria fondamentale caratteristi- ca di mettere alla prova del terreno sistemi e ideologie astrat- ti, vagliarne la consistenza nelle effettive pratiche quotidiane, andando a rovistare in quello che Edward Burnett Tylor, considerato il fondatore della disciplina nella sua accezione moderna e accademica, chiamò “un mucchio di spazzatura di svariate follie”. È così che Harumi Befu ha recentemente sostenuto che il nihonjinron, lungi dall’essere “spazzatura” e “follie”, offra invece preziosi spunti per una più adeguata comprensione di come istanze nazionaliste infiltrino una so- cietà consumista. Almeno nelle sue manifestazioni più po- polari, il nihonjinron va considerato come un bene di con- sumo, al pari dei “costumi da bagno, delle camicie e delle cravatte” (Befu 2001: 62): esso dispensa stereotipi di nippo- nicità a un mercato che ne è assetato. Tali stereotipi, prose- gue Befu, non affermano come sono i giapponesi, quanto
73

Luigi Urru
piuttosto come dovrebbero essere: il nihonjinron non è “la descrizione di un comportamento” ma “un modello per il comportamento ” (ibid.: 69. Enfasi originale), un modello prescrittivo, cioè, sul come essere giapponesi differenzian- dosi dal resto dell’umanità.
Philippe Pons, del resto, ha osservato l’inadeguatezza del- lo schema interpretativo proposto dal nihonjinron i cui as- sertori, riducendo il Giappone (e, di riflesso, l’Occidente) a un’essenza omogenea e atemporale,
rivendicano un’identità così “assoluta” da compiacersi a vederla ineffabile. Quest e “giapponeserie” non hanno […] che un merito: esse rivelano ancora una volta il pro- blema identitario che i giapponesi si trovano ad affronta- re. (1988: 10).
Tali rivendicazioni di specificità identitaria, per quanto in- dotte e al limite della parodia, contribuiscono da un lato a mantenere l’ordine sociale costituito (per meglio dire: il po- tere nelle mani di chi lo detiene), dall’altro a giustificare, in forme che hanno del ridicolo, una politica economica estera largamente protezionista . A questo riguardo, servizi apparsi sui media hanno reso consapevole anche il grande pubblico occidentale delle barriere doganali innalzate dalle autorità giapponesi verso vari beni di consumo, siano essi gli sci (chia- ramente inadatti alla neve giapponese così diversa dal resto del mondo), o la carne bovina (i giapponesi non la digerireb- bero: hanno un intestino più lungo) oppure il riso (privo delle caratteristiche spirituali del riso indigeno). Oltre a di- fendere gli interessi delle élite nazionali in patria e all’estero, le tesi del nihonjinron valgono come baluard o contro i fanta- smi del passato e le ansie della contemporaneità . L’introver- sione nipponica evidente nel mito della unicità della propria cultura collude con la negazione di un’epoca imperialista, senza dubbio esageratamente estroversa, culminata nella di- sfatta della seconda guerra mondiale. Tale stessa introversio- ne ha inoltre finito per generare in molti giapponesi un senso di isolamento e il timore di una inadeguatezza ad affrontare le attuali sfide della globalizzazione. Ciò avviene, paradossal-
74

Alle volte ritornano
mente, a dispetto dell’adozione di modelli stranieri in ogni campo, dalla gastronomia, alla filosofia, all’urbanistica, così che per l’osservatore esterno il Giappone, o almeno quello spaccato del Giappone che è Tokyo, anziché essere un paese enigmatico è piuttosto un paese stranamente familiare. I segni di una contemporaneità ampiamente condivisa con altre aree (urbane) del pianeta sono tanto evidenti da risultare fuor- vianti. I grattacieli di Shibuya e di Shinjuku (due quartieri della capitale), l’automatico per le Marlboro nella strada ac- canto, gli sterminati centri commerciali, il traffico automobi- listico, il cibo precott o sono tutti segni che suggeriscono al vi- sitatore occidentale la superficiale impressione di non tro- varsi neanche troppo lontano da casa; come afferma Nick Perry, la versione nipponica della modernità (e quindi della contemporaneità) “in un colpo solo ha declinato, osteggiato e ribaltato le dicotomie dell’orientalismo” (Perry 1998: 71). Tuttavia, sono proprio le appropriazioni creative che rendono il Giappone, e sopra tutto i suoi immensi conglomerati urba- ni, interessanti all’occhio dell’antropologo: non la presunta inintelleggibilità ma l’effetto di straniamento indotto dalla parvenza del doppio, come se a Tokyo potessimo rinvenire un fac-simile di noi stessi occidentali.
Il doppio […] è una figura immaginaria che, al pari del- l’anima, dell’ombra, dell’immagine riflessa nello specchio, turba il soggetto come un altro da sé, lo rende contempo- raneamente se stesso e diverso da sé, lo turba come una morte sottile sempre in procinto di compiersi. […]. La forza e la ricchezza immaginaria del doppio, che mettono in gioco l’estraneità e l’intimità di ciascuno con se stesso (heimlich/unheimlich), risiedono nella sua immaterialità, nel fatto che esso non resta che un fantasma. (Baudril- lard 1981: 143).
Nel transito di tutto questo armamentario qualcosa va in- dubbiamente perso; e qualcosa, più che “trovato in traduzio- ne” come ha osservato Clifford Geertz (1988: 47-69), o indi- genizzato come vuole un approccio in voga nell’antropologia odierna, è creato ex-novo, nel senso che appare totalmente
75

Luigi Urru
originale mentre il rimando a un altrove sfuma in una elusività fantasmatica (è dunque iper-reale, per usare un’espressione ca- ra a Jean Baudrillard). Due esempi illustreranno il concetto.
5. Dallo yojôhan al kombini
Per secoli lo yojôhan è stato “l’unità standard dell’ambiente domestico” (Suzuki 2001: 16) giapponese. Si tratta di una ca- meretta di quattro tatami e mezzo di superficie (equivalenti a poco più di sette metri quadri), il minimo indispensabile per il riposo e le attività quotidiane di una persona adulta, protetta da pareti lignee e porte scorrevoli di carta traslucida (fusuma). La prima testimonianza scritta relativa allo yojôhan risale al XIII secolo e racconti e dipinti di epoca Edo ne attestano la diffusione generalizzata tra i ceti popolari della capitale tra il XVI e la metà del XIX secolo. Lo spazio dello yojôhan era a un tempo altamente gerarchizzato e altamente flessibile. Il ta- tami piu lontano dall’ingresso (kirindatami) era riservato agli ospiti di riguardo , quello sulla destra entrando (kyakudatami) spettava a ospiti di media importanza mentre quello imme- diatamente accanto all’ingresso (fumikodatami) era lasciato agli ospiti comuni; il quarto tatami (temaedatami) serviva alla preparazione del tè: l’acqua era scaldata sul mezzo tatami centrale (rodatami) all’interno di una piccola fossa con un braciere (kotatsu). Oltre a costituire l’ambiente ideale per la cerimonia del tè, lo yojôhan era di volta in volta soggiorno (cha no ma), stanza da letto e luogo per incontri romantici leciti e illeciti. Le sue sorti mutaron o radicalmente con l’avvento del- la televisione nel secondo dopoguerra; l’apparecchio tv posto in un angolo privò lo yojôhan del proprio centro e la famiglia giapponese del consueto ambiente per la conversazione. Seb- bene oggi gli yojôhan, le case di legno, i tatami, e le porte scorrevoli siano pressoché scomparsi dal panorama tokyoita, sarebbe errato credere che ciò sia dovuto alla succube ado- zione di modelli occidentali nell’organizzazione dello spazio urbano e domestico. Jinnai Hidenobu ha osservato che a par- tire dalla fine del XIX secolo

76

Alle volte ritornano
forme architettoniche e urbanistiche occidentali furono gradualmente incorporate […] prima con un processo imitativo di prove ed errori, quindi attraverso una inter- pretazione à la japonaise. (Jinnai 1995: 4).
Sono appunto le interpretazioni locali di modelli importa- ti che ci inducono ad sostenere il potenziale creativo dei transiti transnazionali, almeno per ciò che attiene il caso nipponico. Gli anni Ottanta e Novanta hanno infatti visto l’affermarsi del così detto 1DK (i giapponesi lo pronunciano all’inglese), un monolocale di 20-25 metri quadri articolato in camera, angolo cottura e unità bagno spesso prefabbrica- ta e tutta in plastica. La tecnologia vi sovrabbonda: pavi- menti riscaldati, aria condizionata con comando a distanza, frigo intelligente, accensione automatica delle luci, vaso con asse riscaldato a temperatura variabile e getti doccia perso- nalizzabili, antifurto collegato con un’agenzia privata di si- curezza. La popolarit à dello 1DK tra i (giovani) abitanti me- tropolitani è tale che rinomati architetti del calibro di Itô Toyo, Yamamoto Riken e Sejima Kazuyo si sono cimentati con progetti ad hoc, mentre la carta stampata vi dedica am- pi servizi e consacra intere rubriche ai consigli sul come so- pravvivergli, decorarlo e tener lontana la solitudine, senza poi dimenticare che esso è stato il set privilegiato di due se- rial televisivi dei primi anni Novanta, Tokyo Love Story ed Elevator Girl. Palazzi che dall’esterno appaiono come ordi- nari condomini all’occidentale, rivelano internamente mo- nolocali lontani anni luce dalle nostre concezioni residenziali. Il modello importato anziché appiattire il panorama abitati- vo indigeno ha offerto gli stimoli necessari per ricrearlo ex- novo. Per dirla con Suzuki Akira, lo 1DK certifica che “in Giappone non si può applicare la nozione occidentale di residenza familiare” (2001: 41): non esiste nulla di già deciso riguardo il destino della famiglia nucleare. La rivoluzione dello 1DK non è poi esclusivamente abitativa; la leva del si- stema risiede nella capillarità della rete distributiva di merci e servizi. A Tokyo ci sono oltre ventimila kombini con una densità in alcuni quartieri ipertrofica, fino a quattro per iso-
77

Luigi Urru
lato. Chiamarli piccoli empori sarebbe riduttivo, perché i kombini offrono di più: la sopravvivenza a qualsiasi ora del giorno e della notte, si tratti di cibo e articoli vari di pronto consumo – dalle schede telefoniche ai test per la gravidanza– che non troverebbero spazio negli angusti monolocali, si tratt i dell’angolo-edicola per la libera lettura, oppure ancora di bancomat, fotocopiatrice e fax, lavanderia automatica, pagamento bollette e spedizione pacchi. Sebbene kombini sia una contrazione dall’inglese convenience store, affidarsi al- l’etimologia sarebbe fuorviante: di anglo-americano nel kom- bini nipponico non resta che un riflesso lontano, una ri- membranza, o per meglio dire una parvenza fantasmatica.
6. Il sakkaa per reinventare la società
È il calcio a fornire il secondo esempio di creatività locale in- dotta dall’introduzione di modelli esterni. Secondo Jonathan Watts il recente lancio (shinhatsubai) del sakkaa (dall’inglese americano soccer) sulla scena degli sport praticati a livello professionale è stato accompagnato da un intenso processo di “reinvenzione, riconfezionamento and ricommercializza- zione” (1998: 183) sociale. Il sakkaa, che era organizzato in tornei amatoriali fin dal 1921, nel giro di un decennio è di- ventato veicolo per incorporare “una quantità di valori non giapponesi” (ibid. 184) evidenti innanzi tutto nelle kosei- tekina, le abilità del singolo giocatore, e la disinvoltura con la quale egli esprime le proprie emozioni e ostenta una perso- nalità sul campo e fuori. La fulminea popolarità del sakkaa, abilmente pilotata da strategie di marketing targate Sony, tuttavia ha anche agito come “coadiuvante” per riforgiare il senso di appartenenza a una comunità locale e promuovere la transizione da un set di valori basato sull’etica del lavoro, il risparmio e l’accumulo di capitale a uno basato sul tempo libero, il divertimento e la crescita dei consumi interni.
Il caso di alcuni calciatori che non si sono atteggiati in pubblico come prevedeva l’etichetta ha suscitato eco nazio- nale; Kazuyoshi Miura (Kazu per i tifosi) ha fatto parlare di

78

Alle volte ritornano
sé per la sfrontatezza verso il potere costituito, per le con- gratulazioni in giapponese colloquiale con la coppia impe- riale nel giorno delle nozze, e infine per avere accettato il tra- sferimento oltre il suolo patrio, verso l’italico Genoa. Con lui emergeva un nuovo modello: mentre fino ad allora, in altri sport, chi accettava un contratto all’estero era tout court tac- ciato di tradimento, “valere tutto quel denaro e andare a giocare con i migliori era per Kazu, e per il calcio nipponico, motivo di onore” (Watts 1998: 185). La decisione del gioca- tore fu sulla bocca di tutti ma non attivò meccanismi di cen- sura sociale poiché andava mano nella mano con l’idea di “una popolazione più benestante: praticare il [sakkaa] pre- suppone tempo libero, salute e ricchezza. […]. Si tratta di una sorta di stravaganza nazionale, un proclama relativo al potere di acquisto della popolazione” (ibid.: 191). Questo fatto, sia detto per inciso, riecheggiava l’antico slogan “fukoku kyôhei” dell’imperatore Meiji: un paese ricco e un esercito forte. Che un prodotto di importazione abbia inco- raggito enfasi nazionaliste (come dire che mangiando po- modori olandesi ci si sente più italiani) entra di diritto nel ca- talogo degli effetti inaspettati dei transiti transnazionali.
A partire dalla metà degli anni Novanta il tifo per il sakkaa è inoltre venuto a marcare una differenza tra i sarariman, asso- ciati ai valori della famiglia e dell’azienda, e quelli che sono in- dicati come shinjinrui (new lifestyle people). Da notare è che, sull’altra sponda del Pacifico, la scarsa penetrazione del calcio negli Stati Uniti è invece giustificata proprio con il modesto ri- lievo che esso, in quanto gioco di squadra, lascerebbe all’in- dividuo singolo. Per concludere, la promozione del sakkaa in Giappone e in particolare la fondazione della Japanese League, equivalente della nostra Serie A, è andata di pari pas- so con un processo di ricostruzione identitaria locale. Singole municipalità hanno patrocinato la nascita di associazioni cal- cistiche e costruito le attrezzature sportive necessarie per gio- care a livello dilettantistico e professionale, anche in vista dei mondiali FIFA del 2002. L’unione delle forze in vista di un obiettivo comune ha contribuit o a rinvigorire la coesione del- le comunità cittadine, ha trattenut o molti giovani dall’emi-
79

Luigi Urru
grare e, agli occhi di alcuni intervistati, ha agito come buon an- tidoto contro la devianza giovanile, in particolare sottraendo membri alle gang di motociclisti note come bôsôzoku.
7. In-conclusione
Mettere un punto fermo a conclusione di uno scritto su no- madismi e fantasmi sarebbe imbarazzante e contradditto- rio, oltre che impossibile. In effetti, il paesaggio che la mo- dernità ha modellato in Occidente come in Giappone si è ri- velato assai più fertile e disponibile alla novità di ibridi im- previsti di quanto potesse supporre Benjamin settant’anni fa. La sensazione che nella contemporaneità qualcosa sia an- dato perduto, che anzi le rovine di un passato tornino di quando in quando a spuntar e qua e là, è senza dubbio reali- stica; essa, tuttavia, non rende giustizia alla vivace fluidità di una situazione che vede il progressivo sfaldamento di un pensiero fondato sulla passiva adozione di modelli euro- americani:
In termini di contenuto osserviamo la rapida proliferazio- ne di sovrapposizioni multiple tra il Giappone e l’Occi- dente. La “loro” ibridità, tuttavia, è palesemente e coc- ciutamente non la “nostra”. Essa possiede una diversa ge- nealogia e produce differenza secondo le regole di un’altra grammatica. (Perry 1998: 91).
La modernità nipponica appare dunque simultaneamente esotica e familiare, consueta eppur bizzarra al punto da sfu- mare i contorni e la sensatezza stessa della distinzione Orien- te/Occidente . I timori di una bonaccia planetaria indotta dalla globalizzazione paiono tutto sommato infondati: è an- zi proprio la portata globale della modernità capitalista ad avere incoraggiato quei creativi rimaneggiamenti indigeni che permettono all’antropologo di godere ancora di ciò che gli è più caro – una salutare condizione di spaesamento. Se c’è qualcosa ancora da scoprire nel mondo contemporaneo, si tratta non di identità pure (che non sono mai esistite) ma
80

Alle volte ritornano
delle aree di relazione, delle connessioni, della circolazione di immaginari e in definitiva del lavoro possente e invisibile di fantasmi dell’altrove e dell’altrimenti.
Bibliografia:
Agamben G., 1977. Stanze. La parola e il fantasma nella cultura oc- cidentale, Einaudi, Torino.
Appadurai A., 1997 [1996]. Modernity at Large. Cultural Dimen- sions of Globalization, University of Minnesota Press, Minnea- polis e Londra.
Baudrillard J., 1981. Simulacres et simulations, Éditions Galilée, Parigi.
Befu H., 2001. Hegemony of Homogeneity. An AnthropologicalAnalysis of Nihonjinron, Trans Pacific Press, Melbourne.
Benedict R., 1974 [1946]. The Chrsysanthemum and the Sword.Patterns of Japanese Culture, Meridian, New York.
Benjamin W., 1962 [1955]. Angelus Novus. Saggi e frammenti. Ei- naudi, Torino. Traduzione di Renato Solmi [1955. Schriften, Suhrkamp, Francoforte s.M].
Brahimi D., 1992. Un aller retour pour Cipango. Essai sur les para- doxes du japonisme, Noël Blandin, Parigi.
Callari Galli M., 1999 [1996]. Lo spazio dell’incontro. Percorsi nel- la complessità, Meltemi, Roma.
Geertz C., 1988. Antropologia interpretativa, il Mulino, Bologna. Traduzione di Luisa Leonini [1983. Local Knowledge. Further Essays in Interpretative Anthropology, Basic Books, New York].
Hobart M., 1996. A Very Peculiar Practice, or the Unimportance of Penguins, Saggio presentato al Department of Anthropology
and Sociology, School of Oriental and African Studies (SOAS),Londra.
Ivy M., 1995. Discourses of the Vanishing. Modernity, Phantasm, Ja- pan, University of Chicago Press, Chicago.
Iwabuchi K., 2002. Recentering Globalization. Popular Culture and Japanese Transnationalism, Duke University Press, Durham e Londra.
Jinnai H., 1995. Tokyo. A Spatial Anthropology, University of Ca- lifornia Press, Berkeley e Los Angeles. Traduzione di Kimiko Ni-
81

Luigi Urru
shimura [1985. Tôkyô non kûkan jinruigaku, Chikuma Shobô, Tokyo].
Martinez D., (a cura di) 1999 [1998]. The Worlds of Japanese Po- pulare Culture. Gender, Shifting Boundaries and Global Cultures, Cambridge University Press, Cambridge.
Moeran B., 1990. “Beating About the Brush. An Example of Eth- nographic Writing from Japan”, in: Fardon F., (a cura di). Loca- lizing Strategies. Regional Traditions of Ethnographic Writing, Scottish Academic Press, e Washington: Smithsonian Institu- tion Press, Edinburgo.
Monceri F., 2000. Il problema dell’unicità giapponese. Nitobe Inazô e Okakura Kakuzô, ETS, Pisa.
Perry N., 1998. Hyperreality and Global Culture, Routledge, Lon- dra e New York.
Pons P., 1988. D’Edo à Tôkyô. Mémoires et modernités, Gallimard, Parigi.
Remotti F., 1996. “Walter Benjamin in una prospettiva antropolo- gica. Uno sguardo a ritroso sulla modernità”, in: Guglieminetti E., Perone U., e Traniello F., (a cura di). Walter Benjamin: sogno e industria, Celid, Torino, pp. 123-154.
Ronald P. R., 1995. “The Indianness of Iberia and Changing Japa- nese Iconographies of Other”, in: Stuart B. S. (a cura di), Impli- cit Misunderstandings. Observing, Reporting and Reflecting on the Encounteers between Europeans and Other Peoples in Early Mo- dern Era, Cambridge University Press, Cambridge.
Suzuki A., 2001. Do Android Crows Fly Over the Skies of an Elec- tronic Tokyo? The Interactive Urban Landscape of Japan, Archi- tectural Association, Londra. Traduzione di Keith Vincent.
Watts J. 1999 [1998]. Soccer Shinhatsubai. What are Japanese consumers making of the J. League, in: Martinez D., (a cura di)1999 [1998]. The Worlds of Japanese Populare Culture. Gender, Shifting Boundaries and Global Cultures, Cambridge University Press, Cambridge.
Yoshimoto M., 1989. The Postmodern and Mass Images in Ja- pan, in: Public Culture, anno I, n. 2. pp. 8-25.
82

MEMORIA CULTURALE, COSTRUZIONE IDENTI TARIA
IN CONTESTO EUROPEO ED EXTRA-EUROPEO ALL’INIZIO DEL SECOLO XX.
Una storia di vita
di Zelda Alice Franceschi


1. Premessa
Giorni fa, in una riunione politica, ho capito di colpo per- ché per me fosse tanto più facile essere ‘europea’ che per altri. Dovevo parlare e mi sono accorta che non avevo nemmeno più una lingua a mia disposizione. L’italiano che parlo da tanti anni mi è rimasto sempre estraneo; non ho mai voluto addentrarmici troppo per non perdere la mia lingua: il tedesco. Eppure l’ho persa; anni di amore- vole conservazione me l’hanno resa incolore e rigida, come accade con i ricordi.Questa mancanza di lingua non è tutto: non sono italiana benché abbia figli italiani, non sono tedesca benché la Germania una volta fosse la mia patria. E non sono nem- meno ebrea, benché sia un puro caso se non sono stata ar- restata e poi bruciata in uno dei forni di qualche campo di sterminio (Hirschmann 1993: 21).
Di Ursula Hirschmann, iniziatrice del movimento federa- lista europeo negli anni quaranta del novecento e fondatrice del gruppo Femmes pour l’Europe (1975), ci rimane un testo autobiografico non facile da definire (Hirschmann 1993), un taccuino in cui i ricordi si addensano sulle strade di città europee: nella Hohenzollernstrasse di Berlino ove abitava la nonna, (Hirschmann 1993: 53), al bureau di Rue de Lafayet- te, “via vai continuo di compagni francesi, tedeschi e di altre nazionalità” (Hirschmann 1993: 111) sino alla via Cesare Battisti giù verso il canale, a Trieste, ove la Hirschmann ap- prodò all’età di ventidue anni.
Nelle parole della Hirschmann, la consapevolezza di non
85

Zelda Alice Franceschi
possedere alcuna lingua con cui esprimersi trova un compi- mento sofferto nel sentirsi però parte di una grande Europa. Lo spaesamento che questa donna ha sperimentato in tutta la sua vita come migrante, esiliata e deportata diviene me- tafora di un “europeismo degli sradicati”. Questa esperienza, dolorosa e traumatica, problematizza la complessità del con- cetto di identità europea e introduce alcuni temi che vorrei cercare di affrontare. Quattro sono i concetti sui quali arti- colerò il mio discorso: Europa, Identità-Biografia, Memoria e Viaggio-Immigrazione.
Questo saggio nasce da alcune riflessioni emerse in seguito ad una esperienza di campo in cui si è cercato di ricostruire l’esperienza storico-biografica di una donna vissuta tra l’Ita-lia e il Vietnam a cavallo del secolo XIX e XX1. È stato solo dopo alcuni anni di lavoro in archivi, biblioteche e a seguito di lunghe interviste ed estati in compagnia di questa donna, che sono affiorate problematiche le cui istanze erano diverse e congiunte al contempo. Quale significato attribuire al con- cetto di identità? Ha senso oggi parlare di identità euro- pea? Quale il valore della memoria? Del ricordo e dell’oblio? Esistono forse taciti fantasmi che ritornano, costanti e im-placabili2, nelle storie di immigrazione, nei viaggi? Spettri co- stituiti da rappresentazioni, desideri, emozioni e ricordi pront i a formare le identità a plasmare le alterità, a dissolve- re le une insieme alle altre? Vi è forse nel mondo contempo- raneo una circolazione regolare, flessibile e fluida ma al con- tempo sistematica, un movimento identitario che modella appartenenze stratificate, memorie nomadiche, esperienze e storie in cui identità e appartenenza sono di volta in volta ri- cucite e immediatamente dissolte?
Non è facile rispondere a tali questioni; le strategie antro- pologiche nella contemporaneità sono infatti divenute dure e complicate, mentre i paradigmi abituali non solo sono salta- ti ma sempre più spesso, come ricorda l’etnologo francese Jean Jamin,
le nozioni di distanziazione, esotismo, rappresentazione dell’altro e differenza vengono inflesse, rielaborate, ria-
86

Memoria culturale, costruzione identitaria
dattate in funzione di criteri di natura non più geografica o culturale, bensì metodologica e financo epistemologica (Jamin, 1980: 16).
Nonostante, anzi forse proprio a ragione di queste com- plesse premesse, trovo possa essere interessante leggere e tentare di interpretare la contemporaneità, da un punto di vista antropologico, attraverso le ‘storie di vita’, le memorie, le biografie che ognuno di noi continua incessantemente a preservare, a difendere e svelare. Esse possono forse donar- ci una chiave di lettura che mostri le opacità della modernità, le ambiguità delle globalizzazioni e i plurimi localismi del quotidiano. Ed è proprio a partire da una riflessione sulla va- lidità odierna del concetto di Europa che si tenterà di arti- colare questo discorso; l’appartenenza ad una identità euro- pea potrà infatti essere non solo decostruita (Derrida, 1991; Braidotti 1995), ma ridiscussa alla luce “delle aporie, delle nemesi, degli scherzi che il destino dell’Europa ha giocato al- le identità con esso collegate”3 (Passerini 2003: 115).
2. L’Europa a partire dall’Europa. L’Europa dopo l’Europa4
Hans Georg Gadamer in un suo scritto del 1987 ripercor- rendo autobiograficamente la storia dell’Europa attraverso le due guerre, afferma quanto l’Europa sia sempre stata carat- terizzata da una molteplicità culturale e linguistica così forte e dirompent e da dover apprendere “l’ardua lezione della coesistenza” (Passerini 1998: 7). Secondo Gadamer, il desti- no culturale dell’Europa si formò attraverso le differenze, nel dialogo tra diverse aree della creatività umana ed in partico- lare tra filosofia e scienza (Gadamer 1987: 15-33). Quest’ul- tima fu alla base dell’identità europea.
Vivere con l’altro, vivere come altro dell’altro, questo com- pito fondamentale dell’uomo ha valore sia su scala minore che maggiore. Come noi impariamo a vivere come uno con l’altro, quando noi cresciamo ed entriamo nella vita, come si dice, questo vale anche per le grandi associazioni dell’u-
87

Zelda Alice Franceschi
manità, per i popoli e gli stati. Qui vi è un particolare tratto specifico dell’Europa e cioè che essa, più di altri paesi, ha potuto imparare e ha dovuto imparare a vivere con gli altri anche quando gli altri sono diversi. In primo luogo la va- rietà linguistica dell’Europa. L’altro nel suo essere altro vie- ne spinto sempre più vicino (Gadamer 1987: 30).
La complessità dell’identità culturale europea viene bene esemplificata in due testi seminali rispettivamente di Novalis (1995) e Guizot (1871). Sono le riletture contemporanee di Franco Moretti (1993) e di Edgar Morin (1988) che hanno costituito uno spunto fecondo per una riflessione sull’Euro- pa e sul valore della sua identità oggi.
Secondo Moretti, Novalis e Guizot propongono nelle loro opere due modelli di Europa tra loro contrastanti, perché sottendono due concezioni divergenti del sacro Romano Im- pero e della conseguente nascita degli stati nazionali. Il mo- dello di Novalis è quello di un’Europa unita nella fede cri- stiana, fede capace di accorpare tra loro paesi molto diversi. Così esordisce Novalis:
Erano tempi belli, splendidi, quando l’Europa era un pae- se cristiano, quando un’unica Cristianità abitava questa parte del mondo plasmata in modo umano; un unico, grande interesse comune univa le più lontane province di questo ampio regno spirituale. Senza grandi beni terreni un unico capo supremo guidava e univa grandi forze poli- tiche (Novalis 1995: 71).
Novalis rievoca nostalgicamente l’Europa cristiana del Me- dioevo, felice, perché spiritualmente e politicamente una: alla religione cristiana spetta il compito supremo di pace e riunificazione. Novalis, come sottolinea Alberto Reale nel saggio introduttivo al testo, “ci presenta un’immagine ideale, costruita con sapiente selezione di tratti positivi ed elimina- zione degli aspetti negativi, di un’Europa unificata a livello spirituale in un unico regno. È l’immagine non di come era il Medioevo, ma di come avrebbe voluto essere” (Reale 1995:25). Nel testo di Novalis ritroviamo in nuce tutte le argo- mentazioni che vediamo essere riprese polemicamente in
88

Memoria culturale, costruzione identitaria
Guizot e che spinsero lo stesso Renan solo undici anni più tardi a costruire il suo discorso sulla nazione5. Guizot rin- viene, proprio nella caduta dell’universalismo cristiano, la causa principale della nascita degli stati europei. La gran- dezza e la forza di questa nuova Europa non consiste più nell’essere unita attorno ad un unico centro di potere spiri- tuale e politico, ma emerge attraverso il suo essersi frantu- mata in una miriade di stati differenti in virtù della loro or- ganizzazione politico-sociale e della loro tradizione lingui- stico-letteraria. All’idea di un’Europa che attingeva la sua forza da un patrimonio comune, subentra la concezione che sono proprio le differenza culturali all’origine dell’Europa degli stati nazionali:
Ben diversa è stata la realtà della civiltà dell’Europa mo- derna. Senza entrare nei minimi particolari, guardateci, raccogliete i vostri ricordi; essa vi sembrerà all’istante va- riegata, confusa, tumultuosa ; ogni forma, ogni principio di organizzazione sociale vi convivono: i poteri spirituale e temporale, gli elementi teocratico, monarchico, aristocra- tico, democratico, ogni classe, ogni situazione sociale s’in- trecciano[…]. E queste forze diverse sono tra di loro in uno stato di lotta continua, senza che nessuno arrivi a soffocare le altre e a impadronirsi da sole della società (Guizot 1871: 37).
Nelle pagine di Guizot si fa strada l’idea nuova e feconda di una Europa come mutevole campo di forze il cui caratte- re, come dice Morin è “di riunire insieme senza confonderle le più grandi diversità e di associare i contrari in maniera non separabile” (Morin 1988: 22). Come per Renan la nazione non poteva essere una realtà che si potesse descrivere, og- gettivare, identificare precisamente e facilmente riconoscere entro confini, limiti territoriali e caratteristiche biologiche, così era l’Europa che Guizot auspicava. L’aspetto innovativo nei due testi, tra l’altro quasi contemporanei, risiede proprio nel loro “antiessenzialismo”; alla base del concetto di nazio- ne e di Europa, si possono intravedere sempre una “serie di fatti contingenti, di divisioni artificiali, di combinazione e di conquiste, ma in nessun modo un principio necessario e na-
89

Zelda Alice Franceschi
turale” (Poutignat e Streiff-Fenart 2000: 27). Elemento cen- trale di questa Europa come sistema complesso è la “dialo- gica interculturale”, cioè l’interazione tra culture differenti costituita “non solo di complementarietà, ma anche di com- petitività e di antagonismo” istanza che richiede, “per la sua comprensione, l’associazione complessa dell’ordine, del di- sordine e dell’organizzazione (Morin 1988: 22). L’Europa dunque, secondo questa interpretazione, si sarebbe formata nella sua essenza attraverso questa ininterrotta molteplicità: la sua identità richiede differenza e comporta inevitabil- mente l’alterità.
D’altra parte, è chiaro che questa civiltà non possa essere cercata, che la sua storia non possa essere attinta nella storia di un unico Stato europeo. Sebbene ha unità, non dimeno la sua varietà è prodigiosa; non si è sviluppata per intero in nessun paese in particolare. I tratti della sua fisionomia sono dispersi: occorre cercare talvolta in Ger- mania, talvolta in Inghilterra, ora in Italia o in Spagna, gli elementi della propria storia (Guizot 1871: 6).
Nelle parole di Guizot sono proprio le metamorfosi, le tra- sformazioni continue e incessanti che portano al plasmarsi dell’identità europea. Ne esce un’Europa la cui geografia è in- stabile e le cui frontiere sono mutevoli; un’Europa, è bene sottolinearlo, nata sulle frontiere, piuttosto che tra i confini, e che, seguendo ancora Morin nemmeno “si può definire per mezzo di frontiere storiche stabili e chiuse […] luogo di dis- sociazione ed associazione, di separazione e articolazione” (Morin, 1988: 31). Così, con la nascita del concetto di Europa, nozione geografica senza frontiere, dissolvenza frantumata se se ne vuole trovare unità e compattezza, sembrano scompari- re già quelle distinzioni dicotomiche quali dentro-fuori, cen- tro-margine, mentre iniziano ad emergere le zone “in between”, i territor i interstiziali ove ibridazione e contamina- zione sono processi sempre in fieri (Franceschi, Fortunati2000). Ed è interessante notare quanto oggi si rivaluti, nell’a- nalisi antropologica del mondo contemporaneo, proprio il
90

Memoria culturale, costruzione identitaria
concetto di frontiera preferendolo sempre più spesso a quello di confine. La frontiera infatti come chiarisce Ugo Fabietti
è qualcosa che nel momento in cui separa, unisce […] allo scopo di figurarci qualcosa che separa e unisce allo stesso tempo, dobbiamo pensare a una specie di “terra di nessu- no” posta tra due spazi (non necessariamente da inten- dersi in senso “geografico”) ciascuno dei quali è occupato da una società o da una cultura con uno stile distinto da quello dell’altra (Fabietti 1995: 104-105).
Ma soprattutto l’aspetto che emerge nelle pagine di Guizot è un’Europa che “non rimpiange l’unità perduta” (Moretti,1993: 840) e in cui gli stati nazionali, la nazione dunque, presenta proprio quei caratteri individuati da Renan: non una realtà oggettivabile e descrivibile entro confini, limiti territoriali , caratteristiche biologiche. In definitiva sia nel testo di Guizot, come nel discorso di Renan, si intravede lo spirito e il carattere delle comunità immaginate, così come vengono descritte da Benedict Anderson e ove la nazione è:
una comunità politica immaginata, e immaginata come intrinsecamente insieme limitata e sovrana. È immaginata in quanto gli abitanti della più piccola nazione non cono- sceranno mai la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, eppure nella mente di ognuno vive l’immagine del loro essere comunità (Anderson 1996: 26-27).
Se dunque i caratteri propri dell’Europa6 rientrano nella definizione di comunità immaginata di Anderson, il cui “spi- rito è evanescente e asettico” la cui essenza nasce “dal caos, i cui confini sono incerti, a geometria variabile, suscettibili di slittamenti, rotture, metamorfosi” (Morin 1988: 29), viene spontaneo interrogarsi sulla natura della sua identità, sul- l’essenza della sua memoria. Infatti, se l’idea di Europa come unitas multiplex era già presente nell’Encyclopédie curata da Denis Diderot (Morin 1988: 24; Passerini 2003: 103) fu solo molto più avanti che si iniziò a problematizzare l’idea dell’i- dentità e della specificità europea; esempi eclatanti sono in-
91

Zelda Alice Franceschi
fatti le storie canoniche dell’Europa, (Chabod 1961; Curcio1958; Duroselle 1965; Voyenne 1964) che accennavano so- lamente alla questione dell’identità europea.
Parlare oggi di identità, ed in specifico di identità euro- pea, si è rivelata un’operazione complessa per varie ragioni; una fra le tante riguarda proprio i movimenti culturali e le di- namiche sociali del mondo contemporaneo contrassegnati da costanti delocalizzazioni (Hannerz 1998: 322; Fabietti2000: 178) e deterritorializzazioni (Appadurai 1991). Da que- sto nuovo panorama emerge una dialettica profonda tra iden- tità europea e migrazioni, la cui rappresentazione, o meglio la cui “narrativizzazione” si esplica e prende corpo a partire da memorie culturali specifiche, ben localizzate, ma di volta in volta rinegoziate, riconfigurate e riplasmate attraverso le ibridazioni, i meticciati, le connessioni (Amselle 1999; 2001). Come sottolinea Callari Galli diviene indispensabile indagare
le strategie e le pratiche discorsive messe in atto dai singoli gruppi che vivono la diaspora perché esse rivelano che l’e- sperienza della diaspora e dell’esilio rafforza anche i legami con il mondo più vasto, fornendo visioni unitarie e com- plesse sia del ‘locale’ che dell’ ‘altrove’, sie della durezza pre- sente che del rimpianto nostalgico (Callari Galli ivi).
Queste riflessioni potranno forse far luce sui diversi con- cetti di appartenenza e presenza (Fabietti, 2000), memoria e ricordo (Assmann, 2002), identità e identificazione (Bhabha1990; Passerini 2003).
3. Oltre la biografia, al di là dell’identità
Biografia e storie di vita. Analizzare i due etimi può forse aiu- tarci a comprendere perché si è scelto questo genere, perché si è privilegiata questa metodologia7. Dopo avere infatti ana- lizzato la stratificata fluidità del concetto di identità (fluidità è bene sottolinearlo contiene in sé l’idea di appartenenza e distacco, di identità e disincanto) europea vedremo come proprio nel racconto biografico emerga questa stratificazio-
92

Memoria culturale, costruzione identitaria
ne e si sveli una spuria specificità, una originale ibridità: so- no la storia e la memoria, il ricordo e l’oblio a giocare un ruolo fondamentale.
In Italia, all’interno delle discipline etno-antropologiche, viene utilizzata la dicitura ‘storie di vita’. In essa si accorpano le terminologie inglesi di “life story” e “life history” e ovvia- mente quella francese di “récit de vie”. Come sottolinea Jac- ques Le Goff
nelle lingue romanze e nelle altre, storia esprime due, se non tre concetti: 1) indagine sulle azioni compiute dagli uomini che si è sforzata di costruirsi in scienza, la scienza storica; 2) l’oggetto dell’indagine, quello che gli uomini hanno compiuto e secondo Paul Veyne, ‘la storia è sia un susseguirsi di avvenimenti, sia il racconto di questo susse- guirsi di avvenimenti’. Ma la storia può avere un terzo si- gnificato, precisamente quello di racconto. Una storia è un racconto che può essere vero o falso, con una base di realtà storica, o puramente immaginario (1978: 566).
Il termine francese récit ha in sé l’idea del ‘leggere a voce al- ta’ e ‘recitare a memoria’; la voce biografia infine ha nel suo etimo l’idea dello scrivere (bios e graphia). Nelle storie di vita e nelle biografie convivono quindi la volontà di pervenire ad una ricerca oggettiva, la soggettività propria del raccontare, del ‘rammemorare’, la capacità di ‘recitare’ ed infine la possi- bilità di riscrivere, di ricomporre. La biografia e la ‘storia di vi- ta’ in questo senso rappresentano una metodologia complica- ta da definire, una sorta di ‘non detto’ nella storia dell’antro- pologia; in essa infatti sono condensate alcune delle proble- matiche più scottanti della disciplina e che solo l’antropologia moderna ha cercato di affrontare. Da sempre utilizzate per la raccolta di materiale etnografico, su di esse in quanto ‘materia’ umana e personale a lungo si sorvolò preferendo invece con- centrare l’attenzione sul dato: matrimoni , genealogie, riti, cul- tura materiale; questi erano gli elementi sui quali si poteva fon- dare la costruzione di culture oggettive, solide, omogenee. Può essere interessante notare a questo proposito come fin dai suoi esordi questa metodologia si dimostrò particolarmente
93

Zelda Alice Franceschi
adatta per raccogliere storie di immigrazione, in cui il metic- ciato era elemento fondante, racconti di individui che si tro- vavano sempre tra qualche cosa8, posizionati in “between”, sulla frontiera appunto, di una o più culture. Il dato biografi- co divenne allora elemento fondante per dimostrare l’inesi- stenza della purezza, dell’omogeneità e compattezza culturale; non è una caso infatti che esso si fece anche portavoce di tut- te quelle stratificazioni sociali e culturali come “la cultura del- la povertà”, “la cultura analfabeta”, “la cultura della diaspo- ra”. Possiamo tentare oggi di leggere le ‘storie di vita’ come fossero uno specchio sulle discipline etno-antropologiche, la loro utilizzazione da parte degli antropologi riflette in modo preciso ed accurato le ideologie, le influenze del loro pensiero a livello teorico ed epistemologico; non solo, esse possono rappresentare una sorta di “termometro sociale” che misura i livelli di cambiamento e continuità, un termometr o acceso e sempre attento per ricordare quanto sia complesso e intricato il rapporto tra individuo e società. Proprio per il loro caratte- re inadatto al compromesso e alla mistificazione le ‘storie di vi- ta’ si rivelarono fin da subito ‘costrutti culturali’ che non era- no rappresentativi dell’universale modalità di raccontare l’e- sperienza di una vita9. La certezza che questa “testualizzazio- ne” non abbia rappresentato l’universale e naturale modalità di raccontare la propria esistenza, si scontrano oggi non solo con il proliferare di opere di carattere autobiografico, ma con la consapevolezza che esse sono divenute col tempo, nella storia, attraverso la storia, un veicolo e uno strumento di co- noscenza del nostro mondo contemporaneo, occidentale e non occidentale. Partendo da questo presupposto teorico ho tentato di sviluppare un’ipotesi che ha guidato – forse impli- citamente – il rapporto tra biografie e mondo antropologico contemporaneo: attraverso l’incontro della e nella narrazione biografica, rito antropo-poietic o (Remotti 1996b: 9-27)10 di iniziazione, si ‘rinasce’ mutati , vengono modificati i ‘contenu- ti’ e trasformati i ‘contenitori’ di tali narrazioni. Ciò che viene narrato contribuisce, lo dicono molto bene gli antropologi contemporanei11, alla costruzione di un sapere che è oggi ‘di frontiera’, attento a cogliere le maniere diverse e incomplete in

94

Memoria culturale, costruzione identitaria
cui si realizza un’identità. Quest’ultima, nonostante la flui- dità e l’ibridità che la caratterizza, preserva ancora lingue, dialetti, culture, che hanno viaggiato, si sono spostate, ferma- te e di nuovo sono partite. La narrazione biografica, che nella‘storia di vita’ vede il suo corollario antropologico, nella con- temporaneità riesce a svilupparsi con caratteristiche formali ed epistemologiche ben precise e con scopi determinati ravvisa- bili attraverso quelle che Amselle chiama “connessioni” (Am- selle, 2001). Esse non solo possono dare conto della stratifi- cazione identitaria di ognuno, ma tentano in qualche modo di ricostruire e ‘ricompattare’ elementi eterogenei. Le narrazioni biografiche, le ‘storia di vita’, mostrano proprio attraverso il loro valore di testimonianza storica e autobiografica e il ca- rattere frammentari o e incompleto che le caratterizza, di essere una ‘cerniera’ tra il “globale” il “locale”, tra l’individuo e la so- cietà, tra il passato, il presente e il futuro della disciplina. È nel raccontare, nelle modalità di gestire il dialogo, di tacere e di parlare; in luoghi diversi, con lingue altre, che si individuano oggi le strade, i percorsi, le tracce lasciate da ognuno nel cor- so della propria esistenza.
Molteplici potrebbero essere quelle testimonianze capaci di dar conto di percorsi biografici contrassegnati dallo sposta- mento, dal viaggio, dall’immigrazione12. Il narrare autobio-grafico si configura come una ‘nicchia’, un ‘serbatoio’ ove po-ter conservare e quindi in seguito ‘esibire’ un patrimonio al- trimenti silenzioso e deperibile; la scrittura autobiografica, il narrare biografico, quelle che l’antropologia chiama ‘storie di vita’, possono rappresentare la ‘metodologia’ e il ‘genere’ che forse più di altri riescono a tenere conto della complessità dei mondi contemporanei: sono le donne, gli esiliati, i deportati, gli immigrati, i ‘colonizzati’, coloro che parlano, che costrui- scono narrazioni, che attraverso le loro storie e i loro raccon- ti riconfigurano l’assetto del locale e del globale.
Nel suo viaggio attraverso le generazioni e le culture, il racconto emerge per la sua capacità di adattamento ed evoluzione, mentre con l’esilio e l’emigrazione, il viaggio si espande nel tempo e nello spazio ed il racconto diventa confusamente complesso nei suoi effetti ripercussivi. En-

95

Zelda Alice Franceschi
trambi sono soggetti agli azzardi del dislocamento, l’inte- razione e la traduzione; entrambi, tuttavia, hanno la po- tenzialità di ampliare gli orizzonti dell’immaginazione in- dividuale e di spostare il confine tra realtà e fantasia, del qui e del lì; entrambi contribuiscono a mettere in questione i limiti prestabiliti di ciò che, nella vita di tutti i giorni, viene considerato ‘comune’ e ‘normale’, offrendo quindi la possibilità di un altrove-qui o lì (Trinh 1994: 11).
Seguendo il percorso individuato da Trinh Minh-ha, il va- lore autobiografico dei ricordi, delle memorie e degli oblii per coloro che hanno sperimentato la ‘dislocazione’ volon- taria o forzata, è legato ad un processo doppio: di ‘strania- mento’13 da una parte e di ‘riappropriazione’ dall’altra. Come dice Trinh Minh-ha:
Ciò che scelgono di raccontare non appartiene più a loro(Trinh 1994: 10)14.
Il materiale che viene scelto per essere depositato, ‘trat- tenuto’ e dunque raccontato, non appartiene più a colui che ricorda e nemmeno a colui che è ricordato. È come se l’esperienza dell’alterità sperimentata attraverso lo ‘stra- niamento’ producesse uno iato spaziale, temporale e iden- titario tra colui che ricorda e ciò che viene ricordato, tra colui che vede e colui che è visto. Il risultato di questo passaggio è quindi un ‘prodotto’ nuovo, un “investimento immaginativo”, un “atto creativo”. La ‘dislocazione’, il viaggio, l’incontro con l’alterità sollecitano il racconto bio- grafico, ma esso si configura come una narrazione che ha peculiarità sue proprie , che si differenzia dalla biografia classica non tanto nei paradigmi strutturali quanto piutto- sto nella sua valenza e rappresentazione. Come il vino no- vello ottenuto attraverso precise tecniche di fermentazione, imbottigliato poco dopo la vendemmia risulta particolar- mente profumato e fragrante, così questo tipo di narrazio- ne biografica possiede sue modalità di sedimentazione du- rante le quali cambiano le forme, si trasformano gli equili- bri, mutano le configurazioni.
96

Memoria culturale, costruzione identitaria
Ma andiamo per gradi: ripartiamo dall’identità. La cate- goria di identità, come sottolinea Cristina Demaria nell’in- troduzione del saggio di Stuart Hall (Hall 2002) provocato- riamente titolato, “A chi serve l’identita?” “è un’invenzione moderna, che non è divenuta problematica nel corso del tempo, bensì è nata come problema […], può esistere solo come problema” (Bauman 1996 in Demaria 2002: 119). Og- gi parlare di identità, e soprattutto di identità europea, si- gnifica configurare un percorso di rotture, movimenti, at- traversamenti di spazi (Bhabha 1997; Grossberg 1996). Le identità vengono analizzate come “effetti temporanei e in- stabili di relazioni tra differenze” (Demaria 2002: 120); par- lare di identità, significa situarsi all’interno delle specifiche evoluzioni e pratiche storiche che hanno riconfigurato il ca- rattere relativamente “fisso” di culture e popoli; e ancora, in- dagare sull’identità vuole dire riposizionarsi rispetto al pro- cesso di globalizzazione. Infine, intraprendere un’analisi del concetto di identità, ha un significato nella misura in cui si ha l’accortezza di domandarsi non tanto
da dove veniamo, quanto piuttosto cosa possiamo diveni- re, come siamo stati rappresentati, e come tutto ciò si re- laziona con le nostre stesse modalità di autorappresenta- zione (Hall 2002: 134).
Ed è esattamente in questo senso che va interpretata e de- codificata l’identità europea, è precisamente in questo sce- nario che agisce e si costruisce la memoria culturale.
Dopo avere evidenziato alcuni dei processi atti a deco- struire e smontare la categoria dell’identità, è innegabile con- statare quanto di identità si continui comunque e incessante- mente a parlare. Perché? Quali frammenti la contempora- neità ha deciso di riutilizzare? E con quali potenzialità? E an- cora, chi dell’identità europea è testimone e ambasciatore?
Non troveremo certo risposte esaustive a tali quesiti, ma le questioni legate alla memoria culturale possono forse fornire interessanti suggestioni.
In primo luogo, è importante ricordare che alla base della
97

Zelda Alice Franceschi
rappresentazione e della costruzione della nazione si trovino il ricordo e l’oblio. Eppure, scrive Renan:
l’essenza di una nazione sta proprio nel fatto che tutti i cit- tadini abbiano molte cose in comune e che molte ne ab- biano dimenticate (Renan 1997: 48).
4. Il ricordo della memoria, l’oblio: il narrare della storia
La memoria culturale in questo senso rappresenta una ere- dità che ogni nazione si è creata per plasmare la propria identità. Essa agisce sempre su due assi parallele e comple- mentari al contempo: il ricordo (la memoria) e l’oblio (l’am- nesia). Seguendo il percorso di Jan Assmann, secondo il quale “le società hanno bisogno del passato in primo luogo ai fini della loro autodefinizione” (Assmann 1997: 101), la ri- visitazione storica dell’identità europea e la sua decostru- zione “oltre a dar conto di molte dinamiche politiche verifi- catesi nei singoli contesti nazionali, fa emergere la produ- zione culturale delle minoranze, degli oppressi, dei coloniz- zati, ponendola in relazione con la cultura dominante (Cal- lari Galli 2000: 15). È in questo scenario che trovo partico- larmente interessante rileggere la storia dell’identità europea come narrazione: “narrazione” nel viaggio, nell’immigrazio- ne, narrazione che il soggetto di volta in volta rappresenta, articolazione e giuntura tra i diversi punti di approdo nella costruzione identitaria. E non è un caso che Homi Bhabha in un testo da lui curato sul rapporto tra nazione e narrazione (Bhabha 1997) ponga a inizio del suo saggio il racconto del viaggio e dell’esilio che personalmente ha sperimentato, tra le strade delle nazioni del mondo:
Ho infatti vissuto il momento della dispersione di un po- polo che in altri tempi e luoghi – e nelle nazioni di altri – diviene momento di riunione: riunione di esiliati, emigra- ti e rifugiati, di culture ‘straniere’ marginali; riunione alle frontiere, nei ghetti e nei caffè dei centri urbani; riunione nella vita stentata e condotta all’ombra di lingue straniere,
98

Memoria culturale, costruzione identitaria
o nel fluire misterioso di una lingua che non è la propria; riunione dei segni di approvazione e accettazione, di ge- rarchie, discorsi e discipline; riunione di memorie del sot- tosviluppo, di altri mondi vissuti in modo retrospettivo; riunione del passato in un rituale rivitalizzante; riunione del presente (Bhabha 1997: 469).
La memoria, il ricordo, la consapevolezza della necessità dell’oblio sono temi costanti e ricorrenti nella storia della let- teratura antropologica contemporanea; c’è chi ha parlato, pensando alla ricostruzione storica, culturale e politica del- l’Argentina contemporanea da parte di alcuni studiosi di scienze sociali, di “epidemie di memoria” di “eccesso di passato” (Lazzarato 2003). Contrariamente a quanto sta ac- cadendo oggi, cercheremo invano nella storia della disciplina antropologica se volessimo trovare “trattati” specifici sulla memoria15; inutile sarebbe voler reperire una definizione di “memoria culturale”; questa poca attenzione alla memoria, credo sia legata a molteplici fattori. In primo luogo occuparsi della memoria culturale (perché è di questa che l’antropolo- gia dovrebbe occuparsi) probabilmente poneva una serie di problemi epistemologici che l’antropologia ai suoi esordi non era pronta ad affrontare. Non è un caso che Halbwachs si concentrò sulla memoria collettiva e sociale (Halbwachs1987; 1997) sfiorando tutto quanto riguardava invece la me- moria individuale, personale, soggettiva, “emozionale”. Può essere interessante ricordare l’etimologia della parola ricor- do: recordari; re-cor, rimettere nel cuore. Aleida Assmann a questo proposito sottolinea le puntualizzazioni di Friedrich G. Jünger e distingue i termini Gedächtnis (memoria) ed Erinnerung (ricordo) ove il primo indicherebbe il “dato mnestico” ovvero la conoscenza, mentre il secondo l’espe- rienza soggettiva (Assmann 2002: 29). Il destino della me- moria in ambito antropologico segue in maniera quasi ine- sorabile quello delle “storie di vita”, delle biografie e auto- biografie. Di esse era consigliabile occuparsi il meno possi- bile perché mettevano il luce tutto quanto la disciplina cer- cava di celare e nascondere: il complesso rapporto tra l’an- tropologo e il suo informatore; i problemi legati all’oralità,
99

Zelda Alice Franceschi
alla trascrizione e traduzione dei testi; la relazione spazio- tempo così come era vissuta e raccontata da popolazioni al- tre, non occidentali, ed infine parlare della memoria avrebbe messo in luce i complessi e sottili meccanismi che legavano l’antropologia alla politica e al potere. Franz Boas, colui che formò alcuni dei più accaniti sostenitori del metodo biogra- fico, così si esprimeva rispetto alla biografia e alla memoria:
La letteratura antropologica moderna mostra come l’os- servazione ravvicinata delle vite individuali sia considerata essenziale per un ulteriore progresso, e nuovi metodi siano stati concepiti per ottenere le informazioni necessarie. Il valore di alcuni di questi metodi mi sembra dubbio. È ovvio che, tralasciato l’esperimento di laboratorio, l’unica via per ottenere le informazioni necessarie resti una ravvi- cinata e continua esperienza di vita con i popoli e una perfetta padronanza della loro lingua […]. Uno dei meto- di per superare tali difficoltà è chiedere ai nativi di scrive- re o raccontare le proprie autobiografie. I migliori tra loro riportano informazioni preziose riguardo alla lotta gior- naliera per la sopravvivenza e alle gioie e dolori del popo- lo, ma la loro affidabilità, al di là dei punt i più elementari, resta dubbia. Non si tratta di fatti ma di memorie, memorie distorte dai desideri ed i pensieri del momento […]. Re- centemente Lowie ha pubblicato alcune versioni di una storia Crow, raccontata in diversi momenti dallo stesso individuo, che presentano sensibili variazioni nella trama e nei motivi. Io ho pubblicato alcune simili registrazioni della stessa storia, raccontata dallo stesso informatore do- po un intervallo di circa quarant’anni, che mostra la sta- bilità degli elementi formali e la variabilità dei motivi. Questo è ciò che succede molto spesso nelle registrazioni d’esperienze personali. La stessa persona mi ha raccontato degli eventi della propria vita a volte come avvenimenti semplici ed oggettivi, altre volte come esperienze sopran- naturali […]. Le autobiografie […] hanno valore piuttosto come materiale per lo studio della distorsione della verità giocata dal ruolo della memoria nel tempo. Per il resto, non sono altro che una descrizione di costumi raccolta nella ma- niera tradizionale (Boas 1942: 334-335).
La memoria, l’autobiografia e le “storie di vita” non sola- mente rappresentavano quella storia evenemenziale che l’an-
100

Memoria culturale, costruzione identitaria
tropologia boasiana aveva sempre trattato con sospetto, ma di- storcevano i fatti e la realtà, producendo una sorta di divario temporale e spaziale tra Storia e testimonianza, tra ricordo e Ve- rità. Un secondo motivo che portò ad una disattenzione co- stante nei confronti della memoria è il rapporto controverso e ambiguo che l’antropologia ebbe con la storia e quindi con il tempo. Quest’ordine di problemi era da una parte legato a complessi rapporti disciplinari e dall’altro ad un profondo disagio nell’occuparsi della rappresentazione di temporalità al- tre (Viazzo 2000; Fabian 2000). Tracciare e ripercorrere il rapporto che l’antropologia ebbe con la storia e la memoria è davvero complesso; basti pensare alle annotazioni di Lévi- Strauss nella critica all’opera di Sartre (Lévi-Strauss 2003). Lévi-Strauss, che aveva antesignanamente intuito molte delle problematiche che l’antropologia geertziana e post-moderna avrebbero in seguito affrontato, così si esprimeva:
ogni ricerca etnografica muove da ‘confessioni’ scritte o in- coffessate […] di conseguenza il fatto storico non è più da- to degli altri; è lo storico, o l’agente del divenire storico, che lo costituisce per astrazione, e come sotto la minaccia di una regressione all’infinito […]. Anche da questo pun- to di vista, lo storico e l’agente storico scelgono, eliminano e sottolineano, perché una storia davvero totale si risolve- rebbe nel caos (Lévi-Strauss 2003: 271-279)16.
Le pagine di Lévi-Strauss sono davvero illuminanti e rie- scono ancora ad essere di grande attualità. Nell’operazione dello storico che sceglie, elimina e riprende; e poi incasella, ordina e setaccia vi sono echi platonici molto forti17; in fondo l’operazione che compie lo storico, al pari di quella dell’et- nologo consiste in una paziente e minuta ricostruzione, in un lungo riaggiustamento temporale, in un complicato rimo- dellamento spaziale. Seguendo ancora Lévi-Strauss:
L’etnologo rispetta la storia, ma non le concede un valore privilegiato. La concepisce come una scienza complemen- tare alla sua: l’una apre il ventaglio delle società umane nel tempo, l’altra nello spazio. E la differenza è meno grande ancora di quanto non sembri, dato che lo storico si sforza
101

Zelda Alice Franceschi
di restituire le immagini delle società scomparse quali fu- rono negli istanti che, per esse, corrispondettero al pre- sente, mentre l’etnografo fa del suo meglio per ricostruire le tappe storiche che hanno preceduto nel tempo le forme attuali (Lévi-Strauss 2003: 277-278).
Nata con l’ambizione di essere una ‘scienza esatta’, una di- sciplina ‘sperimentabile’ e comunque produttrice di leggi18, essa come esperienza etnografica e conseguente e contem- poranea elaborazione etnologica19, si rivelava in realtà una finzione, “letteraria, sistemica e concettuale” (Fabietti 1999:128-137). È proprio l’indagare sul concetto di finzione (da intendersi nella sua accezione latina di fingere, formare, pla- smare, creare, modellare) che mi ha spinto a ricostruire un percorso in cui memoria, identità, immigrazione e storia eu- ropea hanno trovato equilibri precari, incerti che si potevano guardare solamente da lontano.
5. Viaggio e immigrazione: storie contemporanee, vecchie e nuove questioni
Io sono nata non lontana dalle foreste perchè quando mia mamma mi aspettava... c’erano tutte le liane, lui vedeva tutte quelle liane, per quello che mi hanno chiamato... mi hanno chiamato... Lian20.
Juliette nacque a Bien Hoa il 21 novembre 1909, primoge- nita di cinque sorelle. Sua madre era vietnamita. Il padre Bonifacio infatti emigrò nell’anno 1908 in Indocina, ove Ju- liette abitò fino all’età di 13 anni; allora Bonifacio decise per varie ragioni di mandare le tre figlie rimaste, Juliette appunto, Giuseppina e Mary a studiare in Italia (1922-1930). Il Pie- monte era la terra d’origine della famiglia. Le tre sorelle vis- sero nel collegio di Virle la loro adolescenza; Juliette si sposò non appena terminò gli studi nell’anno 1930; Giuseppina tornò dal padre allora a Saigon e Mary, la più piccola, rimasta sola si ammalò per poi morire presto. Anche Juliette non ap- pena potè tornò dal padre in Indocina il quale intanto aveva
102

Memoria culturale, costruzione identitaria
fatto fortuna come impresario dei lavori pubblici. Tra l’inizio delle prime resistenze e l’abbandono francese dell’Indocina (1945-1954) tornarono tutti in Europa: Bonifacio e Giusep- pina “naturalizzati” francesi si stabilirono a Parigi; Juliette, il marito e i figli rientrarono in Italia. Juliette non si spostò mai più dall’Italia e Giuseppina (allo stesso modo), si stabilì a Parigi con i figli ed il marito. Ogni anno le due sorelle si ri- vedono nella vecchia casa di famiglia che il padre rimise a po- sto durante i suoi soggiorni italiani, nelle sue brevi e sporadi- che visite alle adolescenti e giovani figlie.
Il “lavoro di campo” con Juliette è cominciato, con una prima intervista nel marzo 1999. In seguito abbiamo tra- scorso insieme 15 giorni nell’anno 1999, 2000 e 2001 nella casa di famiglia in Piemonte. Durante questo soggiorno sono stati trovati vari documenti e fotografie della famiglia che so- no stati catalogati e riordinati. Juliette in queste occasioni si è mostrata sempre pronta a raccontare e a ricordare il pro- prio passato.
Nell’impossibilità di ricostruire l’intera ‘storia di vita’ di Lian, credo sia opportuno indagare le ragioni che mi hanno spinto non solo ad utilizzare un nome fittizio, Juliette, ma an- che a mantenere, sovente, il nome di battesimo. Lian mi raccontò una parte della sua vita e decise di selezionare al- cuni episodi precisi21; osservando le modalità di ricomposi-zione di questa biografia (operata da me e da Lian), mi ac-corsi, mentre Lian narrava, selezionando eventi e accadi- menti, scegliendo parole e immagini, che era necessario adot- tare un secondo nome, Juliette. Esso poteva tenere conto di alcune istanze metodologiche che questa narrazione com- portava. Il nome di Lian, mantenuto nel corso dell’intera ricerca, ha cercato di mostrare la difficile mediazione che questa donna dovette operare durante ogni nostro incontro su quanto scelse di rappresentare. C’era il racconto, la ‘rap- presentazione’ della sua esistenza, la sua ricomposizione, e al contempo c’era un’identità storica, quella rappresentata dai documenti, dalle fotografie e legata quindi al suo intero per- corso biografico, alla sua ‘storia’. L’utilizzazione dei due ap- pellativi, Lian e Juliette, vuole mostrare quindi il difficile
103

Zelda Alice Franceschi
equilibrio tra storia di vita e biografia antropologica, tra bio- grafia e autobiografia letteraria.
Lian e Juliette, Juliette e Lian: ognuna porta con sé una sto- ria, un racconto, una vita differente. Prima di cominciare la ricostruzione della ‘storia di vita’ di Juliette, credo possa es- sere interessante capire che cosa successe quel giorno del marzo del 1999: quando Lian decise di narrarmi la sua bio- grafia, quando a poco a poco prese forma la ‘storia di vita’ di Juliette. Fu infatti da quella giornata che Lian prese una de- cisione sulla quale poi non volle più tornare: io avrei cono- sciuto la vita di Juliette, lei mi avrebbe raccontato quella par- te di esistenza, io sarei divenuta colei che la ascoltava, che pa- zientemente trascriveva ogni sua parola; ma soprattutto io ero colei che avrebbe accettato questo tacito accordo. Lian di questo lungo percorso tra memorie, ricordi, fotografie e vec- chie storie, non voleva conoscerne nemmeno l’esistenza.
L’utilizzo di uno pseudonimo capace di preservare l’inti- mità di colei che nel corso di questi ultimi tre anni mi ha narrato la sua vita, elimina forse l’unico “punto fisso in un mondo in movimento” (Ziff, in Bourdieu 1995: 74), il solo attestato ufficiale di una “identità sociale costante e durevo- le”: il nome proprio. Non ho sentito raccontare e non ho ri- scritto la storia di Lian, ma mi è stato consentito di ascoltare e ‘registrare’ alcuni eventi della vita di Juliette. Quali impli- cazioni può avere questo ‘passaggio’, questa ‘metamorfosi’ che riempie ogni momento della narrazione, nelle operazio- ni di ricomposizione e ‘ricucitura’ di una vita? Nella pratica di conoscenza e interpretazione di una ‘storia’? E ancora: quali conseguenze questa ‘alterazione appellativa’, e quindi identitaria, porterà nel percorso concreto della vita di Lian? E in quello di Juliette? Secondo Pierre Bourdieu,
in quanto istituzione, il nome proprio si sottrae al tempo, allo spazio e alle variazioni secondo i luoghi e i momenti e così assicura agli individui designati, al di là di ogni cam- biamento, di ogni fluttuazione biologica e sociale, la co- stanza nominale, l’identità col senso di identità con sé stessi, di constantia sibi, che l’ordine sociale richiede […]. Il nome proprio è l’attestato visibile dell’identità di chi lo
104

Memoria culturale, costruzione identitaria
porta attraverso il tempo e gli spazi sociali, il fondamento dell’unità nelle sue manifestazioni successive e della pos- sibilità socialmente riconosciuta di totalizzarle nelle regi- strazioni ufficiali, curriculum vitae, cursus honorum, casel- lario giudiziario, necrologio o biografia, che costituiscono la vita in totalità conclusa dal verdetto emesso su un bi- lancio provvisorio o definitivo (Bourdieu 1995: 75).
La continuità e la coerenza con se stessi, con il proprio per- corso individuale, secondo l’opinione di Bourdieu, è assicu- rata, almeno nelle sue implicazioni più ‘esterne’, attraverso l’attribuzione del nome proprio. È indicativo a questo propo- sito come Bourdieu non ci sveli che cosa, secondo lui, la bio- grafia, rappresenti né come ‘genere letterario’, né tantomeno come ‘metodologia d’indagine’. Egli ci mette al corrente sola- mente di cosa essa non dovrebbe rappresentare: una “sto- ria”. Bourdieu è bene attento a non entrare nel merito delle diverse accezioni che questo termine può avere: indagine, rac- conto, oggetto di indagine. La ‘storia di vita’ rimane
un artificio impeccabile […], la cui costanza probabilmen- te è solo quella di un nome proprio (Bourdieu 1995: 78).
È chiaro come l’utilizzo di uno pseudonimo giunge ad eli- minare anche quell’unica costante trovata da Bourdieu. La‘storia di vita’ antropologica che nell’utilizzo dello pseudo- nimo ripone la prima regola dell’eticità di un patto tacito e memorabile con il lettore, con l’accademia e con la società, non potrà, secondo l’interpretazione di Pierre Bourdieu, nemmeno più essere considerata un “artificio” o una “illu- sione”: cesserà di esistere anche come traiettoria, percorso e tragitto comunque discontinuo, effimero, evanescente. Una diversa posizione, più stimolante in questo contesto, mi sem- bra quella sostenuta da Philippe Lejeune:
gli pseudonimi letterari non sono, in generale, né misteri né mistificazioni; il secondo nome è autentico quanto il primo, indica semplicemente una seconda nascita: la scrit- tura pubblicata . Scrivendo la sua autobiografia, lo scritto- re ne spiegherà l’origine, come ha fatto Raymond Abellio
105

Zelda Alice Franceschi
quando dice di chiamarsi Georges Soulès e spiega le ra- gioni per cui ha scelto un secondo nome. Lo pseudonimo è semplicemente una differenziazione, uno sdoppiamento del nome, che non cambia nulla dell’identità (Lejeune,1986: 24)22.
Gli pseudonimi, secondo Philippe Lejeune, indicano quin- di l’esistenza di una seconda vita che, è bene sottolinearlo, secondo Lejeune si trova nel testo e nel testo pubblicato. Sulla carta, attraverso l’atto della scrittura, il soggetto è come se nascesse per una seconda volta. Ma questa ‘seconda vita’, nulla cambia sia a livello formale che contenutistico nell’i- dentità dell’opera e dell’autore in questione perché, non dobbiamo dimenticarlo, l’autobiografia così come viene in- terpretata da Lejeune in Le Pacte Autobiographique,
non ammette gradi: è tutto o niente (Lejeune, 1986: 25).
Altra cosa è il romanzo autobiografico, in quest’ultimo, l’utilizzo dello pseudonimo potrebbe portare a mutazioni, a rassomiglianze nell’identità tra autore e protagonista e in quant’altro si desideri. Il romanzo autobiografico, a diffe- renza dell’autobiografia, “ammette gradi” (Lejeune 1986:25). E “gradi”, vedremo, sono ammessi anche nella ‘storia di vita’, nella biografia antropologica. Anche qui il raccontare, come del resto lo scrivere il proprio percorso biografico, è come se presupponessero una sorta di “rito di passaggio”, un “rito di iniziazione” a nuova vita (Van Gennep 1981). Quale identità potrebbe allora trasformarsi? Quella del let- tore? Quella di colui che ha raccontato la propria esistenza? Perché, se ci pensiamo bene, da un punto di vista antropo- logico, l’attribuzione di un secondo nome ha in sé qualche cosa di rituale e non dobbiam o scordare che lo scopo di ogni rito, di qualunque natura e in qualunque contesto esso venga rappresentato, è proprio quello di apportare muta- menti profondi nello status individuale e sociale dell’indivi- duo. Bourdieu in realtà già ci aveva messo sulla buona strada perché, pur avendo dissolto la biografia come mero costrut- to ideologico, aveva connesso il ‘nome proprio’ al rituale
106

Memoria culturale, costruzione identitaria
sociale che gli appartiene23: l’attribuzione del ‘nome di bat- tesimo’, quella di un nuovo nome, e di uno pseudonimo quindi, rappresentano un momento rituale di tutto rispetto.
La biografia e le ‘storie di vita’, come metodologia antropo- logica, diversamente dall’autobiografia, utilizzando sistema- ticamente lo pseudonimo rivelano di contenere una vera e propria ‘performance rituale’24. La necessità di utilizzare lo pseudonim o insieme al nome di battesimo sottolineano inol- tre e ancora una volta non solo la stratificazione identitaria, ma il ricorso alla nozione di finzione nella complessa ri-co- struzione di un racconto, di una storia, di una appartenenza. Dopo avere ascoltato la storia di Juliette così come lei l’ha
narrata insieme alla storia del padre Bonifacio, dopo avere compreso quanto il rituale sia una questione legata ad un processo di rimodellamento e riaggiustamento, ho tentato di seguire una pista che mi consentisse di trovare un filo rosso tra interviste, dialoghi informali, documenti familiari, fonti storiche e letterarie. Mi sono chiesta più e più volte il senso di questa narrazione; il valore antropologico di una storia co- sì complessa da ricostruire. Juliette ha narrato nelle interviste quella parte di vita legata all’esperienza storica dell’Indocina sua e del padre, lasciando all’ ‘informalità’ (libere conversa- zioni, discussioni informali, ‘chiacchiere’) il Piemonte e tut- ti quei dettagli più personali e autobiografici dell’Indocina, gli aneddoti, le “bagatelle”. Di alcuni anni e di alcune per- sone che hanno segnato la sua esistenza non ha parlato. Lo ha fatto per preservare una esperienza di dolore e sofferenza, ma lo ha compiuto anche per ‘donarmi’ quella parte della sua vita che riteneva essere interessante per me, per le mie ri- cerche, per i miei studi. Juliette mi ha voluto ‘regalare’ un pezzo di Storia25. Sfogliare il materiale con puntiglio e guar- dare questa storia da lontano, ‘longitudinalmente’ e nel tem- po, mi ha portat o a formulare un percorso la cui istanza epistemologica risiede nella costruzione identitaria: questa donna ha tentato, in questi anni, in ognuna delle sue narra- zioni, di ricostruire la sua identità, come donna e donna im- migrata, che ha viaggiato durante tutta la sua esistenza, im-
107

Zelda Alice Franceschi
parando lingue, dialetti, formandosi in ambienti culturali e sociali differenti.
Durante questi anni di ricerca ciò che è emerso in ogni fa- se della narrazione è il “processo formativo” che questa don- na ha operato durante ogni suo racconto. I procedimenti di costruzione identitaria hanno infatti evidenziato un’iden- tità complessa, la volontà ed il desiderio di ordinare e ri- comporre la propria vita si scontrano in ogni narrazione con un’identità mista, non duplice, ma plurima. Liane e Juliette hanno poi mostrato il valore non solo della memoria e del ri- cordo ma anche ed inesorabilmente la necessità dell’oblio (Ricoeur 2000).
6. Conclusioni
I processi identitari dunque, sono processi metabolici di tra- sformazione e alterazione. Juliette nel ricordare “taglia e cu- ce”, “riannoda e separa”. Ma quello che può essere interes- sante osservare è, da che cosa parte? O meglio, che cosa sepa- ra da cosa? È complesso rispondere. Seguendo le indicazioni di James Clifford (1999), ha oggi più senso chiedersi, “tra quali luoghi ha fatto da spola?”. Questa donna ha viaggiato, ha immigrato, più volte si è radicata, altrettante è partita. E che cosa si è portata con sé? Come e dove ha potuto preser- vare la sua “piemontesità”? La sua appartenenza è molto difficile da circoscrivere, è complessa e stratificata. I luoghi di Juliette possono essere pensati come frontiere, territori di contaminazione, ma anche di vigilanza e affermazione. Ju- liette si colloca sicuramente in una linea di frattura. Può es- sere utile chiedersi, seguendo il pensiero di Amselle, o ugual- mente quello di Bhabha, se è vero che sono crollate le di- stinzioni binaria e dicotomiche e oggi ciò che emerge sono le zone “in-between”, i luoghi degli interstizi (ove i processi di contaminazione e ibridazione sono prevalenti), allora pos- siamo ripensare alle “regole” che condizionano l’assemblag- gio o la separazione? E in quale maniera? Se, come ha sug- gerito Edgar Morin, è necessaria una “riforma del pensiero”
108

Memoria culturale, costruzione identitaria
è certo che oggi vi sono maniere diverse, incomplete, prov- visorie in cui si realizzano sia l’appartenenza identitaria che il viaggio. L’esempio della storia di vita raccolta che ho qui presentato può essere letta e osservata in relazione alla com- plessità dei mondi contemporanei attraverso un approfon- dito ripensamento del concetto di identità europea. In che modo processi che investono le macrostrutture (diaspore, esili, mezzi di comunicazione) toccano la vita quotidiana di coloro che hanno già vissuto e che vivono tuttora su linee di confine? Questa fluidità culturale, questo “approccio conti- nuista” che pone l’accento sul sincretismo originario, in cui si cerca di sfuggire a classificazioni tassonomiche e a qualsiasi “metafisica della sedentarietà” (Callari Galli 2000; Callari Galli, Ceruti, Pievani 1998; Amselle 1999), dove pone l’in- dividuo, la sua memoria storica e sociale, che se è una “me- moria meticciata” per un verso, è una memoria storica pre- cisa e ben “localizzata”?
Note:
1 Cfr. Z. A. Franceschi. 2003. Le storie di vita nelle discipline etno-antro- pologiche. Percorsi metodologici per una ricerca di campo. Tesi di dottorato in Antropologia della contemporaneit à XV ciclo. Università di Milano-Bi- cocca.
2 Cfr. L. Urru. Alle volte ritornano. Fantasma e nomadismi nippo-occi- dentali in questo volume.
3 La citazione è stata lievemente modificata.4 Ringrazio Vita Fortunati per avermi dato l’ispirazione per questa parte
del saggio. Cfr. V. Fortunati. 1996.5 La lezione di Renan fu pubblicata in Oeuvres Complètes, Paris, 1947-
61, vol. I, pp. 887-907. Viene qui utilizzata la traduzione di A. Perri con le annotazioni di M.Tom pubblicata con il titolo di “Cos’è una nazione”. In H. K. Bhabha 1997.
6 Sono interessanti, ma non è possibile ampliare qui il discorso, le critiche di Homi K. Bhabha al pensiero di Anderson sul concetto di “comunità immaginate” in riferimento soprattutto al pensiero di E.Renan. Cfr. Homi K. Bhabha. 1994, pp. 160 e seguenti.
7 Il discorso sulle “storie di vita” come genere letterario o metodologia di ricerca è molto vasto e non è possibile trattarlo in questa sede. Per una esau- stiva trattatazione cfr. Z. A. Franceschi. 2003. Le storie di vita nelle discipli- ne etno-antropologiche. Percorsi metodologici per una ricerca di campo. Tesi di
109

Zelda Alice Franceschi
dottorato in Antropologia della contemporaneità XV ciclo. Università diMilano-Bicocca; interessanti anche G. Marcus 1982; A. Battistini 1990.
8 Si pensi alle autobiografie raccolte da P. Radin (1883-1959), antropo- logo di origine polacca che lavorò con gli Indiani Winnebago; o anche al- l’esperienza di O. Lewis (1914-1970) che raccolse le ‘storie di vita’ degli immigrati in ambienti urbani.
9 Interessante l’articolo di G. Gusdorf del 1956 che riapparve con il ti- tolo di “Conditions and Limits of Autobiography”, in J. Olney 1980.
10 Cfr. F. Remotti 1996 b.11 Sto pensando a J. Clifford 1999 [1997].12 Si pensi per esempio alla recente pubblicazione dell’autobiografia di E.
Said 2000 [1999] e allo stesso modo alla pubblicazione di biografie di per- sonaggi meno conosciuti.
13 In letteratura lo straniamento è un “procedimento compositivo mi- rante a generare una nuova e inconsueta visione di una realtà già nota, me- diante la modificazione delle tecniche espressive e la deformazione degli automatismi del linguaggio comune. Nel teatro e nel cinema, senso di distacco dello spettatore nei confronti della vicenda rappresentata, pro- vocato da un autore o da un attore mediante varie tecniche”, cfr. Voca- bolario della Lingua Italiana Nicola Zingarelli, Dodicesima edizione a cura di M. Dogliotti e L. Rosiello, Zanichelli, 1996. Le prime teorizzazio- ni sul concetto di “straniamento” risalgono al formalismo russo. C. Ginz- burg nel suo testo inizia proprio con una citazione di V. Sklovskij, cfr. C. Ginzburg 1998.
14 Corsivo nostro.15 Cfr. Z. A. Franceschi. Memoria e storia nelle discipline etno-antropo-
logiche. Saggio presentato a Bertinoro maggio 16-18-2003 nell’ambito del Convegno ACUME-GENERA L MEETING . Cfr. www.lingue.uni- bo.it/acume/up3.htm
16 Corsivo nel testo.17 Interessanti le parole di Remotti sulla costruzione identitaria. Cfr. Re-
motti, 1996 b.18 Si pensi all’articolo di F. Boas. 1940 [1887].19 Ecco il parere di Lévi-Strauss riguardo l’etnografia e l’etnologia: “Ri-
mangono da definire l’etnografia stessa, e l’etnologia. Le distingueremo, in modo molto sommario e provvisorio, ma sufficiente all’inizio dell’indagi- ne, col dire che l’etnografia consiste nell’osservazione e nell’analisi di gruppi umani considerati nella loro particolarità (spesso scelti, per ra- gioni teoriche e pratiche, ma non concernenti affatto la natura della ri- cerca, tra coloro che più differiscono dal nostro) e mira a rendere, nel mo- do più fedele possibile, la vita di ognuno di essi; mentre l’etnologia utiliz- za in modo comparativo (e per fini che in seguito bisognerà determinare) i documenti presentat i dall’etnografo. Con queste definizioni, l’etnografia assume lo stesso senso in tutti i paesi; e l’etnologia corrisponde approssi- mativamente a quel che si intende, nei paesi anglosassoni (ove il termine
110

Memoria culturale, costruzione identitaria
etnologia è in disuso), per antropologia sociale e culturale (di cui la prima si dedica in particolare allo studio delle istituzioni considerate come si- stemi di rappresentazioni, mentre l’antropologia culturale si dedica allo studio delle tecniche, ed eventualmente anche delle istituzioni considera- te come tecniche al servizio della vita sociale)”, in Lévi-Strauss 1990 [1964], 14. Questo articolo apparve nel 1949 con il titolo di “Histoire et Ethnologie”. In Revue de Métaphisique et Morale, LVI, n.3-4, pp. 363-91.
20Cfr. Intervista 10 marzo 1999. Nel corso di questa ricerca mi sono im- battuta sia nei documenti che nei dialoghi informali nell’uso dei nomi “Lian”, “Liane”, “Liana”, di volta in volta usati in modo equivalente o per sottolineare al contrario in modo consapevole i diversi contesti in cui la mia interlocutrice ha vissuto. Si è utilizzato inoltre lo pseudonimo Juliette. Cfr. spiegazione in questo saggio.
21 È in questo senso che ho tentato di ricostruire il “racconto di una vi- ta”, “le récit de vie”, “the life story”.
22 Corsivo nostro.23 P. Bourdieu non fa una reale distinzione tra biografia e storia di vita.
Forse perché comunque, come abbiamo sottolineato precedentemente, in francese récit non ha come l’inglese la distinzione tra story e history.
24 L’uso di uno pseudonimo o semplicemente delle iniziali del nome nel- le ricerche antropologiche costituisce una sorta di ‘tacito patto’ tra il ri- cercatore, i propri interlocutori e l’accademia scientifica.
25 C.Jourdan così si esprime per raccontare il doppio registro utilizzato dalla sua interlocutrice Resina: “Ma Resina non si limitava al semplice rac- conto della sua vita. Restando nei limiti della veridicità e, a volte, oltre i confini della propria consapevolezza, Resina proiettava immagini della sua vita, più per se stessa che per me. In certi casi, raccontava la storia che voleva raccontare, in altri, la storia che pensava io volessi sentire. Spesso, si faceva trasportare dalla storia stessa, ammaliata dalla scena che stava de- scrivendo, fondendo realtà e immaginazione” (Jourdan, 1997: 48-49).
111

Zelda Alice Franceschi
Bibliografia:
AA.VV., 1987. L’Identità culturale europea tra germanesimo e lati- nità, Jaca Book, Milano.
Amselle J.L., 1999 [1990]. Logiche meticce. Antropologia dell’i- dentità in Africa e altrove, Bollati Boringhieri, Torino.
Amselle J.L., 2001. Connessioni. Antropologia dell’universalità del- le culture, Bollati Boringhieri, Torino.
Anderson B., 1996 [1991]. Comunità Immaginate, Manifestolibri, Roma.
Appadurai A., 1991. “Global ethnoscapes: notes and queries for a transitional anthropology”, in Fox R.G. (a cura di) Recapturing Anthropology. Working in the Present, School of American Re- search Press, Santa Fe.
Appadurai A., 2001 [1996]. Modernità in polvere, Meltemi, Roma. Assmann J., 1997 [1992]. La memoria culturale. Scrittura, ricordo e
identità politica nelle grandi civiltà antiche, Einaudi, Torino. Assmann A., 2002. Ricordare. Forme e mutamenti nella memoria
culturale, Il Mulino, Bologna.Battistini A., 1990. Lo specchio di Dedalo, autobiografia e biografia,
Il Mulino, Bologna.Bhabha H.K., 1990. “The Third Space”, in Rutherford J. (cura di)
Identity, Community, Culture, Difference, Lawrence & Wishart, London.
Bhabha H.K., (cura di) 1997. Nazione e Narrazione, Meltemi, Roma.
Bianchi C., Demaria C., Nergaard A., (cura di) 2002. Spettri del po- tere. Ideologia identità traduzione negli studi culturali, Meltemi, Roma.
Boas F., 1943. “Recent Anthropology” in Science, Vol. 8, 1943, pp. 311-337 [Read before the American Ethnological Society, May 13, 1942].
Boas F., 1940 [1887]. “The Study of Geography”, in Race, Lan- guage and Culture, McMillan, New York, pp. 639-647.
Bourdieu P., 1995 [1986]. “L’Illusione Biografica”, in Ragioni Pra- tiche, Il Mulino, Bologna, pp. 71-79.
Braidotti R., 1995. Soggetto nomade, Donzelli, Roma.Callari Galli M., 1996. Lo spazio dell’incontro, Meltemi, Roma. Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T., 1998. Pensare la diversità.
Per un’educazione alla complessità umana, Meltemi, Roma.
112

Memoria culturale, costruzione identitaria
Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, Mondadori, Milano.
Chabod F., 1961. Storia dell’idea di Europa, Laterza, Bari.Clifford J., Marcus G.E., 1997 [1986]. Scrivere le Culture, Meltemi,
Roma.Clifford J., 1999 [1997]. Strade. Viaggio e traduzione alla fine del se-
colo XX, Bollati Boringhieri, Torino.Curcio C., 1958. Europa. Storia di un’idea, Vallecchi, Firenze. Demaria C., 2002. “Figure e strategie dell’identità postcoloniale” in Bianchi C., Demaria C., Nergaard A., (cura di) 2002. Spettri del po-
tere. Ideologia identità traduzione negli studi culturali, Meltemi, Roma, pp. 119-129.
Derrida J., 1991. L’altro capo. La democrazia aggiornata, Garzanti, Milano.
Duroselle J.B., 1965 [1964]. L’idea d’Europa nella storia, EdizioniMilano Nuova, Milano.
Fabian J., 2000 [1983]. Il tempo degli altri, L’Ancora, Napoli. Fabietti, U., 1995. L’identità etnica. Storia e critica di un concetto
equivoco, La Nuova Italia Scientifica, Roma.Fabietti U., 1999. Antropologia Culturale. L’esperienza e l’inter-
pretazione, Laterza, Roma-Bari.Fabietti U., Malighetti R., Matera V., 2000. Dal tribale al
globale. Introduzione all’antropologia, Mondadori, Milano.Fontana J., 1995 [1994]. L’Europa allo specchio. Storia di un’iden-
tità distorta, Laterza, Roma-Bari.Fortunati V., Franceschi Z., 2000. “Nazione e Utopia: Elementi
co- muni nella costruzione di due concetti ambivalenti”, in Nell’anno2000. Dall’Utopia all’Ucronia, Leo S. Olschki Editore, Firenze, pp.121-134.
Fortunati V., 1996. “Il concetto di Europa nel Romanticismo”, inLa Questione Romantica, Liguori, Napoli, pp. 15-23.
Franceschi Z.A., 2002. Le storie di vita nelle discipline etno-antro- pologiche. Percorsi metodologici per una ricerca di campo, Tesi di dottorato in Antropologia della contemporaneità XV ciclo. Università di Milano-Bicocca.
Franceschi Z.A., 2002. “La vecchiaia tra memoria sociale e me- moria autobiografica: un percorso interdisciplinare. Resoconto di una ricerca di campo”, in Guerci A., Consigliere S. (cura di) La vecchiaia nel tempo, Erga Edizioni, Genova, pp. 339-352.
Gadamer H.G., 1987. “La molteplicità d’Europa. Eredità e futu-

113

Zelda Alice Franceschi
ro”, in Krali A. (cura di) L’identità Culturale Europea tra germa- nesimo e latinità, Jaca Book, Milano, pp. 15-33.
Ginzburg C., 1998. “Straniamento. Preistoria di un procedimento letterario”, in Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza, Feltrinelli, Milano, pp. 15-40.
Grossberg L., 1996. “Identity and Cultural Studies: Is that All There Is”, in Hall S., Du Gay P. (Eds.) Question of Cultural Identity, Sage, London-Thousan d Oaks-New Delhy, pp. 87-107.
Guizot M., 1871. Histoire de la civilization en Europe, LibrairieAcadémique, Paris.
Gusdorf G., 1980 [1956]. “Conditions and Limits of Autobio- graphy”, in Olney J. Autobiography: Essays Theoretical and Cri- tical, Princeton University Press, Princeton, pp. 28-49.
Hall S., 2002 [1996]. “A chi serve l’identità?”, in Bianchi C., De- maria C., Nergaard A., (cura di) Spettri del potere. Ideologia identità traduzione negli studi culturali, Meltemi, Roma, pp. 129-155.
Halbwachs M., 1987 [1950]. La memoria collettiva, Unicopli, Milano.
Halbwachs M., 1997 [1925]. I quadri sociali della memoria, Iper- medium, Napoli & Los Angeles.
Hannerz U., 1998 [1992]. La complessità culturale. L’organizza- zione sociale del significato, Il Mulino, Bologna.
Hirschmann U., 1993. Noi senzapatria, Il Mulino, Bologna. Hobsbawm E.J., Ranger T. 1994 [1983]. L’invenzione della tradi-
zione, Einaudi, Torino.Jamin J., 1980. “Un sacré collège ou les apprentis sorciers de la so-
ciologie”, in Cahiers internationaux de sociologie, N. 68.Jourdan C., 1997. “Resina’s Life Histories”, in Canberra Anthro-
pology, Vol. 20, no. 1-2, 1997, pp. 40-54.Lazzarato F., 2003. “Volti e ricordi per il futuro”, Il Manifesto, 14
agosto 2003.Le Goff J., 1978. “Storia”, in Enciclopedia, Einaudi, Torino, pp.
566-671.Lejeune P. 1986 [1975]. Il Patto autobiografico, Il Mulino, Bologna. Lévi-Strauss C., 2003 [1962]. Il pensiero selvaggio, Il Saggiatore,
Milano.Marcus G., 1982. “Rhetoric and Ethnographic Genre in Anthro-
pological Research”, in Ruby J., (a cura di) A Crack in the Mirror. Reflexive Perspectives in Anthropology, University of Pennsylva- nia Press, Philadelphia.
114

Memoria culturale, costruzione identitaria
Moretti F., 1993. “La letteratura Europea”, in Storia d’Europa. Vol. 1 (cura di) Anderson P., Aymard M., Bairoch Q., Barberis W., Ginzburg C., Einaudi, Torino, pp. 837-866.
Morin E., 1988. Pensare l’Europa, Feltrinelli, Milano.Novalis, 1995 [1799]. La Cristianità o Europa, in Reale A. (cura di)
Rusconi, Milano.Passerini L., 1998. (cura di) Identità Culturale Europea. Idee, Sen-
timenti, Relazioni, La Nuova Italia, Firenze.Passerini L., 2003. Memoria e Utopia. Il primato dell’intersoggetti-
vità, Bollati Boringhieri, Torino.Poutignat P., Streiff-Fenart J. 2000 [1995]. Teorie dell’etnicità,
Mursia, Milano.Remotti F., 1996 a. Contro l’identità, Laterza, Roma-Bari.Remotti F., 1996 b. “Tesi per una prospettiva antropo-poietica”, in
Allovio S., Favole A., (cura di) Le Fucine Rituali. Temi di antro- po-poiesi, Il Segnalibro, Torino, pp. 9-25.
Renan E., 1997 [1947-61]. “Cos’è una nazione”, in Bhabha H.K. (cura di) Nazione e Narrazione, Meltemi, Roma, pp. 43-63.
Ricoeur P., 2000. La Mémoire, l’Histoire, L’Oubli, Seuil, Paris. Said E.W., 2000 [1999]. Sempre nel posto sbagliato, Feltrinelli,
Milano.Trinh, M.T., 1994. “Other than Myself/My Other Self”, in Ro-
bertson G., Mash M., Tickner L., Bird J., Curtis B., Putnam T., (a cura di) Travellers’ Tales. Narratives of Home and Displace- ment, Routledge, London and New York.
Van Gennep A., 1981 [1909]. I Riti di Passaggio, Bollati Borin- ghieri, Torino.
Viazzo P., 2000. Introduzione all’antropologia storica, Laterza, Ro- ma-Bari.
Voyenne B., 1964. Histoire de l’idée européenne, Payot, Paris.
115


MIGRAZIONI TRANSNAZIONALI:IL DECLINO DELLO STATO NAZIONALE?
Riflessioni antropologiche
di Bruno Riccio


1. Introduzione
Nel gennaio 1999, il premio Nobel per l’economia Amartya Sen nel recarsi alla celebre conferenza del Forum Economi- co Mondiale, che si tiene annualmente a Davos in Svizzera, viene fermato alla frontiera perché privo di visto. Agli occhi della polizia elvetica non sono sembrate soddisfacenti le spiegazioni fornite a proposito: il visto gli era stato promesso dagli organizzatori dell’evento all’arrivo in aeroporto. Né sono servite altre garanzie: carte di credito, permesso di sog- giorno americano, etc.. Il passaporto indiano in suo possesso non equivaleva certo ad uno americano o ad uno degli stati membri dell’Unione Europea! È con quest’aneddoto che l’antropologo Trouillot (2001) inizia una recente riflessione teorica sulla rilevanza dell’antropologia dello stato nell’era della globalizzazione.
Il contributo che viene presentato in questa sede si colloca all’interno di questo dibattito. Ciò che ci si propone è di contestare l’assunzione diffusa nell’antropologia dei mondi contemporanei secondo cui lo sviluppo di reti sociali tran- snazionali da parte dei gruppi migranti eroda automatica- mente la rilevanza dello stato nella vita sociale e culturale.1
All’inizio degli anni novanta si è sviluppato un nuovo ap-proccio teorico e metodologico alle migrazioni che focalizza
1 Il capitolo attinge ampiamente da una relazione presentata al convegno Nationalism, Identity and Regional Co-operation: Compatibilities and In- compatibilities, 5-9 Giugno 2002, Forlì.
119

Bruno Riccio
l’attenzione sulla capacità dei migranti di mantenere relazioni sociali multiple connettendo le società di origine e quelle di approdo e formando così reti trasnazionali che attraversano i confini politici, geografici e culturali. Come altre dimen- sioni dei processi di globalizzazione, anche le migrazioni transnazionali sono spesso considerate come un fenomeno sociale che sfida la sovranità territoriale e il potere esercitato sulle identità collettive da parte degli stati nazionali. Di con- seguenza, in un un’era globale-transnazionale sembrerebbe obsoleto continuare quel processo di ricerca definibile come “antropologia dello stato” (cf. Grillo 1980).
A questo proposito, lo scopo della discussione che seguirà è duplice. In primo luogo, si desidera illustrare, sia da un punto di vista teorico che etnografico, la rilevanza dello sta- to nell’influenzare lo sviluppo delle formazioni transnazio- nali. Inoltre, si vuole fornire un invito metodologico a com- binare, nello studio delle migrazioni, l’approccio transna- zionale con l’etnografia istituzionale ed organizzativa delle pratiche statali e parastatali.
Con questo obiettivo, si fornirà un’introduzione ai recenti tentativi di forgiare un’antropologia transnazionale e alcuni esempi di etnografia della transnazionalità. Si farà riferi- mento al caso senegalese per mostrare come l’accesso al po- tere negli stati d’origine può comportare numerose attività fi- nalizzate a cogliere le potenziali risorse economiche e politi- che dei migranti e, soprattutto, come gli stessi stati di ap- prodo siano capaci di condizionare la vita dei migranti. In se- guito si procederà ad un’analisi dell’ambivalente sviluppo delle politiche migratorie italiane. Verrà preso in considera- zione l’arcipelago delle politiche nei confronti dei migranti e si mostrerà come le loro strategie transnazionali devono co- munque essere negoziate con le rappresentazioni all’interno delle istituzioni di accoglienza tendenti a favorire l’insedia- mento duraturo da parte degli utenti stranieri. Scott (1998) sostiene che un perenne progetto statale è quello di rendere stabili le persone all’interno di un territori o definito. Di con- seguenza, lo stato è sempre stato un nemico delle persone in movimento. È interessante, a questo proposito, constatare
120

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
come tale costante storica dello stato permanga all’interno dei discorsi che animano le politiche dell’immigrazione no- nostante le trasformazioni degli apparati statali nazionali e locali. Si terminerà con un invito ad evitare una concezione reificata dello stato in modo da facilitare un’etnografia che comprenda l’interazione tra lo sviluppo di reti migratorie transnazionali e le diverse pratiche istituzionali, inserite nel- le molteplici culture organizzative che formano un contesto di accoglienza. Si ritiene che questo approccio metodologico aiuti a rappresentare i diversi punti di vista che caratterizza- no il fenomeno migratorio e che possa quindi contribuire a rafforzare l’antropologia delle migrazioni.
2. L’antropologia delle migrazioni e l’etnografia della tran- snazionalità
La recente antropologia delle migrazioni ha subito profonde trasformazioni teoriche e metodologiche beneficiando del- l’accento posto sull’anti-essenzialismo emergente dai diversi tentativi di dare vita ad un’antropologia transnazionale ca- pace di analizzare i sempre più complessi “mondi contem- poranei” (Callari Galli 2003; Rossi 2003). Allontanandosi gradualmente dai tradizionali studi fortemente localizzati si tende ora ad esplorare la sfera dell’immaginazione, la dia- spora come condizione di vita e le identità multiple che vi emergono, la costruzione immaginaria delle località e i di- versi flussi culturali nella nostra era globale di cui quello migratorio è solo un aspetto (Appadurai 2001; Clifford2001). I migranti diventano simboli di ibridità o di creoliz- zazione (Hannerz 2001) e di varie forme di riarticolazioni li- beratorie e trasgressive delle relazioni tra luoghi, culture e identità, non più considerabili come naturali e immobili (Gupta e Ferguson 1997).
Alcuni autori trovano prematuro il tono astrattamente e eccessivamente celebrativo dell’antropologia transnazionale accusandola di esaltare la figura delle persone ai margini senza preoccuparsi abbastanza della loro effettiva margina-
121

Bruno Riccio
lizzazione (Amit-Talai 1998). Vi sono comunque differenze tra i vari “approcci transnazionali” al fenomeno migratorio (Vertovec 1999). Per esempio, l’etnografia della transnazio- nalità considera il transnazionale più come una morfologia sociale (rete, comunità, movimento o campo sociale) e si fo- calizza, attraverso ricerche etnografiche “multilocali”, spe- cificatamente sul fenomeno migratorio e sullo studio di re- lazioni sociali concrete.
Infatti, molti ricercatori ed osservatori hanno constatato le molteplici modalità con cui alcuni migranti continuano ad essere orientati al ritorno e mantengono una forte identifi- cazione con il proprio contesto di partenza. Cercando di superare il modello “bipolare” che tendeva a rappresentare il migrante come uno “sradicato”, rispetto a un contesto con- siderato immutabile, che mira ad “integrarsi” faticosamente in un altro contesto (assunto come egualmente monolitico) queste etnografie delle migrazioni contemporanee hanno cercato di richiamare l’attenzione sulla capacità di molti mi- granti di essere in entrambi i contesti contemporaneamente. In modo pionieristico, Roger Rouse (1991) illustrando il “circuito migratorio transnazionale” che unisce i mutevoli contesti di accoglienza e di partenza (Messico e Stati Uniti) ed in cui scorrono cose, persone, informazioni, mostra come le esperienze e le identificazioni possano essere diffuse al- l’interno di tale circuito. Le relazioni e i legami più intimi possono essere intrattenuti anche a notevole distanza e le tensioni e le contraddizioni sociali di un luogo possono ri- versarsi facilmente nell’altro.
Alcuni antropologi hanno definito con il termine “transna- zionalismo” questo processo attraverso i quali i migranti, gra- zie anche alle innovazioni tecnologiche, tessono reti e man- tengono relazioni sociali, economiche, culturali e politiche che, collegando le loro società di origine a quelle di approdo, attraversano i confini nazionali (Glick Schiller et al. 1992). Tale approccio, inoltre, si caratterizza anche per la sua capacità di evidenziare la dimensione “micro” così spesso assente nel- le analisi della globalizzazione: le etnografie multilocali si con- centrano infatti sulle esperienze quotidiane delle persone. Il
122

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
flusso di oggetti o di idee viene considerato come parte inte- grante delle relazioni sociali dei migranti in quanto soggetti at- tivi nella creazione di campi sociali transnazionali. L’approccio transnazionale costituisce un’innovazione importante rispetto alle teorie centrate principalmente sui contesti d’approdo, da- to che consente di tenere in conto nell’analisi il background socioculturale degli immigrati e i loro legami con il contesto di partenza in modo più dettagliato e sistematico.
L’uso di un approccio transnazionale può rivelarsi molto utile, tuttavia, anche per comprendere adeguatamente gli stessi contesti di approdo. Alcuni migranti riescono ad af- frontare le numerose difficoltà prodotte dalle trasformazioni del capitalismo mondiale verso un liberismo sempre più ac- centuato rivolgendosi al contesto di partenza contempora- neamente a quello di approdo per creare nuove strategie di vita transnazionali. Come per i commercianti provenienti dai due Congo ed emigrati in Francia studiati da MacGaffey e Bazenguissa-Ganga (2000) anche per altri migranti le reti transnazionali possono rivelarsi una risorsa per “resistere all’esclusione” sia in patria che all’estero.
Tuttavia, alcuni autori hanno espresso alcuni dubbi sulla novità sia della transnazionalità sia dell’approccio tranana- zionale alle migrazioni (Amit-Talai 1998; Grillo 2000). Infat- ti, la premessa definitoria, ovvero le reti multiple che colle- gano in modo continuo più contesti, presenta celebri antece- denti nella letteratura antropologica britannica in Africa nel periodo coloniale e post coloniale (Epstein 1958; Parkin1969; Grillo 1973). Questi erano già studi sulla circolarità che univa il rurale e l’urbano attraverso reti sociali. D’altra parte, altri autori hanno sottolineato come, per un insieme di ra- gioni che includono la globalizzazione, le innovazioni tecno- logiche e i processi di decolonizzazione, le reti transnaziona- li possano funzionare con un’intensità sconosciuta nel passa- to: con un’estensione globale e quasi in tempo reale (Smith e Guarniz o 1998). Sarebbero quindi queste caratteristiche di velocità, intensità e frequenza a caratterizzare la novità del transnazionalismo contemporaneo. Basch Glick Schiller e

123

Bruno Riccio
Szanton-Blanc forniscono le seguenti premesse per uno sche- ma teorico sottostante l’approccio transnazionale (1994: 22):
a) la migrazione transnazionale è inestricabilmente legata alle mutevoli condizioni del capitalismo globale e deve es- sere analizzata all’interno del contesto delle relazioni glo- bali tra capitale e forza lavoro;
b) il transnazionalismo è un processo attraverso il quale i migranti con le loro attività quotidiane e le loro relazioni sociali, economiche e politiche creano campi sociali che attraversano i confini nazionali;
c) rigidi concetti delle scienze sociali che condensano cultura, locazione fisica ed identità possono limitare la ca- pacità dei ricercatori nel cogliere e nell’analizzare il fe- nomeno del transnazionalismo;
d) vivendo le proprie vite attraverso i confini i trasmi- granti si trovano a confrontarsi con, e coinvolti in, pro- cessi di nation-building dei due o più stati-nazione. Le lo- ro identità e pratiche sono configurate da categorie ege- moniche quali quella di razza ed etnicità che sono profondamente incorporate nei processi di nation-buil- ding di questi stati-nazione.
Pur condividendo alcune premesse quali l’accento definito- rio posto sugli attori, le loro esperienze quotidiane, le loro relazioni sociali e la critica di concetti rigidi di cultura ed identità , automaticamente collegati ai territori e alla logica se- dentaria dominante, credo che le altre premesse teoriche (a) e (c) siano più interessanti come oggetto di ricerca e di investi- gazione che come premesse da cui partire. Per esempio, le rea- zioni alla ristrutturazion e del capitalismo globale non sono simili in diversi contesti. Inoltre, benché alcune pratiche tran- snazionali possano rivelarsi cruciali nei processi di rafforza- mento di una nazione – si pensi al “nazionalismo in telesele- zione” cui fa riferimento Anderson (1996) – questa caratteri-
124

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
stica non emerge in tanti altri casi di formazioni transnazionali. È per questa ragione che in questa sede si è preferito al ter- mine “trans-nazionalismo” quello meno politico e più generi- co di “transnazionalità” (cf. Ong 1999). Ad ogni modo, ciò che preme sottolineare è la rilevanza contestuale di un insieme di fattori capaci di influenzare le migrazioni transnazionali. Per esempio, i diversi gradi di inclusione ed esclusione, l’accesso dei migranti alla sfera pubblica sociale e politica, la loro si- tuazione legale ed economica all’interno sia del paese di pro- venienza sia di quello di approdo costituiscono aspetti cruciali nel determinare diverse strategie transnazionali.
Queste riflessioni conducono direttamente alla relazione tra migrazione transnazionale e stato. In entrambi i filoni descritti , sia quello più generale che abbiamo chiamato “an- tropologia transnazionale” sia in quello più specificatamente concentrato sul fenomeno migratorio che abbiamo nomina- to “etnografia della transnazionalità”, esistono autori che vedono nelle migrazioni transnazionali dei sintomi del de- clino dello stato nazionale.
Kearney (1996), osservando come, grazie alla migrazione, la comunità mixteca un tempo contadina sia divenuta propria- mente transnazionale in quanto capace di penetrare costante- mente i confini tra il Messico e gli Stati Uniti, ipotizza un’era “post-nazionale” in cui le comunità sfuggono al controllo de- gli stati, trascendendo il potere definitorio di questi ultimi nel fissare categorie di identità per le persone. Sulla base degli effetti congiunti della mediazione elettronica di massa e delle migrazioni transnazionali, in modo più categorico Appadurai ritiene che lo stato come complessa forma politica moderna e l’epoca stessa dello stato nazionale siano giunti a conclusione:
“In un mondo di persone in movimento, di mercificazione globale e di stati incapaci di garantire i diritti basilari an- che alle loro popolazioni etnicamente maggioritarie, la so- vranità territoriale è una giustificazione sempre meno so- stenibile per quegli stati nazionali che sono sempre più di- pendenti da forza lavoro, competenze, armamenti o soldati di provenienza straniera” (2001: 39).

125

Bruno Riccio
Sia Kearney sia Appadurai sottolineano la natura contro- egemonica delle pratiche transnazionali illustrandole come atti di resistenza nei confronti del potere definitorio e rego- latore degli stati nazionali. Pur comprendendo le ragioni di queste posizioni, si ritiene che corrano il rischio di confon- dere le potenzialità con le realtà sociali quotidiane. In primo luogo, lo stato è ovviamente importante per il transnaziona- lismo, in quanto è insito nella sua stessa definizione: i tra- smigranti sono coloro le cui vite quotidiane si svolgono “qui” e “là”, tra due o più stati nazionali, con profonde con- seguenze sia per i migranti sia per gli stati che questi ultimi attraversano. Inoltre, il potere di esclusione e la forza disci- plinatrice degli stati sono ancora molto attivi e lo stato può rivelarsi in alcuni casi un attore creativo nell’utilizzo econo- mico o politico delle reti transnazionali. Per esempio, Robert Smith (1998) sottolinea il ruolo attivo dello stato messicano circa l’utilizzo e l’organizzazione della comunità transnazio- nale nel contesto di approdo (New York). Più precisamente, egli mostra il percorso storico con il quale la comunità di mi- granti provenienti da Ticuana ha beneficiato di ripetuti coin- volgimenti progettuali dello stato locale prima e di quello na- zionale in seguito. Oltre che in micro-progetti di coopera- zione e nell’istituzionalizzazione di meccanismi elettorali fa- cilitanti le votazioni a distanza, queste attività si concretiz- zarono negli anni novanta con l’emergere di una moltitudine di associazioni ricreative che si rivelarono a loro volta come gli attori organizzativi più capaci di mantenere i contatti transnazionali.
Altri autori, sostengono che in zone del mondo diverse fra loro come l’Asia, gli Stati Uniti e l’Europa, gli stati na- zionali, ben lungi dal perdere il loro potere e sovranità, stan- no ora adattando e ridefinendo le loro pratiche per gestire le conseguenze della ristrutturazione economica globale (Ong1999). In Europa, specialmente per quanto riguarda le poli- tiche migratorie, gli stati nazionali mantengono ancora una sovranità assoluta sul processo decisionale, e la globalizza- zione, pur comportando una diminuzione del potere degli stati in alcuni campi, permette che questi ultimi mantengano
126

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
una capacità regolamentatrice potente in aree cruciali per la funzionalità della nuova organizzazione capitalista. Nell’am- bito delle economie capitaliste occidentali, gli stati stanno adattand o i propri ruoli alle mutevoli contingenze economi- che tagliando la spesa pubblica e ristrutturando o addirittu-
ra smantellando i sistemi assistenziali, ma controllando nel contempo i flussi migratori (Gledhill 1998). Lo sviluppo delle migrazioni transnazionali potrebbe stimolare più delle trasformazioni dello stato nazionale come ci siamo abituati a concepirlo che un esaurirsi totale della sua funzione, in par- ticolare per quanto riguarda quella di controllo e di polizia.
Continuiamo ora la riflessione considerando un caso spe- cifico di migrazione transnazionale che evidenzia sia la rile-vanza dello stato d’origine sia di quello di approdo.
3. I senegalesi in Italia come esempio di transnazionalità
Le migrazioni senegalesi che hanno caratterizzato il contesto italiano rappresentano un buon esempio di migrazione tran- snazionale. Quando i migranti senegalesi ne parlano non utilizzano necessariamente il termine più in voga negli studi delle migrazioni contemporanee, ma dichiarano esplicita- mente che: “vivendo parte dell’anno in Italia e l’altra in Se- negal si cerca di sfruttare al massimo i due paesi”. Il Senegal contemporaneo è caratterizzato da una situazione economi- ca e sociale precaria e da un fragile equilibrio di cleavage, che storicamente hanno teso ad incrociarsi e a temperare i po- tenziali conflitti a cui potevano dare adito. Dagli anni ‘60 la popolazione è più che raddoppiata: da 3 a 7 milioni di abi- tanti, con una marcata presenza giovanile nella popolazione con conseguenze sull’aumento delle persone dipendenti per le famiglie (cf. Diop 2002). Molti giovani senegalesi ritengo- no di non avere altra scelta oltre a quella di partire (dem) poiché il ritiro parziale dell’impegno governativo dal settore agricolo, i prezzi alti e le tasse proibitive rendon o sempre più difficile un reddito di sussistenza nelle campagne. I ritorni temporanei, specialmente quando sono caratterizzati da un
127

Bruno Riccio
certo grado di ostentazione delle ricchezze accumulate, in- fluenzano l’immaginazione delle persone che rimangono e, in questo modo, formano uno stimolo simbolico alla par- tenza e una sorta di cultura dell’emigrazione (Riccio 2000)
La transnazionalità dei senegalesi si rivela in attività e tran- sazioni economiche, tra cui il commercio, attraverso confini nazionali e anche a notevole distanza. Essi trascorrono mol- to del loro tempo fuori dal contesto d’origine ma ritornan- doci frequentemente con la finalità di costruire una vita eco- nomica sociale e spirituale per loro e le loro famiglie in Se- negal. L’orientamento al ritorno piuttosto che all’insedia- mento permanente è un altro fattore che contraddistingue le esperienze migratorie dei senegalesi (Riccio 2002). Molti emigrano principalmente per motivi economici ed in parti- colare a causa della crisi della struttura agricola tradizionale. I senegalesi in Italia sono quasi 35.000 che emigrano indivi- dualmente seguendo contatti e reti sociali. Il fatto che essi siano principalment e uomini (94%) testimonia una certa identificazione nei confront i di un modo migratorio maschi- le e mobile (Caritas di Roma 2002).
La maggioranza dei migranti senegalesi sono Wolof, pro- vengono dal bacino arachidiero e dalla capitale e appartengo- no alla confraternita sufi Muridiyya, ordine fondato negli anni ottanta del xix secolo da Cheick Amadou Bamba che riunì di- scepoli tra diversi strati della società (Cruise O’Brien 1971;
Copans 1980; Piga 2000). La confraternita Muridiyya ha la sua capitale a Touba, città nella quale i muridi hanno
costruito la più grande moschea nell’Africa sub-sahariana e che rimane centro di investimento materiale e spirituale di
tutti i discepoli. Sono diversi gli studi che hanno mostrato come i legami verticali ed orizzontali della confraternita
hanno facilitato anche lo sviluppo di reti sociali nell’emigrazione e nelle re- lazioni economiche (Diop
1985; Schmidt Friedberg 1994; Scidà 1994; Carter 1997). L’attività economica svolta da mol- ti senegalesi in Italia è la
vendita ambulante anche se sono in aumento i casi di inserimento lavorativo come dipendenti a volte con ruoli qualificati. Tuttavia, una diretta o indiretta esperienza in
campo commerciale è stata rilevata da molti
128

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
studi (cfr. Ceschi 1998). I muridi, che si sono storicamente spostati dall’ambiente rurale in cui detenevano il monopolio dell’arachide all’ambiente urbano in cui gradualmente hanno conquistato il monopolio del commercio e dei trasporti informali, sono ora impegnati nel commercio a vari livelli dalla vendita al dettaglio per strada allo sviluppo del com- mercio elettronico a livello transnazionale (Ebin 1992). Gli spazi transnazionali sono mantenuti in vita da conversazioni a distanza, telefoniche e con persone in continuo movimen- to tra il contesto di origine e quello di approdo, dalla vendi- ta di cassette in cui, oltre ai poemi sacri, vi si ascoltano anche informazioni sulle decisioni delle gerarchie di Touba. L’uso di internet tra alcuni circoli sparsi per il mondo è un altro esempio di come questa confraternita sappia avvalersi delle nuove tecnologie per articolare la sua organizzazione attra- versando confini geografici e politici.
Gi studi che si sono focalizzati sulla diaspora commerciale muride in diversi contesti di approdo sottolineano il potere di un sistema quasi autosufficiente di reti che collegano le- gami di appartenenza e attività commerciale. Nonostante l’esistenza di questi legami sia indiscutibile, le reti di appar- tenenza religiosa o famigliare non si sovrappongono mecca- nicamente a quelle commerciali ma si aiutano e stimolano re- ciprocamente (Salem 1981). Inoltre, le reti commerciali non sono dei sistemi chiusi come alcuni potrebbero pensare: stu- denti, operai in congedo o anche impiegati possono affidar- si a queste reti commerciali per incrementare i loro guada- gni. Spesso le appartenenze etnico-religiose vengono tem- perate a favore di una solidarietà nazionale o regionale.
Se si considera la parziale apertura delle reti transnaziona- li, emerge un ulteriore aspetto che si rileva importante nella comprensione delle migrazioni transnazionali, ovvero il le- game tra i migranti e l’accesso al potere dello stato di par- tenza. In un recente articolo, la Salzbrunn mostra come, pri- ma di vincere le elezioni del 2000, l’attuale presidente sene- galese Wade abbia puntato sull’influenza degli immigrati sui loro parenti nel contesto di origine riuscendo ad ottenere i voti della maggioranza degli elettori. “La strategia di punta-
129

Bruno Riccio
re sui collegamenti transnazionali come moltiplicatori di vo- ti ha creato una mobilitazione economica importante di so- stenitori politici” (2002: 141). Questo è un esempio di come migrazione transnazionale non significhi automaticamente non-nazionale, ma possa essere al contrario funzionale alla conquista dello stato nazionale.
La rilevanza dello stato, risulta evidente anche quando si ri- volge l’attenzione verso il contesto di approdo. Innanzitutto è solo quando si è ottenuto un permesso di soggiorno che ci si può permettere con serenità di attuare una strategia di vita transnazionale muovendosi come un pendolare che attraversa i confini degli stati. Semplicemente questo dato ci dovrebbe indurr e a temperare le previsioni post-nazionali degli autori discussi nel paragrafo precedente e a riconoscere che comun- que le comunità transnazionali sono obbligate a negoziare con il potere che lo stato esercita sui confini territoriali.
Alcuni migranti ricordano la prima entrata nel paese di ap- prodo come una prova di pazienza e fatica, in cui aspettare il momento opportuno per tentare la sorte. Se e quando en- trano all’interno degli stati, i senegalesi come altri migranti devono scontrarsi con numerosi problemi. La diffusa rap- presentazion e dei migranti come criminali affibbiando lo statuto di illegalità agli irregolari ha comportato la forma- zione di un segmento sempre più vasto della società che si caratterizza come impaurito , senza alcuna tutela legale, privo di difesa nei confronti di datori di lavoro o di padroni di ca- sa che vedono in esso una ghiotta occasione di sfruttamento. È questa una realtà composta da individui esclusi dalla so- cietà in cui comunque vivono. Inoltre, esistono le difficoltà provocate da un’economia ristrutturata in modo post-fordi- sta e dalle trasformazioni delle varie politiche sociali adotta- te dai diversi paesi di immigrazione. Alle delusioni nei con- fronti di quell’ “arcipelago di servizi” (Pazzagli 2002), che implementa le politiche nei confronti degli immigrati e che spesso svolge il ruolo dei “buoni” dal punto di vista del- l’immigrato, l’interazione con altre istituzioni quali la polizia si rivelano spesso in abusi burocratici quando non precipi- tano in discriminazioni esplicite. Sono numerose le espe-
130

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
rienze di lunghissime file e di attese interminabili per otte- nere la documentazione necessaria a evitare il destino di “non-persone” (Dal Lago 1999).
L’ansia prodotta normalmente nel dover confrontarsi quo- tidianamente con l’arbitrarietà discriminatoria delle proce- dure burocratiche si moltiplica per i migranti che non posso- no fare leva sulle conoscenze informali che fungono spesso da sostegno per gli italiani. Questo tipo di esperienze influenza- no anche il modo con cui i senegalesi guardano l’Italia. Di- verse testimonianze confermano una quotidianità fatta di di- scriminazioni nei controlli polizieschi che tendono ad acca- nirsi con una delle comunità migranti più visibile sia per l’at- tività di ambulantato che per il colore della pelle. Spesso, nel lamentare tale situazione gli informatori abbinano alla descrizione di una situazione frustrante il confronto con un altro paese europeo, in parte idealizzato, per evidenziare la mancanza di trasformazione dell’Italia in un contesto civile di accoglienza. Infatti, mentre l’integrazione europea sta in- fluenzando i paesi membri, spingendoli verso un grado di ar- monizzazione delle politiche, i vari contesti storici rendono le politiche migratorie nazionali ancora molto diversificate.
4. Le ambivalenti politiche migratorie italiane all’interno del- la “Fortezza Europa”
Si osserva una profonda ambiguità nel percorso delle politi- che sull’immigrazione in Italia che esprimono da un lato il bisogno oggettivo di lavoratori stranieri da parte del merca- to del lavoro e, dall’altro, una crescente criminalizzazione dei migranti rappresentati a più riprese come un pericolo da espellere. Già negli anni ’80, la reazione del Governo Italia- no al fenomeno della migrazione rispecchiava quest’ambi- guità. Da un lato, infatti, si dichiarava che l’Italia non desi- derava basare il proprio sviluppo economico sulla forza la- voro straniera. Dall’altro, l’Italia, si affermava, era pronta ad accogliere i migranti nel nome della sua tradizione de- mocratica e della solidarietà con la difficile situazione eco-
131

Bruno Riccio
nomica dei paesi in via di sviluppo (Carter 1997). Di conse- guenza, ai migranti veniva data la possibilità di stabilirsi in Italia, ma senza un vero riconoscimento politico del loro status e delle loro esigenze.
In questo contesto, fino al 1986, data della prima delle tre leggi nazionali (1986; 1990; 1998), l’immigrazione è stata af- frontata in termini d’ordine pubblico e di controllo, la- sciando le questioni sociali al settore del lavoro volontario. In base alla legge del 1986, le immigrate sarebbero state trattate come economicamente e giuridicamente dipenden- ti dai rispettivi mariti (Salih 2003). Sarebbero stati ammessi per ricongiungiment i familiari i minori di 18 anni, le con- sorti ed i genitori economicamente dipendenti, previa esi- bizione dello status economico e del tipo di alloggio occu- pato dalla persona facente richiesta di tale ricongiungimen- to. Il permesso di soggiorno di una tale moglie o figlio sa- rebbe stato quindi collegato a quello della persona già resi- dente in Italia e sarebbe stato valido per il medesimo perio- do. In base alla seconda legge, emanata nel 1990, il numero di immigrati che potevano essere accettati in Italia sarebbe stato determinato in base alle esigenze economiche nazionali e conformemente con i trattati europei. In pratica questo si- gnificava che, negli anni novanta, il permesso d’ingresso in Italia veniva accordato solo per ricongiungiment i familiari, a rifugiati politici (principalmente dalla ex-Jugoslavia) ed a coloro già in possesso di un contratto di impiego in Italia. Va notata in questo contesto l’ironia di politiche che raffor- zano le barriere contro coloro che cercano di lavorare le- galmente in Italia, incoraggiando così implicitamente l’in- gresso illegale nel paese malgrado l’opposizione verbale al- l’immigrazione non documentata.
Un fattore significativo dell’evoluzione della politica ita- liana è stato l’appartenenza alla UE ed allo sviluppo di po- litiche dell’Unione concernenti immigrazione, integrazio- ne, esclusione e xenofobia. L’immigrazione in Italia (e in al- tri paesi del Sud dell’Europa) ha contribuito ad una cre- scente preoccupazione a livello europeo circa le frontiere. Da un punto di vista politico, i governi italiani di tutti gli
132

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
orientamenti politici hanno dovuto dimostrare di non offri- re un facile punto d’ingresso, di non costituire in pratica il punto debole dell’unione. Contrariamente a una visione dell’Italia tollerante nei confronti dell’immigrazione irre- golare, Sciortino sostiene che il controllo italiano dell’im- migrazione mostra una tendenza abbastanza coerentemente restrittiva sia in relazione ai nuovi flussi in ingresso che agli immigrati già presenti. Ciò ha comportato una definizione esclusiva di appartenenza sociale. Per esempio, lo sposta- mento verso un regime di chiusura ed esclusione ci è offer- to dalla riforma della legge della cittadinanza del 1992 che ha reso più facile per i discendenti di emigrati italiani riot- tenere la cittadinanza ma anche molto più difficile per gli immigrati chiedere la naturalizzazione. Con questa sempre maggiore enfasi posta sul principio dello jus sanguinis, que- sta legge ha creato un sistema di naturalizzazione a due ve- locità che distingue gli stranieri comunitari da quelli non-co- munitari, per ridurre il numero tra questi ultimi di aventi di- ritto a far richiesta di naturalizzazione. Il periodo di resi- denza legale continua richiesto è stato infatti portato da cinque a dieci anni (Sciortino 1999).
Malgrado la domanda di migranti nell’ambito di un mer- cato del lavoro sempre più flessibile e frammentario, il go- verno italiano ha inoltre continuato a rafforzare i controlli al- le frontiere sotto la pressione dell’idea di una “Fortezza Eu- ropa” sancita dall’Accordo di Schengen. Il contributo italia- no alla costruzione della Fortezza è divenuto ancor più chia- ro con il decreto Dini (fine del 1995) sull’immigrazione. È stato questo il prodotto della strategia populista della Lega Nord e di Alleanza Nazionale, ha diviso la sinistra ed ha rappresentato una svolta decisiva passando dalla vecchia ri- luttanza politica circa un dibattito pubblico visibile sui temi concernenti l’immigrazione ad una sfacciata politica di esclu- sione. Il decreto prevedeva la regolarizzazione per due anni degli immigrati dipendenti , l’espulsione degli immigrati ille- gali e disoccupati, l’espulsione dei cittadini extracomunitari in sospetto di essere “socialmente pericolosi” ed il dovere per gli immigrati alla frontiera di esibire un certificato me-
133

Bruno Riccio
dico. Queste misure avrebbero comportato l’allontanamen- to di molti lavoratori irregolari da parte di datori di lavoro non disposti a pagare i contributi previdenziali ed il conse- guente aumento degli immigrati irregolari disoccupati. Inol- tre, il decreto Dini enfatizzava l’ipocrisia della politica ita- liana sull’immigrazione ed il paradosso per cui: “mentre gli interessi economici ed il declino demografico spingono lo stato ad operare in direzione di un aumento sempre mag- giore degli immigrati di ambo i sessi in Italia e della loro in- tegrazione nell’economia locale, l’opportunismo politico e le esigenze elettorali si muovono in direzione opposta, come espresso dai vincoli sempre maggiori posti sull’immigrazione legale nel Paese” (Salih 2003).
Anche la terza legge sull’immigrazione (1998) sembrava es- sere caratterizzata da questa ambigua coesistenza di pretese di integrazione degli immigrati da un lato e, dall’altro, degli sforzi profusi per la loro espulsione con la criminalizzazione degli immigrati illegali. Essa manifestava l’idea che l’inte- grazione di migranti già stabilitisi in Italia è condizionata alla capacità dello stato di impedire un’ulteriore immigra- zione (illegale). Ogni anno doveva essere stabilita una quota massima di ingressi, comprendente i lavoratori sia stagiona- li che permanenti ed i ricongiungimenti familiari. Queste leggi hanno contribuito a definire i diritti degli immigrati e a stabilire alcune misure per la loro integrazione con garanzie formali a tutti i lavoratori “extracomunitari” regolarmente residenti in Italia ed alle loro famiglie completa eguaglianza di trattamento rispetto ai lavoratori italiani. Inoltre, esse san- ciscono il loro diritto ad avere una casa, a frequentare la scuola, ad organizzarsi in associazioni e a mantenere le loro identità culturali. Tuttavia è forte la discrepanza sostanziale tra la definizione formale di diritti e la loro attuazione. Nel- la maggior parte dei casi i diritti alla casa, al lavoro e all’assi- stenza sanitaria rimangono solo teorici. Inoltre, sul versante coercitivo, la legge del 1998 perpetuava la criminalizzazione dell’immigrazione illegale fissando pene severe a coloro che incoraggiano l’immigrazione clandestina e creando i cosid- detti centri di permanenza temporanea (CPT) per coloro
134

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
che sono entrati illegalmente. La legge Bossi-Fini attual- mente in vigore è paradossalmente più coerente: istituziona- lizza un regime di quasi-apartheid.
Concentrato sulla protezione della frontiera, il discorso po- litico italiano riproduce quanto si ritrova in molti altri paesi europei . L’immigrazione irregolare è stata per tutti gli anni novanta uno dei cavalli di battaglia di aggressive campagne politiche, condott e non solo dall’estrema destra, cosa che ha contribuito alla politicizzazione del fenomeno migratorio ac- crescendo l’ansia per il controllo dei flussi e la tendenza me- diatica a rappresentare i migranti come un problema socio- culturale senza apprezzare la complessità e la varietà delle mi- grazioni (Colombo e Sciortino 2002). Le minoranze presenti nei paesi europei da più generazioni sono state ovviamente colpite dal clima xenofobo stimolato da questa crescente ten- sione maniacale sul controllo dei confini territoriali.
Contemporaneamente , se non conseguentemente, si è avu- ta una forte politicizzazione del concetto di cultura e di ap- partenenza culturale. Infatti le pratiche di esclusione vengo- no spesso legittimate con ragioni “culturalizzanti” fino a giungere a quel “fondamentalismo culturale” (Stolke 1995) che esalta le differenze per giustificare le disuguaglianze e che forgia il nuovo razzismo differenzialista sempre più dif- fuso nei paesi europei. Si tratta di un tipo di strategia di- scorsiva che nega e contemporaneamente costruisce simbo- licamente la sua opposizione nei confronti dei migranti at- traverso argomentazioni emergenti dal senso comune quali il desiderio di regole chiare, l’anelito a legge ed ordine, la di- fesa di interessi economici nazionali o locali e quella di inte- ressi politici autoctoni , legittimando così la diffusa ostilità nei confronti dei migranti come naturale espressione di difesa del propri o territorio. Implicitamente, dietro a questi di- scorsi si annidano concezioni dei migranti come persone culturalmente differenti in modo incommensurabile. Non di rado tale differenza si rivela poi sinonimo di inferiorità e disuguaglianza (Cole 1997).
Altre rappresentazioni per altri versi problematiche pos- sono animare anche le persone orientate all’attuazione dei di-
135

Bruno Riccio
ritti civili coinvolte nelle politiche nei confronti dell’ “arci- pelago immigrazione” (Mottura 1992). In tutta Europa, sta- to dopo stato, regione dopo regione, città dopo città, si pos- sono osservare una miriade di iniziative nazionali e locali, forse queste ultime tra le più interessanti, alcune delle quali basate su istituzioni statali, altre su organizzazioni non go- vernative, altre con il supporto e la partecipazione di immi- grati o delle stesse minoranze etniche (o nate grazie alla loro stessa iniziativa), altre senza, che tentano di affrontare i pro- blemi connessi al vivere all’interno di società che si potreb- bero definire pluraliste (Grillo e Pratt 2002). Considereremo nel paragrafo che segue il sedentarismo specifico che sta alla base delle politiche per gli immigrati con lo scopo di mo- strare come gli attori della “società civile” possono rivelare caratteristiche comunemente associate con le pratiche dello stato. L’organizzazione transnazionale di gruppi migranti deve negoziare con tale sedentarismo di attori che presenta- no “effetti statali” (Trouillot 2001) senza necessariamente appartenere direttamente alle istituzioni statali.
5. “Vedere come lo stato”: Lo sguardo sedentarista nei con- fronti delle migrazioni transnazionali
Nella discussione che segue vedremo come organizzazioni che implementano le politiche stabilite dallo stato riprodu- cano discorsivamente tale orientamento alla sedentarizza- zione. In altre parole, si cercherà di portare alla luce come diverse organizzazioni emergenti dal terzo settore o dalla spesso romanticizzata “società civile” siano in grado, per ri- prendere Scott (1998), di “vedere come lo stato”.
La “casa” è il bisogno ed il problema più urgente per gli immigrati in Italia. Inoltre, l’alloggio rimane una delle aree d’intervento più impegnative per le politiche locali nei con- fronti degli immigrati (Bernardotti 2001). Nonostante spie- gazioni di tipo razzista legittimanti le discriminazioni nel mercato dell’alloggio, come l’eventuale svalutazione dei prez- zi dell’affitto, tendano a stigmatizzare gli immigrati in gene-
136

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
rale, i senegalesi sono tra coloro che incontrano i maggiori problemi nel trovare appartamenti a causa di un’immagine diffusa che li rappresenta come tendenti al sovraffollamento.
La capacità mostrata da alcuni senegalesi di accettare la vi-ta in grossi gruppi con un certo grado di autonomia è stata ritenuta un aiuto fondamentale nel forgiare il modello di prima accoglienza. D’altra parte, un’opinione ricorrente al- l’interno dei servizi, è comunque il “bisogno di saltare ad un altro stadio di integrazione e di politiche per gli immigrati”. Quest o cambiamento sarebbe dovuto anche agli aumenti dei ricongiungimenti famigliari e dovrebbe comportare del- le politiche abitative più orientate sugli appartamenti che sulle palazzine, lasciando gradualmente più autonomia agli immigrati per quanto riguarda l’affitto, la manutenzione e al- tre spese.
Tuttavia, l’organizzazione transnazionale e l’orientamento al ritorno tipico di molti senegalesi si adatta molto meglio alle forme tipiche della “prima accoglienza” che non a questo auspicato “secondo stadio verso l’integrazione”. Dalle espe- rienze pratiche quotidiane emerge un’immagine dei senegalesi che non corrispond e alla logica sedentarista implicitamente assunta dal sistema dei servizi sociali come nella pianifica- zione delle politiche d’integrazione. Ai senegalesi viene da più parti rimproverata la scarsa identificazione con il contesto di approdo e l’orientamento materiale e simbolico a quello di partenza. Sono ricorrenti frasi come “non sono identificati al luogo in cui vivono”, “vivono pensando alle loro famiglie in Senegal”. L’attaccamento che i senegalesi mostrano nei con- fronti del contesto di origine – insieme al loro modo mobile e circolare di organizzare l’esperienza migratoria – viene quindi visto come un problema. Il modo di vita sedentario e la sua istituzionalizzazione tramite la residenza sono considerati co- me “datità” esistenziali anche per tutte le pratiche lavorative e burocratiche che questa comporta. Lo stabilirsi e il radicarsi dei gruppi in un territorio vissuto come proprio è considera- to lo stato normale, dato per scontato come l’unica soluzione esistenziale, la naturale realtà dell’umanità (Callari Galli1998). I senegalesi, in definitiva, non sono utenti abbastanza
137

Bruno Riccio
“disciplinati”. Ideali nella fase d’emergenza, in quanto capaci di sopportare la precarietà delle politiche di accoglienza abi- tativa, lo sono molto meno per le politiche d’integrazione che vengono percepite come “meritevoli” solo da coloro che dimostrano un desiderio forte di stabilirsi definitivamente nel contesto di approdo (Riccio 2001).
Questo sedentarismo coinvolge gli stessi migranti in par- ticolare coloro che vengono considerati come rappresen- tanti delle comunità straniere. Infatti, come sostiene Gledhill (1998), sia stati che governi locali hanno imparato a piegare le nuove politiche delle identità etniche a loro vantaggio, promuovendo strutture istituzionali di rappre- sentanza e carriere professionali di intermediazione per lea- der della comunità che rivelano più un aumento che una di- minuzione degli sforzi tassonomici, di fissazione dell’iden- tità, da parte degli stati di approdo. Per esempio, durante l’estate del 1997 alcuni avvenimenti criminosi che coinvol- sero alcuni stranieri produsse “l’emergenza immigrazione” a livello nazionale piuttost o che “l’emergenza criminalità” a li- vello provinciale. Criminalità e immigrazione cominciarono ad essere discussi come facenti parte dello stesso fenomeno sociale. Poiché la maggioranza degli autori di questi crimini proveniva da altre località, il sindaco di Rimini propose una soluzione che si presentava come illegale dal punto di vista del diritto europeo ed internazionale: la chiusura della pro- vincia ai residenti stranieri provenienti da altre province italiane. In altre parole, si prevedeva un diritto alla mobilità sul territorio nazionale differenziato su basi etnico-nazionali, una sorta di apartheid neanche troppo implicita.
Dopo tale proposta sedentarista, che per finire non si tra- dusse concretamente in alcuna decisione effettiva, venne convocata una conferenza stampa in cui parteciparono co- loro che vengono nominati come “rappresentanti dei citta- dini extracomunitari”. Non è comunque questa la sede per un’analisi dettagliata dell’incontro. Mi interessa esclusiva- mente presentar e alcuni passaggi delle affermazioni di un cit- tadino straniero che lavorava presso un sindacato, poiché mostrano come alcuni di questi immigrati, la cui funzione di
138

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
portavoce emerge spesso più da un’interazione con le istitu- zioni di accoglienza che non da una effettiva rappresentanza della propria comunità di origine, abbiano interiorizzato il sedentarismo dominante.
“I problemi durante l’estate sono creati da gente che viene da fuori, i residenti non hanno nemmeno il tempo per andare al mare perché sono qui per lavorare durante la stagione turistica. … È importante che noi condanniamo questi avvenimenti, sono intollerabili e siamo pronti a col- laborare con le autorità locali per affrontare questi pro- blemi. Abbiamo anche un suggerimento per il prefetto da presentargli all’incontro sulla sicurezza, che è di con- trollare bene il territori o attraverso posti di blocco in tutti i punti di entrata: autostrada, stazione e le strade statali. … Ogni straniero deve essere controllato per capire cosa fa, quali sono le sue intenzioni e chiunque si trovi senza mez- zi di sostentamento, senza una residenza chiara, anche se regolare, ripeto, anche se regolare, deve essere spedito con il foglio di via fuori della provincia”
Sembra che il bisogno di legittimarsi agli occhi degli inter- locutori italiani abbia spinto alcuni di questi “rappresentanti degli stranieri” a riprodurre il linguaggio poliziesco che si ri- scontra nei media e nelle “retoriche dell’esclusione” diffuse in tutta Europa (Stolke 2000), ed involontariamente a contri-
buire alla criminalizzazione dei migranti. Il tema principale è che “il problema viene da fuori”, sembra che si voglia evi- denziare che i “nostri immigrati”, quelli che controlliamo, che conosciamo, che rappresentiamo, che possiamo contare con precisione sono innocui, perché facciamo un buon lavoro.
Il riproporsi da diversi vertici di osservazione di questo sguardo sedentarista e localistico avverte del persistere di ef- fetti statali che superano i confini con cui tradizionalmente si circoscrive le pratiche statali. Liberandosi dalla necessità di stabilire la fine o, sul versante opposto , l’inesauribilità dello stato, dovremmo dedicare le nostre analisi proprio alle multi- ple trasformazioni in atto che caratterizzano le pratiche stata-
li e che si ripropongono anche attraverso altre organizzazioni
139

Bruno Riccio
(Ferguson e Gupta 2002). Questi processi emergono con for- za nel confronto con le nuove migrazioni transnazionali.
6. Riflessioni conclusive: etnografia translocale ed istituzionale
Il percorso illustrato ci porta a mediare tra due posizioni. Da un lato, si è portati ad assumere un atteggiamento cauto nei confronti delle teorie sulla migrazione incentrate esclu- sivamente sullo stato, precisamente perché sia le comunità migranti che le società di origine e di approdo stanno pre- sentando una maggiore indipendenza dagli stati. Dall’altro, si può riconoscere che il potere di disciplinare ed escludere che caratterizza gli stati è ben lungi dall’affievolirsi. Sembra dunqu e difficile ritenere che lo sviluppo di connessioni transnazionali renda ridondante l’esistenza e la retorica del- lo stato nazionale. Le analisi che confermano la continua importanza degli stati nazionali e la loro influenza sui cam- pi sociali e politici transnazionali costituiscono un corretti- vo importante alle asserzioni celebrative e premature che questa è l’era che segna il declino delle “moderne” istitu- zioni. Pur riconoscendo la complessità e la fluidità delle identità e delle culture contemporanee, si è portati a re- spingere queste rivendicazioni.
Il controllo da parte dello stato e le pratiche migratorie transnazionali costituiscono parti interattive dello stesso qua- dro. Le interpretazioni politiche ed egemoniche del migran- te come l’“altro” a livello nazionale e la sua marginalizzazio- ne nel paese ospite, interagiscono con le strategie di vita dei migranti e la costruzione d’identità che sfidano i discorsi nazionali estendendosi al di là dei confini nazionali stessi. Le esperienze e le traiettorie transnazionali sono profondamen- te ancorate ai vincoli ed alle possibilità materiali, legali e culturali che si presentano nei luoghi e nelle nazioni in cui i migranti si stabiliscono. Di conseguenza i contesti di par- tenza e di approdo forniscono una forma alle esperienze ed ai progetti transnazionali dei migranti con modi differenti. Così, le pratiche transnazionali potrebbero rivelarsi molto
140

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
importanti nei processi di rafforzamento di una nazione. Quindi dire transnazionale non vuol dire post-nazionale.
Lo stato, sia nelle sue varianti nazionali sia in quelle locali, non è, naturalmente, un’entità monolitica, ma piuttosto un materiale composito che consta di diverse agenzie con inte- ressi potenzialmente in contrasto fra loro. Come avverte Abélès (2001: 42), “ogni istituzione è tormentata dalle ten- sioni” e il compito dell’etnografo è quello di evidenziare, “partendo dalle rappresentazioni dei suoi interlocutori, le lo- giche talvolta eteroclite, la loro sovrapposizione, i divari che esse inducono”. Conseguentemente, all’interno delle istitu- zioni statali si producono discorsi e pratiche sulla migrazione che potrebbero essere in disaccordo tra loro.
Nell’insieme, tuttavia, si ritiene che nelle società di appro- do il ruolo degli stati non sia diminuito in campi come il con- trollo dell’immigrazione e che nelle società di partenza lo sta- to possa continuare a giocare un ruolo cruciale nella crea- zione di campi transnazionali politici ed economici, riflet- tendo una sempre maggiore dipendenza dalle rimesse dei migranti (Smith 1998). Ne consegue che lo stato, sia della so- cietà di partenza che di quella di approdo, costituisce parte delle condizioni materiali, economiche e normative che si ri- percuotono sulle pratiche transnazionali dei migranti e che danno forma alla loro esperienza vissuta di transnazionalità. Tutto questo è posto in evidenza dalla distribuzione dei di- ritti di cittadinanza e dall’accesso diversificato alle risorse. La cittadinanza in Italia è ancora legata alla nazionalità e i non- cittadini si vedono ancora negato, in linea di principio, l’ac- cesso alla sfera pubblica come definita dallo stato. In Italia una politica di esclusione che enfatizza le diversità opera per impedire ai migranti l’accesso alla condizione di cittadi- no. Le condizioni materiali e normative di incertezza nelle quali vivono molti migranti si ripercuotono sia sulle loro strategie socioeconomiche che sull’interpretazione del loro essere persone sociali nell’ambito di un campo transnazio- nale. Risulta quindi necessario riflettere ulteriormente sul rapporto tra nazionale e transnazionale, approfondendo la
141

Bruno Riccio
comprensione sul come le identità e le pratiche transnazio- nali si articolino con i diritti dei migranti a livello nazionale.
Infine, da un punto di vista metodologico, adottare un approccio che non sia stato-centrico non implica la rimozio- ne dello stato e delle sue trasformazioni dall’analisi. Si è de- siderato evidenziare la natura frammentata ed eterogenea
delle pratiche e delle identificazioni transnazionali, rivelando la complessità della transnazionalità come fenomeno in con- tinua negoziazione con le istituzioni statali e parastatali. La transnazionalità non è un processo uniforme, ma un feno- meno vario e complesso, vissuto in maniera diversa a secon- da del contesto d’origine, della classe e del genere (Riccio2000; 2002; Koser 2000; Salih 2003). È particolarmente im- portante scoprire l’articolazione tra le strutture istituzionali e le pratiche adottate dai migranti per creare forme di vita transnazionali, approfondendo una comprensione multidi- mensionale del come questi processi evolvono (Grillo 2001). Un approccio di questo tipo evidenzia un radicamento spe- cifico nell’ambito dell’egemonia degli stati nazionali che spesso forgia esperienze diverse di transnazionalità.
142

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
Bibliografia:
Abèlés M., 2001. Politica, gioco di spazi, Meltemi, Roma.Amit-Talai V., 1998. “Risky hiatuses and the limits of social
imagi- nation: expatriancy in the Cayman islands”, in Rapport N. and Dawson A., (a cura di) Migrants of identity, Berg, Oxford.
Anderson B., 1996. Comunità immaginate. Origini e diffusione dei nazionalismi, Manifestolibri, Roma.
Apadurai A., 2001. Modernità in polvere, Meltemi, Roma.Basch L., Glick Schiller N., Szanton-Blanc C., 1994. Nations un-
bound: Transnational projects, postcolonial predicaments, and de- territorialized nation-states, Gordon and Breach, New York.
Bernardotti M.A. (a cura di), 2001. Con la valigia accanto al letto. Immigrati e casa a Bologna, FrancoAngeli, Milano.
Callari Galli M., 1998. ‘I percorsi della complessità umana’, in Callari Galli M., Ceruti M., Pievani T. Pensare la diversità, Mel- temi, Roma.
Callari Galli M., 2003. ‘I nomadismi della contemporaneità’ in Callari Galli M. (a cura di) I nomadismi contemporanei, Guaral- di, Rimini (questo volume).
Caritas di Roma, 2002. Immigrazione: dossier statistico 2002, An- terem, Roma.Carter D.M., 1997. States of grace. Senegalese in Italy and the new
Eu- ropean immigration, University of Minnesota Press, Minneapolis. Ceschi S., ‘Spazi culturali dei venditori ambulanti
della comunità senegalese a Roma’ in Clemente P., Sombrero A.M. (a cura di)
Persone dall’Africa, CISU, Roma.Clifford J., 2001 (1997). Strade. Viaggio e tradizione alla fine del se-
colo xx, Bollati Boringhieri, Torino.Cole J., 1997. The new racism in Europe: a Sicilian ethnography,
Cambridge University Press, Cambridge.Colombo A., Sciortino G., (a cura di), 2002. Stranieri in Italia.
Assimilati ed esclusi, Il Mulino, Bologna.Copans J., 1980. Les Marabouts de l’arachide: la confrérie mouride
et les paysans du Sénégal, Le Sycomore, Paris.Cruise O’Brien D.B., 1971. The Mourides of Senegal. The political
and economic organisation of an islamic brotherhood, Clarendon Press, Oxford.
Dal Lago A., 1999. Non-persone. L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano.
Diop A.M., 1985. “Les Associations Murid en France”, Esprit, 102.

143

Bruno Riccio
Diop M.C. (a cura di), 2002. Le Senegal contemporain, Karthala, Paris.
Ebin V., 1992. ‘A la recherche de nouveaux “poissons”. Stratégies commerciales mourides par temps de crise’, Politique Africaine, 45. Epstein A.L., 1958. Politics in an urban African
community, Man-chester University Press, Mancheste r.
Ferguson J., Gupta A, 2002. ‘Spatializing states : toward an eth- nography of neoliberal governamentality’, American Ethnologist,29, 4.
Gledhill J., 1998. ‘Thinking about states, subalterns and power re- lations in a world of flows’ ICCCR International Conference on Transnationalism, 17 Maggio, Mancheste r.
Glick Schiller N., Basch L., Szanton-Blanc C., 1992. Toward a transnational perspective on migration, New York Academy of Science, New York.
Grillo R.D., 1973. African railwayman. Solidarity and opposition in an African labour force, Cambridge University Press, Cambridge.
Grillo R.D. (a cura di), 1980. “Nation” and “State” in Europe: anth-ropological perspectives, Academic Press, London.
Grillo R.D., 2000. ‘Riflessioni sull’approccio transnazionale alle mi- grazioni’, Afriche e Orienti, 2, 3/4.
Grillo R.D., 2001. ‘Transnationalism and the city: anthropological perspectives’, Plurimondi, 5.
Grillo R.D., Pratt, J., (a cura di), 2002. The Politics of recognizing difference. Multiculturalism Italian-style, Ashgate, Aldershot.
Gupta A., Ferguson J. (a cura di), 1997. Culture, Power, Place,Duke University Press, Durham.
Hannerz U., 2001. La diversità culturale, Il Mulino, Bologna. Kearney M., 1996. Reconceptualizing the peasentry. Anthropology
in global perspective, Westview Press, Boulder.Koser K., 2000. ‘Da rifugiati a comunità transnazionali? Il caso eri-
treo in Inghilterra e Germania’, Afriche e Orienti, 2, 3/4.MacGaffey J., Bazenguissa-Ganga R., 2000. Congo-Paris. Transna-
tional traders on the margins of the law, Indiana University Press, Bloomington.
Mottura G. (a cura di), 1992. L’arcipelago immigrazione, Ediesse, Roma.
Ong A., 1999. Flexible citizenship. The cultural logics of transna- tionality, Duke University Press, Durham.
Parkin D., 1969. Neighbours and nationals in an African city ward, Routledge, London.
144

Migrazioni transnazionali: il declino dello stato nazionale?
Pazzagli I., 2002. “L’arcipelago dei servizi: uno sguardo sulle di- mensioni organizzative” in Sgrignuoli A. (a cura di) Donne mi- granti dall’accoglienza alla formazione. Un’analisi culturale dentro e fuori i servizi, FrancoAngeli, Milano.
Piga A., 2000. Dakar e gli ordini Sufi, Bagatto, Roma.Riccio B., 2000. ‘Spazi transnazionali: esperienze senegalesi’, Afri-
che e Orienti, 2, 3/4.Riccio B., 2001. “Migranti senegalesi e operatori sociali nella Ri-
viera romagnola. Una etnografia multi-vocale del fenomeno mi- gratorio’, La Ricerca Folklorica, 44.
Riccio B., 2002. ‘Senegal is our home: the anchored nature of Se- negalese transnational networks’, in Al-Ali N., Koser, K. (a cura di), New Approaches to Migration? Transnational Communities and the Transformation of Home, Routledge, London.
Rossi C., 2003. Antropologia culturale. Appunti di metodo per la ri- cerca nei “mondi contemporanei”, Guerini, Milano.
Rouse R., 1991. ‘Mexican migration and the social space of post- modernism’, Diaspora 1, 1.
Salem G., 1981. ‘De la brousse sénégalaise au Boul’ Minch: le sy- stème commercial mouride en France’, Cahiers d’Etudes Afri- caines, 81-83.
Salih R., 2003. Gender in Transnationalism. Home, Longing and Be- longing Among Moroccan women, Routledge, London.
Salzbrunn M., 2002. ‘L’impatto delle reti transnazionali degli emi- grati sulle elezioni presidenziali in Senegal nel 2000’, Afriche e Orienti, 4, 4.
Schmidt di Friedberg O., 1994. Islam, solidarietà e lavoro. I muridi senegalesi in Italia, Edizioni della Fondazione Agnelli, Torino.
Scidà G., 1994. ‘Fra carisma e clientelismo: una confraternita mu-sulmana in migrazione’, Studi Emigrazione/Etudes Migrations,31, 113.
Sciortino G., 1999. ‘Mapping in the dark: The evolution of Italian immigration control’, in Brochman G., Hammar T. (a cura di) Mechanisms of Immigration Control, Berg, Oxford.
Scott J.C., 1998. Seeing like a State. How certain schemes to im- prove the human condition have failed, Yale University Press, New Haven.
Smith M.P., Guarnizo L.E. (a cura di), 1998. Transnationalism from below, Transaction Publishers, New Brunswick.
Smith R. C., 1998. ‘Transnational localities: community, technology and the politics of membership within the context of Mexico
145

Bruno Riccio
and U.S. migration’ in Smith M.P., Guarnizo, L.E. (a cura di), Transnationalism From Below, Transaction Publishers, New Brunswick.
Stolke V., 2000. ‘Le nuove frontiere e le nuove retoriche culturali della esclusione in Europa’ in Mezzadra S., Petrillo A., I confini della globalizzazione, Manifestolibri, Roma.
Trouillot M.R., 2001. ‘The anthropology of the state in the age of globalization’, Current Anthropology, 42, 1.
Vertovec S., 1999. ‘Conceiving and researching transnationalism’,Ethnic and Racial Studies, 2, 2.
146

CONTESTI UMANITARI E PERIFERIE EMERGENTI: LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
E I NOMADISMI DELLA CONTEMPORANEITÀ
di Ivo Giuseppe Pazzagli


1. Premessa
I nuovi nomadismi che percorrono la contemporaneità sono divenuti oggetto privilegiato ed emergente della ricerca e della riflessione antropologica (Bhabha 1994; Appadurai1996; Hannerz 1996) e fra i nuovi attori di questo universo frammentato e attraversato da flussi transnazionali, vanno certamente inclusi gli individui, i gruppi e le idee che a vario titolo si muovono lungo le direttrici molteplici attivate dal si- stema dall’intervento umanitario e della cooperazione inter- nazionale. (Fisher1997: Markowitz 2001; Mehta 2001; Pan- dolfi 2000). D’altra parte il mondo dell’intervento umanita- rio e della cooperazione è oggi un complesso e vasto arcipe- lago che si è venuto progressivamente strutturand o a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e rappresenta cer- tamente uno dei fenomeni che si inscrivono all’interno delle complesse dinamiche che caratterizzano i processi di glo- balizzazione (Fisher 1997; Markowitz 2001; Mehta 2001).
Una delle caratteristiche e degli effetti di questo fenomeno è rappresentato dal prodursi al suo interno di nuove forme di nomadismo e di ibridismo culturale “intenzionale”. Come cercherò di mostrare, analizzando la vicenda della ex Iugo- slavia, (Cfr. infra p. 158 e seg.) l’intervento umanitario e la cooperazione internazionale, nella misura in cui contribui- scono a strutturare contesti che vedono l’intreccio e il con- fronto tra logiche, rappresentazioni e interessi di attori so- ciali diversi, comportano l’attivazione di processi di nego- ziazione, mediazione e ibridazione culturale e sono, per que- sto, oggetto di una crescente attenzione da parte degli an- tropologi (Fisher1997; Markowitz 2001; Mehta 2001).

149

Ivo Giuseppe Pazzagli
2. La complessità dei nuovi contesti
Come molti antropologi hanno evidenziato nel dibattito di questi ultimi anni, proprio i processi connessi alla globaliz- zazione, accelerando la circolazione di persone, informazio- ni, immagini e significati, contribuiscono alla produzione della diversità. Processi quali la creazione di culture tran- snazionali delocalizzate – o come le definisce Hannerz (1998;2001) “di strutture di significato che viaggiano su reti di co- municazione sociale non interamente situate in alcun sin- golo territorio” –, da un lato, e i processi di ibridazione e in- digenizzazione, dall’altro, non preludono ad una riduzione della diversità, ma al contrario ad una sua accelerata produ- zione nonché ad una trasformazione profonda dei processi che caratterizzano il prodursi e il manifestarsi di tali diversità nell’intreccio fra locale globale, e ad una trasformazione dei modi in cui individui e gruppi utilizzano le differenze nelle diverse arene locali e non, in cui si trovano ad interagire.
La mondializzazione dei contesti, d’altra parte, fornisce un nuovo grande teatro d’azione, non solo alle nuove in- crespatur e dell’identità, alle affermazioni disperate di prete- se originalità etniche, religiose o storiche, o ancora alle ma- nifestazioni ricorrenti ed estreme di violenze simboliche, in- tellettuali e fisiche, ma anche ai diversi attori che si muovono sulle arene periodicamente attivate dalle crisi internazionali. E l’impossibilità di controllare le conseguenze dell’azione sociale ci deve rendere oggi, sempre più attenti alla com- plessità dei campi che si strutturano, nell’intreccio fra locale e globale, su questi teatri (Agier 1997).
3. L’antropologia e la cooperazione allo sviluppo
Il coinvolgimento dell’antropologia nella cooperazione per lo sviluppo e in progetti di cambiamento programmato vanta una lunga tradizione e allo stesso tempo è da sempre fonte di controversie e di scontri all’interno della disciplina.
Erede diretta dell’antropologia applicata, l’antropologia
150

Contesti umanitari e periferie emergenti
impegnata sul terreno dello sviluppo, a partire già dagli anni’60 si è guadagnata, di fatto, una relativa autonomia fino a diventare una rubrica autonoma (Colajanni 1994; 1998).
Sarà perché come sostiene Borofsky (2000: 500) vi è stata sempre una chiara e soggiacente continuità nei soggetti di studio prescelti in genere dagli antropologi: “perdenti” o “derelitti” da sempre l’antropologia ha rivolto una partico- lare attenzione a chi ha meno potere, a quanti sono ai mar- gini rispetto ai centri in cui si esercita il potere politico ed economico occidentale. Sarà che dalla seconda metà dell’800 le diverse forme che ha assunto il rapporto fra “noi” e gli “altri” ci ha visti, senza sostanziali soluzioni di continuità, sulla frontiera1, più o meno coinvolti e più ò meno consape-volmente compromessi all’interno delle complesse relazionidi potere che l’occidente “sviluppato” ha instaurato con es- si nelle forma del colonialismo o del neocolonialismo (Hy- mes 1979; Malighetti 2002), certo è che il coinvolgimento dell’antropologia nei processi di cambiamento dei popoli del sud del mondo è stato costante anche se ha assunto nel tempo modalità alquanto differenziate.
Di fatto l’antropologo ha svolto diversi ruoli fra loro in- terconnessi: raccogliere e analizzare informazioni, fornire supporto nella definizione di progetti e di politiche, parteci- pare alla realizzazione di tali progetti e monitorarne gli effetti in termini di cambiamento sociale e culturale (Nolan 2002:72). Un coinvolgimento basato sulla convinzione che un uso selettivo delle conoscenze antropologiche possa costituire un vantaggio in rapporto al miglioramento delle condizione dei gruppi coinvolti negli interventi e per una migliore effi- cacia degli stessi. Nonostante questa convinzione sia larga- mente condivisa fra gli antropologi impegnati nella coope- razione, tuttavia non c’è accordo su come questa conoscenza possa essere utilizzata al meglio (Gow 2002: 302; Colajanni1994; 1998).
Su un versante Cernea, un antropologo impegnato per molti anni presso la World Bank, si caratterizza per una po- sizione che lui stesso definisce social engineering action model postulando una sorta di trasposizione delle conoscenze pro-
151

Ivo Giuseppe Pazzagli
prie delle scienze sociali in strumenti di conoscenza e cam- biamento utili per produrre e organizzare nuove relazioni sociali, per democratizzare i processi di pianificazione e fa- cilitare la più vasta partecipazione (Cernea 1991; 1995). Co- me sottolinea Gow (2002), Cernea propone una versione contemporanea dell’ “autorità antropologica” affermando di fatto che lo scienziato sociale, e solo lo scienziato sociale, è l’unico a trovarsi in una posizione tale da poter decidere e parlare per conto delle popolazioni locali.
All’altro estremo troviamo la posizione espressa da Alan Hoben, forse il primo antropologo ad occupare una posi- zione elevata in USAID, l’agenzia del governo federale degli Stati Uniti per lo sviluppo e l’intervento umanitario, ed an- che uno dei primi a scrivere sull’esperienza di lavoro antro- pologico nell’ambito delle istituzioni per lo sviluppo (Gow2002: 302). Nella prospettiva di Hoben l’antropologia può svolgere un ruolo importante contribuendo a chiarire e cam- biare molti degli assunti espliciti e impliciti che sono alla base dell’azione di coloro che hanno responsabilità dirette nella pianificazione e nell’implementazione di azioni di svi- luppo o di intervento umanitario (Hoben 1982). Una fun- zione critica che si esplica in un lavoro di chiarificazione fi- nalizzata al cambiamento delle prospettive degli attori coin- volti; un approccio teso a fornire una visione dello sviluppo dal basso e a gettare luce sull’organizzazione, gli interessi e le strategie delle élite e delle burocrazie locali. Un orientamen- to metodologico che fa perno sulla nozione di “elucidazio- ne” e sulla fiducia nell’educazione; una strategia che sa di dover mettere in conto un percorso tortuoso, incerto e lento, per ottenere delle ricadute sulla società in termini di cam- biamento. Approccio cui si contrappone la propensione al- l’azione, il carattere gerarchizzante e decisionista del social engineering action model (Gow 2002: 303).
Tuttavia, nonostante la diversità degli approcci, e la scarsa propensione a comunicare i risultati del proprio lavoro pro- fessionale, il contributo degli antropologi ha riguardato una serie di questioni che vanno dai processi di rilocalizzazione forzata al colonialismo, dallo studio dell’organizzazione e
152

Contesti umanitari e periferie emergenti
delle caratteristiche delle elite locali alla conoscenza delle economie familiari e dei sistemi di proprietà comune, dallo studio e delle economie formali all’analisi di quelle informa- li (Gow 2002: 203).
3.1. Dall’antropologia impegnata nei processi di sviluppo al- l’antropologia dello sviluppo
Nonostante la inevitabile contiguità e frequentazione reci- proca sul terreno, tuttavia, non c’è mai stato un grande fee- ling ne fra gli antropologi e gli esponenti delle diverse am- ministrazioni coloniali, prima, e i funzionari degli organi- smi internazionali poi, ne fra gli antropologi impegnati in progetti di sviluppo e gli esponenti dell’antropologia acca- demica (Escobar 1995; Gowe 2002; Malighetti 2002).
E se da un lato hanno certamente influito gli scarsi risultati pratici delle più volte tentate collaborazioni, a causa della “non facile commensurabilità fra il sapere dell’antropologia e le conoscenze che gli uomini pratici ritenevano necessarie” (Malighetti, 2002: 98), dall’altro a far problema è stata la di- mensione compromissoria implicita in qualsiasi ricerca orien- tata a fini pratici, svolta all’interno di relazioni di potere for- temente asimmetriche e difficilmente tematizzabili come quel- le che l’occidente industrializzato ha instaurato con i paesi cosiddetti in via di sviluppo nella fase di decolonizzazione.
A metà degli anni ’80, poi, sotto l’influenza degli approcci decostruzionisti e postmodernisti affermatisi in quegli anni, l’antropologia impegnata nell’ambito dei progetti di coope- razione allo sviluppo è stata sottoposta ad una caustica quan- to radicale critica insieme alla cooperazione nella sua globa- lità, accusata di essere semplicemente una forma avanzata di neo-colonialismo e di imperialismo. Ed è nel quadro di tale critica radicale, che tende ad affermare l’esistenza di una sostanziale “continuità storica tra le pratiche occidentalizzan- ti di cambiamento pianificato del periodo coloniale e le at- tuali iniziative per lo sviluppo dei paesi ex coloniali” che, se- condo alcuni autori, va inquadrato il coinvolgimento di una parte dell’antropologia della seconda metà del secolo scorso
153

Ivo Giuseppe Pazzagli
nei progetti e nelle iniziative di sviluppo dei paesi ex colo- niali (Grillo, 1985; Escobar 1995; Malighetti 2002).
Una sorta di anatema che la nuova Antropologia dello svi- luppo lancia contro le pratiche che si articolano intorno alla cooperazione per lo sviluppo e contro l’antropologia che con esse si è compromessa.
Secondo Gow l’antropologo che più di altri e soprattutto prima di altri ha contribuito a lanciare la sfida postmoderna al rapporto che l’antropologia ha instaurato con lo sviluppo è stato Escobar (1991; 1995) che, nel corso degli anni, ha so- stenuto con tenacia le sue tesi nonostante lo sbarramento cri- tico posto da altri antropologi (Tommasoli 2001).
Una critica che in ogni caso ha portato la comunità degli antropologi, anche quelli più impegnati sul terreno della cooperazione e dell’aiuto umanitario, a riflettere sulla no- zione stessa di sviluppo e ad alzare il livello dell’analisi fino ad includere nel campo di ricerca il ruolo e le caratteristiche delle organizzazioni implicate a vario titolo nell’intervento quali gli organismi internazionali, le Ong, i mass media, i movimenti ed infine il ruolo stesso dei linguaggio, inteso non tanto nel suo aspetto di strumento in grado di riflettere la “realtà”, ma di macchina produttrice essa stessa di realtà (Fisher1997; Hudson 2001; Markowitz 2001; Mehta 2001; Pandolfi 2002; Sabelli 1994).
A partire da una prospettiva Foucaultiana, la nozione di sviluppo viene esaminata in quanto pratica discorsiva si- stematicamente correlata a forme di conoscenza e a tecni- che di potere. In tale prospettiva il discorso dello sviluppo funzionerebbe quale giustificazione e legittimazione di un intervento teso ad indurre cambiamento imposto dall’e- sterno e la cui presunta “necessità” si basa su una pre-de- finizione sia del problema che delle modalità di soluzione (Gow 2002; Mehta 2001)
Una critica che si intreccia e progressivamente si ricon- nette, da un lato, alla più generale discussione intorno ai cambiamenti culturali connessi ai processi di globalizzazio- ne e alla crisi della modernità e, dall’altro, ai riflessi che tali cambiamenti producono nel dibattito interno all’antropo-
154

Contesti umanitari e periferie emergenti
logia. Dibattito che ha il suo punto di massima accelerazio- ne negli anni immediatamente susseguenti alla pubblica- zione, nel 1986, del libro “Wrthing Culture: Poetics and Politics of Ethnography” a cura di Gorge Marcus e James Clifford contenente gli interventi e le riflessioni scaturite da una serie di seminari svoltisi nella primavera del 1984 presso la School of American Research di Santa Fè nel New Messico. Un testo che ha diviso gli antropologi, portando al- la luce con veemenza problemi, dubbi e critiche da lungo tempo presenti nel dibattit o antropologico (Clifford, Mar- cus 1997; Callari Galli 2000: 65; Hymes 1979) e che non ha risparmiato nessuna delle vecchie certezze su cui si basava il lavoro etnografico.
3.2. I nuovi scenari della cooperazione e il ruolo delle Ong
Ma non è certo solo l’antropologia ad essere costretta a ri- vedere radicalmente le proprie coordinate teoriche e meto- dologiche sotto la spinta dei cambiamenti economici e poli- tici che hanno caratterizzato l’ultimo quarto del secolo scor- so. Dalla fine della divisione in blocchi contrapposti sim- boleggiata dalla caduta del muro di Berlino all’accelerazione verificatasi nello sviluppo delle nuove tecnologie dell’infor- mazione e della comunicazione, gli anni ’80 costituiscono in un certo senso uno spartiacque fra le politiche e le strategie di intervento impostate nell’immediato dopoguerra dalle su- perpotenze uscite vincitrici dal conflitto e le politiche ela- borate successivamente alla fine dei blocchi.
Ed è sullo sfondo costituito da questi più generali cambia- menti che verso la fine degli anni ’80 appare in tutta la sua evidenza la crisi dei modelli d’intervento utilizzati fino a quel momento nell’ambito della cooperazione allo svilup- po. Gli anni ’90, infatti, sono caratterizzati dalla ricerca di nuovi percorsi e nuove strategie per lo sviluppo. A partire dal Summit sulla Terra organizzato dall’Onu a Rio de Janei- ro nel 1992, l’ultimo decennio del secolo scorso è segnato da susseguirsi di conferenze internazionali organizzate dalle Nazioni Unite e dal moltiplicarsi di forum e convegni inter-
155

Ivo Giuseppe Pazzagli
nazionali organizzati dalle Ong che contribuiscono a mette- re a fuoco questa crisi e a definire nuovi orientamenti e coordinate di riferimento per la costruzione e la gestione degli interventi (Ianni 1999).
In questo nuovo scenario le Ong hanno assunto un ruolo crescente nella gestione dei flussi di risorse destinate allo sviluppo. Un fenomeno che ha assolto un ruolo primario
nel trasformare le diverse arene della cooperazione allo svi- luppo in contesti sempre più affollati da soggetti molteplici.
Dal punto di vista specifico della contemporaneità inter- pretata nei suoi aspetti nomadici tre aspetti di questo pro-cesso appaiono rilevanti.
Innanzitutto la crescita del ruolo delle Ong nei processi di cooperazione ha spinto i donatori verso una maggiore for- malizzazione delle politiche che essi intendevano perseguire e delle procedure di assegnazione delle risorse e di gestione e controllo dei progetti, quando non ad imporre logiche di co- noscenza della realtà e di problem setting che, in quanto ri- tenute scientifiche e universali, hanno avuto spesso l’effetto di rendere immune la definizione delle strategie d’azione da ogni contaminazione o valorizzazione dei sistemi di cono- scenza e di interpretazione della realtà legate alle specificità delle culture locali (Metha 2001). Un processo che ha spinto le Ong stesse verso l’assunzione, più o meno consapevole, di logiche formalizzanti e l’adozione di metodologie di inter- vento relativamente svincolate dalla specificità dei singoli contesti d’intervento e che le costringe a muoversi all’interno di una sorta di tecno-scape traslocale (Appadurai 2001).
In secondo luogo pare rilevante evidenziare il ruolo che le Ong hanno avuto in questi ultimi quindici anni nell’attiva- zione di movimenti a sostegno della loro azione. Le Ong, in- fatti, oltre ad elaborare proprie e specifiche culture orga- nizzative, sono spesso espressione di movimenti o di orga- nizzazioni sociali portatrici di specifici orientamenti valo- riali quando non di vere e proprie opzioni ideologiche, poli- tiche e/o religiose. In questa prospettiva, dunque esse hanno svolto e svolgono un ruolo attivo nell’interpretare e dare concretezza alla nozione di sviluppo; interpretazioni e idee
156

Contesti umanitari e periferie emergenti
per la cui diffusione, spesso, le stesse Ong, si attivano favo- rendo la nascita di movimenti a sostegno della loro azione2. In altre parole, ciò a cui si è assistito in questi anni è un crescente impegno delle Ong, sia dei paesi del nord che del sud del mondo – attive nella cooperazione per lo sviluppo e nell’aiuto umanitario – nella costruzione di network che connettono fra loro in molteplici modi aree geografiche e mi- lieu socio-culturali diversi, facendo circolare imponenti flus- si di risorse e di persone, di informazioni e ideologie, di co- noscenze scientifiche e tecnologie.
Infine gli anni ’90 vedono l’affermarsi di un altro processo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario: la cosiddetta cooperazione decentrata (Ianni1999). In Francia e in Italia, soprattutto, si sono venute svi- luppando una serie di esperienze che hanno visto il coinvol- gimento di soggetti nuovi: dalle associazioni del volontariato ai sindacati, alle amministrazioni locali, ai circoli ricreativi aziendali. In un quadro caratterizzato dalla critica sempre più aspra nei confronti delle logiche e delle strategie tradi- zionali della cooperazione allo sviluppo di tipo bilaterale, si viene affermando una retorica che pone l’enfasi su categorie che paiono avere un carattere per così dire alternativo.
Parole d’ordine come cosviluppo, sviluppo partecipativo, cooperazione decentrata, sviluppo dal basso, pongono spesso in contrapposizione stato e società civile, istituzioni nazionali e internazionali, da un lato, e comunità locale, dall’altro dando legittimazione e copertura ideologica ad una visione della cooperazione che Ralph Grillo e Bruno Riccio (2003) definiscono populista e che fornisce il necessario supporto al- l’attivazione di una molteplicità di attori all’interno di mi- croprogetti sia in patria – rivolti soprattutto a gruppi di im- migrati – che nei paesi in via di sviluppo.
Progetti che spesso attivano flussi bidirezionali, nel senso che tendono a coinvolgere gruppi di immigrati in progetti di sviluppo delle realtà locali dalle quali provengono, pro- ponend o una sorta di gemellaggio fra comunità locali, ov- vero ponendosi l’obiettivo non solo di attivare flussi di de- naro e di know how fra qui e la ma anche conoscenza reci-
157

Ivo Giuseppe Pazzagli
proca sotto diverse forme: dallo scambio di visite fra le ri- spettive autorità locali, all’ospitalità di minori, a forme di turismo responsabile, ecc.
Questi tre fenomeni inoltre, come sottolinea Callari Galli nella sua introduzione, non solo si intrecciano su uno sfondo caratterizzato da un progressivo affievolirsi della coincidenza fra cultura e territorio a favore di una diffusione di idee gene- rali, di stili di vita e di appartenenze a comunità immaginate sempre più caratterizzate da multipolarità territoriale, ma coinvolgono altresì individui e gruppi – migranti e rifugiati, masse urbanizzate caratterizzate da povertà estrema e bambi- ni di strada, per fare solo alcuni esempi – la cui relazione con il territorio appare profondamente alterata in diversi sensi.
4. I nuovi contesti della cooperazione e dell’intervento uma- nitario: il caso del conflitto nella ex Iugoslavia.
L’azione concomitante e sinergica di questi fattori, resa possi- bile dal processo di globalizzazione dell’economia e delle co- municazioni, di fatto ha reso il “campo” della cooperazione e dell’aiuto umanitario enormemente più complesso rispetto al passato; una complessità che, per essere analizzata, impone di fare attenzione ad una molteplicità di variabili, di piani e di contesti, diversamente intrecciati nelle situazioni concrete.
Per esemplificare cosa intendo per complessità di campo, mi riferirò alla vicenda balcanica che ha coinvolto profon- damente il nostro paese nell’ultimo decennio. L’esperienza della guerra nei Balcani, a mio avviso, rappresenta un ottimo esempio di come i processi di globalizzazione interagiscano sulla dinamica degli interventi umanitari e della coopera- zione, contribuendo a strutturare contesti che vedono l’in- treccio e il confronto tra logiche, rappresentazioni e interes-
si di attori assai più numerosi e diversificati che nel passato. Scelgo la ex Iugoslavia come esempio, non solo perché in
essa il nostro paese è stato particolarmente coinvolto, ma anche per il suo evidente carattere paradigmatico in rap-porto al tema in questione.
158

Contesti umanitari e periferie emergenti
L’esperienza della ex Iugoslavia, d’altra parte, in quanto prima crisi internazionale dopo la dissoluzione dei blocchi, ha avuto un carattere assolutamente peculiare e paradigmatico in quanto condensa e contiene una molteplicità di processi mai comparsi simultaneamente e, proprio per questo si pone co- me una sorta di spartiacque fra vecchie e nuove emergenze.
La crisi balcanica ha rappresentato, infatti, una novità inat- tesa e scioccante in quanto rivelava come nel cuore stesso dell’Europa potessero manifestarsi forma di tribalizzazione del conflitto che sembravano possibili solo in contesti “altri”, lontani, sia sotto il profilo spaziale che politico-culturale. Una crisi che mostrava drammaticamente quanto fosse illu- soria la convinzione che la diffusione della scolarità e della partecipazione politica potessero, di per sé, costituire un ar-
gine sufficiente ed efficace contro la barbarie. Benché i Bal- cani siano sempre stati considerati la polveriera d’Europa, una marca di confine rimasta per secoli sotto l’influenza di una cultura non europea, la ex Iugoslavia di Tito era pur sta- ta la culla del movimento dei paesi non allineati e il primo
paese socialista a prendere le distanze dallo stalinismo e dal- la politica dei blocchi contrapposti, alimentando illusioni, sia nel nord che nel sud del mondo, sulla possibilità di un so- cialismo dal volto umano. Una sorpresa e un disincanto che certamente hanno influito sul ritardo con il quale il resto dell’Europa ha preso coscienza della novità e della dramma-ticità di ciò che stava accadendo.
Il carattere paradigmatico di tale esperienza, d’altra parte, è confermato dalla vasta letteratura emersa in questi ultimi anni che, direttamente o indirettamente, fa riferimento alla crisi balcanica: dai reportage giornalistici del periodo bellico alla letteratura di taglio diaristico e/o di prima riflessione3, relativa alla fase post bellica, alla saggistica di varia imposta- zione disciplinare sviluppatasi a partire dall’immediato do- poguerra. Molta letteratura di matrice antropologica, infatti ha diffusamente focalizzato l’attenzione su ciò che di nuovo e drammaticament e originale si è prodotto in quell’area pri- ma, durante e immediatamente dopo la crisi: il collasso del-
159

Ivo Giuseppe Pazzagli
lo stato e l’etnicizzazione del conflitto, le pulizie etniche (Nagengast 1994; Hayden. 2002), l’intervento militare della forza multinazionale e l’intervento umanitario degli organi- smi internazionali, con gli effetti di sospensione della sovra- nità che, soprattutto nelle fasi di immediata post emergenza, sembra comportare (Campbell 1999; Ignatieff 2002; Pan- dolfi 2000; 2002) e ultimo, ma certamente non meno im- portante, il nuovo ruolo assunto dai media nella costruzione e nella gestione della crisi Jugoslava e delle crisi umanitarie in genere (Both 2001; Appadurai 1996; 2002).
Inoltre i Balcani sono stati in questi anni e sono tutt’ora oggetto di interventi a carattere umanitario e di coopera- zione allo sviluppo con progetti di dimensioni e tipologia fra le più disparate; progetti che di fatto hanno messo a con- fronto e intrecciato storie di individui, di piccole organizza- zioni e grandi organismi internazionali e comunità locali.
Tuttavia, ferme restando le importanti acquisizioni matu- rate all’interno di questo dibattito, l’angolatura dalla quale mi sembra interessante analizzare la vicenda Balcanica, nel- l’intento di cogliere gli aspetti nomadici della contempora- neità, è quella di analizzare e mettere in relazione le diverse “arene” che, in riferimento alla specifica realtà italiana, la cri- si in questione ha, di fatto, attivato – l’arena italiana e quella senz’altro più analizzata dei Balcani – con l’intento di co- gliere i processi trasformativi che hanno interessato i diversi attori coinvolti e la complessità di campo con cui si sono do- vuti confrontare coloro che sono intervenuti a partire da una prospettiva non solo solidaristica ma anche e soprat- tutto professionale.
La vicenda Jugoslava ha, infatti, allargato il numero e la ti- pologia di persone che hanno avuto diretta esperienza di un contesto di crisi umanitaria e coinvolto una larga base di operatori non professionisti della cooperazione.
Le ragioni di questo coinvolgimento di gruppi e attori inu- suali è da ricercarsi nella peculiarità del conflitto nella ex Iu- goslavia e nella pluralità di elementi di natura rappresenta- zionale ed esperienziale che esso ha messo in risonanza.
160

Contesti umanitari e periferie emergenti
4.1 La scena italiana in rapporto alla crisi balcanica
Per molti italiani la Iugoslavia é stata per anni un luogo co- nosciuto e familiare, associato ad un immaginario turistico e a precise e dirette esperienze di vacanza.
Su questo sfondo la deflagrazione della guerra in Croazia nel 1990, come documenta la cospicua letteratura apparsa in questi anni sull’argomento, è apparsa a molti, non solo inat- tesa e inspiegabile, ma situabile in uno spazio di cui si era fatto esperienza e di cui si aveva una rappresentazione che contrastava drammaticamente con le immagini del conflitto fornite dai media.
D’altra parte, lo scoppio della guerra ha immediatamente comportato l’arrivo in Italia di un flusso disordinato e a vol- te convulso di profughi che hanno contribuito a rendere le conseguenze del conflitto ancora più concrete ed esperibili, attraverso le narrazioni di testimoni diretti.
Sullo sfondo di un’Italia in piena crisi istituzionale e attra- versata dal nascente leghismo, l’ingresso prorompente dei media sulla scena di un conflitto cruento e fratricida, vicino geograficamente e percepito come interno al contesto euro- peo – il suo essere correlato non solo con il fallimento della transizione dall’economia di piano all’economia di mercato, ma anche con la crisi di uno stato che era sempre apparso come il più occidentale fra quelli appartenenti all’est euro- peo – hanno sicuramente evocato, in quegli anni, fantasmi e preoccupazioni sul fronte domestico e chiamato ad una as- sunzione di responsabilità associazioni, organizzazioni poli- tiche e operator i istituzionali: così la solidarietà e l’interven- to umanitario, grazie anche alla copertura offerta dai media, ha finito col costituirsi come un’arena assai peculiare dove diversi attori hanno messo in scena una rappresentazione complessa, polisemica e diretta ad una molteplicità di pub- blici e dove, in virtù della complessità del campo che si è an- dato progressivamente strutturando, si sono realizzate tra- sformazioni identitarie sia dei gruppi professionali tradizio- nalmente impegnati nell’intervento umanitario che degli at- tori apparsi per la prima volta su tale scena.
161

Ivo Giuseppe Pazzagli
Dalle carovane dell’aiuto umanitario, indiscriminato e cao- tico, dispiegatosi in pieno conflitto sotto i riflettori enfatici della stampa nazionale e locale (Miozzo 1998,), alle innume- revoli associazioni di volontariato attivatesi nel periodo post bellico sui terreni più disparati, alle istituzioni locali interve- nute in fase immediatamente successiva ad inseguire e a dare copertura ed espressione politica all’attivismo della società ci- vile attraverso la cosiddette “cooperazione decentrata”, in- numerevoli sono state le occasioni, anche per i cittadini meno impegnati nel volontariato e nell’azione umanitaria, per avere una qualche forma di contatto diretto con aspetti pur parzia- li di questa drammatica e complicata vicenda4.
Al punto tale che la crisi balcanica è divenuta un caso em- blematico analizzato da diversi punti di vista: come esempio di un massiccio, incontrollato e non richiesto invio di dona- zioni di cibo, soprattutto per bambini (Borel et al., 2001) e medicinali al di fuori di ogni meccanismo di coordinamento, dalla conseguenze disastrose in termini costi per correggere gli errori compiuti.
Un processo lungo, che ha visto l’alternarsi di fasi diverse, anche in rapporto al ripetersi delle emergenze nell’area bal- canica, e sicuramente dagli effetti contraddittori sulla scena interna: da una sorta di illusione di potenza e di capacità di azione – per cui mobilitarsi nell’aiuto si può – e che tende ad attivarsi e a riemergere appena si accendono i riflettori su una nuova emergenza umanitaria, alla costruzione di capa- cità imprenditoriali e nuove competenze nell’ambito della raccolta di aiuti e finanziamenti attivabili all’occorrenza, “utili” non solo in rapporto ai potenziali beneficiari, ma an- che all’acquisizione di visibilità e prestigio per i soggetti che operano sulla scena locale e nazionale.
E si tratta in ogni caso di un campo ancora in profonda e rapida evoluzione: pur essendo cambiate le retoriche e le rappresentazioni del contesto balcanico, nel passaggio alla fase della “cooperazione allo sviluppo”, attualmente in corso, altri attori sono entrati o stanno entrando in campo – come ad esempio le imprese e le loro strutture associative – atti-
162

Contesti umanitari e periferie emergenti
vando nuovi contesti e nuove problematicità la cui compren- sione appare rilevante sia sotto il profilo teorico che pratico.
4.2 La scena balcanica nella lettura degli operatori di Coope- razione Italiana
L’impatto con il contesto della ex Iugoslavia mette imme- diatamente in evidenza la sostanziale inadeguatezza dei mo- delli operativi utilizzati in precedenti esperienze di coopera- zione internazionale, una incompatibilità di approcci che per molti ha richiesto un significativo periodo di decom- pressione, di rielaborazione del know-how acquisito e degli apprendimenti realizzati in precedenti esperienze.
Come evidenziano diversi testimoni che hanno operato nella ex Iugoslavia in diversi contesti e con diversi ruoli, provenendo da molteplici esperienze sul campo in paesi in via di sviluppo, non solo Cooperazione Italiana, ma “l’intera comunità internazionale si è proiettata nella ex-Iugoslavia con la stessa attitudine che derivava dall’esperienza vissuta in decenni di lavoro nei paesi in via di sviluppo. Mai la comu- nità dei donatori aveva operato in un paese occidentale, mai avremmo potut o immaginare di effettuare un’operazione umanitaria in Europa , di dover intervenire a casa nostra” (Miozzo 1998: 24).
Nuove patologie sanitarie e nuovi problemi sociali posti dal collasso del sistema di welfare preesistente in relazione a target di popolazione non presenti nei paesi in via di svilup- po, come gli anziani; l’esistenza di controparti professional- mente preparate , di livello europeo, che rendevano difficile e impegnativa l’interlocuzione ponendo richieste di aiuto inu- suali, soprattutto in ambito sanitario, non previste da alcun protocollo dell’aiuto umanitario tarato sui paesi in via di sviluppo (Miozzo 1998; Camerini 1998).
Ma se da un lato l’essere europei costituiva un elemento di vicinanza in rapporto ai contesti di vita, dall’altro nasconde- va effettive differenze su altri piani. Per esempio, l’influenza duratur a di sistemi politico-istituzionali propri del socialismo reale, era riscontrabile nella presenza diffusa di culture la-
163

Ivo Giuseppe Pazzagli
vorative di tipo burocratico, orientate alla esecutività, non orientate alla soluzione dei complessi problemi posti dall’e- mergenza post bellica e, per esempio dalla necessità di ge- stire imponenti flussi di denaro secondo le logiche imposte dagli organismi internazionali.
L’impatto con un contesto sostanzialmente europeo, sia pure con caratteristiche peculiari, ha subito messo in evi- denza questo aspetto sottaciuto ancorché evidente di ogni re- lazione d’aiuto: la logica di potere che è insita nella struttura stessa dell’aiuto.
Per la prima volta, molti operatori provenienti dai contesti classici del lavoro di cooperazione e reclutati per fronteg- giare l’emergenza jugoslava si sono trovati ad operare in un contesto dove, anche in virtù degli alti livelli di istruzione che caratterizzano da sempre i paesi del socialismo reale, questa asimmetria fra donatore e ricevente non era affatto data per scontata. Dove gli attori locali, – socializzati a forma di par- tecipazione politica che, anche se diverse rispetto a quelle ti- piche delle democrazie liberali, erano comunque articolate e complesse – pretendevano un riconoscimento e un rispetto di logiche istituzionali e di potere locale, formalizzate e nien- te affatto destrutturate dall’emergenza bellica, chiedevano di controllare dove finivano gli aiuti e di decidere con i dona- tori come spendere i soldi.
Ma la richiesta di un ruolo negoziale nelle decisioni sull’u- tilizzo dei fondi, e attivo nella loro gestione, da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali, non solo appariva inu- suale e difficilmente inquadrabile nei modelli classici del- l’intervento umanitario, ma implicava l’accettazione di logi- che locali nell’allocazione delle risorse, nel modo di conce- pire la democrazia e la “trasparenza”, molto dissonanti e vissute come assolutamente inaccettabili per chi operava se- condo le logiche proprie degli organismi internazionali.
Nella rappresentazione degli attori istituzionali che hanno preso parte a questa fase dell’intervento umanitario, la com- plessità posta da questo contesto inusuale, ha comportato estenuanti negoziazione e l’adozione, ritenuta “necessaria” quantomeno nella prima fase e in rapporto ad obiettivi di
164

Contesti umanitari e periferie emergenti
“efficienza” imposti dagli organismi internazionali di riferi- mento, di una strategia imperniata sull’assunzione del lin- guaggio e della logica dell’aiuto umanitario che, come diversi autori hanno messo in evidenza, comporta una sospensione temporanea della sovranità e una logica di sostanziale espro- priazione mediante la inclusione di tutti gli interlocutori lo- cali nella categoria dei “beneficiari”, per definizione “vulne- rabili” e quindi incapaci di azione autonoma e di autodeter- minazione. (Pandolfi 2002; Igniatieff 2002).
Tuttavia, soprattutto in Bosnia-Erzegovina dove la durata dell’intervento è stata di gran lunga superiore a quella clas- sica degli interventi umanitari, a questa strategia, cui si è potuto facilmente fare ricorso nella fase di massima emer- genza, si sono progressivamente andate sostituendo strategie diverse e più centrate sulla cooptazione all’interno dei pro- getti degli interlocutori locali.
D’altra parte, la durata dell’intervento ha comportato una progressiva complessificazione del contesto e l’introduzione crescente di logiche difformi per l’azione convergente di atto- ri diversi: dalle Nazioni Unite deputate al controllo militare del territorio, alle diplomazie internazionali impegnate nella definizione e nella attuazione degli accordi di Dayton, agli organismi internazionali, alle Ong espressione di tutti i paesi industrializzati5, a quello che può essere considerato, senzaombra di dubbio, l’elemento nuovo dell’esperienza Balcanica,e cioè l’entrata in campo, in forme dimensioni mai verificatesi in precedenti crisi umanitarie, delle associazioni del volonta- riato6, soprattutto italiane e dei paesi europei limitrofi.
Come sottolina uno dei testimoni,
“l’esperienza balcanica, in quanto costituisce la prima cri- si internazionale dopo la dissoluzione dei blocchi, rap- presenta un elemento di discontinuità, uno spartiacque fra vecchie e nuove emergenze: la dissoluzione dei blocchi, infatti, in quanto ha ampliato le capacità e le possibilità di intervento in aree non più soggette a tutela, ha moltiplica- to e diversificato le politiche d’intervento rendendo i ter- ritori dell’aiuto contesti in cui operano soggetti con una lo- gica di mercato”.
165

Ivo Giuseppe Pazzagli
Un’arena in cui l’offerta di aiuto è divenuta, con il passare del tempo, molteplice, così come molteplice è divenuta pro- gressivamente la richiesta di aiuto, in parte indotta e richia- mata dall’offerta stessa; Un’arena nella quale si afferma la necessità, sconosciuta in precedenti interventi in paesi in via di sviluppo, di fare rete, di avere attenzione ai rapporti con gli altri attori presenti sulla scena, al fine di compren- derne le strategie, per fare delle alleanze, per non sovrap- porsi e potersi posizionare in maniera efficace nel mercato degli aiuti.
E su questa arena, caratterizzata da crescente complessità, si sono attivate sperimentazioni insolite, sono state tentate strade nuove e spesso contraddittorie, si sono creati conflit- ti e apert i negoziazioni di varia natura, si sono ridefinite identità istituzionali e organizzative e si sono prodotti feno- meni di ibridazione culturale significativi e a diversi livelli (Camerini 1998; Canevaro, Berlina, Camasta 1998).
Una complessità che in prospettiva, a giudizio di molti, sembra destinata a riprodursi in molti contesti attivati dagli interventi di emergenza a seguito di catastrofi naturali e umanitarie.
5. Conclusioni
A conclusione di questa riflessione mi pare importante sot- tolineare il ruolo che l’antropologia può e deve giocare nel fornire strumenti di analisi capaci di rendere conto dell’in- treccio di elementi e delle complessità che caratterizzano i nuovi contesti della cooperazione.
A prescindere dall’obiettivo specifico di ogni intervento, la sua realizzazione non può infatti prescindere da una rico- struzione e da una analisi dei diversi contesti nei quali l’a- zione si articola e della scena locale in cui si situa l’oggetto dell’intervento.
In altre parole, il carattere transnazionale dei processi atti- vati sia dalle nuove crisi umanitarie che dalla cooperazione allo sviluppo, per essere adeguatamente studiate e comprese,
166

Contesti umanitari e periferie emergenti
richiedono strategie di ricerca multilocali e multifocali, ca- paci di far emergere la percezione che le persone hanno del cambiamento del loro milieu culturale e, allo stesso tempo, consentano di analizzare l’incidenza, nella strutturazione dei contesti di intervento, dei diversi sistemi interconnessi: dalle istituzioni locali ai grandi organismi che tagliano trasversal- mente i confini nazionali e regionali, dalle culture locali ai flussi di informazioni, di immaginari e di significati che cir- colano nel sistema globale dei media.
D’altra parte le critiche mosse dall’antropologia dello svi- luppo all’antropologia applicata, ancorché vissute con molto disagio dai ricercatori impegnati nei progetti di cooperazione, hanno, di fatto, contribuito ad accresce la loro attenzione per le complessità derivate dalla molteplicità degli attori presenti sul terreno, dalle dinamiche che caratterizzano le relazione fra contesti locali e mondo globale, dal nomadismo virtuale e reale che caratterizza i gruppi e gli individui con i quali si tro- vano ad interagire e dal fatto di fare ricerca quasi sempre a partire da una collocazione istituzionale e organizzativa speci- fica e dall’essere quindi oggetto di rappresentazioni connotate in termini di potere da parte dei beneficiari degli interventi.
Un’antropologia che, abbandonata la prospettiva ristretta e angusta di una focalizzazione esclusiva sul locale e ripreso il contatto con il dibattito epistemologico che ha attraversato la disciplina in questi ultimi due decenni, ripensi oggetti di stu- dio, concetti teorici e coordinate metodologiche mettendosi nella condizione di produrre conoscenze utili ad intervenire in contesti caratterizzati da crescente complessità (Gow 2002).
167

Ivo Giuseppe Pazzagli
Note:
1 Per una lettura dell’antropologia come sapere di frontiera in quanto svi- luppatosi nelle aree di contatto e di scambio fra culture diverse vedi Fa- bietti 1999.
2 Markowitz (2001) segnala come in America Latina le ong, sollecitando il formarsi di vasti gruppi di sostegno alla loro azione, abbiano svolto un ruolo critico nel formarsi di movimenti sociali, contribuendo a rivitalizzare e ad espandere la società civile, giungendo ad esercitare talvolta una di- screta influenza nella destinazione delle risorse, fino al punto di arrivare a svolgere un ruolo visibile e formale nella vita politica.
3 A titolo puramente esemplificativo di questo genere di letteratura cfr: Canevaro, Berlini, Camasta 1998; Mattioli 1999. Voglio inoltre ringrazia- re particolarmente Alfredo Camerini la cui lunga esperienza in diversi contesti e con ruoli diversi, si è rivelato di enorme importanza per accre- scere la mia comprensione del tema in discussione.
4 Il fenomeno d’altra parte non ha riguardato solo l’Italia ma l’Europa in- tera. Si veda a questo proposito l’analisi relativa all’Olanda condotta da Norbert Both (2001)
5 Sulle nuove dinamiche dell’aiuto umanitario che si sono venute strut- turando nelle recenti crisi internazionali e sul ruolo dei media nel deter- minare la quantità e la qualità degli aiuti vedi fra gli altri Olsen et al., 2003.
6 Per una rassegna degli studi antropologici dedicati al cosiddetto “terzo settore” e al ruolo che esso ha avuto nella cooperazione allo sviluppo vedi Lewis, 1999.
Bibliografia:
Agier M., a cura di, 1997. Anthropologues en danger. L’engage- mente sur le terrain, Editions Jean-Michel Place, Paris.
Appadurai A., 2001, [1996]. Modernità in polvere, Meltemi, Roma. Appadurai A., 2002. Dead certainty: Etnic Violence in the era of
Globalisation, in Hinton A. L., (a cura di), 2002. Genocide: AnAnthropological reader, Blackwell Publishers Ltd, Malden.
Bhabha H., 2001. I luoghi della cultura, Meltemi, Roma, [1994] Bisogno M., Chong A., 2002. Poverty end Inequality in Bosnia
and Erzegovina After the Civil War, World development, Vol. 30, No. 1, pp. 61-75.
Borrel A., Taylor A., McGrath M., Seal A., Hormann E., PhelpsL., Mason F., 2001. “From Policy to Practice: Challenges in In-
168

Contesti umanitari e periferie emergenti
fant Feeding in Emergencies During the Balkan Crisis”, Disa- sters, 25 (2): 149.
Borofsky R., 2000, [1994]. “Antropologia applicata. Introduzio- ne”, in Borofsky R., (a cura di), L’antropologia culturale oggi, Meltemi, Roma, 2000.
Both N., 2001. “From indifference to entrapment: the Nether- lands and the Yugoslav crisis, 1990-1995”, International-Affairs.77 (2) : 455.
Callari Galli M., 2000. Antropologia per insegnare, Bruno Monda- dori, Milano.
Camerini A., 1998. “Aiutare ad aiutare: cooperativi in emergenza”, in Canevaro A., Berlini M. G., Camasta A. N., (a cura di), 1998. Pedagogia cooperativa in zone di guerra, Erikson, Trento.
Campbell D., 1999. “Apartheid Cartography: the political anthro- pology and spatial effects of international diplomacy in Bosnia”, Political Geography, 18 (1999), 395-435.
Canevaro A., Berlini M. G., Camasta A. N., (a cura di), 1998. Pe- dagogia cooperativa in zone di guerra, Erikson, Trento.
Carniawska B., 2000, [1997]. Narrare l’organizzazione. La costru- zione dell’identità istituzionale, Edizioni di Comunità, Torino.
Cernea Michael M., 1991. Knowledge from Social Science for de-velopment Policies and projects, in Cernea Michael M. (a cura di), Putting people first: sociological Variables in Rural Develop- ment, Oxford University Press, New York.
Cernea Michael M., 1995. “Social Organization and DevelopmentAnthropology”, Human Organization, 54: 340-352.
Clifford J., Marcus G. E., 1979. Scrivere le culture. Peotiche e poli- tiche in etnografia, Meltemi, Roma.
Colajanni A., 1998. “Note sul futuro della professione antropolo- gica: l’utilità dell’antropologia come problema teorico e appli- cativo”, in Etnoantropologia n. 6-7. 1997-1998, pp. 23-35.
Colajanni A., 1994. “L’antropologia dello sviluppo in Italia”, in Co- lajanni A., Di Cristofaro Longo G., Lombardi Satriani L. M., (a cura di), Gli argonauti: l’antropologia e la società italiana, Ar- mando, Roma.
Escobar A., 1991. “Anthropology and the Development Encoun- ter: the making and Marketing of development anthropology”, American Ethnologist, 18: 658-682.
Escobar A., 1995. Encountering Development: The making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Prin- ceton, Trad. it. parziale in Malighetti 2002, pp. 293-308.
169

Ivo Giuseppe Pazzagli
Fabietti U., 1999. Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpre- tazione, Laterza, Bari.
Fabietti U., 2000. “Il traffico delle culture”, in Fabietti U., Mali- ghetti R., Matera V., Dal tribale al globale, Bruno Mondadori Editore, Milano.
Fisher W. F., 1997. “DOING GOOD? The Politics and Antipolitics of NGO Practice”, Annual review of Anthropology, 23:
439-464. Gowe D. D., 2002. “Anthropology and Development: Evil Twin or
Moral Narrative”, Human Organization, 61 (4).Grillo R., Rew A., a cura di, 1985, Social anthropology and deve-
lopment policy, Tavistock, London.Grillo R., Riccio B., 2003. “Translocal Development: Italy-Sene-
gal”, in a special issue on “Transnational migration, return and development in West Africa”, Population Society and place, [in corso di pubblicazione].
Hannerz U., 2001, [1996]. La diversità culturale, Il Mulino Bolo- gna, (Trad. it. parziale: Transnational Connections. Culture, Peo- ple, Places, Rutledge, London-New York, 1996).
Hannerz U., 1998. [1992]. La complessità culturale. L’organizza- zione sociale del significato, Il Mulino, Bologna.
Hayden R. M., 2002. Imagined Comunities and Real Victims: Self- Determination and Etnic Cleasing in Yugoslavia, in Hinton A. L. (a cura di), 2002.
Heyman, Josiah McC., 1995. “Putting power in the Anthropo- logy of Bureaucracy”, Current Anthropology, 36: 261.
Hinton A. L. (a cura di), 2002. Genocide: An Anthropological rea- der, Blackwell Publishers Ltd, Malden.
Hoben A., 1982. “Anthropologists and Development”, AnnualReview of Anthropology, 11: 349-375.
Hudson A., 2001. “NGOs’ transnational advocacy networks: from‘legitimacy’ to ‘political responsibility’?”, in “Global Networks”,1, 4, pp. 331-352.
Hymes D., 1979, [1969]. Antropologia radicale, Bompiani, Milano. Ianni V., 1999. La cooperazione decentrata allo sviluppo umano,
Rosemberg & Sellier, Torino.Ignatieff M., 2002. Intervention and state failure, Dissent, Vol. 49,
pp. 114-123.Lewis D., 1999. “Revealing, widening, deepening? A review of
the existing and potential contribution of anthropological approaches to “third sector” research”, Human Organization, 58 1: 73-81.
Malighetti R., 2001. Antropologia applicata, Unicopli, Milano.

170

Contesti umanitari e periferie emergenti
Malighetti R., 2002. “Post-colonialismo e post-sviluppo: l’attualità dell’antropologia coloniale”, Antropologia, (22): 91-114, Melte- mi, Roma.
Marcus G., 1995. “Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography”, Annual Reviews in Anthropology, 24: 95-117.
Marcus G., Fischer M., 1986. Anthropology and Cultural Criti- que: an Experimental Moment in the Human Science, University of Chicago Press, Chicago.
Markowitz L., 2001. “Finding the Field: Notes on the Ethno- graphy of NGOs”, Human Organization, 60 (1): 40-46.
Mattioli S., 1999. Mi piace che siano misti, Magma edizioni, Pesaro. Mehta L., 2001. “The World Bank and its emerging knowledge
empire”, Human Organization, 60 (2): 189-196.Miozzo A., 1998. Cosa è cooperazione italiana, in Canevaro A.,
Berlini M. G., Camasta A. N., (a cura di), 1998.Nagengast C., 1994. “Violence, Terror, and the Crisis of the State”,
Annual review of Anthropology, 26: 109-36.Nolan Riall W.,2002. Development anthropology: encounters in the
real world, Westview Press, Boulder, Colorado.Nordstrom C., Robben A. C. G. M., (a cura di), 1995. Fieldwork
under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, Uni- versity of California Press, Berkeley.
Olsen G.R., Castensen N., Hoyen K, 2003. “Humanitarian Crisis: What Determines the Level of Emergency Assistance? Media Coverage, Donor Interests and the Aid Business”, Disasters,27(2): 109-126.
Olujic M. B., 1995. “The Coroatian War Experience” in Nord- strom C., Robben A. C. G. M., (a cura di), Fieldwork under Fire. Contemporary Studies of Violence and Survival, University of Ca- lifornia Press, Berkeley.
Pandolfi M., 2000. L’industrie humanataire: une souveraineté mou- vante e supra-Coloniale. Reflèxion sul l’experience des Balkans, Multitudes, 2000, Autom.
Pandolfi M., 2002. “Moral Intrepreneurs” , souverainetes mou- vantes et barbelés: le bio-politique dans le Balkans postcomuni- stes”, Anthropologie e Société, 26, (1), pp. 29-50.
Sabelli F., 1998, [1993]. Ricerca antropologica e sviluppo, EdizioniGruppo Abele, Torino.
Tommasoli M., 2001. Lo sviluppo partecipativo. Analisi sociale e lo- giche di pianificazione, Carocci, Roma.
171


Collana Guaraldi Universitaria
In catalogo
Andrea GuizzardiLa Previsione economica
Ennio BispuriInterpretare Fellini
Pier Francesco Frillici e Federica Muzzarelli (a cura di) Dispensa del Corso di storia e tecnica della fotografia (prof. Claudio Marra)
Bruno GandolfiCapire il turismo. Politiche, formazione, incentivi, organizzazione.
Mara BenadusiEtnografia di un istituto scolastico
Di prossima apparizione
Ivo Giuseppe Pazzagli (a cura di)I nuovi territori dell’identità
Lawrence VenutiScandali della traduzioneA cura di Stefano ArduiniTraduzione italiana di Roberta Fabbri
M. C. Galli, Giovanna Guerzoni, B. Riccio (a cura di)Culture e conflitto

Finito di stampare nel mese di gennaio 2005 per conto di Guaraldi Editore
presso il Centrostampa Digitalprint – Rimini