MIGRAZIONI NEL CORNO D’AFRICA - Caritas Italiana · La guerra civile combattuta in Etiopia alla...
Transcript of MIGRAZIONI NEL CORNO D’AFRICA - Caritas Italiana · La guerra civile combattuta in Etiopia alla...
Dossier realizzato da Angelo Pittaluga, Casco Bianco di Caritas
Italiana a Gibuti nell’anno 2008-2009.
MIGRAZIONI NEL CORNO D’AFRICA
INDICE
Introduzione 2
Capitolo I. La realtà degli stranieri nella Repubblica di Gibuti 3
1. Stime quantitative e problemi principali 3
2. I richiedenti asilo 8
3. Proposte d’intervento e ruolo della Chiesa Cattolica 16
Capitolo II. Campo profughi di Ali Addé 18
1. L’organizzazione del campo 18
2. I problemi principali dei rifugiati 22
3. La minoranza cristiana nel campo profughi 27
4. La vendita dei Resettlement Programs 30
Capitolo III. Migrazioni verso i Paesi arabi 33
1. Il viaggio dei migranti 34
2. Il traffico dei clandestini 37
3. I pericoli del viaggio 39
1
Introduzione
Il Corno d’Africa rappresenta, nel panorama mondiale, uno spazio di migrazione
tanto importante quanto poco indagato. L’instabilità politica ed i conflitti che hanno
agitato negli ultimi decenni l’Eritrea, l’Etiopia e la Somalia, insieme alla miseria
assoluta che colpisce larga parte della popolazione di questi Paesi, l’assenza di
prospettive lavorative, la discriminazione di gruppi etnici e minoranze, la violazione di
diritti umani fondamentali, hanno determinato in questa zona del continente africano un
movimento umano stupefacente e preoccupante.
Centinaia di migliaia di persone, lasciati dietro di loro i villaggi, le famiglie, gli
affetti, “l’universo dotato di senso”, si sono messi in marcia senza nulla al seguito, se
non la speranza di una vita migliore; spesso, la speranza stessa di sopravvivere. Un
flusso umano inimmaginabile, che ogni giorno, senza sosta, percorre queste terre
dell’Africa Orientale verso la Repubblica di Gibuti e verso i Paesi Arabi, attraversando
il Golfo di Aden su barche di fortuna, che non sempre arrivano a destinazione.
I migranti credono che, di fronte alle difficoltà della vita quotidiana, si debba
accettare il rischio di partire. Come sostiene qualcuno: “le persone disperate compiono
gesti disperati”1.
Di fronte alla vastità di questo fenomeno, che riguarda anche minoranze
perseguitate, e un numero allarmante di bambini abbandonati, pare necessario ed
urgente compiere ogni sforzo per conoscerne le cause, i protagonisti ed i problemi
principali.
Pare opportuno, in particolare, soffermare l’attenzione su tre aspetti principali. In
primo luogo si prenderà in esame la condizione degli stranieri nella Repubblica di
Gibuti, con particolare riferimento alla categoria dei “richiedenti asilo”. In secondo
luogo si esaminerà la realtà del campo profughi di Ali Addè. Infine, si volgerà lo
sguardo sui migranti che attraversano il Paese, per raggiungere i Paesi arabi.
1 Msgr. G. Bertin, Protection and care for all, intervento alla conferenza regionale di Sanaa, Yemen, su “Protection for Refugees and Mixt Migration in the Horn of Africa”, organizzato dall’Alto Commissariao delle Nazioni Unite per i Rifugati (UNHCR); Sanaa, 20.5.2008.
2
CAPITOLO I
La realtà degli stranieri nella Repubblica di Gibuti
1. Stime quantitative e problemi principali
Gibuti è sempre stato considerato una destinazione favorita per i migranti e i
rifugiati provenienti dai Paesi limitrofi: l’Etiopia, l’Eritrea e la Somalia. La guerra civile
combattuta in Etiopia alla fine degli anni ’80, in particolare, con la destituzione del
presidente e i disordini interni, ha generato un vero e proprio esodo degli etiopi verso
Gibuti. Ma non solo dai Paesi limitrofi provengono gli immigrati. I genocidi che si sono
abbattuti, negli anni ’90, sulla zona dei Grandi Laghi (Ruwanda, Congo, Burundi), e le
guerre sanguinarie combattute in diversi altri Paesi dell’Africa (Sudan, Uganda…)
hanno attirato a Gibuti un numero sempre crescente di persone.
La percentuale di immigrati a Gibuti è oggi stimata intorno al 20 % della totale
popolazione del Paese (stimata a 700.000). Gibuti in effetti viene descritto come un’oasi
di pace in un deserto in tempesta, in una regione cioè carica di problemi e rischi per la
sicurezza: la costante minaccia di una guerra di frontiera tra Eritrea ed Etiopia, le
continue battaglie tra i sostenitori del Governo e le Corti Islamiche in Somalia, ed i
nuovi contrasti in Kenya. Una certa stabilità economica e politica a Gibuti ha attirato in
questo Paese migliaia di persone in cerca di migliori prospettive di vita.
Negli ultimi anni, inoltre, Gibuti è divenuto una “destinazione di transito” per
migliaia di persone dirette verso i Paesi Arabi e verso l’Europa. Nei primi mesi del 2008
un gran numero di migranti ha scelto la rotta per lo Yemen passando da Gibuti, come
alternativa al tragitto proposto dai pericolosi “scafisti” di Bossaso, in Somalia. Da
Gennaio a Marzo 2008 sono stati registrati da UNHCR 2.213 nuovi arrivi a Gibuti dalla
Somalia (251 a Gennaio, 1.100 a Febbraio, 862 a Marzo). Un continuo flusso di
migranti viene segnalato nella zona tra il Somaliland e Gibuti, nel tentativo di
oltrepassare il confine. È stata rilevata inoltre la presenza di trafficanti che, per eludere
questa zona sorvegliata, trasportano i migranti via mare da Zeila (Somaliland) verso il
3
nord di Gibuti, e da qui verso lo Yemen. Nel mese di Marzo sono stati arrestati circa
200 migranti, alcuni fermati al confine con l’Eritrea, tra Obock e Khor-Angar, altri
fermati in mare, mentre si apprestavano ad attraversare illegalmente lo stretto tra Gibuti
e lo Yemen2.
Un forte movimento umano si rileva inoltre sul tragitto che dall’Etiopia
attraversa Gibuti, fino alla costa nordorientale, punto di sbarco verso i Paesi arabi. Su
questa strada si contano ogni giorno decine e decine di viandanti che, partiti a piedi
dall’Etiopia, tentano di raggiungere i villaggi di Tadjoura e Obock nella speranza di
trovare, il prima possibile, un passaggio per lo Yemen.
La realtà degli immigrati a Gibuti si presenta estremamente variegata, per quanto
riguarda il Paese di provenienza, la ragione della migrazione e lo status giuridico sotto il
quale il migrante viene riconosciuto. Le stime quantitative sulla presenza degli stranieri
sono inevitabilmente parziali e imprecise, poiché riguardano soltanto quella parte di
persone “riconosciute” dal Governo gibutino e dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i
Rifugiati. Secondo le più recenti statistiche, del febbraio 2009, sono presenti a Gibuti
9.186 stranieri riconosciuti come “rifugiati”, di cui 8.882 presso il campo profughi di
Ali-Addeh e 304 “rifugiati urbani”, che vivono al di fuori del campo. I dati sulla
provenienza geografica di questi sono così espressi:
- Eritrea 150
- Etiopia 551
- Somalia centrale 358
- Somaliland 2.832
- Somalia del sud 5.290
- Sudan 3
- Yemen 2
A questi si aggiungono 428 stranieri “richiedenti asilo”, per i quali è in corso la
procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato. Costoro provengono
2 Cfr. UNHCR, Djibouti: Implementing the 10- Point Plan of Action, UNHCR, Ginevra, 2008.
4
dall’Eritrea (225), dall’Etiopia (201), dal Sudan (1) e dalla Repubblica Democratica del
Congo (1)3.
Sollevando lo sguardo dalle statistiche stampate, tuttavia, s’incontra il volto più
spaventoso, e preoccupante, dell’immigrazione a Gibuti. Il volto di oltre 10.000 persone
senza alcun riconoscimento giuridico definito, e di conseguenza senza alcuna tutela e
protezione. Gli immigrati “illegali” costituiscono la maggioranza degli stranieri presenti
nel Paese. Costoro non hanno uno status giuridico, e sovente nemmeno un documento
d’identità valido, dunque non hanno speranze di un impiego lavorativo “in regola”, di
un’assistenza sanitaria in caso di malattia, né la garanzia di un giusto trattamento e di
una giusta difesa in caso di arresto da parte della Polizia. Nella maggior parte dei casi,
data l’assenza di documenti validi, non possono nemmeno dimostrare “chi sono”.
Fantasmi, che hanno perso tutto dalla vita. Fino alla loro “identità”.
Gli immigrati irregolari a Gibuti provengono principalmente dall’Etiopia, ma si
rileva altresì una presenza significativa di eritrei e somali “non riconosciuti”. Costoro si
suddividono, per quanto riguarda la ragione della migrazione, in due gruppi principali:
immigrati “economici” e immigrati “politici”. I primi si sono messi in cammino per
trovare prospettive di lavoro migliori, laddove nel loro Paese la miseria li riduceva a
condizioni di vita ai limiti della sopravvivenza umana. I secondi sono partiti a causa di
discriminazioni e violenze verso il loro gruppo etnico (vedi il caso di oromo opposti al
Governo etiope), o come dissidenti nei confronti di regimi autoritari (vedi il caso degli
studenti eritrei, fuggiti dal loro Paese perchè costretti ad arruolarsi nell’esercito, al
servizio di un Governo totalitario). Entrambi questi gruppi, gli immigrati “economici” e
gli immigrati “politici”, sono accomunati evidentemente da un comune denominatore,
che possiamo definire “migrazione forzata”. Partiti per necessità, rischiando tutto, anche
la vita, perchè non avevano alternativa alcuna.
L’aspetto paradossale di questa realtà, che suscita uno sdegno istintivo, si trova
nel fatto che la maggior parte di queste persone, specie gli immigrati “politici”, hanno il
diritto ad essere riconosciuti come rifugiati. Presentano, per dirla altrimenti, tutte le
caratteristiche che secondo la legge internazionale, e la Convenzione di Ginevra del
1951 (ratificata dal Governo di Gibuti), dovrebbero garantire loro l’attestato ufficiale di
rifugiato, con tutti i rilevanti vantaggi che un riconoscimento giuridico può determinare
3 UNHCR, Statistiques au fevrier 2009, Unité d’Enregistrement et Statistiques, UNHCR, Djibouti, 2009.
5
(in termini di tutele giudiziali, possibilità lavorative, partecipazione a progetti di
reinserimento sociale...) 4. Eppure, a causa dell’inoperosità, dell’inefficienza ed anche
della corruzione che abitano gli uffici ministeriali, e a causa di un certo compiacente
lassismo delle agenzie delle Nazioni Unite, costoro continuano a vedersi negato il
riconoscimento di un documento che per legge gli compete. Sprovvisti di ogni tutela, e
talvolta di ogni fonte di sostentamento, continuano a bussare alle porte degli uffici
competenti per raccontare la loro storia, di esseri umani costretti a scappare dalla
necessità di salvarsi la vita, che hanno il disperato bisogno – e il diritto – di
un’assistenza immediata. E costantemente si vedono respinti, maltrattati e inascoltati;
trattati per quello che sono. Fantasmi. Ma di questo aspetto si parlerà più
dettagliatamente nel prossimo paragrafo.
Torniamo ora al discorso sulla situazione dell’immigrazione a Gibuti, centro
nevralgico dei movimenti migratori del Corno d’Africa. Abbiamo visto che si dirigono
verso questo Paese due principali flussi di persone: coloro che attraversano il Paese per
raggiungere, attraverso lo stretto di Ba bel-Mandeb, lo Yemen e gli altri Paesi arabi, e
coloro che raggiungono il Paese come destinazione. Questi ultimi, migranti
“economici” e “politici”, si stabiliscono a Gibuti cercando un impiego lavorativo che
permetta loro di sopravvivere e, laddove ve ne siano i presupposti, intraprendono il
complesso iter burocratico per il riconoscimento dello status di rifugiato.
I principali problemi che le persone immigrate affrontano riguardano tre ambiti:
la salute, il lavoro, il rapporto con la Polizia. Per quanto riguarda il primo aspetto gli
immigrati denunciano gravi difficoltà ad accedere agli spazi ospedalieri in caso di
malattia, sia per un problema economico, non avendo i soldi sufficienti a pagarsi le
cure, sia anche per un problema di “rifiuto” degli stranieri senza documenti da parte
degli istituti di cura. I problemi di salute peraltro, vivendo queste persone in condizioni
estremamente disagiate, in abitazioni di fortuna o sulla strada, mangiando quando
possibile, sovente senza possibilità di lavarsi, sono frequenti e talvolta gravi.
Il lavoro costituisce un altro preoccupante problema per gli stranieri: tanto
difficile da trovare quanto necessario per sopravvivere. Non avere i documenti significa
“formalmente” non poter essere assunti, né tantomeno poter aprire un’attività propria.
Per guadagnarsi da vivere, pertanto, gli immigrati sono costretti spesso a lavori 4 V. UNHCR, Refugee Status and Resettlement, 2004; in particolare Cap. 3.4, Eligibility under the 1951 Convention and Regional Instruments.
6
sottopagati, senza tutela alcuna. In alcuni casi si rivolgono ad attività criminali: furti,
rapine, traffici di vario genere, che alimentano la diffusa ostilità verso di loro da parte
della popolazione gibutina.
Il problema della Polizia, infine, costituisce la paura principale degli immigrati
illegali. In quanto “clandestini” sono sempre soggetti alla possibilità di arresto e
deportazione, e conseguentemente vivono nel costante timore di essere strappati a
questa città, dove faticosamente cercano di sopravvivere. In alcuni casi il rapporto con
la Polizia si manifesta in maniera violenta, laddove agli arresti seguono ingiustificati
pestaggi e violenze arbitrarie. Come si è detto, queste persone spogliate di ogni cosa,
senza nemmeno un pezzo di carta che attesti “chi sono”, non hanno speranza che
vengano presi in considerazione i loro diritti: diritti di chi?Privati di ogni loro
prerogativa, non sono più nulla. Fantasmi, soggetti ad ogni arbitrio e violazione.
Per contro, esistono delle associazioni che si prendono cura di queste persone. A
fronte dei due principali organismi cui compete il riconoscimento dello status di
rifugiato, UNHCR e ONARS, si trovano diverse associazioni e istituzioni che tentano di
affrontare i problemi più urgenti per gli stranieri immigrati. Le principali a questo
riguardo sono l’UNICEF, per quanto concerne i diritti dei bambini; AMDA,
organizzazione non governativa giapponese che offre assistenza medica ai rifugiati;
APEF, associazione partner di ONARS e UNHCR per i servizi di assistenza sociale
presso il campo profughi di Ali Addeh; EPED (Eglise Protestante Evangelique de
Djibouti), che si è impegnata in passato nell’istituzione di una scuola per rifugiati etiopi
e che fino ad oggi si occupa dell’accoglienza e dell’orientamento degli immigrati
richiedenti asilo; CARITAS Gibuti, che offre assistenza sanitaria agli stranieri e un
centro per l’alfabetizzazione e l’inserimento sociale dei ragazzi di strada, provenienti
per lo più da Etiopia e Somalia.
7
2. I richiedenti asilo
Lo stato di Gibuti prevede una procedura precisa per l’ottenimento dell’attestato
di rifugiato. La persona immigrata si deve presentare per prima cosa all’ufficio ONARS,
un dipartimento del Ministero degli Interni che si occupa espressamente dei richiedenti
asilo. Qui si svolge l’intervista, nel corso della quale la persona interessata racconta la
propria storia, il motivo della migrazione, i rischi per la sicurezza e l’incolumità
personale che attualmente subisce. In seguito all’intervista vengono prese le impronte
digitali ed una fotografia, inserite nel dossier.
Dopo questa procedura iniziale il contenuto dell’intervista viene “valutato” da
una commissione composta da rappresentanti dell’Onars, i quali esprimono un parere
preliminare sull’esistenza o meno, in capo alla persona interessata, dei requisiti per
l’ottenimento dello status di rifugiato. A questo punto il dossier passa al vaglio del
Ministero degli Interni, dove una commissione speciale decide, sulla base del parere
dell’Onars, se accettare o rigettare la richiesta del richiedente asilo. In caso di rigetto,
devono essere precisati i motivi. In caso di accoglimento, viene trasmesso il fascicolo
agli uffici di UNHCR, dove viene rilasciato l’attestato ufficiale di rifugiato.
La procedura si presenta formalmente chiara e semplice da seguire. Seguendo la
lettera della legge, ci si aspetta che una persona in fuga da un Paese in guerra, o
perseguitata in ragione della sua etnia o religione, possa venire a Gibuti ed essere
riconosciuta come rifugiato in un breve periodo di tempo, ricevendo le tutele e la
protezione che le Nazioni Unite possono fornire. Tuttavia, a fronte di quanto la legge
scritta stabilisce, troviamo una realtà molto diversa.
I richiedenti asilo che si recano all’ONARS vengono normalmente lasciati fuori
dal portone, per intere giornate. Se insistono a bussare, rischiano l’arresto, o i
maltrattamenti del servizio di sicurezza. I pochi fortunati che riescono a fare l’intervista,
si trovano a dover aspettare una risposta che non arriva mai. La Commissione speciale
presso il Ministero degli Interni, incaricata di accettare o rigettare le richieste dei
richiedenti asilo, è ferma, si dice, da più di un anno. I fascicoli giacciono sulle scrivanie
impolverate degli uffici ministeriali, e nulla si smuove. E le migliaia di persone, che
hanno un disperato bisogno di un attestato giuridico che li tuteli, restano in attesa, in
8
balia degli eventi e dei rischi che quotidianamente subiscono. Inascoltati, maltrattati,
considerati buoni a nulla.
Sono state realizzate alcune interviste con persone straniere residenti a Gibuti,
che da anni attendono l’attestato di rifugiato. Il contenuto di queste interviste offre una
fotografia quanto mai chiara delle condizioni tremende cui queste persone sono
soggette.
Intervista n. 1. Studente eritreo, scappato dal suo Paese a causa della dittatura:
Vengo dall’Eritrea. Ero studente universitario, ma succedevano cose strane. Nel 2003, durante un esame i nostri paper erano stati consegnati al Military Office, per farli correggere. Dopodiché ci avevano comunicato che tutti dovevamo entrare per un certo periodo nell’esercito, tutti gli studenti, per frequentare un corso tenuto dai militari. Noi eravamo studenti, non dovevamo entrare nell’esercito. Ci dicevano che entrando per questo periodo nell’esercito avremmo avuto diverse agevolazioni, e dopo il corso avremmo potuto riprendere le lezioni. Ma non era precisato quando avremmo potuto ritornare all’Università, e non era sicuro che saremmo potuti tornare. Dopo questo episodio i militari sono tornati ancora all’Università, armati, e noi ci chiedevamo cosa stesse succedendo… Ogni giorno entravano nell’edificio, e chiudevano gli ingressi. Alla fine abbiamo capito che entrare nell’esercito non era più una proposta, ma che tutti eravamo tenuti a farlo. Senza possibilità di decidere. Ci hanno tolto le tessere universitarie, e un ufficio militare si è insediato all’interno della facoltà. L’Eritrea è governata da un regime totalitario. Il presidente è la sola persona che ha l’ultima parola su ogni decisione. Non ci sono mai state elezioni democratiche nel Paese. Quando il Presidente è salito al potere ero bambino, non mi ricordo bene… Ma ho visto quello che è successo negli anni. Cinque ministri del governo sono finiti in prigione, per opinioni politiche divergenti rispetto al Presidente. E ancora oggi sono in prigione. E 15 membri del Gabinetto, anche loro finiti in prigione. Sono stati arrestati diversi giornalisti. 8 giornali privati sono stati chiusi. Non esiste libertà di parola; non puoi parlare di tutto ciò che vuoi. Puoi parlare solo di argomenti a favore del Governo. Se parli negativamente del Governo, può essere pericoloso. I servizi segreti possono arrivare a casa tua nel cuore della notte, e prelevarti. È successo; e nessuno sa dove queste persone siano finite. Nessuno parla di loro, e osa chiedere dove sono finiti. Tutti hanno paura. C’è una fortissima attività di spionaggio. Tutti i giornali fanno solo una propaganda a favore del Governo. Il carattere autoritario dello Stato è divenuto chiaro a tutti. La libertà di parola è stata annientata. La libertà di movimento è stata a sua volta molto ristretta. Il Paese ha iniziato a essere occupato da un numero inverosimile di check points. Per andare dal mio paese al paese più vicino, che è un tragitto di 25 chilometri, trovi 3 check points. Capisci? In 25 chilometri. E controllano costantemente i documenti. Tengono sotto rigido controllo tutta la popolazione. Il regime totalitario controlla ogni movimento e ogni cosa che succede nel Paese. Sanno dove vado, cosa sto facendo… L’attività delle spie è
9
fortissima: li trovi ovunque, soprattutto tra le giovani generazioni. Non puoi fidarti di nessuno, nemmeno dei tuoi amici. Nemmeno dei tuoi fratelli. Non puoi incontrare chi vuoi… se per esempio un giorno ospiti un bianco a casa, è sicuro che il giorno dopo i servizi segreti vengono a bussarti alla porta, e a interrogarti. È successo anche a me. Avevo incontrato un vecchio amico, che veniva da Israele. E ci siamo fermati a chiacchierare, in inglese. E appena ci siamo salutati, delle persone sono venute a chiedermi spiegazioni, su chi era quel tale, e cosa ci siamo detti. Persino se ti fermi a chiacchierare in gruppi numerosi, più di 5 o 6 persone, questo può destare sospetto, che volete tramare qualcosa… Non c’è alternativa: o giuri obbedienza al regime, o devi lasciare il Paese. Ci sono stati problemi anche per i capi religiosi nel Paese. Le due religioni principali dell’Eritrea sono l’Islam e il Cristianesimo, quest’ultimo diviso tra cattolici e ortodossi. Più sette minore. In principio sono state accettate le due religioni principali, e perseguitati i membri delle sette, testimoni di Geova, avventisti… sono state dichiarate illegali 36 chiese. Ma pian piano il rafforzamento del potere del Governo ha fatto sì che si creasse una “religione di Stato”. E il regime, tu sai, è un regime socialista, che va affermando il principio che non esistono religioni, se non l’obbedienza al Governo. In Eritrea abbiamo sempre vissuto nel massimo rispetto reciproco, tra le differenti religioni, senza mai avere problemi. Per secoli, mai i cristiani hanno avuto problemi coi musulmani, o con gli ebrei. Mai avuto guerre di religione, mai guerre etniche; abbiamo sempre avuto un comune nemico, l’Etiopia, ma tra noi abbiamo sempre convissuto in pace. Ma da quando questo signore ha preso il potere, ha iniziato a creare diffidenze e divisioni tra cristiani e musulmani. Nel 2006 è stato arrestato il Patriarca della Chiesa Ortodossa. Il Vescovi della Chiesa Cattolica attraversano un momento altrettanto difficile, perché si sono opposti alla decisione del Governo di arruolare nell’esercito anche i preti e i religiosi. E anche diversi imam sono stati arrestati, tutti gli imam sono sotto il controllo del Governo. E non è consentito pregare nei luoghi pubblici. All’università gli studenti non possono dire la preghiera. Io sono musulmano, la mia fede è ciò che io sono, e perché non posso dire la preghiera? Diversi ragazzi sono stati arrestati per questo. Un imam che io conoscevo è stato prelevato nella notte dalla sua casa. Lo conoscevo bene, seguivo la preghiera con lui, e adesso nessuno sa che fine abbia fatto. Nessuno lo sa, e osa chiederlo. Alla fine, ho deciso di lasciare l’Eritrea. Era il Dicembre 2003. Quando sono successi quegli episodi all’università, l’entrata dei militari negli edifici della facoltà, e l’ordine di entrare nell’esercito per un “periodo” di corso… avevamo un mese, soltanto un mese, per tornare a casa, restare con le famiglie: a Gennaio 2003 dovevamo presentarci al comando militare. E come ti dicevo, nessuno di noi era sicuro che avremmo mai fatto ritorno all’Università. Sentivamo che saremmo stati utilizzati come soldati, al 100%. E allora ho deciso in questo mese di scappare dal Paese. Il mio piano era di raggiungere l’Etiopia. Sono partito dal mio paese per Asmara, da qui per Massawa, e da Massawa verso l’Etiopia. È stato un viaggio tremendo, a piedi, senza nulla con me. C’era con me un’altra persona. Era la prima volta che mi trovavo in questa parte dell’Eritrea; non conoscevo nemmeno la strada giusta. Ma alla fine siamo arrivati al confine. Là abbiamo incontrato un gruppo di militari etiopi, di controllo alla frontiera. Abbiamo subito raccontato loro la situazione, e loro hanno risposto che ci avrebbero accompagnato al campo dei rifugiati. Però, ci hanno detto, se volete entrare al campo, dovete pagare del denaro. E io ho detto “ok”, e ho pagato, una somma molto alta. Mi sono fidato di loro.
10
Ci hanno caricato su un camion, ed è iniziato un viaggio di tre giorni. Finalmente siamo arrivato a un villaggio, e il camion si è fermato là, e ci ha scaricato. Non c’era nessun campo in questo villaggio. Un militare ci ha detto allora di aspettare sul posto, che avrebbero fatto ritorno in breve. E sono scomparsi. Non li abbiamo più rivisti. Abbiamo chiesto, allora, dove ci trovavamo. E gli abitanti ci hanno risposto che eravamo al confine con lo Stato di Gibuti. “Cosa”?, ho risposto io. Ci eravamo fidati dei militari, non avevamo alternativa, e ci ritrovavamo in un posto sperduto al confine con Gibuti. Siamo andati all’ufficio immigrazione di questo paese. E lì ci hanno preso le carte d’identità. E ci hanno comunicato che eravamo considerati possibili spie del governo eritreo. Ci hanno arrestato, e incarcerato. Siamo rimasti in prigione più di 3 mesi, in attesa di giudizio. 3 volte siamo stati presentati alla Corte, e alla fine il caso è stato chiuso, senza condanna. Io ho chiesto che ci portassero al campo dei rifugiati, ma mi hanno risposto che il campo era chiuso, che non venivano più accettati nuovi rifugiati. Ho chiesto indietro i miei documenti, ma si sono rifiutati di renderli. Il giudice aveva intimato di restituirmi i documenti, ma la polizia li ha tenuti. Avevo con me solo il certificato scolastico del Collegio, solo questo. A questo punto, ci hanno rimesso su un camion e ci hanno trasportato fino a Gibuti. A Gibuti sono andato subito a UNHCR. Ho bussato alla porta, ma la porta era chiusa. Ero spaventato, non avevo nulla con me, nemmeno un documento. Era il maggio 2004. Ho dovuto aspettare molti mesi. Finalmente, a Settembre 2004, sono riuscito ad avere accesso agli uffici. C’era un tale di nome George, greco, a cui ho spiegato la mia storia, di eritreo richiedente asilo. E lui mi rispose che dovevo andare all’ONARS. Sono andato all’ONARS, e l’ufficio era chiuso. Avevo conosciuto allora un’amica americana, Emmanuel, che lavorava per la Chiesa Protestante di Gibuti. Grazie a lei avevo ottenuto un nuovo appuntamento all’UNHCR; era il dicembre 2004. Siamo andati insieme a UNHCR, ma ci hanno ripetuto che per avere i documenti è necessario passare per l’ONARS. Allora siamo andati all’ONARS, e qui abbiamo incontrato il signor Elmi, a cui ho spiegato la mia storia. Ho mostrato anche i documenti di ICRC. Elmi mi disse che mi avrebbe intervistato dopo 5 giorni, e che mi avrebbe fatto avere i documenti. Ero contento, stavo riacquistando fiducia. Sfortunatamente, questa amica americana doveva partire per la Francia. Ebbene, quando sono tornato per fare l’intervista, da solo, non mi hanno fatto entrare. Mi conoscevano, ero stato pochi giorni prima nei loro uffici, eppure presentandomi da solo mi hanno cacciato. Era l’inizio del 2005. Sono stato tutto il giorno davanti ai cancelli, perché dovevo entrare, avevo l’appuntamento: quello era il mio giorno, per avere i documenti. E tutto il giorno il cancello è rimasto chiuso. Alla sera ero stanco, affaticato, e così sono tornato a casa. Sono tornato a UNHCR, e qui ho incontrato un ragazzo congolese, molto disponibile, a cui ho potuto spiegare la mia storia. Ma anche lui mi ha ripetuto la stessa cosa: devi andare all’ONARS. Ho provato in tutti i modi. Ho pensato anche di cambiare il mio nome, ho telefonato e ho detto di chiamarmi George, di essere americano, per farmi fissare un appuntamento. Ma quando sono arrivato all’entrata, di nuovo non mi hanno fatto entrare. Capisci che per noi avere la carta di rifugiato è una necessità. Per trovare un lavoro, per essere sicuri… ne abbiamo bisogno! E poi ne abbiamo diritto. Abbiamo lasciato il nostro Paese a causa della dittatura, e qui non abbiamo niente. Acqua per lavarci, vestiti, lavoro, assistenza medica… siamo esseri umani, abbiamo bisogno di queste cose basilari! E possiamo sperare di avere accesso a questi beni basilari solo con l’attestato di
11
rifugiati. Se ti ammali cosa puoi fare? Capisci che con l’ambasciata eritrea non possiamo avere nessuna relazione: loro lavorano per il Governo, e noi siamo disertori, siamo ricercati in patria. Nessuno ci considera, eppure, io credo, l’ONARS dovrebbe preoccuparsi di noi. E le Nazioni Unite, perché sono lì? Non dovrebbero giusto aiutarci? Sono più di quattro anni che aspettiamo. E intanto continuiamo a essere immigrati illegali, esposti a tutti i rischi. Vedi, la differenza tra gli esseri umani e gli animali è che noi esseri umani pensiamo, e pensiamo al nostro futuro, a cosa potremo fare. E ora, come puoi pensare al futuro in questa situazione? Non abbiamo un posto dove potremo andare, non una speranza. Siamo diventati come animali. Abbiamo bisogno di qualcosa per il nostro futuro. A Gibuti non abbiamo nessuna possibilità. Non possiamo studiare, e migliorarci. Non possiamo trovare un lavoro stabile. E poi abbiamo paura, perché le spie del Governo eritreo sono anche qui. Sono ovunque, soprattutto in America, e in Italia. A Roma c’è una numerosissima comunità eritrea, e sono tutti a favore del regime, lo sostengono. E nessuno parla di quello che realmente succede nel nostro Paese. Hai mai sentito una notizia, un telegiornale, una radio, raccontare le brutalità che il Governo totalitario dell’Eritrea compie? Mai. Nessuno ne parla, nessuno conosce. E noi soffriamo, e sogniamo che nel nostro Paese la situazione cambi, che potranno esserci libere elezioni, che questo regime finisca, e gli eritrei finiscano di soffrire. Intervista n. 2. Richiedente asilo etiope, di etnia oromo, scappato dal Paese a causa
della persecuzione nei confronti di organizzazioni del suo gruppo etnico.
Sono nato nel 1976 in Etiopia, vicino al confine col Sudan. Ho completato gli studi di scuola secondaria nel 1997, e nel 1998 ho iniziato un corso per diventare insegnante. Prima di questo però in Etiopia era successo qualcosa. Nel 1991 c’era stato un colpo di stato, contro il presidente Menghistu. Si era instaurato un nuovo Governo di transizione. Io al tempo supportavol’Oromo Liberation Front, perché io sono oromo. Dopo il 1992 il nuovo Governo etiope iniziò una serie di attività contro gli oromo. Nel 1994 sono stato arrestato, e sono rimasto in prigione 3 anni, fino al 1996. Soltanto per il fatto di essere oromo, e aver sostenuto l’Oromo Liberation Front. Dopo la prigionia ho potuto finire i miei studi, e diventare insegnante. Ma dopo un anno, sono stato nuovamente arrestato, e portato nelle prigioni federali di Addis Abeba. Sempre per la medesima ragione: perché sono oromo. Solo per questo, perché non sono mai stato militare, e pur aderendo all’Oromo Liberation Front non ho mai partecipato ad atti di guerriglia. Dopo un anno di prigionia sono uscito, e sono andato agli uffici di ICRC (Croce Rossa Internazionale) per raccontare la mia storia. Sono stato registrato e mi hanno assegnato un numero identificativo. Ma restare nel Paese era diventato troppo pericoloso, e così nel 2001 sono partito per Gibuti. Dopo un anno però, nel luglio 2002, le forze di sicurezza di Gibuti mi hanno arrestato e messo in prigione, come immigrato clandestino. Dopo due mesi, a settembre, mi hanno accompagnato in Etiopia, ad Addis Abeba, e qui sono stato messo in prigione per la terza volta, fino al 2004. Mi hanno interrogato, per avere informazioni sull’ Oromo Liberation Front, ma io non sapevo nulla. Allora mi hanno messo in isolamento, sottoterra. E hanno iniziato a torturarmi.
12
Mi prendevano d’improvviso dalla cella, mi abbagliavano con luci accecanti, mi bastonavano, e con una lama mi facevano tagli sulle mani e sulle dita. Non potevo vedere nessuno… io volevo parlare con ICRC ma mi tenevano chiuso sottoterra. Per due anni… non ho potuto vedere nemmeno qualcuno della mia famiglia. Finalmente mi hanno fatto uscire di prigione, e subito sono fuggito in Somalia, ad Argheisa. Non avevo soldi per andare più lontano, in Kenia, o in Sudan; conoscevo Gibuti, e così sono andato ad Argheisa per poi fare ritorno a Gibuti, nel settembre 2004. Arrivato a Gibuti, sono andato agli uffici di UNHCR, ma mi hanno detto di recarmi all’ONARS. Allora sono andato all’ONARS, e qui mi hanno detto di andare a UNHCR… una rotazione, capisci? Non capivo cosa dovevo fare, ma ho continuato a insistere con gli uffici. Alla fine sono stato registrato all’ONARS nel 2006, dopo due anni dal mio arrivo a Gibuti. E dopo non poche sofferenze, perché andare all’ONARS non è semplice: è molto lontano dal centro, e non ci sono mezzi di trasporto, quindi bisogna andare a piedi. E lì le persone non sono molto gentili. Per i neri, come me, entrare è molto difficile. Non ti aprono la porta. Ma dopo due anni sono riuscito. Mi hanno preso la fotografia, mi hanno fatto l’intervista e mi hanno registrato, nel maggio 2006. Dopo la registrazione sono tornato a UNHCR, ma qui mi hanno detto che dovevo aspettare. Non mi hanno spiegato niente; solo questo: devi aspettare. E ho dovuto aspettare altri due anni, fino al 2008. Quattro anni… io ho scritto a UNHCR appena arrivato a Gibuti, nel 2004; ho scritto la mia storia, e ho inviato il mio numero identificativo di ICRC. E sono passati quattro anni prima di avere accesso. Ho sentito dire che per avere questi attestati devi pagare qualcosa, perché c’è molta corruzione in questi ambienti, ma io non ho soldi; e poi non voglio pagare per una cosa che è mio diritto avere! Solo nel luglio 2008 ho potuto essere intervistato presso l’ufficio delle Nazioni Unite per i rifugiati: ho potuto parlare con una signora, Katrina, che veniva da Ginevra. L’intervista è durata tre ore e mezza. E ha controllato i miei documenti, la mia fotografia, e alla fine mi ha assegnato un numero di file come rifugiato. Questo però non è un attestato ufficiale di rifugiato; è solo un numero di file. Sono riconosciuto da UNHCR come rifugiato, ma non mi hanno ancora rilasciato un documento. E io ho bisogno proprio di questo: un attestato ufficiale. Per essere protetto. Perché se torno in Etiopia, questa volta vanno ad uccidermi. E anche a Gibuti corro gravi rischi: l’intelligence etiope lavora anche a Gibuti, non dobbiamo dimenticarlo. Ho bisogno della carta di rifugiato. Per avere una garanzia di non essere arrestato dalla Polizia anzitutto. E per poter trovare un lavoro. Per adesso posso solo fare lavori saltuari, soprattutto come insegnante d’inglese. Il Vescovo di Gibuti mi ha aiutato in questo, dandomi supporto e aiuto materiale. La mia vita è tremendamente difficile. A causa della mia etnia, oromo. Gli oromo in questo momento sono dispersi in tutti i Paesi vicini all’Etiopia. A Nairobi, in Kenya, in Somalia, in Sudan, e spesso questi vengono scoperti, e deportati nelle prigioni di Addis Abeba. In Gibuti ci sono più di trentamila oromo. E in Etiopia subiamo una discriminazione da parte del regime inimmaginabile. Non solo noi oromo. Ci sono diverse etnie in Etiopia, amara, kambata, sooddo, e anche queste subiscono discriminazioni, da parte del Governo che è nella mani del TPLF (Tigrai People Liberation Front). La guerra civile continua ancora oggi. Nel mio villaggio, nella mia regione, si trovano ancora oromo che lottano contro il regime, membri dell’Oromo Liberation Front, e ogni gruppo etnico ha i suoi soldati, come gli amara, e tutti gli altri. Sono morte tante persone. Mio padre è stato ucciso dai soldati governativi. E mia mamma, e i miei
13
fratelli, io non so dove siano. Forse anche loro morti. E a volte penso che i morti sono più fortunati di noi, che restiamo in vita, e non abbiamo nulla. Non un posto dove andare, un lavoro, una speranza.
Intervista n. 3. Rifugiato somalo, proveniente da Mogadiscio
Mi chiamo Y. Vengo da Mogadiscio. Sono arrivato a Gibuti 5 mesi fa, nel Dicembre 2008, e sono andato ad Ali Addé. Sono partito a causa della guerra. È troppo pericoloso, tutti i giorni ci sono combattimenti, e uccidono le donne, e i bambini, continuamente. Non si può stare là. Troppo pericoloso. Ti uccidono in strada, ti sparano addosso. Per questo sono partito. Ho 9 bambini, e la mia famiglia è ancora a Mogadiscio. Sono venuto a Gibuti per avere l’attestato di rifugiato, e fare qualcosa per la mia famiglia. Ci sono voluti 10 giorni per arrivare qui, un viaggio difficile. Quindi sono entrato nel campo, sono andato direttamente ad Ali Addé. Là ti danno qualcosa da mangiare, poi c’è una scuola. Sto cercando il modo di far venire qui anche la mia famiglia. Anche se la vita nel campo ha molti problemi. Soprattutto perché non c’è nulla da fare. Non puoi lavorare, non puoi far niente. Ma almeno non c’è il rischio di essere ucciso in strada. Qualche volta vengo a Gibuti per cercare qualcosa, ma anche qui non c’è niente. Così dopo qualche giorno torno al campo, col bus. Qui a Gibuti vado magari alla moschea, dove mi danno qualche offerta. Ma non so come far arrivare la mia famiglia. Vorrei avere una vita migliore. Ma a Mogadiscio va sempre peggio. La Somalia è un Paese meraviglioso, ma la situazione politica è ingestibile. Ognuno vuole il comando, il potere; ogni gruppo vuole la presidenza per comandare il Paese, e questo genera la guerra. I miei bambini non possono più andare a scuola, anche uscire in strada è molto pericoloso. Al campo di Ali Addé ci sono molto persone etiopi, eritree e somale. E tutte hanno bisogno di aiuto. Tutte aspettano che le Nazioni Unite trovino per loro una soluzione; tutte vogliono uscire dal campo. E aspettano un programma di resettlement. Ogni sera vai a dormire e speri che il giorno dopo sia quello buono. Ma non cambia niente, nessuno parte. Speri di partire per l’America, ma sai che è un sogno, che non succederà. Come puoi partire? Ogni giorno la vita è sempre uguale. Al mattino mi sveglio, mangio un po’ di pane, per colazione. E poi… niente. Torno un po’ a dormire, sto seduto dalla tenda, parlo un po’ con gli altri. Il pomeriggio è uguale. Dormo un po’, parlo con gli altri. Poi alla sera vado a dormire. Per far passare il tempo mastichiamo kat. Se ne trova molto al campo, tutti lo prendono. Ti aiuta un po’ a non pensare.
La realtà dei richiedenti asilo costituisce uno degli aspetti più drammatici della
questione migratoria nel Corno d’Africa. Esseri umani scappati per necessità, che la
Repubblica Democratica di Gibuti si è impegnata a difendere, sottoscrivendo le
Convenzioni internazionali sui rifugiati, e che si ritrovano soli, senza nessun appoggio.
14
Leggere i documenti di legge appare beffardo, se si rivolge lo sguardo alla condizione
reale di questi uomini. La divergenza abissale tra quanto la norma stabilisce e quanto
concretamente accade, tra la procedura che gli uffici dovrebbero seguire ed il
comportamento che gli impiegati ministeriali effettivamente tengono, suscita sgomento.
Vedere queste persone derise dall’autorità, e i loro diritti sbriciolati, insieme alle loro
speranze, ferisce la coscienza. Si prova un sentimento di disapprovazione morale
talmente forte che diventa doloroso fisicamente, quando si guarda negli occhi questi
ragazzi. Chi siete? «Rifiuti umani», come vi definisce Zygmunt Bauman: ecco cosa
siete. «Senza nessuna funzione utile da svolgere nella terra del loro arrivo e soggiorno
temporaneo e nessuna intenzione o prospettiva realistica di assimilazione e inserimento
nel nuovo corpo sociale»5.
Uomini e donne che hanno perduto tutto, «i mezzi su cui poggia l’esistenza
sociale, vale a dire un insieme di cose e persone comuni dotate di senso – la terra, la
casa, il villaggio, la città, i genitori, i beni, i posti di lavoro e altre pietre miliari della
vita quotidiana. Queste creature alla deriva e in attesa non hanno altro che la loro «nuda
vita», la cui continuazione dipende dagli aiuti umanitari»6.
5 Z. Bauman, Vite di scarto, Laterza, Roma-Bari, 2007. 6 M. Agier, Aux bord du monde, les réfugés, Flammarion, Paris, 2002.
15
3. Proposte d’intervento e ruolo della Chiesa cattolica
La preoccupante situazione in cui versano i migranti del Corno d’Africa ci
spinge a superare la mera analisi critica del fenomeno, ed a sollevare qualche proposta
concreta per affrontare il problema. A tal proposito si possono individuare due possibili
strategie, “a lungo termine” e “a breve termine”.
«La principale soluzione di lungo termine a questo crescente movimento di
persone è certamente il miglioramento delle condizioni di vita nei Paesi di origine. Per
raggiungere questo obiettivo appare di assoluta necessità un impegno internazionale. In
particolare dev’essere rafforzata una strategia che indirizzi gli aiuti umanitari nei
confronti dei più vulnerabili. Non possiamo pensare di ottenere risultati semplicemente
difendendo le frontiere nei nostri Stati»7. Accanto a questo impegno per una maggiore
responsabilità internazionale, sul piano della distribuzione delle risorse e dell’attenzione
alle aree più svantaggiate del pianeta, si deve compiere ogni sforzo perché gli uffici
competenti alle questioni dei rifugiati e dei richiedenti asilo agiscano nel rispetto della
legalità. Non possiamo accettare che impiegati ministeriali, o delle agenzie delle
Nazioni Unite, trattino le persone migranti senza rispetto delle regole, e della dignità
della persona umana. Dobbiamo denunciare queste derive “disumanizzanti”, e fare il
possibile per cambiare una situazione intollerabile. A questo proposito appare opportuna
una campagna d’informazione sui diritti che spettano per legge a tutti i migranti, a
prescindere dallo status giuridico, da diffondersi presso gli uffici competenti e le
associazioni che in qualche misura hanno a che fare con queste persone.
Tenendo a mente e lavorando concretamente per la soluzione di lungo termine,
tuttavia, dobbiamo pensare anche alla realtà presente. «Considerato che questo
movimento di persone è “misto”, dobbiamo offrire protezione ai rifugiati e richiedenti
asilo senza però dimenticare che tutti i migranti, a prescindere dalla loro razza, fede,
genere o status, meritano attenzione e protezione. Se i rischi, le violenze, i traffici di
esseri umani, il contrabbando, non fanno distinzione tra rifugiati e altri migranti, come
possiamo noi distinguere le vittime di questa migrazione riservando i nostri aiuti
soltanto ad alcuni di questi? Dobbiamo migliorare gli standard internazionali di
7 Msgr. G. Bertin, Protection and care for all, cit., Sanaa, 20.5.2008.
16
accoglienza e cura dei migranti vulnerabili e le norme di protezione e i servizi umanitari
per aiutare tutti i migranti che sono vittime di povertà, violenze e traumi, dopo viaggi
molto pericolosi sulla strada e attraverso il mare. Dopo il loro arrivo questi “migranti
misti” hanno bisogno in primo luogo di un immediato servizio di accoglienza, in
secondo luogo di una visita psico-sociale e di un ricovero iniziale, in terzo luogo di un
rinvio a istituzioni specializzate per offrire supporto e un ricovero ulteriore. Tutto
questo include assistenza dopo l’arrivo, cibo, adeguate attenzioni mediche, cure psico-
sociali, opportunità di regolarizzazione attraverso i canali legali di migrazione, etc.»8.
La Chiesa Cattolica di Gibuti, che è una realtà estremamente fragile e
minoritaria in un Paese musulmano, si è impegnata in prima persona per la tutela dei più
vulnerabili tra i migranti: i bambini e i malati. Grazie al centro Caritas trovano ristoro e
protezione un centinaio circa di giovanissimi, provenienti dall’Etiopia, dalla Somalia, o
figli di immigrati, e numerosi adulti con problemi di salute. Costoro sono senza
documenti e senza prospettive. La Chiesa offre loro la possibilità di studiare, e dona
aiuti alimentari e servizi igienici. In una realtà drammatica quale è la vita dei migranti,
maltrattati e respinti, questo segno di solidarietà e fraternità appare un aiuto quanto mai
necessario.
8 Ibidem
17
CAPITOLO II
Campo profughi di Ali Addé
1. L’organizzazione del campo profughi
Il campo profughi di Ali Addé, situato ad una ventina di chilometri da Ali
Sabieh, costituisce il principale centro per rifugiati della Repubblica di Gibuti. Le stime
ufficiali rivelano la presenza di circa 9.100 rifugiati, provenienti dalla Somalia centrale
e meridionale, dall’Etiopia e dall’Eritrea (quest’ultima comunità è attualmente
rappresentata da un numero esiguo di rifugiati: una dozzina appena).
Il campo è gestito congiuntamente dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR) e dall’ufficio governativo legato al Ministero dell’Interno
(ONARS). A queste due principali istituzioni si aggiungono associazioni “partners”,
che svolgono servizi differenziati: AMDA, organizzazione non governativa giapponese
di assistenza sanitaria, APEF, associazione gibutina che si occupa dei servizi sociali
18
all’interno del campo, Life International, a sua volte legata ai servizi sociali. Si attende
inoltre l’arrivo di una nuova associazione, LWF, che coprirà i servizi legati
all’educazione, assumendo la gestione della scuola per rifugiati all’interno del campo 9.
La procedura amministrativa di registrazione e inserimento all’interno del campo
è la seguente. Attraversata la frontiera, i migranti devono recarsi nella città di Gibuti, e
presentarsi all’ufficio dell’ONARS per effettuare una prima intervista. Se provengono
da Paesi o zone in guerra, o in situazioni di emergenza umanitaria, la procedura è
semplificata. Viene effettuata in questi casi un’intervista di gruppo, per accertare se
effettivamente costoro provengono da una zona segnata da emergenza umanitaria.
Costoro sono considerati “prima facie” come rifugiati. Una volta che l’ONARS ha
accertato la veridicità della loro storia, possono recarsi all’ufficio di UNHCR, dove
ricevono l’attestato ufficiale di rifugiati grazie al quale possono accedere al campo
profughi.
Il regolare ingresso nel campo di Ali Addé conferisce ai rifugiati il diritto a
ricevere alcuni servizi. In primo luogo costoro ricevono una tenda dove abitare, le cui
dimensioni variano a seconda del numero dei familiari. I profughi singoli, in alcuni casi,
devono dividere la tenda con altri rifugiati. Per quanto riguarda le soluzioni abitative il
campo è strutturato in diverse sezioni, ciascuna delle quali raggruppa i rifugiati
provenienti dalla medesima zona. Si ha così la sezione etiope, la sezione del Sud-
Somalia, la sezione degli eritrei, etc. I profughi hanno altresì il diritto a ricevere razioni
alimentari, la cui quantità varia ancora secondo le dimensioni del nucleo familiare. 9 Le informazioni sui dati numerici e sull’organizzazione del campo profughi sono state assunte in seguito a intervista con i responsabili del campo di UNHCR. Si riportano di seguito le domande proposte a costoro. 1. Organisation of the Ali Addeh Refugee Camp
- Statistics of the refugees in the camp in the last 5 years - Nationality, age and sex of refugees - Direction of the camp (UNHCR – ONARS) - Activities organised for the refugees in the camp (school, food forniture, etc.)
2. Procedure of enregistrement for the refugees - When they arrive at the camp, what do they have to do? - Who can be accepted in the camp? - What about the asilum seekers that can not be accepted?
3. Daily life of the refugees in the camp (possibly, doing interviews with some of them). - How is your tipical day in the camp? - Which activities do you get? - What are the main problems? - What are your hopes for the future?
19
Per regolamentare la distribuzione dei viveri e l’assegnazione delle tende
ciascun rifugiato riceve un foglio di riconoscimento, assegnato da UNHCR, dove sono
segnati l’identità del titolare, i componenti del nucleo familiare, e le fotografie di
ciascuno. Per i problemi di salute i rifugiati possono rivolgersi al dispensario sanitario
di AMDA, dove ricevono visite mediche e medicinali.
Per i bambini ed i giovani esiste la possibilità di frequentare la scuola. In passato
l’educazione dei rifugiati era affidata all’UNESCO; attualmente la scuola viene gestita
direttamente da UNHCR, in attesa, come si diceva, dell’arrivo di una nuova
associazione non governativa (LWF) che assumerà tale incarico. Frequentano la scuola
circa 1.400 allievi, di età compresa tra i 6 ed i 19 anni, e 19 insegnanti, alcuni salariati
da UNHCR, altri volontari. Il sistema scolastico è strutturato in 7 classi, che
corrispondono rispettivamente al “livello” di preparazione. Un bambino inizia
normalmente la scuola dalla prima classe, ma è possibile che un nuovo rifugiato, appena
arrivato al campo, abbia accesso direttamente ad un livello più alto di scolarità.
Attualmente la classe settima costituisce il punto di arrivo dell’educazione dei
rifugiati, ma il direttore della scuola si sta impegnando per fare in modo che i ragazzi
possano proseguire i loro studi. Il primo obiettivo concerne l’istituzione di una classe
ulteriore (classe ottava), per consentire almeno un anno aggiuntivo di scolarità. Il
20
desiderio maggiore del direttore, tuttavia, riguarda la possibilità di inserimento
scolastico, per i più meritevoli, nelle Università pubbliche.
21
2. I problemi principali dei rifugiati
I rifugiati registrati presso Ali Addé hanno “formalmente” l’obbligo di restare
all’interno del campo. Tuttavia l’entrata non è rigidamente sorvegliata, tanto che la
maggioranza dei rifugiati entra ed esce senza troppi problemi. Del resto all’interno del
campo costoro ricevono una tenda per dormire e una razione alimentare per mangiare;
per tutte le altre necessità (vestiti, utensili per cucinare, etc.) devono in qualche maniera
organizzarsi. Così ogni giorno centinaia di persone escono dal campo per dirigersi verso
Ali Sabieh e verso la città di Gibuti, dove risiedono per periodi più o meno prolungati,
per trovare qualche lavoro occasionale e comprare qualcosa.
Questo fatto costituisce il singolare fenomeno dei c.d. urban refugees (rifugiati
urbani): persone registrate come rifugiati presso il campo profughi, ma che si trovano in
città. Fenomeno che genera, peraltro, alcuni problemi rilevanti. Spiega Satoro,
responsabile dell’associazione AMDA: «noi abbiamo la responsabilità dell’assistenza
medica per i rifugiati del campo di Ali Addé. Il problema è che qualche volta i rifugiati
si presentano, per avere aiuto, presso il nostro ufficio di Gibuti! E noi non sappiamo
come comportarci… non dovrebbero essere lì, eppure sono rifugiati, e chiedono
assistenza medica, che è fondamentalmente il nostro compito. Non è facile…».
Un altro problema si pone in caso di fermo da parte della Polizia. In questa
circostanza infatti i rifugiati presentano il documento di riconoscimento delle Nazioni
Unite, che in principio dovrebbe garantire loro protezione e tutela, ma all’interno del
campo profughi. Al di fuori, costoro non potrebbero stare. Si creano pertanto situazioni
difficilmente definibili dal punto di vista giuridico, e difficilmente gestibili dal punto di
vista amministrativo.
Si deve considerare al contempo che la possibilità per i rifugiati, tacitamente
concessa, di uscire dal campo, costituisce una valvola di sfogo necessaria. La vita nel
campo profughi, in effetti, non è semplice. Lo si capisce arrivando in macchina, dal
villaggio di Ali Sabieh: dopo aver percorso chilometri e chilometri di deserto roccioso e
di montagne, in un territorio sperduto, lo sguardo incontra all’improvviso, dietro una
collina, una distesa di tende e capanne inimmaginabile.
Campo profughi di Ali Addé: un ammasso di oltre novemila esseri umani nel
cuore del nulla. Senza elettricità e senza acqua corrente nelle case (termine peraltro
22
inappropriato, trattandosi per lo più di tende bianche col simbolo blu di UNHCR, o
capanne di legno), e senza nulla da fare.
Procedendo in macchina verso la zona degli uffici s’incontrano le persone,
intente alle loro faccende quotidiane. Bambine dai vestiti colorati che vanno al pozzo a
riempire d’acqua le loro taniche gialle, donne che sistemano e puliscono le loro
malferme capanne, uomini seduti che masticano kat. S’incontrano talvolta i loro sguardi
imploranti. Ed è doloroso pensare a tutto ciò che questi sguardi hanno visto: i massacri
di Mogadiscio, la povertà mortale delle campagne etiopi, l’irruzione dell’esercito, per
l’arruolamento forzato, nelle università eritree... Colpevoli soltanto di essere nati in un
luogo sbagliato del pianeta, scappati per disperazione, costoro si ritrovano a vivere in un
campo lontano da tutto, ricevendo qualcosa da mangiare, in attesa che qualcuno trovi
per loro una soluzione.
23
«We need a life» mi dice Abdurrashim, distinto signore somalo scappato da
Mogadiscio nel 1999. «Qui non abbiamo niente, nemmeno un albero per rinfrescarci,
solo deserto e montagne… Trascorri qui 10 anni della tua vita, e ti senti vecchio; ti senti
prigioniero. Ci danno qualcosa da mangiare, ma non abbastanza per calmare la fame.
Tutti noi aspettiamo una possibilità di Resettlement».
I Resettlement Programs costituiscono l’unica speranza per i rifugiati internati
nel campo. Si tratta dei progetti di reinserimento che UNHCR organizza e gestisce di
raccordo con i Governi dei Paesi “richiedenti”. La procedura si svolge nel modo
seguente. Uno Stato che si trova ad aver bisogno di un ingresso regolarizzato di un certo
numero di persone, per esempio per esigenze lavorative, rivolge la propria richiesta
all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. In questa circostanza
l’UNHCR organizza all’uopo un programma di Resettlement, per trasferire il numero
richiesto di rifugiati verso lo Stato che ne ha fatto domanda. Esistono progetti di
Resettlement anche in ambito universitario, per giovani rifugiati che abbiano
l’intenzione, e le capacità, per proseguire in un nuovo Paese i loro studi.
La speranza di poter partire, un giorno, per l’Australia, gli Stati Uniti, l’Europa,
è il sogno che tiene vive queste persone. Sogno che potrà realizzarsi solo per un numero
esiguo di costoro. E nel frattempo, nell’attesa di una partenza che forse non arriverà
mai, queste migliaia di uomini e donne consumano i loro giorni senza far nulla,
aspettando: aspettando la loro razione quotidiana di cibo, aspettando un rappresentante
dell’Onu che li riceva, aspettando che il calar della sera rinfreschi il calore del deserto,
portandosi via un altro giorno di vita speso ad aspettare.
24
Abdillahi, giovane somalo, aspetta da anni che arrivi anche per lui una
soluzione. Con un inglese parlato alla perfezione mi racconta: «non mi ricordo da quanti
anni sono qui. Nel frattempo mi sono sposato, e ho avuto tre bambini. Lavoro come
insegnante d’inglese. Quando mi capita di incontrare qualche funzionario delle Nazioni
Unite rivolgo sempre la mia richiesta: quando potrò partire con la mia famiglia? Sai
cosa mi rispondono? Non sei mica l’unico rifugiato! Guardati intorno, tutti vogliono
partire; tu hai anche un lavoro, di cosa ti lamenti?».
La vita si trascina stancamente, in questo campo profughi rinchiuso tra le
montagne del deserto gibutino. Montagne aspre, che sembrano volerlo nascondere agli
occhi degli uomini, per non far sapere cosa succede laggiù. Tornano alla mente allora le
parole feroci di Zigmunt Bauman, a proposito della condizione dei rifugiati.
I rifugiati sono rifiuti umani. Senza nessuna funzione utile da svolgere nella terra del loro arrivo e soggiorno temporaneo e nessuna intenzione o prospettiva realistica di assimilazione e inserimento nel nuovo corpo sociale. Dal loro attuale luogo di soggiorno, la discarica, non c’è ritorno e non c’è via d’uscita. Una distanza abbastanza grande da impedire che i miasmi velenosi della decomposizione sociale raggiungano luoghi abitati dai loro abitanti autoctoni è il principale criterio di scelta dell’ubicazione dei campi permanentemente temporanei. Fuori dai quei luoghi, i rifugiati sono un ostacolo e un fastidio; dentro, sono dimenticati. Tutti i rifiuti, compresi i rifiuti umani, tendono a essere accumulati indiscriminatamente nella stessa discarica. L’atto di destinare ai rifiuti pone fine a differenze, individualità,
25
idiosincrasie. I rifiuti non hanno bisogno di distinzioni impalpabili e sottili sfumature, a meno che non siano destinati al riciclaggio: ma le probabilità dei rifugiati di essere riciclati in membri legittimi e riconosciuti della società umana sono a dir poco vaghe e infinitamente remote. Sono state prese tutte le misure per garantire la permanenza della loro esclusione. Persone senza qualità sono state depositate in un territorio senza denominazione. I rifugiati, i rifiuti umani della terra di frontiera globale, sono «gli esclusi in carne ed ossa», gli outsiders assoluti, outsiders ovunque e fuoriposto ovunque tranne che in posti che sono essi stessi fuori posto: i «non luoghi» che non appaiono su nessuna carta geografica utilizzata da normali esseri umani nei loro viaggi. Una volta fuori, fuori a tempo indeterminato, il recinto del campo è l’unico dispositivo necessario per far durare per sempre l’«indeterminatezza» dei fuori posto 10.
10 Z. Bauman, Vite di scarto, cit.
26
3. La minoranza cristiana nel campo profughi
La dimensione religiosa costituisce un aspetto di fondamentale importanza per i
rifugiati. In una realtà contrassegnata, come si è visto, da difficoltà, sofferenze,
ingiustizie e poche speranze sulla vita futura, la fede rappresenta infatti un supporto
insostituibile, un aiuto incommensurabile per dare un senso alla propria esistenza.
Al campo profughi di Ali Addé la grande maggioranza dei rifugiati sono di
religione musulmana. Tuttavia esiste una minoranza di rifugiati etiopi di religione
cristiano-ortodossa, una minoranza nascosta e poco considerata, per non dire
discriminata, che merita invece di essere ascoltata e valorizzata.
I profughi cristiani hanno cercato nel tempo di organizzarsi all’interno del
campo. Hanno installato, nella sezione etiope, una tenda adibita a luogo di preghiera.
Non si tratta di una vera e propria chiesa, non rispettando i canoni ortodossi in materia
di luogo di culto, e dunque non vi può essere celebrata la messa; tuttavia un gran
numero di rifugiati si riunisce quotidianamente in questo spazio, per pregare. In alcune
occasioni anche il prete ortodosso di Gibuti sale al campo profughi, per offrire
assistenza spirituale ai fedeli. Nelle festività più importanti sono invece i rifugiati a
recarsi nella capitale, per assistere alla messa officiata nella chiesa ortodossa della città.
Si deve sottolineare, tuttavia, che la minoranza di rifugiati cristiani non gode di
vita facile all’interno del campo. Un momento particolarmente drammatico, in
particolare, si è avuto in seguito alla pubblicazione, nel settembre 2005, delle vignette
umoristiche sul Profeta Maometto sul quotidiano danese Jyllands-Posten. L’episodio in
questione, com’è noto, ha avuto ripercussioni terribili in tutto il mondo musulmano, ed
anche nello sperduto campo profughi di Ali Addé la reazione non si è fatta attendere 11.
L’obiettivo scelto, in questo caso, è stato la piccola sala di preghiera dei rifugiati
cristiani.
Alcuni profughi etiopi intervistasti raccontano con paura il ricordo di queste
vicende. «Era buio, e abbiamo iniziato a sentire un clamore che si avvicinava. Eravamo
nella nostra tenda, per pregare, e sentivamo questo rumore che cresceva, e grida, sempre
11 In seguito alla pubblicazione, sul quotidiano danese, delle vignette umoristiche sul tema del Profeta Maometto, le proteste prendono una piega terribile in tutto il mondo musulmano. A fine gennaio 2006 le manifestazioni antidanesi si moltiplicano. Vengono uccise diverse persone, in Afghanistan, in Libia, in Nigeria e altrove: secondo un conteggio, i morti sono stati 139.
27
più forti. Siamo usciti, e abbiamo visto una folla venire contro di noi, con torce accese.
Gridavano, insultavano, e hanno iniziato a lanciare sassi. Siamo usciti di corsa, scappati
via. E loro hanno distrutto la nostra chiesa, completamente. Una paura terribile,
temevamo di essere uccisi».
In seguito a questo episodio una delegazione di UNHCR si è recata
immediatamente a incontrare la comunità etiope, per presentare le proprie scuse,
promettendo che in futuro avrebbero garantito sicurezza e incolumità alla minoranza
cristiana. Tuttavia rimane da capire come mai, in quest’occasione, il servizio di
sicurezza del campo profughi non è intervenuto, lasciando che si compisse la
distruzione del luogo di preghiera.
Si deve sottolineare altresì che, nonostante le promesse dei rappresentanti delle
Nazioni Unite, la vita religiosa per i rifugiati cristiani non è divenuta più semplice.
Racconta ancora M., profugo etiope di etnia oromo, arrivato a Gibuti nel 1991: «quando
passiamo davanti alla nostra chiesetta dobbiamo fare molta attenzione a fare il segno
della croce. Perché se ti vede qualche musulmano potrebbe tirarti un sasso. Così quando
andiamo a pregare, uscendo dalla tenda, dobbiamo sempre stare attenti. Riceviamo
spesso delle minacce, e non ci sentiamo protetti. E poi gli insulti, costantemente, di
“infedeli”, e altro… è pesante, perché sappiamo di non poter reagire. Perché siamo
pochi, una minoranza, e non siamo minimamente considerati».
Un esempio manifesto di discriminazione, del resto, si è avuto in occasione della
giornata mondiale del rifugiato, festeggiata ad Ali Addé giovedì 18 luglio 2009. In
apertura della cerimonia un capo religioso musulmano ha recitato i versetti del corano,
come preghiera islamica. Lasciando senz’altro la priorità alla preghiera musulmana, che
riguarda la maggioranza dei rifugiati, sarebbe stato opportuno concedere un piccolo
spazio, in seconda istanza, per una breve preghiera cristiana. Per la lettura di un passo
del Vangelo, ad esempio. Ma questa possibilità non è stata neppure presa in
considerazione. Perdendo così un’altra occasione per far sentire la minoranza cristiana
meno isolata, inascoltata, discriminata.
A fronte di questi episodi descritti, sorge spontanea una domanda. Quale
importanza viene attribuita, dalle autorità competenti, al diritto di libertà religiosa?
Diritto fondamentale della persona umana, difeso dall’art. 18 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo dell'Onu (1948), che ne offre altresì una definizione
28
compiuta: «La libertà religiosa è libertà di culto, libertà di aderire ad una religione e di
non professarne alcuna, libertà di celebrare i riti della propria religione privatamente e
pubblicamente, libertà di cambiare religione».
Quale importanza riveste dunque questo diritto fondamentale, se si permette che
una minoranza religiosa venga quotidianamente insultata, minacciata e maltrattata,
senza ricevere un minimo di considerazione?
29
4. La vendita dei “Resettlement Programs”
La Repubblica di Gibuti è stata il teatro, qualche anno addietro, di un grave
scandalo che ha coinvolto l’ufficio ministeriale dell’Onars e alcuni funzionari di
UNHCR. Racconta Ann Encontre, attuale Representative dell’Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i Rifugiati presso Gibuti: «la gestione dei “Resettlement Programs” è
questione estremamente delicata, da quando si è scoperto il giro di corruzione che si
celava dietro la gestione di questi progetti, qualche anno fa».
La storia in questione si svolge, prevalentemente, nelle sale degli uffici
ministeriali. A quanto pare, in queste eleganti stanze di potere, si sono consumate
attività criminali degne di un emozionante film thriller… Ma procediamo con ordine,
lasciando da parte le metafore cinematografiche, poiché ciò che si è avuto a Gibuti non
è stato un film, ma una vicenda tremendamente reale.
Esistono tre possibili soluzioni per i rifugiati riconosciuti dalle Nazioni Unite. La
prima soluzione (reimpatriation) consiste nel rimpatrio, laddove le condizioni che nel
Paese di origine avevano indotto la migrazione (guerra, emergenza umanitaria,
discriminazione etnica o religiosa, etc.) siano venute meno. La seconda soluzione (local
integration) riguarda l’inserimento sociale nel Paese di asilo, qualora il rifugiato,
considerate le sue caratteristiche culturali, linguistiche, religiose, si ritiene possa
favorevolmente inserirsi in questa società. L’ultima soluzione (Resettlement) prevede
infine la possibilità di un inserimento sociale in un Paese terzo.
La terza soluzione rappresenta, come facilmente si può intuire, la prospettiva più
desiderabile per i rifugiati. Resettlement Program significa infatti partire per un Paese
ricco, avendo a disposizione il biglietto aereo, una sistemazione abitativa nel luogo di
arrivo, un lavoro o un’iscrizione pagata per l’Università. In altre parole, per persone che
provengono da Paesi in guerra, da situazioni di povertà estrema, da condizioni di vita
inumane, un viaggio verso il paradiso. Un’occasione concreta di costruirsi un futuro; di
ricominciare a vivere.
Dov’è dunque il problema? A pensarci bene, non è così difficile da indovinare.
Un biglietto aereo pagato per gli Stati Uniti o il Canada, un lavoro sicuro, con tutte le
tutele e garanzie, e una casa… si tratta di una prospettiva di vita che, evidentemente, fa
gola a tutti. Non solo a coloro che, in quanto rifugiati riconosciuti dalle Nazioni Unite,
30
ne hanno effettivamente diritto. Di qui la forte tentazione di fare dei Resettlement
Programs un traffico illegale, e molto fruttuoso.
Gibuti, come già si è sottolineato, rappresenta un luogo di migrazione per
migliaia di individui provenienti dalla Somalia, dall’Etiopia e dall’Eritrea. Una volta
arrivati costoro iniziano le pratiche burocratiche per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Si recano in primo luogo all’ufficio dell’ONARS, dipartimento del Ministero
dell’Interno responsabile per i rifugiati ed i richiedenti asilo, dove svolgono una prima
intervista. Viene qui allestito, per ciascuno di costoro, un dossier. Dopo aver svolto
l’intervista viene loro presa una fotografia. Se sussistono i presupposti per il
riconoscimento, vengono inviati all’ufficio di UNHCR, dove ricevono l’attestato
ufficiale di rifugiati. Il dossier a questo punto è completo; si tratta soltanto di attendere
che, prima o poi, arrivi per loro una soluzione di reinserimento sociale.
Qualche anno fa giunse a Gibuti, all’ufficio delle Nazioni Unite per i Rifugiati,
un certo numero di programmi di Resettlement, indirizzati principalmente verso il
Canada. Ebbene, i funzionari competenti non resistettero alla tentazione. Presi in mano i
progetti di Resettlement, compresero che questi potevano fruttare un’enormità di denaro.
Quanti gibutini avrebbero pagato cifre esorbitanti per partire per il Canada, e trovare là
casa, lavoro… Si trattava semplicemente di manomettere i documenti in questione, e i
dollari sarebbero piovuti dal cielo. Così, diedero avvio ad una serie di pratiche
sconcertanti.
In primo luogo scelsero i rifugiati a cui assegnare i programmi. I dossier erano
tutti in regola, con i dati anagrafici dell’interessato, il Paese di provenienza, i motivi
della migrazione, etc. E la fotografia. A questo punto avrebbero dovuto contattare i
titolari dei dossier, i rifugiati selezionati, stringer loro la mano e consegnare il biglietto
aereo, per la partenza verso una nuova vita. Sognata e meritata, dopo anni di sofferenze
e privazioni. Ma così non fecero. Al loro posto, affidarono i programmi di Resettlement
a cittadini di Gibuti, in cambio di forti somme di denaro, sostituendo l’identità dei
rifugiati con quella dei gibutini.
E i rifugiati che avevano diritto al Resettlement? Questa è la parte più
angosciante della storia. Perché attraverso questa operazione, i rifugiati selezionati per il
progetto di reinserimento venivano defraudati della loro identità. Senza poter fare nulla
per impedirlo.
31
Quando lo scandalo della vendita dei programmi di reinserimento venne
scoperto, i Governi di molti Paesi interruppero immediatamente le proposte di
Resettlement indirizzate alla Repubblica di Gibuti. Oggi, al maggio del 2009, sembrano
prossime ad arrivare le prime nuove proposte, dopo un lungo periodo di pausa. Sarà di
fondamentale importanza tenere il massimo livello di vigilanza, per evitare che nuovo
traffici illeciti pregiudichino ancora il diritto per i rifugiati di ricostruirsi una vita,
affossando definitivamente la credibilità del Governo gibutino.
32
CAPITOLO III
Migrazioni verso i Paesi arabi
Le informazioni sulle migrazioni verso lo Yemen ed i Paesi Arabi sono state
raccolte nel corso di un soggiorno a Obock, paese a nord della Repubblica di Gibuti
dove salpano le barche cariche di clandestini. Sono stati intervistati il prefetto aggiunto
Amin, il capitano della Polizia di Obock Omar, diversi abitanti del paese che hanno
raccontato la loro testimonianza. Sono stati incontrati anche alcuni clandestini, ma
l’intervista con loro si è resa impossibile per un problema di lingua e per una loro
reticenza a raccontare la propria storia.
I dati e le informazioni sul movimento dei clandestini attraverso Gibuti e verso i
Paesi Arabi sono inevitabilmente solo indicativi, dal momento che non esistono stime
ufficiali sul numero degli stranieri irregolari migranti. Costoro peraltro evitano per
ovvie ragioni di passare per le frontiere, e cercano di tenersi nascosti allo sguardo della
Polizia. Avere dati precisi sul fenomeno non è pertanto possibile, eppure si tratta di un
movimento migratorio di tale portata che merita senz’altro di essere indagato.
Ogni giorno attraversano il Paese centinaia e centinaia di persone, provenienti
dall’Etiopia e dalla Somalia, in una lunga marcia sotto il sole, verso le spiagge di
Obock. Tra costoro si trovano molte donne, e bambini. I rischi che accompagnano
questo viaggio di speranza e disperazione sono molteplici: un gran numero di migranti
non arriverà mai alla fine del viaggio. I corpi di costoro giacciono tra le pietre nere del
deserto gibutino, o sul fondale silenzioso del Golfo di Aden; nessuno conosce la loro
storia.
Di fronte alla gravità della situazione sembra opportuno compiere ogni sforzo
per conoscere il fenomeno e le sue cause, e pensare a possibili rimedi, che potrebbero
salvare vite umane.
33
1. Il viaggio dei migranti
Se in passato i migranti partivano “allo sbaraglio”, prendendo con sé tutti i soldi
che potevano recuperare e mettendosi in marcia con la speranza di raggiungere, in
qualche modo, la penisola arabica, oggi il viaggio dei clandestini è decisamente più
organizzato. Costoro partono dall’Etiopia e dalla Somalia seguendo un percorso
prestabilito. Si muovono con poche monete al seguito, conoscendo il rischio di essere
spogliati durante il viaggio dei loro averi, e arrivati a un certo punto del tragitto si fanno
inviare da casa nuovo denaro. Attraversano i confini con Gibuti tenendosi a distanza dai
luoghi di frontiera controllata, e si mettono sulla strada per Obock, ultima fermata prima
di prendere la via del mare.
Una volta raggiunta Obock i migranti si dirigono il prima possibile verso le
spiagge, per salpare. Fermarsi in città costituisce infatti un inutile perdita di tempo e di
denaro, senza contare il rischio quotidiano di essere fermati dalla Polizia ed essere
deportati al confine, dovendo così ricominciare da capo il viaggio. I clandestini che si
vedono muoversi nel paese, dunque, sono coloro arrivati a Obock senza i soldi per
pagarsi la traversata. Costoro sono costretti a fermarsi e a cercare con l’elemosina, e
qualche lavoro occasionale, di mettere da parte la somma necessaria per partire.
Chi ha con sé i soldi sufficienti, come si diceva, si dirige immediatamente verso
le spiaggie. A una trentina di chilometri circa a nord di Obock, infatti, si stende una
costa sabbiosa molto lunga, che va da Raz Bir fino alla spiaggia di Godoria, dove ogni
notte partono piccole imbarcazioni yemenite per l’altra sponda dello stretto. Per arrivare
a queste spiagge i migranti si fanno accompagnare da guide locali. Dietro pagamento,
moltissimi giovani di Obock conducono nottetempo i clandestini attraverso le piste del
deserto, fino ai luoghi di partenza delle barche. Diversi ragazzi intervistati raccontano di
svolgere abitualmente questo lavoro, e affermano di considerare il viaggio dei migranti
una risorsa per il loro paese.
Le barche che partono verso lo Yemen sono riempite all’inverosimile prima di
salpare. Una piccola imbarcazione di pescatori, che normalmente può contenere dieci,
quindici persone, viene caricata di quaranta e più individui, ammassati l’uno sull’altro.
Le barche sono dotate inoltre di motori molto potenti, che permettono di raggiungere la
costa dello Yemen in poco più di tre ore. Tuttavia a causa del carico spropositato, e
34
della velocità sostenuta, di gran lunga superiori alle capacità della barca, non sempre i
migranti arrivano a raggiungere l’altra sponda.
La tragedia degli affondamenti e dei morti in mare costituisce uno degli aspetti
più drammatici del fenomeno migratorio nel Corno d’Africa. Negli ultimi tempi molti
migranti etiopi, che non hanno mai visto il mare, si danno da fare sulle spiagge di
Obock per imparare a nuotare, prima d’imbarcarsi. Conoscono i rischi che li aspettano,
e si preparano al peggio.
Le spiagge fuori Obock, dove s’imbarcano i clandestini
Quando le imbarcazioni riescono a raggiungere la costa yemenita, i migranti
trovano pronte ad attenderli delle vetture. Lo Yemen rappresenta infatti solamente un
punto di passaggio; appena sbarcati i clandestini montano a bordo delle macchine e
partono immediatamente verso la frontiera dell’Arabia Saudita. Qui, si dice, i controlli
non sono particolarmente severi. I migranti vengono scaricati a qualche centinaio di
metri dal confine, attendono la notte e col favore delle tenebre entrano in Arabia. In
questo Paese normalmente costoro hanno parenti, amici o persone conosciute che li
35
aspettano. I migranti sperano di poter iniziare una nuova vita, trovare un lavoro,
ricominciare da capo.
Non possiamo conoscere, ovviamente, la sorte che li aspetta. Tuttavia,
considerate le difficoltà che normalmente gli stranieri incontrano nei Paesi europei,
possiamo presumere che difficilmente i migranti etiopi e somali troveranno di fronte a
loro una vita facile e agiata.
36
2. Il traffico dei clandestini
Il traffico dei migranti nel Corno d’Africa costituisce un’attività strutturata ed
altamente proficua. Il numero di individui che si mettono in marcia è in effetti enorme,
ed inevitabilmente con gli uomini si muove una sorprendente quantità di denaro. Si
pensi solo al tragitto via mare dalle spiagge di Obock allo Yemen. Pressoché ogni notte
centinaia di persone s’imbarcano sulle piccole navi, riempiendole ben oltre la capienza
massima, e ciascuno deve pagare. Si stima che in pochi viaggi i trafficanti abbiano già
coperto il costo della barca; tutto il resto è guadagno netto, che tocca cifre formidabili.
Per questo motivo costoro non danno troppo peso al fatto che, di tanto in tanto,
qualcuna delle loro barche affondi, con decine di persone a bordo. Si tratta
semplicemente di comprare una barca nuova. I morti, in fondo, non costano nulla; anzi,
prima di partire hanno già pagato il loro biglietto.
Il traffico è gestito per la prima parte del viaggio, fino alla città di Obock, da
trafficanti etiopi e gibutini; dalle spiagge in poi l’organizzazione dei clandestini passa
nelle mani degli arabi. I primi controllano i flussi umani che attraversano Gibuti
dall’Etiopia e dalla Somalia, e il traffico di denaro che li accompagna. Negli ultimi
tempi questi trafficanti gestiscono anche spostamenti dei clandestini in vettura, in alcuni
tratti del tragitto. Questa novità dei passaggi in macchina è uno dei motivi per cui si
vedono, ultimamente, meno migranti in marcia sulla strada che dal Gubetto va verso
Tadjoura e Obock. Gli arabi gestiscono il passaggio via mare ed il tragitto dallo Yemen
all’Arabia Saudita, mettendo a disposizione le piccole imbarcazioni yemenite e le jeep
che trasportano i clandestini attraverso la penisola arabica.
Il capitano della Polizia di Obock si dichiara onestamente impotente di fronte al
fenomeno. «Si tratta di un traffico organizzato; esiste un vero e proprio “cartello”, come
per il traffico della droga, e noi non abbiamo gli strumenti per contrastarlo. Qualche
volta fermiamo alcuni di questi clandestini, ne accertiamo la provenienza e li
riaccompagniamo alla frontiera. Dopo una settimana li ritroviamo a Obock. Costoro
peraltro, che hanno già percorso la strada, diventano guide per altri clandestini: si fanno
pagare per accompagnare altri migranti fino alle spiagge di Obock».
D’altro canto il controllo di questo fenomeno da parte delle autorità statali dello
Yemen è totalmente assente. Infatti le coste sud-occidentali del Paese, dove sbarcano i
37
clandestini, sono controllate e gestite interamente dagli “anziani”, capi villaggio e leader
che qui hanno un potere indiscusso. Persino le autorità governative non possono
interferire con le loro decisioni. E come si può facilmente immaginare, costoro sono
profondamente invischiati nel traffico dei clandestini.
Del resto, come si è detto, lo Yemen rappresenta solamente un luogo di
passaggio; le autorità centrali del Paese, dunque, non debbono nemmeno preoccuparsi
degli effetti di un’immigrazione sul territorio. Semplicemente chiudono un occhio sul
flusso umano che quotidianamente attraversa il Paese, e lasciano che gli anziani
gestiscano indisturbati il loro traffico.
Le piccole imbarcazioni che trasportano i clandestini
38
3. I pericoli del viaggio
Nonostante il viaggio dei migranti verso la penisola arabica sia oggi, come si è
visto, “ben organizzato” , molto gravi continuano ad essere i rischi per coloro che si
mettono in marcia. Si è detto sopra del pericolo di affondare e morire in mare, sorte a
cui tristemente vanno incontro migliaia di migranti, ma questo rischio non è il solo. Il
tragitto che costoro percorrono a piedi dall’Etiopia e dalla Somalia fino alla costa di
Gibuti è, infatti, carico di insidie.
I migranti devono attraversare tratti di deserto roccioso, sopportare temperature
infernali, trovandosi spesso senza viveri e senza acqua. Molti di loro, soprattutto donne
– vittime principali di questo crudele fenomeno – muoiono lungo la strada. Tra le file
dei migranti in marcia si possono scorgere anche bambini, e possiamo immaginare
quanto sia difficile, per individui in tenera età, arrivare alla fine del viaggio.
Le condizioni di vita alle quali i viandanti sono sottoposti, e l’assenza di cure
igieniche, favoriscono inoltre la diffusione di malattie. Si deve ricordare inoltre che un
gran numero di migranti è affetto dal virus HIV, un particolare che costituisce
letteralmente una tragedia nella tragedia. Le donne soprattutto, quando non hanno più
niente per sopravvivere, si trovano costrette nei villaggi che incontrano a vendere il
proprio corpo. Questa abitudine ha favorito, inevitabilmente, la veloce diffusione della
malattia, sia tra i migranti che tra la popolazione gibutina.
La descrizione del fenomeno migratorio nel Corno d’Africa ci pone di fronte ad
una realtà feroce. La fotografia impietosa di centinaia di migliaia di individui, in marcia
sotto il sole del deserto, ci scuote profondamente e solleva questioni che esigono una
risposta. Perché milioni di persone, al mondo, decidono di migrare, lasciando tutto
dietro di loro, mettendo a rischio la loro stessa vita? Dove si dirigono, cosa sperano di
trovare? Quanti di costoro muoiono silenziosamente, senza lasciare traccia delle loro
esistenze? Quale valore hanno queste vite 12?
12 Il numero esatto dei rifugiati sparpagliati per il mondo è oggetto di discussione ed è probabile che lo rimanga, visto che l’idea stessa di «rifugiato» è un concetto aspramente dibattuto. Le cifre più affidabili che abbiamo a disposizione sono prodotte per via burocratica, mediante la registrazione e l’archiviazione, in primo luogo dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nei suoi rapporti annuali intitolati The State of the World’s Refugees. L’ultimo rapporto (2006) stimava il loro numero a 22 milioni e 100 mila (la cifra non comprende i rifugiati affidate alle cure di altre agenzie e le minoranze perseguitate cui è negata un’identità statuale e che non si sono registrate da nessuna parte oppure cui è stata rifiutata la registrazione). Z. Bauman, Vite di scarto, cit.
39
Da queste domande si delinea, in ultima istanza, il vero fulcro del problema: la
diseguaglianza del mondo che abitiamo. La differenza abissale che separa i ricchi dai
disperati della Terra. L’immagine reale dei bambini che camminano nella polvere,
bruciati dal sole, ci deve indurre a chiederci: cosa si sta facendo, concretamente, per
ridurre le diseguaglianze del mondo? Che cosa sto facendo io, in prima persona?
Il mare di Obock, speranza di una vita migliore per i migranti e tomba per molti di costoro
ANGELO PITTALUGA
40












































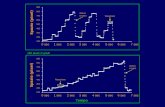




![sinsaude.org.brsinsaude.org.br/upload/Hospital Beneficente Santa Gertrudes[1].pdf · R$ 973,86 R$ 1.400,OO R$ 1.150,00 R$ 1.100,OO 982,79 R$ 1.001,16 Parágrafo único: Os valores](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/60bed162bbaaaf0e0e463ff7/beneficente-santa-gertrudes1pdf-r-97386-r-1400oo-r-115000-r-1100oo.jpg)










