Materiali gessosi per modelli Scienza dei materiali dentali.
Materiali Per Il Disegno
description
Transcript of Materiali Per Il Disegno
-
2unit 1 La comunicazione grafica I materiali per il disegno unit 1
3
I materiali per il disegno
Tipi di carta
Le carte da disegno comunemente usate sono di tre tipi:
carta bianca opaca a superficie liscia, adatta per disegnielaborati sia a matita sia a inchiostro di china;
carta bianca opaca a superficie ruvida, usata per disegniartistici elaborati (a mano libera), a matita o a carboncino;
carta lucida trasparente per disegni tecnici a china o amatita (questo tipo di carta si presta alla riproduzioneeliografica e permette di ricavare, per sovrapposizione,particolari disegni dinsieme).
Per luso scolastico, si ricorre generalmente a fogli di cartabianca liscia tipo Fabriano.Gli schizzi si eseguono di solito su carta quadrettata o mil-limetrata, opaca o trasparente.
Matite e mine
Esistono in commercio le matite di legno (Figura 1.1a),le mine contenute nei portamina a pinza (Figura 1.1b)e le mine sottili (a partire da 0.3 mm di diametro) conte-nute nei portamina automatici (Figura 1.1c).Qualunque sia il mezzo utilizzato, la traccia lasciata sul foglio dovuta alla grafite (una delle forme che il carbonio assumein natura), una sostanza nera e untuosa, facilmente sfaldabile.A seconda del tipo di impasto e della percentuale di grafitepresente, le mine hanno una diversa gradazione di durezza.
Durezza delle mine
La minore o maggiore durezza dellimpasto viene indicatacon le lettere B, F, H, iniziali delle parole inglesi black (nero),firm (stabile), hard (duro) vedi tabella 1.1.
Le mine di gradazione B hanno un impasto con grafite piabbondante, quindi lasciano un segno pi nero e scorronosul foglio senza incidere la carta: sono le mine morbide.Al contrario, le mine di gradazione H liberano la grafite pilentamente, quindi il segno tende al grigio e la mina incidemaggiormente il foglio: queste mine sono dette dure.
GRANDEZZA E DUREZZA DELLE MINETENERE MEDIE DURE DURISSIME
Lettera Numero Lettera Numero Lettera Numero Lettera Numero
6B 00 2B 2 H 31/20 6H 6
5B 0 B 21/2 2H 4 7H 7
4B 1 HB 21/2 3H 41/2 8H 8
3B 11/2 F 3 4H 5 9H 9
5H 51/2
Uso artistico Scrittura e disegni Disegni tecnici Usi speciali(litografia, ecc.)
Scelta delle mine
preferibile usare mine tanto pi dure quanto pi ruvida la carta e quanto pi sottili si vogliono le linee.
Per il disegno tecnico, come indicazione di massima, sonoconsigliabili le mine comprese tra F e 2H, tenendo contoche la scelta delle mine molto personale, perch legataalla maggiore o minore pesantezza della mano di chi di-segna.
Affilatura delle mine
Quando la punta si consuma, il segno della mina diventapi grosso, perci per disegnare con tratto uniforme bisognamantenere la mina appuntita, affilandola spesso.
Laffilatura si effettua con affila-mine a carta abrasiva o ra-schietti (Figura 1.2), con i quali si possono ottenere duetipi di punta:
punta conica, per tracciare linee utilizzando righe,squadre, sagome e scritture; quella pi usata perchfacilmente realizzabile e consente di ottenere un segnonitido e uniforme, specie ricorrendo alla rotazione dellamatita durante il tracciamento;
punta a taglio obliquo o scalpello (Figura 1.3) permine da inserire nel compasso: si ottiene facilmente concarta abrasiva, permette una costanza di tratto (nel casodel compasso, non si pu ruotare la punta) e facilita iltracciamento di cerchi a piccolo raggio.
1 2
Per mine calibrate (di diametro 0.3-0.5-0.7-0.9 mm) si pos-sono usare portamina ad avanzamento automatico che, ri-spetto a quelli a mina cadente, permettono di ottenere pifacilmente un tratto a spessore costante, senza dover usarespesso laffila-mine.
Uso corretto delle mine
Le mine tradizionali devono sporgere dal contenitore apinza di circa 1 cm. La matita va inclinata nel senso delmoto per facilitare lo scorrimento e va fatta ruotare su sestessa per uniformare il consumo della mina (Figura 1.4).
Gomme
I segni lasciati sul foglio dalla matita si possono asportarecon la gomma, che deve essere abbastanza morbida enon colorata, per evitare che sul foglio che si sta cancel-lando resti del colore.
Sono utili anche altri tipi di gomma (Figura 1.5), come lagomma-pane (che serve a ripulire il foglio eliminando glieccessi di grafite depositata) o come le gomme dure a se-zione sottile o le matite-gomma, che consentono di can-cellare con maggiore precisione e di togliere anche una solalinea dal disegno, lasciando inalterato il resto.
Affilatura della mina con carta abrasiva o raschietto.
Figura 1.2
a) Matita di legno. b) Portamina a pinza. c) Portamina automatico.
Figura 1.1
Tabella 1.1Affilatura della mina con carta abrasiva o raschietto.
Figura 1.3
Uso corretto delle mine.
Figura 1.4
Vari tipi di gomme.
Figura 1.5
I materiali tradizionalia) b) c)
-
unit 1
SI
NO
c)
a) b)
c)
Gli strumenti fondamentali per il disegno
Squadre
Per guidare la matita nel tracciare linee rette, linee parallelee linee perpendicolari si usano le squadre, normalmentecostruite in resina sintetica.
Le squadre hanno sempre un angolo retto e sono di duetipi (Figura 1.6a e 1.6b):
squadra a 45 (con due angoli uguali); squadra a 30 e 60.Per riportare parallele a una direzione data, una squadraserve da guida e laltra scorre come esemplificato in fi-gura 1.6c.
Gli strumenti ausiliariGoniometri
Il goniometro (Figura 1.9a) uno strumento che permette di misurare lampiezza degli angoli: costituito da un disco gra-duato in cui sono segnate 360 divisioni (ogni divisione corrisponde a 1). Molto diffuso il semidisco graduato con 180 di-visioni, come quello riprodotto in Figura 1.9b. Come le righe e le squadre, anche i goniometri sono generalmente realizzatiin resina sintetica.
Curvilinee
I curvilinee sono sagome in resina sintetica, che si usanoper tracciare con facilit e decisione linee curve o raccordi.Esistono in commercio curvilinee fissi (Figura 1.10) e cur-vilinee deformabili: i curvilinee fissi sono in genere vendutiin serie di tre pezzi, con sagome diversificate in modo daconsentire lesecuzione di qualunque tipo di curva; i curvi-linee deformabili solitamente si usano solo per le curve digrandi dimensioni.
Uso corretto delle squadre
Attenzione alluso corretto delle due squadre! Per non avereproblemi di riporto di parallele, se il foglio non fissato alpiano di lavoro, bisogna ricordarsi di tenere sempre il si-stema delle due squadre ben allinterno del foglio, in modoche, tenendo ferme le squadre, si tenga fermo anche il fo-glio stesso (Figura 1.7).
Compasso
I compassi (Figura 1.8) si usano per tracciare circonferenzeo per riportare misure.
La comunicazione grafica I materiali per il disegno unit 1
54
30
60
b b
2b
b)
45
45
l
l
a)
a) Squadra a 45 (con due angoli uguali).b) Squadra a 30 e 60. c) Uso di duesquadre per riportare parallele a unadirezione data.
Figura 1.6
Uso corretto delle due squadre.
Figura 1.7
a) Goniometro circolare. b) Goniometro semicircolare.
Figura 1.9
Curvilinee.
Figura 1.10a) Compasso. b) Balaustrone. c) Prolunga.
Figura 1.8
b)
a)
Il compasso (Figura 1.8a, pagina precedente) munito diuna punta di acciaio, usata come vincolo di centro, al-lestremit di un braccio.Allestremit dellaltro braccio vengono applicati, secondo lanecessit, una mina di grafite o un puntale di penna a ser-batoio.La mina, come gi detto, deve avere la punta a taglio obli-quo o a scalpello. Sul compasso si monta una mina pi te-nera di quella della matita, perch durante la tracciatura siesercita una pressione minore.
Il compasso formato essenzialmente da due aste incer-nierate fra loro, che si muovono con apertura angolare. Unbuon compasso deve disporre di una cerniera che consentadi aprirlo senza troppo sforzo, ma anche senza eccessivafacilit.Il compasso pi usato il balaustrone a regolazione micro-metrica (Figura 1.8b, pagina precedente), che offre unasso-luta garanzia di stabilit durante luso. Compasso e balaustronepossono essere muniti di prolunga per tracciare circonferenzead ampio raggio (Figura 1.8c, pagina precedente).
-
6unit 1 La comunicazione grafica I materiali per il disegno unit 1
7
Strumenti per tracciare
Sono in commercio molti tipi di mascherina in resina tra-sparente (Figura 1.11), che permettono la tracciatura ra-pida guidata di cerchi o parti di circonferenza (circoligrafi
o circolografi), di ellissi (ellissografi), di diciture con ca-ratteri a stampatello (normografi) o di elementi conven-zionali relativi ai vari tipi di disegno (mascherine per simbolielettrici, per simboli di arredamento, ecc.).
Penne e china
In alcuni casi i disegni sono rifiniti a matita, in altri con in-chiostro a china. Si usano per questo delle penne ricari-cabili a cartuccia, fornite di punte intercambiabili per latracciatura di linee di spessore diverso (Figura 1.12).
Lattrezzatura minima comprende una cartuccia con almenodue puntali, per linee di 0.25 e di 0.5 mm di spessore. inoltre necessario lanello di raccordo, che serve per mon-tare il puntale della penna con la cartuccia dinchiostro sulbraccio del compasso o del balaustrone.
a)
d)
b)
e)
c)
f)
a)
b)
c)
Vari tipi di mascherina per tracciare.a) Mascherina per cerchi; b) mascherina per architettura;c) mascherina per simboli elettrici; d) mascherina per ellissi;e) mascherina per raccordi circolari; f ) normografo perscrittura unificata diritta.
Figura 1.11
a) Penne a china con cartuccia e punta di ricambio. b) Esempio di set con quattro penne per diversi spessori, inchiostro eanello di raccordo per montare la penna sul compasso o sul balaustrone. c) La penna montata sul balaustrone.
Figura 1.12
I supporti tradizionali
Tavolette per il disegno
Si trovano in commercio molti tipi di tavolette attrezzateper il disegno, dotate di riga parallela o anche (come nel-lesempio illustrato in figura 1.13) di tecnigrafo, cio di unostrumento che consiste in due righe disposte ortogonal-mente, guidate a spostarsi mantenendo le direzioni di orien-tamento. Queste tavolette consentono di tracciarespeditamente linee fra loro perpendicolari, parallele e obli-que e risultano, per le piccole dimensioni, di grande ma-neggevolezza.
Tavoli con tecnigrafo
Sono solitamente destinati ai disegnatori e agli studi pro-fessionali: si tratta di tavoli speciali che possono assumereinclinazioni diverse e sono muniti di un tecnigrafo (Fi-gura 1.14).
I supporti informatici
Generalit
Quando si parla di computer o personal computer, si in-tende un insieme di elementi composto da unit cen-trale, video, tastiera e mouse.
Per la scelta del computer da adibire a stazione grafica, importante conoscere i requisiti minimi richiesti dal soft-ware di disegno grafico.Tutti i programmi professionali per il disegno necessitano diun hardware particolarmente evoluto rispetto a quanto ri-chiesto per software gestionale, word processor o database.Nelle pagine seguenti, analizzeremo le principali compo-nenti da considerare per la definizione di una stazione gra-fica (Figura 1.15).
Tavoletta grafica con riga parallela e tecnigrafo.
Figura 1.13
Tavolo da disegnatore con tecnigrafo.
Figura 1.14
Una stazione grafica.
Figura 1.15
-
8unit 1 La comunicazione grafica I materiali per il disegno unit 1
9
Unit centrale
Lunit centrale lelemento fondamentale di un computer.
Quelle in commercio sono contraddistinte da una siglaposta dopo il nome del costruttore e il tipo di modello, chene sintetizza le caratteristiche principali.Ad esempio, la sigla
Intel P4/ 3.2 GHz/512 MB
indica le seguenti caratteristiche:
P 4 tipo di microprocessore (Pentium 4 di Intel); 3.2 velocit di clock (GHz); 512 capacit della memoria RAM (MB).
Microprocessore
Ilmicroprocessore il motore del personal computer, cheesegue i calcoli per svolgere tutte le operazioni (nel casospecifico dellutilizzo grafico, i calcoli per il tracciamento deldisegno). Elenchiamo qui di seguito gli elementi caratteriz-zanti per la classificazione:
Pentium 4 3.2 GHz, Celeron 2.4 GHz, Centrino T.M.1.4 GHz, AMD Athlon 28001. Queste sigle indicano latipologia di processore con relativo indice prestazionale(GHz) dei maggiori produttori di microprocessori, comeappunto Intel e AMD.
Velocit operativa (3.2-3.6-2.8 GHz) del processore: siesprime in miliardi di impulsi e indica il numero di ciclioperativi al secondo. La velocit di un microprocessore simisura in Gigaherzt (GHz): maggiore il valore in GHz,maggiori sono le prestazioni del microprocessore.
Memoria RAM
Lamemoria RAM (Random Access Memory: memoria adaccesso casuale) la memoria di lavoro dei computer.
Ogni volta che si esegue un programma, il sistema opera-tivo legge dal disco e carica il programma in memoria (tuttii programmi si eseguono dalla memoria RAM). evidente che tanto pi grande un programma, tantomaggiore deve essere la quantit di memoria disponibile.Oggi la dotazione RAM per stazioni grafiche va da un mi-nimo di 256 MB (disegno bidimensionale) a 512-1024 MB(disegno tridimensionale).
Dischi fissi, floppy disk, CD e DVD
Il disco fisso (anche indicato con il termine inglese harddisk, HD), o memoria di massa, lelemento in cui ven-
gono custoditi i programmi applicativi, i dati, i file di lavoro(Figura 1.16).
Il disco fisso si caratterizza per la capienza in GB (miliardidi byte), per la velocit di rotazione e per la velocit di ac-cesso ai dati. interfacciato al resto del sistema con un con-troller che gestisce il transito dei dati.Le dimensioni minime consigliate per una stazione graficavanno da 40 GB a 80 GB.I floppy disk sono dischetti magnetici con un diametro di3.5 pollici, sui quali possibile registrare dati e programmiche possono essere utilizzati su altri computer. La capienzadei dischetti arriva fino a 1.44 MB (dischetti ad alta densit).I CD (compact disc) sono dischi sui quali vengono memo-rizzati i dati mediante tecnologia laser. Hanno una capacitdi 650-700 MB ed esistono in versione CD-ROM (a solalettura), CD-R (registrabili una sola volta) e CD-RW (regi-strabili pi volte). I programmi disponibili in commercio ven-gono generalmente forniti su CD-ROM.I DVD usano la stessa tecnologia laser utilizzata per i CD, masono in grado di contenere 4.7 GB o 9,4 GB, esistono inversione scrivibile (2R e/o 1R) o in versione riscrivibile (RW).I dispositivi USB sono una valida alternativa ai floppy disk(che hanno una capacit di memorizzazione estremamenteesigua e non pi adatta a file di CAD). Le thumbdriver, co-munemente dette penne USB, consentono di immagazzi-nare su un componente estremamente piccolo (grandepoco pi di una gomma da cancellare) grandi quantit didati. In commercio si trovano con varie capacit: le pi co-muni sono 128-256-512 MB - 1 GB. Cominciano a diffon-dersi anche gli hard disk esterni USB (160 GB).
Un disco fisso (hard disk).
Figura 1.16
Monitor
Linterfaccia grafica molto importante nelleconomia di unastazione grafica, perch sul video che nasce e si evolve ildisegno fino alla fase finale di stampa. Un buonmonitor ri-duce laffaticamento visivo e permette di visualizzare il di-segno con una buona risoluzione (capacit di potermostrare unimmagine in modo chiaro con tutti i particolaricomprensibili).
I parametri che classificano un monitor sono la dimen-sione dello schermo, la risoluzione e la frequenza direfresh.La dimensione data dalla misura della diagonale delloschermo (tubo catodico) espressa in pollici (unit di misuraanglosassone: 1 = 25.4 mm). I monitor grafici, normalmente,hanno le seguenti dimensioni: 17, 19, 21, 28 e possonoarrivare fino a 36. Si raggiunge gi una buona resa con 17(va comunque precisato che larea visiva reale sempre leg-germente inferiore a quella dichiarata dal costruttore).La capacit di risoluzione (cio di dettaglio nella defini-zione dellimmagine) inversamente proporzionale alle di-mensioni del pi piccolo punto (pixel) rappresentabile sulloschermo: minore il pixel, pi alta la risoluzione. La di-mensione dei pixel dei monitor oggi in commercio varia da0.36 a 0.22 mm.La frequenza di refresh rappresenta il numero di volte incui le immagini a video vengono aggiornate per ogni se-condo, aspetto molto importante nellambiente grafico, dovele immagini sono statiche. Pi alto il valore di refresh, mi-surato in Hz (Hertz), e pi si ottengono immagini nitide estabili, senza fastidiosi sfarfallii che dopo qualche tempopossono provocare sensazioni di nausea. Un monitor buonoha frequenze di refresh con valori intorno agli 80 Hz.Va ricordato, infine, che tutti i monitor devono possedereuna serie di requisiti minimi dettati da norme vigenti nei sin-goli Paesi dove il prodotto distribuito. In Italia, questi re-quisiti sono stabiliti dalle norme UNI EN 29241.In questi ultimi anni, i monitor con tecnologia LCD (LiquidCrystal Display), detti anche schermi piatti, stanno sop-piantando i monitor CRT, in quanto hanno raggiunto pre-stazioni ottimali sia nella risoluzione video sia nellavisualizzazione da punti di osservazione laterali.
Scheda grafica
La scheda grafica linterfaccia in grado di elaborare esupportare risoluzioni previste dal monitor.
Le pi recenti schede sono dotate di un processore graficoe di memoria video in grado di elaborare in modo auto-nomo le informazioni grafiche.
La risoluzione grafica personalizzabile mediante unappositautility dal sistema operativo e pu essere impostata, a secondadel tipo di monitor collegato, a 800 3 600 pixel per pollice(monito 15-17), a 1024 3 768 e a 1280 3 1024 (monitor19-21). possibile ottenere risoluzioni di 1600 3 1280, ma necessario utilizzare monitor professionali.Per capire meglio il concetto di risoluzione, vediamo comeappare lingrandimento di una sezione tracciata su un mo-nitor collegato a una scheda video con risoluzione 680 3 420e poi la stessa sezione con risoluzione portata a 1024 3 768(Figura 1.17).Come si vede, leffetto a scalini caratteristico delle risolu-zioni pi basse scompare con la risoluzione pi alta.
Tastiera e mouse
Per luso grafico, la tastiera e ilmouse non necessitano diparticolari requisiti e sono identici a quelli in dotazione aqualunque personal computer (Figura 1.18).
Un arco di circonferenza rappresentato con risoluzione a) 680 3 420 pixel per pollice econ risoluzione b) 1024 3 768 pixel per pollice.
Figura 1.17
Stazione grafica con monitor, tastiera e mouse.
Figura 1.18
-
unit 1I materiali per il disegno
11
unit 1 La comunicazione grafica
10
Una buona tastiera (quella italiana ha 104 tasti) deve pos-sedere alcuni standard ergonomici, quali la possibilit di in-clinazione e una limitata escursione dei tasti.Il mouse, cio il dispositivo mediante il quale si aziona ilcursore sullo schermo e si selezionano e attivano i comandidai menu e dalle icone, pu essere dotato di un numero va-riabile di pulsanti abbinati a varie funzioni. Lo standard at-tuale un mouse ottico a 2 tasti e rotella centrale.
Le periferiche di stampa
Gli elementi che permettono di trasportare il disegno pro-dotto a video su carta, o comunque su supporti idonei per lastampa (lucidi, acetati, ecc.), sono la stampante e il plotter.
La stampante lo strumento pi versatile e veloce per leoperazioni di stampa e permette di ottenere formati A4 e A3.Tramontata, per lambiente grafico, la versione ad aghi (acausa della pessima resa qualitativa nella stampa grafica),hanno avuto notevole diffusione le stampanti a gettodinchiostro e le stampanti laser (Figura 1.19), com-plice sia una progressiva diminuzione dei prezzi, sia un li-vello di qualit sempre pi elevato.
Questi tipi di stampante rappresentano il supporto idealeper la produzione di disegni in piccoli formati: entrambe, in-fatti, hanno raggiunto risoluzioni elevate, 1200 3 1200 dpie oltre per le laser e 1440 3 720 dpi per il getto dinchio-stro (il dpi 5 dots per inch, cio punti per pollice, il valoreche permette di riconoscere la qualit di stampa: pi alto il valore di punti per pollice, migliore la qualit di stampa).Rispetto alle stampanti a getto dinchiostro, le laser per-mettono una maggiore velocit di stampa (8-12 pagine alminuto per i modelli di fascia media). Per contro, le stam-panti a getto dinchiostro permettono di sfruttare anche ilcolore a prezzi accessibili, a differenza di quanto consentela tecnologia laser, che ha ancora costi elevati.
I plotter (Figura 1.20) sono essenzialmente di due tipi: apenna o a getto dinchiostro. Ormai per quelli a getto din-chiostro stanno soppiantando quelli a penna, che sonoquasi totalmente fuori produzione.Il plotter a getto funziona come una stampante a getto din-chiostro, in grado di supportare, a seconda del modello, for-mati A0 o A1; fornisce risoluzioni fino a 2400 3 2400 dpiper stampe in quadricromia (stampa con lutilizzo dei quat-tro colori: nero, ciano, giallo, magenta).Inoltre, il plotter a getto dinchiostro chiede tempi di prepa-razione minori e gestisce lo spessore delle linee, il tipo ditratto e il colore direttamente attraverso il software.
Software
Il software lelemento in grado di interpretare i comandidettati dalloperatore e trasformarli in linguaggio macchina,permettendo a chiunque di disegnare senza avere nozionidi programmazione (Figura 1.21, a pagina seguente).
Con successive release (termine che identifica gli aggior-namenti del software), si raggiunto un buon grado di fa-cilit duso, per cui sono sempre minori, se non nulli, iprerequisiti informatici richiesti per disegnare in CAD.Il mercato offre una vasta serie di programmi per il disegno,adatti a esigenze pi o meno professionali, sia in ambiente2D (bidimensionale) sia 3D (tridimensionale) o Rende-ring (modalit tridimensionale che permette di visualizzareloggetto disegnato come ripreso dal vero).La scelta dei software va fatta a seconda del tipo di disegnoda realizzare (2D, 3D, alla natura; architettonico, meccanico,impiantistico ecc.), ma dipende ovviamente anche dallin-vestimento economico. I prezzi dei software di disegnovanno infatti da poche centinaia di euro fino a decine di mi-gliaia di euro per le applicazioni pi sofisticate di tipo pro-fessionale, utilizzate ad esempio nei reparti di progettazionedelle grandi industrie meccaniche.
Stampante laser.
Figura 1.19
Esempi di disegno tecnico in CAD (Computer Aided Design, cio disegno assistito dal calcolatore). Sopra, un disegno meccanico.Sotto, un disegno architettonico.
Figura 1.21
Plotter.
Figura 1.20
-
unit 1I materiali per il disegno
13
unit 1 La comunicazione grafica
12
Il crescente sviluppo dellhardware ha permesso di spostarelutilizzo di CAD evoluti (prima esclusivamente utilizzati suWorkstation) verso i personal computer: un normale PC difascia media attrezzato con una buona scheda video e unabuona dotazione di memoria RAM consente un agevole uti-lizzo di CAD 3D per la modellazione solida. La prerogativadi questi software quella di progettare un componente oun assieme di componenti in grado di simulare in toto log-getto reale permettendo quindi di analizzare mediante si-mulazione i cinematismi, lusura, il comportamento disituazioni critiche. Tutte queste caratteristiche permettonodi velocizzare la fase progettuale delloggetto evitando la co-struzione dei prototipi che venivano utilizzati per i collaudidi qualit prima di avviare la produzione in serie.I vari tipi di sofware per la modellazione solida (i pi diffusisono Solid Age, Pro Engegnering, Autodesk Inventor)
si presentano con un approccio al disegno medianteschizzo che, opportunamente parametrizzato con lag-giunta di vincoli geometrici e dimensionali, consentir inogni successiva fase di eseguire modifiche, rigenerando il di-segno in tempi rapidissimi (cosa non possibile nei sistemiCAD bidimensionali).Per quanto riguarda la tipologia di applicativi per la model-lazione solida, non esiste uno standard assodato come peril 2D; possiamo collocare Inventor e Solidage in unaprima fascia (anche sotto il profilo dei costi dacquisto), perpassare a Pro Engegnering, Camtasia che sono softwareestremamente professionali ma con costi dacquisto mag-giori anche nelle versioni educational.A supporto della parte di applicazioni CAD trattate in questocorso, abbiamo scelto come software 2D AutoCAD 2005 ecome software 3D Autodesk Inventor Professional 9.
Riproduzione e archiviazione dei disegni
Strumenti tradizionali di riproduzione e archiviazione
I disegni di progettazione vengono normalmente eseguiti a inchiostro di china su fogli lucidi e riprodotti su carta mediantemacchine eliocopiatrici.Leliocopiatura un particolare sistema di duplicazione che consente il trasferimento del disegno dal lucido a una specialecarta fotosensibile (Figura 1.22).
I disegni originali eseguiti su lucido devono essere conser-vati entro appositi tubi di cartone, arrotolati in modo da evi-tare che si formino pieghe. Eventuali pieghe, infatti,verrebbero lette come linee dalla macchina eliografica,sporcando la riproduzione del disegno.Le copie riprodotte su carta formato A0 devono poi essere pie-gate, seguendo lo schema in figura 1.23, sino al formato A4.
Con il passare del tempo, gli originali su lucido subiscono unprogressivo deterioramento, mentre la pellicola si induriscee si opacizza, rendendo poco leggibili le copie prodottedopo alcuni anni dalla stesura dei disegni originali.La produzione di copie dei disegni di progettazione ha su-bto una radicale trasformazione con lavvento del CAD e larelativa stampa su plotter.Lavvento del disegno in formato elettronico CAD ha fatto sche ogni copia stampata sia come loriginale, con il van-taggio che si producono stampe nel formato pi idoneosolo quando servono, riducendo i costi.I file di disegno vengono archiviati come qualunque altrofile in cartelle (directory ) e sotto-cartelle (sotto-directory ),
strutturate in modo da rendere facile la ri-cerca (Fi-gura 1.24). Lindividuazione dei file oggi estremamenterapida e precisa sfruttando sia il motore di ricerca proprio diWindows sia i motori di ricerca, corredati di visualizzazionedellanteprima del disegno, dei vari programmi di CAD.
Trasferimento dei file
Il progressivo sviluppo del disegno in formato elettronico,con la diffusione e il consolidamento dello standard Auto-CAD (con il formato dei file di disegno dwg) e la diffusionedel formato di interscambio dei file dxf con le altre piatta-forme CAD, consente il trasferimento dei file di disegno trai vari studi di progettazione sfruttando la capillare diffusionedi Internet e della posta elettronica. In questo modo, studidi progettazione situati in citt diverse o addirittura in Paesidiversi contribuiscono allo sviluppo dello stesso progetto,lavorando sul medesimo file.Larchiviazione definitiva dei progetti, a seconda delle loro di-mensioni, pu essere eseguita registrando i file su CD, capacidi ospitare fino a 700 MB di dati, oppure su cartucce DAT (Di-gital Audio Tape), capaci di memorizzare da 2 a 24 GB di dati,a seconda del tipo e delle utility di compressione utilizzate.Larchiviazione sui CD mediante la scrittura con lunit dimasterizzazione pi indicata per piccole unit di proget-tazione, mentre le unit DAT sono utilizzate negli uffici conpi stazioni grafiche collegate in rete. Entrambi i supportisono molto affidabili e, se conservati in modo corretto, dif-ficilmente si deteriorano.Macchina per la riproduzione
eliografica di disegni.
Figura 1.22
1
210 239 185 185 185 1851189
841
297
297
247
A0
P
= =
Schema di piegatura di un disegno formato A0 UNI 938.
Figura 1.23
Struttura di una cartella e relative sotto-cartelle in cui archiviare i file di disegno.
Figura 1.24


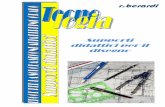





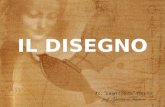






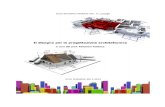

![I MATERIALI: MAPPA CONCETTUALE - Tecnologia e Disegno · I MATERIALI: MAPPA CONCETTUALE. Title: Zanichelli_Rosano_Tecnologia_Ciak08_ins [modalità compatibilità] Author: Lenovo Created](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f5fda00548dde3bdb23bc7a/i-materiali-mappa-concettuale-tecnologia-e-i-materiali-mappa-concettuale-title.jpg)

