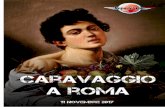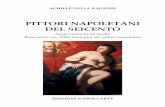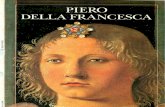M - Tutti i Pittori dalla A alla Z
-
Upload
tutelatemi -
Category
Documents
-
view
1.140 -
download
3
description
Transcript of M - Tutti i Pittori dalla A alla Z
-
Ma Yuan(attivo intorno 1190-1230). Pittore cinese originario del-lo Shansi. Membro di una famiglia di pittori professioni-sti, M che venne onorato da una cintura doro nel-lAccademia dei Song del Sud di Hangchow, associatoa Xia Gui nella fondazione della scuola detta Ma-Xia.(ol).
Mabe, Manabu(Kamapo Ken 1924). Lartista, il pi noto della comunitnipponica brasiliana anche la personalit pi incisivadella pittura informale in Brasile. Il suo stile, cromatica-mente assai raffinato, domina liricamente lo spazio. M rappresentato presso lInst. of Contemporary Art di Bo-ston, a Monaco (np), al mac di San Paolo, al mam di Riode Janeiro ed al Walker Art Center di Minneapolis, e si distinto nelle Biennali di San Paolo e di Parigi. (wz).
MAC (Movimento per lArte Concreta)Si suole far coincidere la nascita del MAC con la realiz-zazione e quindi con lesposizione, di una cartella di do-dici stampe a mano, edite dalla Libreria Salto, di Milano,ed ivi esposte dal 22 dicembre 1948. Le dodici stampe diquesta prima cartella cui seguirono altre erano operadi altrettanti artisti (Dorazio, Dorfles, Fontana, Garau,Guerrini, Mazzon, Monnet, Munari, Perilli, Soldati,Sottsass, Veronesi). In realt, promotori della manifesta-zione e del Movimento furono i pittori Gillo Dorfles (an-che teorico e critico darte), Gianni Monnet (anche ar-chitetto e grafico), Bruno Munari (gi interessato ad altri
M
Storia dellarte Einaudi
-
media espressivi), Atanasio Soldati: tutti da tempo perve-nuti allastrattismo per vie e in momenti diversi, edifferenziati nei rispettivi linguaggi. Li univa e fu que-sto il nucleo del MAC un rifiuto/chiusura verso le va-rie formalizzazioni dellarte figurativa del dopoguerra,fossero quelle inclinate espressionisticamente (a Milano,dalla radice di Corrente), o quelle, allora largamentedivulgate, del post-cubismo picassiano, o infine quelleconfluenti nel cosiddetto realismo socialista di pistretta intenzione poetica. Degli autori della prima car-tella di stampe, del 1948, i romani Dorazio, Guerrini ePerilli non aderirono mai ufficialmente al MAC, cosi co-me Lucio Fontana, pur sempre accolto con interesse an-che in successive attivit e manifestazioni del movimen-to. Il MAC si pose come legittimo erede e continuatoredella grande tradizione dellastrattismo europeo daKandinsky, Klee e Mondrian, da De Stijl e van Doesburgal Bauhaus, al concretismo svizzero di Arp e Max Bill e delle sue filiazioni italiane degli anni Trenta. Lo stes-so termine di Arte Concreta era mutuato da questatradizione: stando a indicare che la vera arte astratta nonprocede per semplificazioni, geometrizzazioni e astrazionia partire dai dati naturali, ma si costituisce astrattasulla base delle potenzialit linguistiche delle forme puree dei colori e creando oggetti quadri, sculture, archi-tetture, ecc. del tutto autosufficienti ed autonomi,concreti appunto perch privi di qualsiasi referente na-turalistico. Per collocare storicamente lorigine del MACnellambito della situazione artistica italiana deldopoguerra, utile ricordare alcuni eventi pi o menocontemporanei: nel 1946 a Venezia la Nuova secessioneartistica italiana ed il Manifesto del Realismo OltreGuernica, Milano; 1946-47, il Fronte nuovo delle Arti,dissoltosi nel 48; nel 1947 Forma i a Roma e manifestodel Gruppo spaziale Italiano; 1952, affermazione delleposizioni astratto-concrete del gruppo degli Otto pitto-ri italiani. Il MAC si struttur solo in seguito, nel 52, informe organizzate precise, con organismi direttivi e conadesioni formali. Si mantenne sempre coerente con i pro-pri principi ed ebbe contato con diversi nuclei di ricerchepi o meno affini in tutta Italia, ferma restando la di-scriminante verso ogni posizione figurativo-realistica. Lasua attivit si estrinsec in pubblicazioni varie, in mostreed altre iniziative. La vicenda del MAC di solito scan-dita dagli storici dellarte in due fasi: la prima, dalle ori-
Storia dellarte Einaudi
-
gini alla morte di Soladati (1953); la seconda, dal 1953fino alla dissoluzione del movimento nel 1958. Esiste,presso la Civica Galleria dArte Moderna di Gallarate,un Archivio Storico del mac. (sr).
Maccagnino, Angelo (Angelo di Pietro da Siena,detto)(documento 1439-56). Nel 1439 maestro famoso, se ilsenato della repubblica di Siena intercede presso il cardi-nale di Firenze Giovanni Vitelleschi perch gli vengacondonata la pena inflittagli per un omicidio. Nel 1447 documentato a Ferrara come pittore di Lionello dEste; alui spettano, secondo le fonti, alcune Muse per la resi-denza di Belfiore (lumanista Ciriaco di Ancona nel 1449dice di mano del M le figure di Clio e di Melpomene; lealtre sette sono attribuite, nel Dialogo di Ludovico Car-bone, di poco posteriore, a Cosm Tura, che gli succe-dette nella carica di pittore del duca). Che le Muse delTura e del M siano da riconoscersi, com stato propostoin pi occasioni, in quelle gi nel palazzo ferraresedellInquisizione, alcune delle quali gi attribuite da Lon-ghi a Galasso (la Polymnia di Berlino, sm, gg, Melpome-ne ed Euterpe del nm di Budapest, Urania ed Erato passa-te nel 1992 da Casa Strozzi allo Stato), resta ancora unproblema aperto. Come la personalit di Galasso, anchequella di M ancora da chiarire. Suggestiva la propostadi identificare il Maestro del Desco di Boston con M.Questi appare infatti al corrente sia degli sviluppi dellacultura ferrarese verso la met del secolo che dellam-biente fiorentino e senese, tra Domenico Veneziano eDomenico di Bartolo. (sr).
Maccari, Cesare(Siena 1840 Roma 1919). Iscrittosi allAccademia diSiena (1855), segu i corsi di scultura per poi passare aquelli di pittura tenuti da Luigi Mussini. Completata laformazione a Roma e Venezia, il cui punto di forza fu lostudio delle opere del rinascimento italiano, vinse nel1866 il concorso Biringucci con un quadro che ne esem-plifica lorientamento accademico e storicistico: Ultimigiorni del Magnifico (1866: Roma, Palazzo Madama). Sta-bilitosi a Roma, si dedic con un certo successo allaffre-sco (cfr. Amore che incontra le tre Grazie: Roma, Palazzo
Storia dellarte Einaudi
-
del Quirinale). Dal 1873 al 1879 tratt soggetti di gene-re letterario per poi tornare a farsi interprete del quadrostorico-celebrativo (La deposizione di Papa Silvestro, 1880:Torino, gam) costruito secondo i princip di osservanzadel vero e di fedelt alla ricostruzione storica dambien-te. Nel complesso i risultati pervengono ad una certastucchevole legnosit come negli affreschi nel Palazzo delSenato a Roma (Cicerone accusa Catilina; Partenza di Atti-lio Regolo; Curio Dentato), quelli con storie romane per laConsolazione di Genova e per il Palazzo Pubblico di Sie-na (Il plebiscito di Roma e Le Esequie di Vittorio Emanue-le II) del 1886-88. (sr).
Maccari, Mino(Siena 1898 Roma 1989). Nel 1924, a Colle Val dEl-sa, fond assieme allo scrittore e disegnatore Leo Longa-nesi il periodico Il Selvaggio (1924-43) trasferito nel27 a Firenze organo del movimento di Strapaese.Alla rivista insieme politica, letteraria ed artistica Mdiede unimpronta molto personale attraverso unintensaproduzione in cui gli scritti irridenti e i versi polemici siintegravano con la verve dei suoi disegni caricaturali. Ber-saglio principale della sua satira caustica e violenta lu-niverso borghese dellItalia contemporanea, con i suoiconformismi morali e il suo stile di vita sociale. Il lin-guaggio tagliente, di una violenza fustigatrice ed amara,si rif sapientemente alla tradizione della grafica popola-re ottocentesca; ma anche, e specialmente, ad una cultu-ra estremamente smaliziata e aggiornata, sugli esempi siadella grafica satirica di certo Ottocento francese, sia sul-la suggestione di Ensor, sia, soprattutto, sui precedentipi prossimi dellEspressionismo tedesco, della Brcke edi Grosz in particolare, del quale riprende anche moltispunti tematici. La polemica antiborghese fu ben prestointerpretata in chiave di ribellismo allormai consolida-to conformismo ufficiale del regime fascista istituziona-lizzato. Essa ha, del resto, una stretta corrispondenzacon un preciso filone ideologico rintracciabile allinternodel fascismo: un filone che andava opponendo alle de-generazioni della borghesia ormai vincente (e dellacitt come simbolo di corruzione morale e di moderni-smo cosmopolita) i valori sani e genuini di un am-biente popolare e paesano, intriso di spiriti in qual-che modo ancora rivoluzionari.
Storia dellarte Einaudi
-
Nel dopoguerra la verve sanguigna e ironica di M, graf-fiante ma divertita e tragicomica, sostanzialmente grotte-sca, si ritrova nelle caricature eseguite periodicamenteper il settimanale Il Mondo: dove tornano le consuetetematiche, applicate alla nuova societ di quegli anni.Anche la sua produzione pittorica, di modi tendenzial-mente espressionisti nel segno sintetico e nellasprezzacromatica, nasce da un analogo umore esistenziale. AllaBiennale veneziana del 1948 fu assegnato a M il Premiointernazionale per lincisione; una mostra personale dellasua opera stata allestita alla Biennale del 1960. (lm+sr).
macchiaioliCos nel 1862 un anonimo recensore della Gazzetta delPopolo aveva definito, nel senso dispregiativo e popola-resco di scavezzacolli, quei pittori che intorno al 1855avevano dato origine in Firenze, nellambito del trapassodal gusto romantico a quello verista, ad un rinnovamentoantiaccademico dello stile, individuando proprio nellac-centuato contrasto timbrico e chiaroscurale della mac-chia il principio fondante della loro maniera. Dalle pa-gine della Nuova Europa Telemaco Signorini, capofiladel gruppo, volle polemicamente adottare il nuovo termi-ne, attorno a cui si riconobbero gli artisti che costituiro-no il nucleo storico e principale del movimento: i to-scani Serafino De Tivoli, Odoardo Borrani, Raffaele Ser-nesi e Adriano Cecioni, scrittore e scultore oltre che pit-tore; il pesarese Vito DAncona; il napoletano GiuseppeAbbati e Vincenzo Cabianca da Verona, cui si aggiunselallora giovanissimo Diego Martelli, che dei m fu criticointelligente e mecenate sensibile. In certo senso pi isola-ti gli altri due protagonisti, assieme a Signorini, dellanuova esperienza di macchia: Giovanni Fattori e Sil-vestro Lega, che alle istanze del gruppo ader relativa-mente tardi, nel 1861.Gi dal 1849-50, in parallelo allinsorgere delle passionipolitiche e delle comuni aspirazioni liberali a seguito deimoti del 48, fermenti di ribellione alla pittura dominan-te, romantica nei soggetti ma sostanzialmente accademicanello stile, avevano animato vivaci discussioni artisticheattorno ai tavoli del Caff Michelangelo, a pochi passidallAccademia, destinato a divenire in questa fase la se-de e in certo senso il simbolo del movimento. Ma nel
Storia dellarte Einaudi
-
Storia dellarte Einaudi
1856 che tali confuse aspirazioni trovano approdo in unamaturazione pi concreta. Data questanno, infatti, la-pertura al pubblico fiorentino della notevole collezionedel principe Anatoli Demidoff in Villa Pratolino, ricca dicapolavori della migliore pittura contemporanea francese:da Ingres a Delacroix, a Delaroche allora amato, para-dossalmente, per quegli accenti psicologico-narrativi cheappesantiscono la sua opera fino ai paesaggi di Barbi-zon ed alle accese, contrastate cromie dellorientalistaDecamps, che esercitarono una suggestione durevole tra igiovani italiani. Contemporaneamente approd a Firenze,reduce anchegli da un viaggio in Europa culminato nellavisita allExposition Universelle di Parigi, il napoletanoD. Morelli, che nel frigido panorama della pittura di sto-ria aveva portato la ventata di un colorito nuovo, bril-lante, argentino sono parole di Martelli , e di unaveloce scioltezza meridionale. Sempre da Parigi un al-tro napoletano, S. Altamura, aveva introdotto la no-vit del momento, destinata ad avviare gli entusiasmi diuna nuova sperimentazione: quel famoso ton grison dicui si era servito Decamps, lo specchio nero che, deco-lorando il variopinto aspetto della natura, permette diafferrare pi prontamente la totalit del chiaroscuro, del-la macchia (Martelli). Ed proprio in funzione di una resa abbreviata e conci-sa dei rapporti tonali e chiaroscurali che la macchia, incontrasto con la priorit del contorno e della prospettivatradizionali, si propone come limpalcatura strutturale sucui si articola e definisce, in una netta scansione di pia-ni, il rilievo spaziale. ancora Martelli a riassumere gliintendimenti e le istanze dei giovani pittori: Essi dice-vano che tutto il rilievo apparente degli oggetti raffigura-ti su di una tela si ottiene mettendo nella cosa rappre-sentata giusto il rapporto fra il chiaro e lo scuro e questorapporto non esser possibile rappresentarlo al suo verovalore che con delle macchie o pennellate che lo raggiun-gessero esattamente. Gi adottata come puro abbozzoin alcune correnti della pittura di storia, anche se solo co-me semplice accentuazione del chiaroscuro pittorico peremanciparsi dal difetto capitale della vecchia scuola(lappiattimento sulle mezzetinte, come sostiene Signori-ni), naturalmente spostandosi alla diretta pratica delpaesaggio che la macchia raggiunse i suoi esiti pi inte-ressanti. Ma anche da notare che alla radice del Sin-tetismo macchiaiolo non difficile scorgere una compo-
-
nente culturale tipicamente purista. Anticipati solo inparte da quella Scuola di Stagga che aveva a capo unaltro futuro macchiaiolo, De Tivoli, anchegli reduce nel56 dagli incontri parigini con Troyon e Rosa Bonheur,nellestate del 58 e del 60 Signorini, Cabianca e Cri-stiano Banti cercarono per primi nella luce vivida e pienadella Spezia la verifica dal vero delle teorie finora di-battute. Nel contempo tra Montemurolo e Piantavigneancora Banti, Cabianca e Cecioni sperimentavano lospecchio nero. Ne risult una serie di dipinti acerbi e for-se troppo recisi, scolpiti a colpi di sole nellombra nera(Boito), che fecero scandalo alla Promotrice di Firenze eTorino del 1861: il Merciaio di La Spezia (1858, probabil-mente il primo quadro macchiaiolo) e Il Ghetto di Vene-zia di Signorini, e tre celebri opere, oggi perdute, diCabianca: Porci al Sole, La Mandriana, Donna con un por-co contro il sole, che vennero considerate come il mani-festo della nuova pittura. Ben lontana dagli eccessi pro-grammatici e di pi meditato spessore costruttivo la ri-cerca autonoma di Fattori, di certo stimolata dallincon-tro col romano Nino Costa, robusto paesaggista ed ora-tore di grande finezza. In Soldati francesi del 59 (1859),nelle Macchiaiole, nelle Acquaiole livornesi (1865) ed intutte le opere maggiori del periodo di Livorno: la Signoraal sole, la Signora allaperto e la Rotonda di Palmieri(1866), Fattori raggiunge nella scansione esatta dei pianie delle luci, cui si fa complice ladozione del formatoorizzontale allungato che meglio asseconda la distribuzio-ne metrica e modulare delle larghe campiture di colo-re, un equilibrio perfettamente compiuto ed oramai giclassico. Si accostarono precocemente alla macchia ancheSernesi (Cupolino alle Cascine, 1860 ca.) e DAncona (Ilportico, 1861), rivelando entrambi doti di calibrata e net-ta visione; cos come lAbbati, che al temperamento esat-to della scuola meridionale sa coniugare una grande in-tensit materica e cromatica (Chiostro di Santa Croce,1862), ed il fiorentino Borrani, che nel rigore dellacomposizione inserisce sovente una nota garbata ma de-scrittiva di costume (26 aprile 1859, 1861; Cucitrici di ca-micie rosse, 1863). Gli anni Sessanta vedono cos lo sviluppo e la precisa-zione della tecnica di macchia in esperienze parallele maspesso dialetticamente differenti, concentrate soprattuttoattorno ai due centri, impropriamente definiti scuole,di Castiglioncello e Piagentina. La tenuta di Castiglion-
Storia dellarte Einaudi
-
cello, ereditata da Martelli alla morte del padre nel1861, venne ben presto a sostituirsi al Caff Michelan-gelo come animato punto di incontro e territorio privile-giato di unattiva sperimentazione sul vero luminoso,che si tradusse nelle mirabili Vedute e Marine di Abbati,Sernesi e Borrani ma soprattutto nelle solari tele di Fat-tori, a partire dal 67 impostosi come la personalit do-minante del gruppo. Nonostante sia ancora il versatileSignorini a figurare da padre e trascinatore, lanima ve-ra di Piagentina, dove si stabil nel 1861 presso lamicoeditore Batelli, invece Silvestro Lega, la cui pittura im-prontata ad un intimismo lirico e quotidiano, sorrettoper da un impianto solidamente classico (si vedano i trecapolavori del Canto dello stornello, La visita e Il Pergola-to, del 1967-1968), condiziona nel senso di una medita-ta intonazione affettiva il percorso dei suoi compagni:ancora Abbati, Sernesi e Borrani. La morte di Sernesi(1866) e di Abbati (1868); il mutato clima politico, chedopo la delusione di Aspromonte raffren gli entusiasmiin un pi cupo ripiegamento interiore; la dispersione, in-fine, dei continui viaggi contribuirono al progressivo di-sgregarsi del gruppo, solo formalmente rappresentato da-gli interventi critici e teorici di Signorini e Cecioni suIl Gazzettino delle Arti del Disegno (1867) ed ilGiornale Artistico del 1873-74. Un processo che Si-gnorini per primo, in uno scritto del 74, vuole anticipa-to di anni: Cos verso il 1862 questa ricerca artisticache aveva fatto il suo tempo mor senza onor di sepoltu-ra lasciando ai posteri un soprannome bernesco fiorenti-no . Attraverso linflusso crescente della cultura fran-cese, cui offr nuovi legami il tramite di Boldini e DeNittis che nel 1869, dopo una breve esperienza tra i M,si trasferirono a Parigi, nuovi motivi e nuovi temi, im-prontati a quel gusto aneddotico e borghese che dettavala moda ai salons parigini, entrarono a far parte delrepertorio figurativo. Particolarmente sensibile lin-fluenza di artisti come Tissot, Stevens e Jules Breton,gi ammirati come modelli di moderno naturalismo du-rante la visita di Signorini, Cabianca e Banti al Salondel 1861 mentre va ridimensionato il rapporto con ilgruppo degli impressionisti, i cui contatti certi non data-no prima del 1873-74 e trovano un significativo sboccotra il 78 e il 79, durante lultimo soggiorno in Franciadi Martelli. In questo clima di relativa involuzione nonmancano, tuttavia, i capolavori: la Sala delle agitate a San
Storia dellarte Einaudi
-
Bonifazio di Firenze (1865) o Aspettando (1867), di Signo-rini; o ancora lintero periodo di Bellariva del Lega, chepersegue una sua progressiva; personalissima forma di in-teriorizzazione del vero (Le bambine che fanno le signore,1872). Aliena da ogni tentazione di psicologismo, inve-ce, ma fedele ai principi di solidit strutturale che nellamacchia avevano trovato origine, si svolge la straordina-ria, ultima produzione del solitario e misconosciuto Fat-tori.Nonostante la scarsa risonanza che il movimento dei Mesercit sui contemporanei escludendo linflusso indivi-duale di Signorini e Lega sui giovani Nomellini e Gioli odi Fattori su Modigliani la rilevanza storica del grupporesta comunque notevole per la pittura italiana, che tro-va in esso una prima espressione di avanguardia in gradodi varcare i limiti del regionalismo in un approdo di coe-rente maturazione. (fca).
Macchietti, Girolamo(Firenze 1535-92). Allievo di Michele di Ridolfo, fu in-fluenzato dal Vasari con il quale collabor in PalazzoVecchio a partire dal 55. Nel 1560 documentato a Ur-bino e da qui si trasferisce a Roma, dove soggiorna dueanni. Nel 1563 torna a Firenze, dove a quanto pare siassocia con il Cavalori. Vasari e i suoi modelli (Parmigia-nino, Bronzino e Salviati) sono in genere i punti di rife-rimento per le opere eseguite in questo periodo dal M:Allegoria della ricchezza (Venezia, C dOro), Adorazionedei Magi (Firenze, San Lorenzo) del 1567-68, sua primacommissione pubblica. Contemporaneamente il pittoredimostra di non essere estraneo alle tendenze che, in no-me di una nuova chiarezza ed essenzialit, erano in que-gli anni promosse da Santi di Tito (vedi ad esempio Ma-donna della cintola, 1569: Firenze, SantAgata). In questapi articolata accezione del gusto fiorentino attorno al70 devono essere lette anche le due composizioni concui M partecip alla decorazione dello Studiolo (1570-72, Medea ed Esone; le Terme di Pozzuoli). Del 1573 ilMartirio di san Lorenzo (Firenze, Santa Maria Novella)opera di notevole impegno che rivela anche interessi perla pittura veneziana. Nei suoi ultimi due decenni di atti-vit M si sposta di frequente da Firenze ad altri centriitaliani e anche oltralpe: a Parigi (1573-1574), a Napoli(1579-83) ed infine in Spagna. (sr).
Storia dellarte Einaudi
-
Macci, Rmulo(Buenos Aires 1931). Dopo aver lavorato nella pubblicit,si dedic alla pittura a partire dal 1956. Soggiorn a NewYork ed in Europa, esponendo in alcune grandi citt. Lasua carriera cominci nel 1961, quando si un a Luis Fe-lipe No, Ernesto Deira e Jorge de la Vega, con i qualicostitu il gruppo della Nuova Figurazione; la mostra delgruppo organizzata presso il Museo di Buenos Aires(1962) riscosse un certo favore. Malgrado ladesione chetutti questi artisti dichiarano per la Nuova Figurazione,la loro pittura pi astratta che figurativa; la figura uma-na, generalmente frazionata in linee e piani e gli altri mo-tivi compositivi servono a M per creare spazi sui generische non rinviano ad alcuna immagine. M rappresentatoal Guggenheim Museum di New York, a Buenos Aires(mn e mam), al mrba di Bruxelles, al Museo del xx se-colo di Vienna, al Walker Art Center di Minneapolis.(jrb).
MacDonald, James Edward Hervey(Durham (Inghilterrra) 1873 - Toronto 1932). Studi di-segno e pittura nei corsi serali di Hamilton e Toronto, la-vorando contemporaneamente come disegnatore in studiartistici commerciali. Sub linflusso dellArt Nouveau at-traverso la rivista The Studio. Tornato in patria dopoun soggiorno di cinque anni in Inghilterra, espose per laprima volta a Toronto nel 1908. In questo periodo sem-bra influenzato dal post-impressionismo. Fervido ammira-tore del paesaggio canadese, e poeta occasionale, lavoralla ricerca di una forma espressiva specificamente nazio-nale. La visita ad unesposizione di arte scandinava aBuffalo nel 1912 fu per M determinante e contribu alladefinizione di un suo stile personale. I dipinti che esegunellanno seguente rivelano gi, sia nei soggetti che nellatecnica pittorica, i caratteri essenziali della scuola delgruppo canadese dei Sette. Si tratta di paesaggi dellOn-tario settentrionale, dai colori brillanti e ritmati, eseguiticon una tecnica assai vicina a quella del neoimpressio-nismo. Tipico esempio dello stile del gruppo dei Sette uno dei migliori quadri di M, la Diga dei castori (1919:Toronto, ag). (jro).
MacDonald, Margaret(Newcastle-under-Lyme 1865 - Chelsea 1933). Allieva
Storia dellarte Einaudi
-
della Scuola di belle arti di Glasgow, disegn ed eseguopere in metallo, spesso in collaborazione con la sorellaFrances; ha lasciato acquerelli su temi simbolisti, comeSummer, progetto di vetrata, 1893-94 (Glasgow Univer-sity, Mackintosh coll.) o The Fifth of November (Glasgow,School of Art), che venne riprodotto su The Magazi-ne, pubblicazione cui spesso collaborarono le sorelle Me Mackintosh. Margaret fece parte del gruppo dei Quat-tro e spos larchitetto Mackintosh nel 1900; collaborspesso con lui nella decorazione di interni accentuando inopere come il pannello decorativo della Willow Tea-Room a Glasgow nel 1904 sinuosit e carattere astrattodel segno grafico.Frances (1874-1921), allieva della Scuola di belle arti diGlasgow, lavor prima da sola o in collaborazione con lasorella Margaret; in particolare esegu, intorno al 1893-1894, un grande progetto di decorazione murale, Croci-fissione e Ascensione (Glasgow University, Mackintoshcoll.); il suo acquerello A Pond (1894: Glasgow, School ofArt) presenta elementi vegetali che vengono resi quasi informe antropomorfiche e figure nude stilizzate che se-guono il linearismo degli steli, motivi che la pittrice fon-de nella sofisticata evoluzione della sinuosit della lineadi contorno e nel colore dato a tinte piatte, generalmen-te molto chiare. Frances fece parte del gruppo dei Quat-tro, che diede vita allo stile di Glasgow, e nel 1899 spo-s uno dei membri del gruppo, Herbert MacNair, colquale da allora cooper nella progettazione di mobili, og-getti darte e vetrate. Nel 1907 divenne insegnante nellaScuola di belle arti di Glasgow. (gl).
MacDonald-Wright (Vranken (van) Stanton, dettoStanton)(Charlottesville in Virginia 1890-1973). Allievo di R.Henri a New York, si rec nel 1907 a Parigi. Qui fre-quent lAcadmie Julian ed alcuni corsi alla Sorbona;determinanti per la sua formazione per, come per quel-la degli artisti americani presenti in questi anni a Parigi,furono il Salon des Indpendants ed il Salon dAutomne,in occasione dei quali M pot vedervi retrospettive divan Gogh e Czanne ed in particolare le opere di Matis-se e dei fauves. Nel 1912 fu decisivo lincontro col com-patriota Morgan Rssel. Attratti entrambi dalle teorie delcolore formulate dal neoimpressionismo, studiarono ed
Storia dellarte Einaudi
-
applicarono i principi scoperti dai fisici Chevreul,Helmholtz e Rood. Nacque cos, lanno seguente, il Sin-cromismo (dal nome di una tela di Russel), il cui pro-gramma, uninterpretazione dinamica e tendenzialmenteastratta del cubismo, venne formulato dai due pittori inoccasione del Neuer Kunstsalon di Monaco nel giugno1913. Nello stesso anno tele sincromiste vennero presen-tate allArmory Show di New York, nonch alla Gall.Bernheim-Jeune di Parigi. Il Sincromismo venne allora de-finito come vagamente orfista da Apollinaire; le espe-rienze di Delaunay avevano infatti influito sullarte diRussel e di M. Nel 1914 questultimo abbandon gli stu-di di figura e natura morta per comporre le prime teleastratte, nelle quali cerchi e porzioni di cerchi colorati so-no disposti scientificamente secondo le leggi dei coloricomplementari, per coppie e triadi armonizzanti: Sin-cromia (1913: Stati Uniti, coll. priv.); Astrazione in baseallo spettro, Disposizione 5 (1914: Des Moines Art Cen-ter, Iowa). Di paternit americana, il Sincromismo otten-ne un certo successo soprattutto negli Stati Uniti, quan-do Frost, tornato dallEuropa, si diede a diffonderne iprincip in occasione della mostra di M alla Carroll Gall.(New York 1914). Tornato a New York nel 1916, Mpartecip alla mostra del Forum allAnderson Gall.; lospazio dei suoi quadri in questo periodo si organizza perpiani sovrapposti, mentre le tonalit impiegate si fannopi trasparenti (Orientale. Sincromia in blu-verde, 1918:New York, Whitney Museum). Ma, come Hartley,OKeeffe e molti altri, abbandon presto lastrattismodavanti alla crisi del modernismo. Ci nonostante nel1953, dopo una carriera oscura interrotta da lunghi viag-gi, torn al Sincromismo (Canto di vittoria, 1955: Los An-geles, coll. priv.); limportante retrospettiva della suaopera, organizzata nel 1956 dal County Museum di LosAngeles, stata accolta col pi vivo entusiasmo. (em).
macedone, scuolaLespressione stata impiegata per la prima volta dal bi-zantinista francese Gabriel Millet per indicare i dipintimacedoni, Jugoslavi e russi prodotti durante lepoca deiPaleologhi. Questi dipinti, sono caratterizzati dalla ricer-ca di plasticit delle forme, dalla vivacit delle notazionirealistiche e dallespressione del movimento. Gli studi re-centi, distinguendo i dipinti della scuola m da quelli di
Storia dellarte Einaudi
-
Costantinopoli, hanno cercato nel contempo di determi-nare i centri vitali di questa scuola. Secondo gli studiosigreci, tali centri furono in primo luogo Tessalonica, ed inmisura minore, il Monte Athos. Da Tessalonica sarebbe-ro venuti i pittori che decorarono le chiese iugoslave. Glistudiosi jugoslavi ed alcuni tedeschi, pur riconoscendo lerassomiglianze tra i dipinti delle chiese greche e quellidelle chiese jugoslave, ritengono che queste ultime costi-tuiscano un gruppo distinto, che designano come scuoladi Milutin, in base al nome del kral sotto il cui regnovenne eseguita la maggior parte di queste pitture. (sdn).
Machaev, Michail Ivanovi(1716-70). Collaboratore di G. Valeriani (1745), prosegularte del suo maestro nel genere del paesaggio urbano. autore di molti disegni ed incisioni di vedute panorami-che di San Pietro-burgo, Mosca e dei palazzi suburbanidegli zar e della nobilt. Gli si attribuiscono anche alcu-ne vedute dipinte della capitale (la Prospettiva Nevski vi-sta da palazzo Anickov, 1750 ca.: Mosca, Gall.Tretjakov). (bl).
Machiavelli, Zanobi di Jacopo di Piero(Firenze 1418 - Pisa 1480). Formatosi forse sotto Filip-po Lippi, collabora probabilmente con Gozzoli, agli af-freschi del Camposanto di Pisa; di certo, nel 1476-77affresca i sopraccieli del transetto dellAnnunziata nelDuomo della citt. Fu operoso soprattutto in lucchesiae nel pisano. Dipinge una Sacra Conversazione per lalta-re maggiore del monastero di Fregonaia (Lucca, MuseoGuinigi), affine a quella, firmata, eseguita per la chiesadi Santa Croce in Fossabranda a Pisa (Pisa, mn di SanMatteo), nellambito dellopera di riedificazione, abbel-limento e risanamento della citt promosso dallarcive-scovo Filippo de Medici (1461-74). Per la medesimachiesa, Zanobi firma e data 1473 una Incoronazione del-la Vergine (Dijon, mba), ove si combinano in modo evi-dente le diverse componenti del suo stile: i rimandi aPesellino e Lippi (per le tipologie e la composizione, peril divagare frequente sui particolari) si intrecciano a re-miniscenze angelicane filtrate e prosciugate dal linguag-gio gozzoliano. Tali i caratteri costanti delle sue opere,che vanno tuttavia accentuando preziosit ed eleganzaquando destinate ad una fruizione privata. Cos , per
Storia dellarte Einaudi
-
esempio, nelle diverse edizioni di una Madonna col Bam-bino, oggi conosciuta nelle versioni e variazioni diFucecchio (mc) , Roma (Gall. Pallavicini), Paris (PetitPalais), New Haven (Yale Univ. Art Gall.). La presen-za, sul bordo del manto della Madonna, di alcuni versitratti dalla Canzone 366 di Petrarca (Fucecchio e Ro-ma), e dal Canto XXXIII del Paradiso dantesco, attestala rarit esemplare di alcune sue invenzioni iconografi-che e tematiche, nellambito ricco e tuttavia poco varia-to, delle Madonne fiorentine del Quattrocento, e pre-suppone il contatto dellartista con una committenzapiuttosto colta e raffinata. Non interessato alla elabora-zione delle strutture spaziali e prospettiche propria amolta pittura del suo tempo, Zanobi sembra volersi con-centrare su pochi, scelti particolari, usati quali sigle per-sonali ed innovative, cos come, nelle sue migliori com-posizioni, su pi meditati accostamenti cromatici e suidettagli. (scas).
Machuca, Pedro(Toledo? Granata 1550). La formazione di M si svolsein Italia, come attesta la sua prima opera firmata e data-ta: la Madonna del Suffragio (Madrid, Prado, provenientedalla coll. Collicola di Spoleto) del 1517, di complessacomposizione stilistica, cui concorrono sia lammirazioneper i grandi modelli di Raffaello e di Michelangelo sia leaffinit con le ricerche romane e fiorentine contempora-nee tra Perino, Rosso e Andrea del Sarto. M , con A.Berruguete, lunico artista non italiano che abbia parteci-pato in prima persona al momento formativo della ma-niera centroitaliana. Alla sua documentata presenza aRoma nel corso del quinquennio 1515-20 collegata lapossibilit di una sua partecipazione alla decorazione del-le Logge, in particolare in quelle scene di pi inquietaconnotazione stilistica, e pi in generale allattivit dellabottega di Raffaello. Tornato in Spagna nel 20, si stabi-lisce a Granata, dove incaricato da Carlo V di eseguireil progetto dellAlhambra. In quellanno dipinge la SacraFamiglia della Santa Croce per la Cappella Reale dellacattedrale di Granata. Nella Pentecoste (Ponce, PuertoRico) e nella Deposizione dalla croce (Madrid, Prado, for-se proveniente dallItalia meridionale, come la pala dellostesso soggetto ora nel mercato antiquario romano) fra iricordi indelebili della esperienza italiana M sembra pri-
Storia dellarte Einaudi
-
vilegiare quelli che, come Polidoro, assecondano la suatendenza ad uno stile espressivo fino al caricato e al pa-tetico. Ancora problematica lattivit tarda di M, chenel 46 si impegna a dipingere un retablo per la cattedra-le di Jan, in gran parte eseguito da collaboratori. La suafama di architetto ha fatto dimenticare per lungo tempolopera pittorica, pur apprezzata dai contemporanei (F.de Holanda) allo stesso livello delle creazioni dei grandimaestri italiani. (acl+sr).
Maciet, Jules(Parigi 1846-1912). Apparteneva ad una agiata famigliastabilitasi a Parigi originaria di Chteau-Thierry. Inizila sua collezione con qualche timido acquisto di stampee di oggetti darte; poi si interess ai maestri minoriolandesi; infine scoprila pittura del xviii sec., non anco-ra apprezzata dai collezionisti. Cominci intorno al1875 ad interessarsi del Museo delle arti decorative diParigi, a quellepoca collocato in unala del palazzo del-lIndustria; da allora gli dedic il proprio tempo e partedella propria fortuna. Fu generosissimo mecenate, eprincipale artefice della trasformazione e dello sviluppodel Museo, poco dopo trasferito nel padiglione di Mar-san: M don oltre 2300 oggetti diversi, mobili, arazzi,sculture, pitture (scuole fiamminga del xvii sec. e fran-cese del xviii sec.). Fra i tanti musei che beneficiaronodelle donazioni di M, va citato il Louvre di Parigi, cheegli arricch di opere rare, delle quali intu assai prestolimportanza. Tra queste da citare la preziosa tavoladel Maestro di Moulins: Anne de Beaujeu presentata dasan Giovanni Evangelista, che raggiunge cos al Louvre latavola corrispondente, Pierre II de Beaujeu presentato dasan Pietro; una Crocifissione con scene della vita di sanGiorgio di un pittore borgognone del xv sec., prove-niente dalla certosa di Champmol (in deposito nel mbadi Digione), e quattro fogli miniati del Libro dore diTorino. Al Museo Carnavalet M don un Ritratto duo-mo di Prudhon e disegni del xvii sec. Non dimentic laprovincia e i musei minori, come quelli di Sens, Gray eChteau-Thierry, luogo di origine della sua famiglia.Particolarmente favorita fu Digione, al cui museo donuna serie di dipinti di varie scuole, in cui dominavano iprimitivi, soprattutto fiamminghi, ma anche italiani(Maestro dellOsservanza) e tedeschi. (gb).
Storia dellarte Einaudi
-
Mack, Heinz(Lollar (Assia) 1931). Si form dal 1950 al 1953 pressolAccademia di Dsseldorf; nel 1956 ottenne la laurea infilosofia allUniversit di Colonia. Dal 1958 esegu i suoiprimi rilievi di cubi luminosi. Co-fondatore del GruppoZero, entrato in contatto con Yves Klein, Tinguely, Fon-tana, nel 1963 dipinge il suo ultimo quadro propriamen-te detto. Nel 1965-66 soggiorn a New York, esponendopresso Howard Wise. Le mostre serali del Gruppo Zero,ebbero luogo nel 1957-58 a Dsseldorf, nel suo studio ein quello di Otto Piene. Con gli amici Piene e GntherUecker, M rifiut il tachisme ed utilizz materiali anoni-mi e di rifiuto per fabbricare i suoi oggetti. Gi nel 1958sviluppa, a Zero 3, il suo Sahara-Projekt, montaggio otti-co in un luogo non ancora trasformato dai contatti con lacivilt, che nel 1968 pot realizzare, quando venne gira-to il suo film Tele-Mack, elaborato in parte al confine delSahara, a nord del Grand Erg orientale. Tale concezione,che pure si differenzia dalla Land Art, consente allarti-sta di superare lambito del museo attraverso una dimen-sione monumentale, che si esprime allaperto. I lavori diM investono numerosi complessi urbani, particolarmentea Leverkusen (Mathildenschule, 1960) e Dinslaken (O.Hahn-Gymnasium 1966), nonch i padiglioni della Ger-mania nelle esposizioni internazionali di Montreal (1967)e di Osaka (1970). (dh).
Macke, August(Meschede 1887 - Perthes (fronte di Champagne) 1914).Trascorse la sua infanzia a Colonia, poi a Bonn; dal 1904al 1906 segu i corsi dellAccademia di belle arti e dellaScuola di arti decorative di Dsseldorf. Soggiorn unaprima volta a Parigi nel 1907; fu poi allievo di Corinth aBerlino, dove incontr Bernard Koehler, zio della sua fu-tura moglie, collezionista interessato alla pittura francese;su suo consiglio torn a Parigi (1908). Di nuovo a Bonndopo un anno di servizio militare (1909), conobbe F.Marc (gennaio 1910), che lo mise in rapporto con Kan-dinsky a Monaco, ed entr nel gruppo di Der Blaue Rei-ter. La visione delle opere di Matisse (esposte a Monaconel 1910) influ sulluso del colore, inteso come compo-nente creativa e come fondamentale mezzo di traduzionedella forma (Tappeto con giacinti, 1910, coll. priv.). LaTempesta (in museo a Saarbrcken), esposta alla prima
Storia dellarte Einaudi
-
manifestazione di Der Blaue Reiter (1911), riflette netta-mente la poetica di Kandinsky; ma tale influsso non duraturo. Per M il problema della fusione tra forma e co-lore di ordine plastico pi che spirituale. Durante le-state del 1912, in compagnia di Marc, incontra a ParigiDelaunay e Le Fauconnier, il cui ricordo avvertibilenelle Bagnanti su sfondo di paesaggio urbano (1913: Mona-co, np). Nel corso degli ultimi due anni della sua vita, Msfrutta la lezione analitica del cubismo, vitalizzata perdal cromatismo luminoso di Delaunay, a vantaggio diunespressione serena, i cui temi favoriti sono quelli deltempo libero in citt, delle passeggiate in riva al lago o lavisita al giardino zoologico, della passante davanti allevetrine (Personaggi con lago azzurro, 1913 alla Staatlischekh di Karlsruhe; Signora con giacca verde, 1913: Colonia,wrm): spesso M ricerca un accordo tra la trasparenza cri-stallina delle superfici e la materialit pesante della forma(Ragazza allacquario, 1914: Wuppertal, Von-der-HeydtMuseum). Nellaprile del 1914, M parte per la Tunisiacon Klee e Moilliet; ne riporta 25 acquerelli, di cui alcu-ni sono da considerarsi tra le sue opere pi belle. Lac-querello lo obbliga ad abbandonare lo schema ancora ana-litico del cubismo, a suggerire rapidamente le forme colmassimo di economia, trattando con disinvoltura laprospettiva e la leggibilit immediata dellimmagine (ilMercante di brocche, in museo a Mnster). Tornato inGermania M non ebbe il tempo di proseguire le sue ri-cerche, che, come attesta lepistolario, avrebbero potutocondurlo molto rapidamente allastrattismo; gli ultimi di-pinti ed acquerelli rappresentano una messa a punto del-le conquiste dei mesi precedenti (la Partenza, Colonia,wrm). La parte originale dellopera di M, elaborata indue anni, una sintesi tra le ricerche francesi ed il liri-smo al quale tendono invece le correnti tedesche, che glipermette di coordinare sensazioni e sentimenti; lo spiritoche emana deve ancora molto al gusto per la rappresen-tazione della vita moderna, caratteristico della fine del-lOttocento e dellinizio del Novecento. Il suo catalogo,compilato da Gustav Vriesen nel 1953 (riedito nel 1957),comprende 548 acquerelli e 550 dipinti. (mas).
Mackintosh, Charles Rennie(Glasgow 1868 - Londra 1928). Architetto, decoratore edisegnatore scozzese, studi presso la Scuola darte di
Storia dellarte Einaudi
-
Glasgow, nel 1889 entr come disegnatore nella dittaHoneyman e Keepie. Partecip a vari concorsi ed otten-ne una borsa di studio che gli consent di visitare, nel1891, lItalia, il Belgio e la Francia, viaggio da cui ri-port numerosi disegni e acquerelli di monumenti (Gla-sgow University, Mackintosh coll.). Ai corsi serali dellaScuola di belle arti di Glasgow ritrov il collega J. Her-bert MacNair. Il direttore della scuola, Newbery, che fe-ce loro conoscere le due sorelle MacDonald (Frances spo-ser NacNair nel 1899, e Margaret sposer M nel 1900),svolse un ruolo importante nella diffusione delle novitdellArt Nouveau attraverso la rivista The Studio, su-perando le tradizioni provinciali di Glasgow, e facendoconoscere in particolare le illustrazioni di Beardsley e diC. Schwabe, le Tre fidanzate di Toorop (oggi a Otterlo,Krller-Mller). M sinteress anche, come mostrano isuoi quaderni di schizzi, allo studio delle piante e dellin-terpretazione simbolica della crescita vegetale. Il suo ac-querello pi sorprendente, che combina simbolismo e fan-tasia, Cavoli in un orto (1894: Glasgow, School of Art).M il maggior rappresentante del gruppo dei Quattroche seppe creare, a Glasgow uninterpretazione dellArtNouveau che combinava armoniosamente linearismoespressivo e razionalit della struttura. Le opere di pro-gettazione architettonica maggiori di M a Glasgow sonoin particolare lIstituto darte di Glasgow, 1897-1909, ela Sala da t di Mrs Cranston a Glasgow, del 1897. Ti-piche della sua arte decorativa, di estrema sensibilit, so-no le minute figure femminili, unite a fiori stilizzati e adintrecci in cui affiorano reminiscenze celtiche, e la predi-lezione per le tonalit tenui: avorio, verde oliva, rosa; es-se si ritrovano negli arredi, nelle illustrazioni di libri onei manifesti. I Quattro vennero rapidamente apprezzatiin Europa, esponendo con grande successo a Vienna nel1900 su invito della Secessione, poi a Torino nel 1902.Nel 1914 M lasci Glasgow per Londra, disegn qualchemodello di tessuti e produsse soprattutto paesaggi ad ac-querello, in particolare durante il lungo soggiorno a Port-Vendres dal 1923 al 1927. (gl).
Maclise, Daniel(Cork 1806 - Londra 1870). Di origine scozzese, si formal Cork Institute, che possedeva una collezione di calchida sculture antiche. Inizi la carriera di pittore a Cork
Storia dellarte Einaudi
-
eseguendo ritratti a matita; un suo piccolo schizzo attirlattenzione di Sir Walter Scott, nel corso di un soggior-no dello scrittore a Cork nel 1825. In seguito ebbe lapossibilit di recarsi a Londra, dove entr alla Royal Aca-demy nel 1828. Continu lattivit di ritrattista nella ca-pitale; il suo ritratto di Charles Dickens (Londra, npg)venne esposto alla Royal Academy nel 1840. In questianni inizi ad interessarsi alla pittura narrativa, sceglien-do soggetti tratti dalla letteratura, dalla vita contempora-nea, dalla storia e dalla leggenda. Nel 1844 fu tra i sei ar-tisti chiamati a decorare il Parlamento di Westminster:complet nel 1859 lIncontro tra Wellington e Blcher, ela Morte di Nelson nel 1864. Lopera di M caratterizza-ta in gran parte da soggetti eccessivamente letterari e dacomposizioni sovraccariche sorrette da un disegno acca-demico ed accurato e da una pittura rifinita che non tra-lascia alcun dettaglio descrittivo. Alcuni suoi dipinti han-no un certo vigore e calore comunicativo; ma in altri (leNozze di Aoife e di Strongbow. Dublino, ng) la composi-zione greve e la profusione dei dettagli prevalgono sul ta-lento. (js).
Macrino DAlba, Giovanni Giacomo De Alladiodetto(Alba? attivo in Piemonte tra il 1495 e il 1513). La suaformazione stata messa in rapporto con un viaggio inItalia centrale, tuttavia del tutto ipotetico, cui risalireb-bero apporti classicisti di radice toscana, umbra e ro-mana, ma innanzi tutto egli conobbe lambiente braman-tesco fra Milano e Pavia. Il trittico con la Madonna, quat-tro santi e due donatori datato 1495 gi al Memorial Halldi Philadelphia, acquistato nel 1957 dal mc di Torino, siimpone per le forti qualit ritrattistiche che poi ritorna-no nei Santi del polittico per la certosa di Pavia nel 1496e nel 1498 nella pala con la Madonna in gloria e santi perla certosa di Asti ora nella Galleria Sabauda, cos comenel Ritratto di un Cavaliere di Malta, New York, coll.Morgan, del 1499. Il Trittico del 1499 gi a Lucedio eora nel vescovado di Tortona, la Madonna, due santi e duedonatori, del 1501, la pala nel Municipio di Alba, le altrepale della Pinacoteca Capitolina a Roma (Madonna e duesanti) e del santuario di Crea presso Alessandria (Madon-na e quattro santi) del 1503, la Nativit e quattro santi,New York, Historical Society del 1505, una Nativit del
Storia dellarte Einaudi
-
1508 a San Giovanni ad Alba, Il Matrimonio mistico disanta Caterina e cinque santi a Neviglie (Cuneo) bergogno-nesca, rispecchiano lintelligente evoluzione del pittore insenso rinascimentale. (ag + sr).
MadabaNel 1844 in questa antica citt del paese di Moab (oggiGiordania), che fece parte dellArabia romana, venne ri-trovato in una chiesa della seconda met del vi sec., un mosaico di 227 m (distrutto in parte nel 1896). Nelmosaico rappresentata una carta geografica della TerraSanta al cui centro posta Gerusalemme. (mfb).
Madarsz, Viktor(Csetnek 1830 - Budapest 1917). Obbligato ad emigraredopo la sconfitta nella guerra dindipendenza, cui avevapartecipato (1848-49), studi pittura a Vienna ed a Parigi.Ader al romanticismo storico trovando motivi dispira-zione nella denuncia delloppressione asburgica in Unghe-ria. Lszl Hunyadi pianto dalla madre e dalla fidanzata(1859, Budapest, gn), Zrinyi e Frangepn nella cella dei con-dannati a morte (1864: ivi.) riscossero successo ai salons egli valsero lelogio di Thophile Gautier. Dopo il compro-messo austro-ungarico M torn nel suo paese; ma la situa-zione politica era mutata e la sua pittura dimpronta ro-mantica non riscosse consensi presso il pubblico orientatoverso il virtuosismo tecnico della pittura accademica. (dp).
MaderueloIl piccolo eremitaggio della Vera-Cruz de M in Spagna(provincia di Segovia) presenta un impianto a sala rettan-golare, voltata a tutto sesto costituita da una navata uni-ca e coro. Le pareti erano coperte di affreschi, oggi alPrado di Madrid. Il tema, assai diffuso in Spagna in epo-ca romanica, del Pantocrator cinto dal tetramorfo, occupail colmo della volta a botte, mentre la corte celeste si svi-luppa su ciascun lato in due zone parallele: gli angeli tra cui i famosi arcangeli portatori delle scritte Postula-cius e Peticius, presenti in certe absidi catalane e al-cuni santi costituiscono il registro inferiore; una serie conApostoli sopra di essi. La lunetta orientale rappresentalAdorazione dellagnello da parte degli angeli: il simbolodivino collocato in un medaglione, al centro duna cro-
Storia dellarte Einaudi
-
ce gemmata, tra lOfferta di Caino e quella di Abele. Ipannelli in basso, rappresentano lAdorazione dei Magi eMaddalena che unge i piedi di Cristo. Verso ovest, sopralarco trionfale, si trova la Creazione di Adamo ed il pec-cato originale. Il complesso di tecnica assai semplice.Tuttavia la povert del colore terre, bianco e nerofumo compensata dallimpiego di toni composti, per esem-pio un rosa. Le convenzioni stilistiche che guidano le pie-ghe e i drappeggi, la semplificazione dei tratti dei volti,la schematizzazione delle architetture, accostano gli af-freschi di M ad alcuni degli affreschi di San Baudilio deBerlanga presso Soria, e di Santa Maria di Tabuli. Lamaggior parte degli studiosi attribuisce queste diverseopere a un unico maestro, discepolo del Maestro di Ta-buli, che decor il coro di San Clemente e unabsidioladella cattedrale di Roda. (jg).
MadhuAttivo sotto il regno dellimperatore moghul Akbar(1556-1605) questo pittore indiano citato da Abl Fazl,nel suo Aini-Akbari, tra le figure dominanti del laborato-rio imperiale. Partecip alla decorazione dei grandi ma-noscritti dellepoca di Akbar ed acquist grande fama co-me ritrattista. Il suo Sagi jain (Benares, Bharat Kala Bha-van), in veste bianca su fondo verde unito, annuncia, perla finezza del disegno e lo sforzo di caratterizzazione delvolto, larte del ritratto del xvii sec. (jfj].
Madou, Jean-Baptiste(Bruxelles 1796-1877). Si form presso lAccademia diBruxelles; dal 1818 al 1820 fu addetto ai servizi topo-grafici dellesercito. Come disegnatore litografo M svolseun ruolo importante in Belgio nella diffusione della lito-grafia, con diverse serie ispirate allepoca contemporanea(Costumi del Belgio, 1830; Bruxelles e Dintorni di Bruxel-les) che ebbero grande successo. Professore di disegno al-la Scuola militare, nel 1850 venne nominato professore acorte. Dipinse soltanto dal 1840 in poi, realizzando so-prattutto piccole scene di genere, nelle quali presenteuna ripresa dello spirito decorativo del xviii sec. (la Festaal castello, 1851: Bruxelles, mrba; il Guastafeste, 1854:ivi; i Politicanti di paese, 1874: ivi). Gli si debbono anchealcuni ritratti e affreschi per la residenza reale di Cier-gnon (1874). (mas).
Storia dellarte Einaudi
-
MadrazoDinastia di pittori spagnoli che copre lintero xix sec. eche svolse un ruolo fondamentale nella storia della pittu-ra spagnola e dei suoi rapporti con lEuropa. I suoi dueprotagonisti, il fondatore Jos e Federico, suo figliomaggiore, che dominarono larte ufficiale, quanto menocome ritrattisti, hanno lasciato un corpus di opere note-vole e spesso di alta qualit.Jos (Santander 1781 - Madrid 1859) ebbe come maestroa Madrid Gregorio Ferro. Un ritratto di Godoy gli valsenel 1803 una pensione reale a Parigi. Allievo di Daviddal 1802 al 1806, che ne lod il quadro Ges dinanzi algran sacerdote, fu condiscepolo di Ingres, di cui divenneamico. Stabilitesi poi a Roma con una borsa di studio, vidimor per quindici anni; quando Napoleone invase laSpagna, rifiut di riconoscere Giuseppe Bonaparte e re-st pintor de Camara nella corte fantasma del re de-posto. Lasci Roma solo dopo la morte di Carlo IV; nelfrattempo aveva sposato Isabelle Kuntz, figlia di un pit-tore tedesco e di una romana. Tornato a Madrid nel1819 la sua fedelt gli garant una situazione privilegiataa corte dopo la restaurazione. Svolse un ruolo decisivo,dal 1823, nella riorganizzazione dellinsegnamento dellebelle arti da parte dellAccademia, su modello francese, enello sviluppo del nuovo Museo del Prado: fond un la-boratorio litografico e diresse il Museo dal 1838 al 1857.Fu pure amatore e collezionista: la sua collezione, il cuicatalogo pubblicato nel 1856 menzionava 650 dipinti perla maggior parte spagnoli, era considerata la pi notevoledi Madrid. Alla sua morte le opere principali, acquistatedal marchese di Salamanca, ne condivisero le vicissitudi-ni, ma alcuni dipinti furono venduti direttamente adamatori stranieri: cosi i Goya (tra cui lAutoritratto), chevennero acquistati dal conte de Chaudordy, ambasciatorefrancese, e da lui lasciati al Museo di Agen.Come pittore M introdusse in Spagna il neoclassicismodavidiano, riprendendone fedelmente i modelli per quan-to riguarda la gerarchia dei generi ed il culto dellanti-chit, ma stemperando il rigore del colore: lartista nonaveva mai rinnegato la tradizione spagnola di Velzquez.Tuttavia i suoi quadri di storia, relativamente poco nu-merosi (Greci e Troiani si disputano il corpo di Patroclo,1812: Roma, Quirinale; la Morte di Viriato, 1808: Ma-drid, Prado, nelledificio annesso del Casn, tratta da
Storia dellarte Einaudi
-
unincisione dal Dolore di Andromaca di G. Hamilton),sono freddi e compassati, e i poeti romantici irrisero que-sto Viriato, morto cosi tranquillo. Jos, disegnatore ec-cellente e compositore rigoroso, fu ritrattista di grandestile, come dimostrano i ritratti di rappresentanza (Cardi-nal Gardoqui, 1817: in museo a Bilbao; Manuel Garcia dela Prada, 1827: Madrid, Academia de San Fernando) e leopere pi semplici (Autoritratto: Madrid, Prado, nelle-dificio annesso del Casn; Federico de Madra-zo, 1833:New York, Hispanic Society; il Conte de Vilches: Madrid,Prado, Gasn). La carriera del figlio Federico (Roma 1815 -Madrid1894) fu tanto precoce quanto lunga. Formato dal padre,ricevette nel contempo dal poeta Lista una cultura uma-nistica non comune, Federico dipinse a quattordici anniil suo primo quadro di storia ed ottenne a diciassette an-ni un lusinghiero successo su un tema di attualit (la Re-gina Maria Cristina mentre cura Ferdinando VII) e a diciot-to divenne accademico, eletto allunanimit per la suaClemenza di Scipione (1839). Un primo viaggio a Pariginel 1833 gli procur lamicizia di Ingres e del baroneTaylor, di cui fece eccellenti ritratti (New York, Hispa-nic Society; Versailles). Quando vi torn per un pi lun-go soggiorno (1837-39) la loro protezione gli valse lac-cesso al salon ed un incarico reale per Versailles (Goffre-do di Buglione, re di Gerusalemme, Sala delle crociate,quadro abilmente composto nello stile di Delaroche). Poiin due anni trascorsi a Roma (1840-42) fu in relazionecoi Nazareni tedeschi; il loro influsso avvertibile nelleTre Marie al sepolcro (Madrid, Palazzo reale), lodato daOverbeck e da Ingres. Ma, tornato a Madrid, Federicoabbandon la pittura di storia dedicandosi al ritratto ecollezionando nel contempo incarichi ed onori ufficiali.La sua opera, assai pi copiosa di quella del padre, com-prende oltre seicento ritratti. Egli raffigur, influenzatoda Ingres, la corte (Isabella II, Alfonso XII), laristocra-zia (Duca de San Miguel, Marchese de Montelo, Contessa deVilches, raffigurando Eduardo Rosols, Carolina Corona-do, al Gasn del Prado), e prosegu la tradizione del ri-tratto psicologico spagnolo raffigurando il mondo dellelettere, delle arti e del teatro (Larra: Madrid, Museoromntico; Ventura de la Vega: ivi; la Avellaneda: Madrid,Museo Lzaro Galdiano; Eduardo Rosols, Carolina Coro-nado: Madrid, Prado, Casn), nei suoi aspetti convenzio-nali, le mode che si succedono, le uniformi e i gioielli.
Storia dellarte Einaudi
-
Federico, come il padre, fu pi disegnatore che colorista,ma alcune figure, soprattutto busti femminili (CarolinaCoronado, Sofia Vela: Madrid, Prado, Casn) hanno unfascino pensoso in cui sopravvive un accento romantico.I ritratti a matita costituiscono la parte della sua operapi ingresiana, e forse la pi libera e preziosa. Due fra-telli minori di Federico hanno importanza nella storia ar-tistica del xix sec.: Pedro (Roma 1816 Madrid 1898),buon disegnatore e ugualmente dotato per le lettere, lamusica, la matematica, fu co-fondatore nel 1833 (con loscrittore Ochoa) di El artista, rivista illustrata ad imi-tazione de lArtiste parigino, che nella sua breve vitaraccolse un brillante gruppo di giovani scrittori e di arti-sti romantici. In seguito, alto funzionario, accademico,autore di pubblicazioni importanti sullarte spagnola(Espaa artistica y monumental) si dedic allo studio deiquadri del Prado (di cui pubblic nel 1872 un Catalogohistorico-descriptivo: escuelas italianas y espaolas, primocatalogo critico tuttora basilare) e in generale delle colle-zioni reali di Spagna (Viaje artistico de tres siglos por lascolecciones de cuadros de los reyes de Espaa, 1884). Il pi giovane dei tre M, Luis (Madrid 1825-1897), chesi rese noto nel 1848 con un Tobia che rende la vista alpadre, fu pittore di soggetti religiosi e storici e docenteapprezzato. I figli di Federico proseguirono la tradizione di famiglia;il primo Raimondo de M y Garrer (Roma 1841 - Ver-sailles 1920), il secondo Ricardo de M (1831-1917). Essisubirono linfluenza del pittore Mariano Fortuny, che neaveva sposato la sorella Cecilia. Ritrattisti, pittori di ge-nere e di nudo, la loro carriera si svilupp quasi intera-mente fuori di Spagna, in Italia e soprattutto a Parigi (diRaimondo si ricordano: Duchessa dAlba, 1881: Madrid,coll. dAlba; Alluscita della messa: Baltimore, wag). (pg).
MadridFatta capitale della Spagna da Filippo II, nel 1561, lapiccola citt di M divenne un centro artistico durante gliultimi anni del xvi sec., grazie ad artisti toledani e ad ungruppo di pittori di corte che lavoravano alla decorazionedel Palazzo Reale lAlczar e dellEscoriai. La pre-senza degli italiani attivi nel monastero e rimasti in Spa-gna domin la produzione pittorica nel primo quarto delxvii secolo.
Storia dellarte Einaudi
-
La fondazione di nuovi conventi, attratti dalla vicinanzadella corte, forn abbondante lavoro ad artisti come Car-ducho, Cajs, Castello, Nardi, e a qualche altro (Maino,Nuez, Lanchares, van der Hamen), che, come loro, rup-pero col manierismo romano concedendo un posto sem-pre maggiore agli elementi naturalisti e barocchi, con lacomparsa ancora timida dei contrasti chiaroscurali. Que-sti stessi artisti, con qualche ritrattista di tradizione cor-tigiana (Gonzles, Villandrando, Vidal) operano per il Pa-lazzo Reale e le dimore aristocratiche: la clientela bor-ghese ebbe assai poco peso nelle commissioni.Velzquez giunse a M nel 1623. Qui assimil pi profon-damente le lezioni dei veneziani e dei fiamminghi, di cuipot studiare i capolavori nelle collezioni reali. Il suo in-flusso, bench quasi non si avverta fuori della corte, riscontrabile in qualche artista della generazione pre-cedente, come Jos Leonardo o Bartolom Roman, ri-spettivamente allievi di Caxs e di Carducho, e special-mente in tutti i ritrattisti che in seguito operarono a M.I due principali cantieri furono lAlczar di cui FilippoIV fece rimodernare le parti principali sotto la direzionedi Velzquez e il palazzo del Buen Retiro, costruito apartire dal 1632 (Salone delle Battaglie, con dipinti diVelzquez, Maino, Zurbarn, Carducho, Pereda). La col-lezione reale di pittura che conteneva fiamminghi e ita-liani del xvi e xvii sec., fu una vera scuola per gli artisti. La scuola di M acquist importanza nella seconda metdel secolo, grazie a un cenacolo di artisti di origine assaidiversa. Generalmente ben dotati, questi pittori sispira-rono soprattutto ai maestri veneziani; ne adottarono laricchezza cromatica e la tecnica nervosa e suggestiva. Sitratta soprattutto di pittori di pale daltare, di grandicomposizioni religiose spesso ispirate dalle incisioni fiam-minghe della scuola di Rubens, assai diffuse in Spagna; visi pu scorgere anche un riflesso delle serie che lo stes-so Rubens aveva direttamente inviato alla corte spagnola.In numero minore, si possono menzionare gli artisti chesi specializzarono nel paesaggio (Collantes, Ximeno) oche preferirono il bodegon (Ramirez, J. B. Espinosa, Pon-ce), i fiori (Arellano) o il ritratto. Tra i pi anziani, del-la generazione di Velzquez, vanno citati in primo luogoPereda, assai vicino allarte veneziana, Juan Rizi, A.Arias, di tendenze molto classiche, ed anche Camilo eFrancisco Rizi, il cui stile barocco, pi pomposo, annun-cia quello degli artisti della fine del secolo. Questultima
Storia dellarte Einaudi
-
generazione, pi omogenea stilisticamente e qualitativa-mente, composta di artisti che, almeno come coloristi,furono tra i migliori dEuropa. Considerati madrileni,provenivano per da tutta la Spagna. Accanto a madrile-ni autentici come Antoliez o Coello, sincontrano astu-riani come Carreo de Miranda, castigliani del nord co-me Cerezo di Burgos, andalusi come Herrera il Giovane,Escalante o Alfaro. Alcuni sono persino di origine stra-niera, come i fiamminghi A. Smit o Antonio van de Pe-re. Il loro stile, decorativo, dinamico ed esuberante, allamaniera fiamminga, ma coloristicamente raffinato su unagamma chiara e fresca, si diffuse tanto nei grandi quadridaltare che nellaffresco, mediante audaci effetti diquadratura, procedimento italiano introdotto dai bolo-gnesi Mitelli e Colonna, che Velzquez aveva condotto aM per la decorazione ad affresco di palazzi e dellEsco-rial. Principali maestri ne furono Francisco Rizi, ClaudioCoello, Jimnez Donoso, F. Solis, Herrera il Giovane.Sfortunatamente conserviamo troppo scarse opere di que-sto tipo (M, cupola di SantAntonio dei Portoghesi). Ladecorazione murale e la produzione di dipinti daltare sa-ranno ancora le principali attivit del cordovano Palomi-no, che appartiene gi alla cultura del xvin sec. per la suaammirazione per Luca Giordano, giunto in Spagna nel1692. (aeps).Dal xviii sec., lattivit dei pittori madrileni si fuse nellacorrente generale della pittura spagnola. In seguito alladistruzione dellAlcazar nel 1734 dovuta ad un incendio,la costruzione dellattuale palazzo, caus la chiamata deigrandi frescanti italiani, Giaquinto, Tiepolo e larrivo delneoclassicismo con Mengs.La pittura madrilena, meno danneggiata dai saccheggidella guerra napoleonica di quella sivigliana, sofferse perlincamerazione dei beni ecclesiastici nel 1835: il MuseoNacional, che aveva riunito a M i quadri raccolti nelleprovince centrali del regno, venne sciolto nel 1872; i suoifondi passarono al Prado solo in piccola misura, e furonoassurdamente dispersi in musei ed edifici pubblici in tut-ta la Spagna. Daltro canto la guerra civile distrusse granparte della pittura madrilena, per lincendio di interni dichiese ricche di opere importanti (la cattedrale di San Isi-dro el Real, antica chiesa dei Gesuiti; il convento di San-ta Isabel, ove, in particolare, scomparve una delle pibelle Immacolate di Ribera; la cappella di San Isidro). Re-stano peraltro testimonianze, troppo poco note, della
Storia dellarte Einaudi
-
scuola di M, oltre ai musei ove essa ben rappresentata(Prado, Academia de San Fernando, Musei Cerralbo, L-zaro Galdiano, delle Descalzas e dellEncarnacin).Numerose chiese parrocchiali e conventi (San Jernimo elReal, i Carboneras, il Carmen, San Justo y Pastor) dnnopreziosi contributi alla sua conoscenza, e soprattutto al-cuni complessi rimasti intatti ricordano tuttora la M de-gli Asburgo: Mercedarias de Don Juan de Alarcon (con leopere del capitano Juan de Toledo e di Montero deRojas), Benedettine di San Placido (con la grandiosa An-nunciazione di Claudio Coello e le sue visioni monastichesugli altari secondari), cappella del terzo ordine france-scano (opere di Cabezalaro). Infine, la chiesa a pianta el-littica di San Antonio de los Alemanes, interamente de-corata di affreschi da Carreo e F. Rizi, costituisce uncaso piuttosto eccezionale nella M del xvii sec. Non sideve peraltro dimenticare che durante il xviii sec. la mo-narchia borbonica rinnov, decorandole a fresco, nume-rose chiese madrilene, e fond un grande monastero divisitandine, le Salesas Reales della regina Barbara diBraganza, ove tra i marmi colorati si raggruppano, intor-no alla brillante Visitazione di Corrado Giaquinto, grandiquadri italiani e francesi. soprattutto, Goya ha lasciato in alcune chiese madrile-ne neoclassiche oltre alla Predicazione di san Bernardinoin San Francisco el Grande, che fu il suo primo successoufficiale nel 1784 i suoi capolavori decorativi e religio-si: il primo in San Antonio de la Florida, con gli affre-schi (1798-99) che ambientano un miracolo di santAnto-nio in una scena di vita popolare; il secondo a SantAn-tonio Abate: lUltima comunione di san Giuseppe Calasan-zio, opera del suo ultimo periodo (1819), che lillumina-zione rembrandtiana rende incisivamente espressiva. (pg).Museo dellAccademia di San Fernando Fondata nel1752, lAcademia de San Fernando si stabil nel 1774 nelpalazzo che occupa tuttora, in calle Alcal, dopo che lar-chitetto Diego de Villanueva ebbe rimaneggiato in stilesevero un edificio concepito secondo il gusto chur-rigueresco che dominava allinizio del secolo. LAcade-mia possiede circa ottocento dipinti e oltre tremila dise-gni. Il museo deve la variet delle sue raccolte a molte-plici donazioni, e soprattutto al fatto di essersi arricchitodei quadri gi appartenuti ai Gesuiti, dopo la loro espul-sione dalla Spagna da parte di Carlo III, ed a Godoy,quando la collezione del ministro caduto nel 1808 fu po-
Storia dellarte Einaudi
-
sta sotto sequestro. Da notare due patetici Morales (EcceHomo, Piet], un mirabile complesso di Zurbarn (cinqueDottori della Misericordia, Visione del santo gesuita AlonsoRodriguez), numerosi Ribera (Ascensione della Maddalena,1636), due Murillo giovanili provenienti dal conventofrancescano di Siviglia (lEstasi di san Francesco, lE-lemosina di san Diego dAlcal), due quadri che sono tra ipi rappresentativi della scuola castigliana del xvii sec.(lUltima messa di san Benedetto di F. Juan Rizi e il Sognodella vita di Pereda), e ottime opere di B. Gonzlez, Ca-no, Carreo.Goya trionfa con ritratti ufficiali (la Tirana, celebre attri-ce madrilea), ritratti privati di scrittori (Moratin), artisti(Villanueva), amici (Muarriz) e con due autoritratti; an-che rappresentato da piccole scene tra il reale ed il fanta-stico (la Sepoltura della sardina, la Casa dei pazzi, prove-nienti dalla donazione Garcia de la Prada nel 1839). Ilxviii sec. internazionale dei Borboni e il xix sec. accade-mico sono rappresentati da numerose opere, accanto aglispagnoli (Gonzalez Ruiz, Andrs de la Calleja, Maella) fi-gurano numerosi stranieri: Mengs, Baioni, i francesi Ra-ne, L. M. van Loo, primo direttore dellAccademia, LaTraverse, Fragonard (bozzetto del Sacrificio di Callirol).Quanto ai disegni, predominano gli italiani, manieristi ebarocchi (Pontormo, Barocci, Pietro da Cortona, Marat-ta, mille disegni del quale vennero portati da AndreaProcaccini, pittore di Filippo V; Tiepolo), gli spagnoli so-no rappresentati forse meglio che in ogni altro museo(Berruguete, Luis Tristan, Carducho, importanti gruppidi Cano, Carreo, Antonio del Castillo; il mirabile Cardi-nal Bargia attribuito a Velzquez).Museo Cerralbo Il marchese de Cerralbo (Madrid 1845-1922), gran signore carlista e personaggio poliedrico (fuuno degli iniziatori degli studi preistorici in Spagna e di-resse numerosi scavi in Castiglia), raccolse una collezionedi pittura assai varia in un palazzo arredato secondo ilgusto del 1880. Lo Stato, erede delledificio e delle col-lezioni pot in seguito acquistare un terreno limitrofo,che consenti ampliamenti e rimaneggiamenti. Il museo dalargo spazio a pittori stranieri, con quadri e disegni: Tin-toretto, Palma il Giovane, van Dyck, Boucher, HubertRobert. Ma il posto preponderante assegnato alla pittu-ra spagnola del secolo doro. Vi si trova la maggior partedei maestri valenzani e castigliani: Ribalta, Ribera, Tri-stan, Orrente, Camilo, Cano, Pereda (Apparizione del ri-
Storia dellarte Einaudi
-
tratto di san Domenico al monaco di Soriano), Antoliez(Martirio di san Sebastiano) appaiono con grandi dipintimolto significativi. I due capolavori di El Greco (SanFrancesco riceve le stimmate) e di Zurbarn (la pi belladelle sue Immacolate Concezioni) sono le opere pi im-portanti che il museo conserva.Museo de las Descalzas Reales Nel 1559, allinizio delregno di Filippo II, linfanta Juana, sua sorella, fond unmonastero di Francescane Scalze, ove si ritir e dove inseguito presero i voti molte principesse della famiglia rea-le. Posto in pieno centro di M, in un palazzo antico tra-sformato da J. B. de Toledo, architetto dellEscorial, ilconvento si arricch costantemente di opere darte offer-te dai sovrani. Dopo il 1906 fu aperto al pubblico, in al-cune ore della giornata, e vi fu allestito un museo. Lin-teresse principale delle Descalzas di immergere il visita-tore, a qualche centinaio di metri dalla Puerta del Sol edalla Gran Via, nel mondo ascetico e devoto caro agliAsburgo. Il grande scalone, la cui sontuosit contrastacon la modestia degli edifici conventuali, venne rivestitodi stucchi e dipinto a fresco sotto Carlo II (1684), pro-babilmente da allievi degli italiani Colonna e Mitelli, fat-ti venire da Velzquez; Claudio Coello, cui talvolta si attribuita parte della decorazione, pot forse operarvi. Ilciclo dei Sette Arcangeli, riflesso di un culto molto popo-lare nella Spagna del tempo, e i dipinti illusionistici chepresentano la famiglia di Filippo IV inginocchiata dietroun grande balcone, formano un impressionante complessobarocco, unico nellantica M. Al piano superiore, una se-rie di cappelle (dellImmacolata, di Guadalupe, degli An-geli, dellEcce Homo, del Miracolo) aperte sulle galleriedel chiostro, serbano intatto larredo di piccoli altari, sta-tue policrome, dipinti devoti, talvolta inseriti tra vetri. Ilmuseo propriamente detto raccoglie una notevole serie diritratti reali, tra cui quello, particolarmente evocativo,delle Piccole Infante, figlie di Filippo II di Snchez Coello,nonch un buon complesso di dipinti italiani (si segnalauna Santa Margherita di Cecco da Caravaggio) e fiammin-ghi del xv e xvi sec. Rubens rappresentato da un gran-de San Francesco e dagli arazzi del Trionfo dellEucaristiache Filippo IV gli ordin per il monastero, i cui bozzettisono al Prado. Museo de la Encarnacin Nel 1965 il suc-cesso del Museo delle Descalzas indusse il Patrimonio delEstado ad aprire al pubblico un altro monastero reale, unpo pi recente, quello che Filippo III e la regina Mar-
Storia dellarte Einaudi
-
gherita avevano fondato nel 1601 col titolo dellIncarna-zione. Le Agostiniane Scalze occuparono il convento, co-struito da Francisco de Mora, vicinissimo allAlczar, cuilo collegava una galleria oggi scomparsa. I dipinti che or-nano la chiesa, il chiostro e gli edifici conventuali costi-tuiscono un insieme omogeneo, assai caratteristico del-lepoca, nella quale il manierismo evolve verso il tenebri-smo. La transizione manifesta nelle opere di Carducho(Annunciazione, San Filippo e Santa Margherita, nella chie-sa), di Bartolom Gonzlez, di van der Hamen, speciali-sta in bodegones, che qui si rivela buon pittore religioso(San Giovanni Battista). Uno dei migliori esempi dello sti-le largo e veemente della generazione successiva nellasagrestia: la grande Parabola delle nozze di BartolomRomn. Museo Lzaro Galdiano II fondatore del museo, don Jo-s Lzaro Galdiano (1862-1947), fu grande collezionista.Autodidatta, di carattere indipendente, divenuto ban-chiere, costru unimmensa fortuna. Nel 1899 fond LaEspaa moderna, rivista che diresse personalmente perparecchi anni; accumul quadri, disegni, oggetti darte,libri con insaziabile passione: ne conservava a Parigi e aLondra quasi altrettanti che a M. Morto senza eredi, la-sci tutta la sua fortuna allo Stato spagnolo (si tratta del-la fondazione Lzaro che pubblica la rivista darteGoya). La totalit delle sue collezioni venne in seguitoraggruppata a M nel Parque Florido, grande casa che eglisi era fatta costruire al limite della M residenziale: unnuovo edificio, affacciato sul giardino, consenti di com-pletare linstallazione del museo. Le collezioni compren-dono una sezione di primitivi spagnoli: valenzani (Mae-stro dei Perea, San Lazzaro tra Marta e Maria), aragonesi(Maestro di Lanuza, Vergine di Mosen Sperandeo, 1439),castigliani (Maestro di vila, Trittico della Nativit; Bar-tolom de Castro, San Domenico), andalusi (trittico diJuan Hispalense detto Juan de Sevilla).Sono poi da notare i ritratti di corte del xvi sec. (A.Mor, Snchez Coello) e soprattutto i dipinti del secolodoro, dovuti non soltanto a grandi nomi come Murillo,Herrera il Vecchio (San Giuseppe e il Bambino Ges,1648), Carreo, Claudio Coello (Comunione di santa Te-resa), ma anche di artisti secondari come Antoliez(Immacolata Concezione) o Solis. Goya rappresentato danumerosi ritratti, schizzi di modelli per arazzi, scene digenere (Scene di stregoneria). accompagnato dai suoi
Storia dellarte Einaudi
-
precursori (Paret, il Magazzino di moda) e dai continuato-ri della sua vena romantica e fantastica: Alenza e so-prattutto i Lucas. Lzaro, che aveva recuperato numerosiquadri dei due Lucas, padre e figlio, ne organizz a Pari-gi la prima mostra. Infine, senza sottovalutare linteressedei rari italiani (San Giovanni attribuito a Leonardo) edei numerosi fiamminghi e olandesi, si nota il carattereeccezionale del gruppo inglese. Lzaro infatti aveva rac-colto una decina di ritratti di Reynolds (Lady Sanders,1757), Romney (la Vedova), Gainsborough, Lawrence,Etty, e quattro paesaggi di Constable, che costituisconoun complesso unico in Spagna.Museo municipal Dedicato alla storia della capitale, maricco di opere darte, possiede preziosi dipinti di generedel xvii sec. (Paret, Manuel de la Cruz) ed una serie dimodelli per la Manifattura reale degli arazzi (Bayeu, Josdel Castillo), scene popolari simili a quelle dei cartonidi Goya al Prado, e talvolta ad essi paragonabili.Quanto al Museo dArte contemporanea, distaccato nel1962 dal Museo darte moderna ed arricchito di operenegli anni successivi, esso offre oggi unimmagine abba-stanza completa della pittura del xx sec., principalmentespagnola. stato inaugurato nel 1977 nella citt univer-sitaria. Le esposizioni di arte contemporanea si tengonodal 1986 nelledificio del Centro de Arte Reina Sofia, an-tico Ospedale Generale di M costruito sulla Glorieta deAtocha.Museo del Palacio real Le sale del Palazzo reale, rico-struito dagli italiani Juvara e Sacchetti dopo lincendiodel vecchio Alczar nel 1734, costituiscono in se stessiun museo di pittura decorativa italiana e spagnola.Raphael Mengs e i suoi seguaci spagnoli Antonio Gon-zlez Velzquez, Francisco Bayeu, Maella, Vicente Lpezne hanno abbellito i soffitti di composizioni storiche e al-legoriche. Un capolavoro di fantasia poetica limmensosoffitto della Sala del trono, opera di G. B. Tiepolo allavigilia della morte, col Trionfo della monarchia spagnolache raggruppa i continenti ed i popoli dellImpero. Van-no aggiunti i mirabili ritratti di Carlo IV e di Maria Lui-sa di Goya, che occupano il posto donore in una dellesale. Inoltre, dal 1962, una scelta dei migliori dipinti cheornavano gli antichi palazzi reali stata concentrata negliappartamenti della regina Maria Cristina. Un gruppo diprimitivi fiamminghi (Bosch, Patinir) rammenta la predi-lezione dei sovrani spagnoli per le scuole nordiche; tra le
Storia dellarte Einaudi
-
opere principali il Polittico della regina cattolica (o alme-no i quindici suoi pannelli rimasti in Spagna), scene del-la vita di Cristo eseguite per Isabella dal suo pittore Juande Flandes. Il San Paolo di El Greco, la Salom di Cara-vag-gio, il grande Cavallo bianco ritrovato nelle soffittedel palazzo e attribuito a Velzquez sono opere stupenderimaste a lungo ignorate. Tuttavia il posto donore te-nuto dal xviii sec., con due piccole tele di Watteau, pia-cevoli dipinti di Houasse (Vedute delle residenze reali), Pa-ret (Vedute di porti spagnoli) e Lorenzo Tiepolo, figlio mi-nore del maestro veneziano, che mor prematuramente aM (pastelli con tipi popolari madriteni, gi goyeschi). An-che Goya rappresentato (Guerriglieri aragonesi; SantEli-sabetta al capezzale di unagonizzante, grisaille, 1815).Museo del Prado Importante per ricchezza numerica (ol-tre tremila tele, di cui duemilacinquecento attualmenteesposte), eccezionale per la proporzione di opere di al-ta qualit (e per il loro stato di conservazione, dovuto alclima secco della Castiglia), per la rilevanza storica di uncomplesso che riflette lo sviluppo duna grande scuola dipittura, lo spirito di un popolo e il gusto dei suoi re. Igruppi di opere di Tiziano, Rubens, Velzquez e Goyasono essenziali per la conoscenza di tali maestri. Fondatonel 1818 con decreto di Ferdinando VII, il Prado restper mezzo secolo museo reale, raccolta delle collezionidei sovrani spagnoli.Da Carlo V in poi, gli inventari consentono di seguirelarricchimento dei fondi reali. Il destino e il gusto del-limperatore si riflettono nellammirevole serie dei Tizia-no (Carlo V vincitore a Mhlberg, Isabella diPortogallo, laGloria di Carlo V, in particolare), completata in segui-to dagli incarichi o dalle acquisizioni di Filippo II (la Re-ligione soccorsa dalla Spagna). Ma il re accord un ruolonon meno importante agli artisti del nord: il romanistaCoxcie o il grande ritrattista Antonis Mor, e ricerc an-che pittori della generazione precedente, Bosch e Patinir.Quanto a Filippo IV, la sua passione di collezionista fuinsaziabile: monopolizz, o quasi, la produzione di Velz-quez, confer numerosi incarichi a Rubens ed ai suoi al-lievi (in particolare lintera decorazione del padiglione dicaccia della Torre de la Parada mitologie di Rubens,animali di Snyders e Paul de Vos oggi passata al Pra-do), ordin paesaggi a Claude Lorrain, fece acquistarequadri in Italia dai vicer di Napoli (Madonna del pesce,Salita al Calvario di Raffaello), a Venezia da Velzquez,
Storia dellarte Einaudi
-
nelle Fiandre dai governatori, in particolare nellasta se-guita alla morte di Rubens (Autoritratto di Tiziano), epersino a Londra dallambasciatore di Spagna, in occasio-ne dellasta che segu lesecuzione di Carlo I (Sacra Fami-glia di Raffaello, Venere di Tiziano). Linventario del1700 menziona 5539 quadri nei palazzi reali, di cui 1622allEscorial. Durante il regno di Filippo V le collezionisubirono un irreparabile disastro, con lincendio del pa-lazzo di M: quasi un terzo dei suoi quadri and distrutto(cinquecentotrentasette su millecinquecentosettantacin-que), tra i quali opere fondamentali di Velzquez. Ma al-la regina Isabella Farnese dovuto un cospicuo apportodi dipinti italiani del xvii sec. e qualche opera di Muril-lo; Carlo III fece appello ad artisti di fama internaziona-le, Tiepolo e Mengs, e questultimo fu per qualche tem-po arbitro delle belle arti (incarichi ai Bayeu, a J. del Ca-stillo, a Goya). Linventario redatto alla morte di CarloIII nel 1789 menziona quattromilasettecentodiciassettedipinti. Mengs aveva gi suggerito la creazione di un mu-seo. Furono per i ministri di Carlo IV, Godoy e Ur-quijo, senza dubbio spinti dallesempio del Louvre diParigi, che ne prepararono la realizzazione nel 1800. Lostesso Urquijo, divenuto primo ministro di Giuseppe Bo-naparte, redasse nel 1809 il decreto che istituiva il mu-seo: ai dipinti reali dovevano aggiungersi le opere miglio-ri provenienti dai conventi appena soppressi. In seguitoagli eventi politici e militari, tale museo esistette solo sul-la carta, ma il progetto riprese consistenza sotto Ferdi-nando VII, incoraggiato dalla sensibilit della regina, Ma-ria Isabella di Braganza.Si scelse allora, per ospitare il Museo reale, ledificio neo-classico costruito da Villanueva a partire dal 1785, lungola passeggiata del Prado. Lesecuzione fu rapida: un annoe mezzo dopo la decisione il museo veniva inaugurato,con tre sale che esponevano trecento dipinti, tutti spa-gnoli; il catalogo del 1858 raggiunge i duemila pezzi.Un nuova tappa si apr con la rivoluzione repubblicanadel 1868: da reale il Prado divenne nazionale, e so-prattutto si arricch nel 1872 di un apporto considerevo-le, con lo smembramento del Museo de la Trinidad, com-posto dai quadri provenienti dai conventi soppressi. Su-bentr allora una fase in cui gli acquisti diminuirono, masi procede a nuove sistemazioni e ad ampliamenti. Dopola guerra civile, nel 1939, il Prado ritrov intatti i suoitesori, e venne ripreso il programma di riorganizzazione.
Storia dellarte Einaudi
-
Le acquisizioni dopo il 1912 salirono ad oltre seicento di-pinti: opere portate dallEscorial (van der Weyden, Bo-sch, Tintoretto), o da chiese vittime degli eventi (Aposto-li del Greco, da Almadrones); opere provenienti da scam-bi con musei stranieri: dal Louvre di Parigi (Immacolatadi Murillo) e dal mma di New York (affreschi romanicidi San Baudilio de Berlanga). Ma la maggior parte delleopere vennero offerte o acquistate dal ministero dellE-ducazione nazionale e dal Patronato: nel 1915, lascitoPablo Bosch di novanta dipinti (primitivi spagnoli e fiam-minghi, Morales, El Greco); nel 1930 lascito FernndezDuran (van der Weyden, Oudry; Goya, Colosso); nel1942, donazione Cambo di primitivi italiani e di tre Bot-ticelli; nel 1975, don Marques de Casa Torres (un Velz-quez e due Goya).Tra le acquisizioni menzioniamo il grande ritratto eque-stre del Duca di Lerma di Rubens (1969), primitivi spa-gnoli, opere di Cano, Espinosa, Zurbarn, Murillo, Pa-ret, Goya (i ritratti di Jovellanos e della Marchesa di San-ta Cruz), il Cristo morto portato dagli angeli di Antonelloda Messina, la Continenza di Scipione di Gian BattistaTiepolo, un Autoritratto di Rembrandt (1941) e una doz-zina di ritratti inglesi comperati tra il 1958 e il 1968. Leraccolte di opere delle diverse scuole sono quantitativa-mente assai ineguali: Venezia, le Fiandre e, in misura mi-nore, la Francia sono con la Spagna le pi rappresentate.Quanto allItalia vanno ricordate, oltre allAnnunciazionedel Beato Angelico e la Morte della Vergine di Mantegna,anche opere di recente acquisizione (Botticelli, Antonelloda Messina). Per il xvi sec., oltre ai pittori veneziani, fi-gurano Raffaello (lo Spasimo di Sicilia degli Olivetani diPalermo, Madonna del pesce, Madonna della perla, Ritrattodi giovane cardinale); Andrea del Sarto (Vergine tra Tobiae Raffaele, Sacrificio dIsacco, ritratto di Lucrezia di Bac-cio); Correggio (Noli me tangere), Bronzino, Barocci (Nati-vit, Calvario). Di grande importanza la raccolta di Tizia-no, che comprende ritratti (Carlo V vincitore a Mhlberg,Isabella di Portogallo, Federico Gonzaga, Autoritratto delpittore vecchio), dipinti religiosi (Adorazione dei Magi, Sa-lita al Calvario, Santa Margherita), dipinti storico-allegorici(la Gloria di Carlo V; Filippo II offre alla Vittoria lin-fante Don Fernando; la Religione soccorsa dalla Spagna) emitologici (Danae, e i due baccanali: Offerta a Venere eGli Andrii). La cultura barocca rappresentata soprattut-to grazie alla collezione della regina Isabella Farnese: i
Storia dellarte Einaudi
-
Carracci, Cara-vaggio, G. Reni, Domenichino, Guercino,Albani. Di notevole interesse gli affreschi di AnnibaleCarracci (Vita di san Giacomo e di san Diego dAlcal) tra-sportati dalla chiesa romana di San Giacomo degli Spa-gnuoli, il ciclo dei grandi dipinti sulla Vita di san Gio-vanni Battista di Stanzione, alcuni dipinti dei primi cara-vaggeschi italiani venuti in Spagna, come Borgianni (Au-toritratto) e Cavarozzi (Nozze mistiche di santa Caterina), enumerose tele di Luca Giordano, chiamato a M da CarloII Importante anche la ricca sezione del xviii sec.: Pan-nini, Baioni, Amigoni, Giaquinto, i Tiepolo. La pitturanordica documentata, a partire dal xv sec., da tutti isuoi grandi maestri, dalla bottega di van Eyck (la Chiesae la Sinagoga), da Bouts, dal Maestro di Flmalle, daMemling, da Grard David a van der Weyden (grandio-sa Deposizione dalla croce, gi allEscorial). Assai ricco, ilxvi sec. nordico dominato da Patinir, Bosch (Giardinodelle delizie, Adorazione dei Magi, Tentazione di santAnto-nio, Carro di fieno), Bruegel il Vecchio (Trionfo della mor-te). Il xvii sec. dominato da Rubens, con tre gruppi bendefiniti: le opere dipinte a M nel corso dei due viaggi del1606 e del 1628 (gli Apostoli e Ritratto equestre del ducadi Lerma, Ritratto equestre di Filippo II, copie da Adamoed va di Tiziano), i modelli per gli arazzi del TrionfodellEucarestia, commissionati per le Descalzas Reales diM dallinfanta Isabella Chiara Eugenia (1628), di cui ilPrado possiede sette mirabili bozzetti, lenorme comples-so mitologico dalle Metamorfosi di Ovidio, dipinto attor-no al 1636, con la collaborazione di tutta la bottega diRubens, per ornare il padiglione reale della Torre de laParada nel bosco del Prado; e inoltre lAdorazione deiMagi (1609), il ritratto di Maria de Media, il Ballo deicontadini, il Giardino damore. Van Dyck e Jordaens sonoanchessi assai ben rappresentati. Da segnalare ricche se-rie di Teniers e soprattutto di Bruegel de Velours (i Cin-que Sensi, le Quattro Stagioni, il Paradiso terrestre).A questesuberante ricchezza si contrappone la povert ditestimonianze su nazioni che furono in opposizione poli-tica con la Spagna asburgica, lOlanda e lInghilterra. Perla prima, la cui fioritura pittorica coincide con la conqui-sta dellindipendenza, due sale espongono esempi di ma-nieristi tardi (van Haarlem, Apollo dinanzi al tribunale de-gli di), paesaggisti (Cuyp, van Goyen), pittori di cacce(Wouwerman) e di nature morte (Meda, Jan Davidz deHeem), ove risaltano Ruisdael e Rembrandt (Artemisia,
Storia dellarte Einaudi
-
1634). Quanto allInghilterra, la cui assenza era presso-ch totale, donazioni o acquisti recenti hanno costituitoun gruppo, forte di una dozzina di ritratti di Lawrence(Conte di Westmorland, Miss Martha Carr), Raeburn, Hop-pner, Oppie.La Germania del rinascimento figura con dipinti poconumerosi, ma fondamentali. Intorno a quattro Drer diprimordine (Autoritratto, Hans Imhoff, Adamo ed Eva], siraggnuppano alcuni eccellenti quadri di Baldung Grien (leTre Grazie, le Et e la Morte), Cranach (Caccia di Carlo Vpresso lElettore di Sassonia), Amberger.Il fondo francese ricco e vario. Vi si possono distin-guere tre gruppi: anzitutto, quello risalente a Filippo IV,con un bel complesso di opere di Poussin (una quindici-na di pezzi, tra cui il Parnaso, il Trionfo di Davide) e al-cuni Claude Lorrain (dieci paesaggi dipinti per il re diSpagna, tra cui Tobia e langelo, Santa Paola che simbar-ca a Ostia), cui si aggiunge un eccezionale SbastienBourdon, il Ritratto equestre di Cristina di Svezia. In se-condo luogo, leredit dei Borboni, pi considerevole epi varia, comprendente quanto venne eseguito in Spa-gna dai Pintores de Cmara; Houasse, con soggetti re-ligiosi e mitologici e alcune scene assai pi personali(LInfante Luigi in grigio e soprattutto la modernissimaVeduta dellEscorial), Ranc (numerosi ritratti), L. M. vanLoo (con la grande Famiglia di Filippo V alla Granja);quanto venne in seguito ricevuto o commissionato inFrancia: ritratti della famiglia reale (lInfanta Maria Vitto-ria di Largillire, il Luigi XV bambino di Gobert, il gran-de Luigi XVI di Callet, dono del monarca al conte dA-randa); scene di genere (due piccoli Watteau) o paesaggi(quattro Vernet ordinati nel 1781 dal futuro Carlo IVper la sua casita dellEscorial). Infine, alcune impor-tanti tele provenienti da acquisti o lasciti pi recenti, co-me il Vouet (il Tempo vinto dalla Giovinezza e dalla Ret-tezza), lAnnunciazione di Finsonius, i ritratti di Oudrydel Conte e della Contessa de Castelblanco, il monumenta-le Colosseo di Hubert Robert.Il Prado resta comunque anzitutto un museo castigliano,dove predominano gli artisti originari della Castiglia ochiamati in Castiglia dalla corte. Solo alcuni dipinti(Frontale romanico di Guies, Storie di san Giovanni Batti-sta e della Maddalena della bottega dei Serra, Retablo diSan Miguel del maestro di Argis, la tavola centrale delretablo di Daroca, del 1474, con San Domenico di Silos,
Storia dellarte Einaudi
-
capolavoro di Bermejo, Madonna dei cavalieri di Montesadella bottega di Rodrigo de Osona) rappresentano laCatalogna, lAragona e Valenza in et medievale. Si puinvece seguire lo sviluppo della pittura in Castiglia e nelLen dallepoca romanica (dipinti murali di San Baudiliode Berlanga e di Maderuelo) fino al rinascimento, inparticolare con il bel gruppo dei Gallego e di Berruguete.Il xvi secolo presente con capolavori di Antonis Mor,Snchez Coello, Pantoja de la Cruz.El Greco magnificamente rappresentato coi suoi quadrireligiosi (Trinit di Santo Domingo Antiguo, San Sebastia-no, Pentecoste) e con ritratti (Il Capitano Julio Romero e ilsuo santo patrono).Il secolo doro illustrato splendidamente: due bei Ri-balta, una cinquantina di Ribera (Martirio di san Bartolo-meo, Sogno di Giacobbe, Santa Maria Egiziaca), quadri diHerrera il Vecchio (Professione di fede di san Bonaventura,Testa di santo decapitato) e di Zurbarn (Fatiche drcole,Immacolata, SantEufemia, il Cardinal Diego de Dez, Scenedella vita di san Pietro Nolasco), Murillo rappresentatoin modo eccellente (due episodi della Fondazione di SantaMaria Maggiore, alcuni dipinti con lImmacolata, e la SacraFamiglia). La scuola madrilea raggruppa al Prado un numero dipittori sufficiente a documentare la variet dei tempera-menti nellevoluzione dal realismo del primo terzo del se-colo (grandi Storie di Certosini di Carducho, Adorazionedei Magi e Pentecoste di Maino, nature morte di van derHamen) al grande stile epico dei contemporanei di Velz-quez, al barocco decorativo della seconda met del seco-lo (Carren). Il Settecento ben rappresentato nel suodoppio volto, quello dei pittori ufficiali (Mengs,Bayeu) e quello degli indipendenti (Melndez, Paret yAlczar). I consistenti nuclei relativi a Velzquez e Goyacostituiscono vari musei nel museo, che raccolgono ca-polavori di periodi abbastanza diversi in modo tale dapoter misurare meglio che in qualsiasi altro luogo la ver-satilit di questi due geni. I dipinti spagnoli del xix sec.sono conservati nellattiguo edificio del Casn del BuenRetiro, antico padiglione di ricevimento del palazzo diFilippo IV. Da Lopez a Mir e Rusiol, questa sezione(escluso Goya) offre una visione interessante anche se unpo frammentaria delle correnti artistiche dellOttocento.Il periodo romantico ben rappresentato: ritratti di F.de Madrazo, C. L. de Ribera, Esquivel e Contirrez de
Storia dellarte Einaudi
-
la Vega; scene di genere illustrate da Alenza, Lameyer,Lucas Velzquez e i costumbristas Bquer, Castellano,Rodriguez de Guzman; paesaggi romantici di Jenaro P-rez Villaamil. Nel penultimo quarto del secolo si distac-cano due personalit con qualche tela importante comequelle dei Figli del pittore in un salone giapponese di For-tuny e il Testamento dIsabella la Cattolica di Rosales.Questa panoramica si conclude con le opere di Valen-ciens Domingo Marquis, Pinazo, Sorolla e una serie dipaesaggi dovuti a Rico, Beruete, Regoyos, Gimeno eRiancho. Nella sala centrale, sotto il soffitto di L. Gior-dano, stato sistemato dopo il 1981 Guernica, tela chePicasso realizz in seguito al bombardamento della picco-la citt delle Asturie (1937) da parte dellaviazione nazi-sta; lopera accompagnata da una serie di disegnipreparatori.Museo Romntico (Fondazione Vega Incln) II marche-se de la Vega Incln (1858-1942), incoraggiato dal suc-cesso del Museo di El Greco che aveva aperto a Toledoricostruendo la casa del pittore, volle tentare una con-simile evocazione a beneficio della pittura romantica spa-gnola ingiustamente poco considerata. Offr dunque alloStato i circa ottanta quadri romantici che aveva raccoltoe restaur, per ospitarli, una dimora aristocratica dellini-zio del xix sec., in calle San Mateo. Aperto nel 1924 edin seguito molto arricchito, il museo offre, col salone daballo, i mobili, le porcellane e gli specchi, una ricostru-zione fedele di interno romantico. Il termine romanti-co viene daltronde preso in senso ampio; i quadri espo-sti vanno infatti dal 1808 al 1860. Cominciando conGoya (San Gregorio), il museo fa posto agli artisti dellaprima met del secolo: decoratori (come Zacaras, Gonz-les, Velzquez, dei