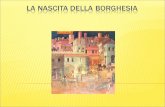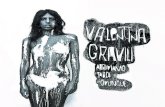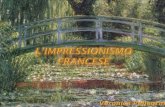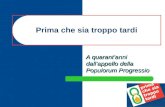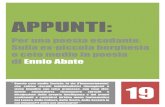M SSONICA - Grande Oriente d'Italia - Sito Ufficiale · 2017-03-06 · politica della borghesia....
Transcript of M SSONICA - Grande Oriente d'Italia - Sito Ufficiale · 2017-03-06 · politica della borghesia....

menteM SSONICA
Rassegna quadrimestrale
ISSN 2384-9312
Laboratorio di storia del Grande Oriente d'Italian.8 Gen.-Apr. 2017

Iscrizione Tribunale Roman.177/2015 del 20/10/2015
Direttore responsabileStefano Bisi
DirezioneSanti Fedele
Giovanni Greco
RedazioneIdimo CorteMarco CuzziSanti Fedele
Bernardino FioravantiGiovanni Greco
Giuseppe LombardoMarco Novarino
Art DirectorGianmichele Galassi
EditoreGrande Oriente d'Italia, ROC n.26027
via San Pancrazio 8, 00152 Roma
Direzione e RedazioneMASSONICAmente,
Grande Oriente d'Italia,via San Pancrazio 8, 00152 Roma
StampaConsorzio Grafico e Stampa Srls - Roma
Rassegna Quadrimestrale edita online suwww.grandeoriente.it
Le opinioni degli autori impegnano soltanto questi ul-timi e non configurano, necessariamente, l'orienta-mento di pensiero della rivista MASSONICAmente odi Società Erasmo Srl.La riproduzione totale o parziale dei testi contenutinella pubblicazione è vietata sotto qualsiasi forma,senza espressa autorizzazione scritta, secondo lenorme vigenti in materia.Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione ancheparziale se non autorizzata. Manoscritti e illustrazioni,anche se non pubblicati, non si restituiscono.
Sommario n.8 Gen.-Apr. 2017
Saggi
“La massoneria strumento della borghesia!” ................1
di Marco Novarino
Alberto Manzi:
il maestro degli italiani e dei latino-americani .............6
di Giovanni Greco
Ugo Bassi:
patriota, barnabita, massone ......................................10
di Alessandro Boselli
Massoni, socialdemocratici e liberali contro
il nazismo. L’organizzazione repubblicana
del Reichsbanner nella Germania di Weimar..............16
di Marco Cuzzi
La centralità del mito di Giordano Bruno nella Masso-
neria italiana dopo l’Unità..........................................22
di Santi Fedele
Il riordino della Memoria
1943: la rinascita della Massoneria italiana ...............25
Tra gli scaffali
Gian Mario Cazzaniga
La catena d’unione ......................................................27
menteM SSONICALaboratorio di storia
del Grande Oriente d'Italia
n.8 Gen. - Apr. 2017
ISSN 2384-9312

Le interpretazioni ideologiche delle teorie diMarx ed Engels operate principalmente daLenin, Trotsky e Rosa Luxemburg – e poi
assimilate e rese operative dalle correntirivoluzionarie del proletariato – diedero vita alcomunismo contemporaneo. Nel movimento comunista – anche se sarebbe piùcor retto parlare di comunismi, per sottolineare lenotevoli dif ferenze esistite a livello mondialenegli ultimi cento anni tra coloro che, a variotitolo, si sono considerati come gli eredi dei padrifondatori – è sempre stata presente una diffusa etenace attitudine antimassonica espressa dai suoiprincipali dirigenti. Non mancarono però anchefigure importanti e prestigiose di comunisti-massoni1.Se appare evidente che le basi del comunismocontemporaneo siano state get tate nel marzo del
1902 quando il giovane Lenin pubblicò il saggioChe fare?, vero e proprio fondamento teorico delfuturo partito comunista, occorre però aspettare il1917, con la rivoluzione bolsce vica, ma soprattuttoil 1919, con la creazione dell’InternazionaleComunista, per poter parlare di movimentocomunista organizzato. Nel marzo del 1919, preceduto da un documentodi Lev Trotsky dal titolo, Sul Congressodell’Internazionale Comunista, nasceva a Moscal’Internazionale Comunista, anche conosciutacome Terza Internazionale. Si trattava non soltantodi un organismo di collegamento tra i partitinazionali, come era stata l’Internazionalesocialista, ma di una struttura gerar chicamentecentralizzata che stabiliva la strategia dell’interomovi mento comunista imponendo ad ogni partitomembro i compiti ne cessari per sviluppare econsolidare la rivolu zione mondiale. Pertanto ledirettive, anche quelle specifi che per i vari partitinazio nali, avevano valore vincolante per l’interomovimento.Nel corso del primo Congresso, tenutosi a Moscadal 2 al 14 marzo del 1919, la questione‘massoneria’ non venne di scussa. Già però nelsecondo, iniziato a Pietrogrado il 17 luglio 1920 eproseguito a Mosca dal 23 luglio al 7 agosto dellostesso anno, la delegazione italiana del Partitosocialista italiano (PSI) presentò ufficialmente ilpro blema che era stato uno dei ca valli di battagliadella corrente massimali sta fin dal con gresso diAncona del 1914.Il PSI era mem bro effettivo dell’Internazionale,ma si opponeva alle pres santi richieste scissionistedi Lenin di espellere la corrente riformista. Idirigenti russi formularono pertanto delle condi -zioni per l’ammissione pensando specialmente alPSI: ciò indispettì però i vertici italiani, vistol’atteggiamento più morbido e conciliante tenutonei confronti del Partito socialista francese cheperò, nel 1914, aveva aderito alla guerra. Pertantola pregiudiziale antimassonica, oltre amotivazione etiche e ideologiche, conteneva unavalenza ‘antifrancese’ tesa ad allentare la pressionesul partito italiano e spostare l’attenzione suquello transalpino che contava al proprio internomolti membri appartenenti anche alle loggemassoniche. Da qui, il tentativo dei delegati
“LA MASSONERIA STRUMENTO DELLA BORGHESIA!”LA PREGIUDIZIALE ANTIMASSONICA NEL MOVIMENTO COMUNISTA INTERNAZIONALE
di Marco Novarino
SAGGI
Copertina del Communist Internationalmagazine, 1920, n.9.
1

italiani di inserire come ventiduesimo punto perl’ammissione all’Internazionale, l’epurazione deimassoni dai partiti comunisti che nei lavori dellacommissione venne così formulata:Ogni partito che voglia aderire all’Internazionale Comu-nista non deve permet tere in ogni caso che i suoi membriappartengano alla setta dei massoni. I massoni costitui-scono effettivamente in diversi paesi organizzazioni poli-tiche che, attraverso la loro conce zione astratta, formale epiccolo borghese dei rapporti sociali, aiutano gli interessidel sistema piccolo borghese nazionale e internazionale2.Durante la discussione il presentatore,l’economista imolese Antonio Graziadei –consapevole di come il problema fosse poco co -nosciuto dai russi con il conseguente rischio dinon essere affrontato nella dovuta considerazione – argomentò la propria richiesta affermando cheE’ sufficiente il semplice esame de gli scritti massonici permotivare la mia istanza. La questione riguardamarginalmente i Russi ma riveste però una grandeimportanza nei paesi latini, in Inghilterra e in America.La massoneria esercita un influsso piuttosto grande inquesti paesi. Si tratta di una organizzazione politica cheaspira al po tere attraverso la conquista ed ilconservatorismo. Essa riuni sce funzionari pubblici euomini d’affari. La dottrina su cui si basa è l’esattocontrario delle teorie marxiste-socialiste. Essa aspira adoccultare le differenze nazionali e di classe sotto una teoriaastratta e formalista della ragione. Inoltre essa è una or -ganizzazione segreta e i compagni che sono membri dellamas soneria ci possono controllare senza che, da partenostra ci siano possibilità di controllo della loroorganizzazione3.L’imolese ricordò inoltre come su tale tematica ilPSI avesse ingaggiato un’importante battaglia nelcongresso di Ancona del 19144 , e malgrado leargomentazioni e la decisione di espellere imassoni dal partito fossero state accolte eapprovate dal movimento rivoluzionariointernazionale, il Partito socialista fran cese nonaveva prestato la dovuta attenzione alla questionee ora stava attraversando una grave crisi a causadel grande numero di mas soni presenti nelleproprie file. L’intervento di Graziadei apportò nuovi elementinel discorso antimassonico da partedell’Internazionale Comunista introdu cendo ilconcetto di massoneria come organizzazionepolitica della borghesia. Pensiero successivamenteripreso, cinque anni più tardi, da Gramsci nel suofamoso discorso parlamentare in occasione delladiscus sione sulla legge contro le società segrete. Si passava quindi da un antagonismo di principia un antagoni smo politico-organizzativo,accusando la massoneria di nascondersi dietro
una veste di scuola iniziatica, ma di essere di fattoil partito della borghesia per di più dotata di unastruttura segreta. Secondo la delegazione italianail fatto che fosse una società segreta la rendevaparticolarmente pericolosa nello scontro in atto traborghesia e proletariato. Il giorno seguente lamozione italiana venne ratificata all’unanimità dalplenun. Malgrado però il voto dell’assembleagenerale, la commissione incaricata della stesuradei punti d’ammissione non accolse la risoluzionecome punto ventidue simo in quanto ritenutascontata. Anche se non esistono do cumenti checonfermino tali con clusioni, riteniamo che siaLenin che Zinoviev avessero intuito le vereintenzioni degli italiani di gio care la carta‘massoneria’ in chiave antifrancese, lasciando cosìcadere volutamente la questione per poiriprenderla successivamente, sem pre contro imassoni francesi iscritti al Partito comunistafrancese, nel IV° Congresso dell’InternazionaleComunista. La ‘questione mas sonica’ ebbe i suoi echi nel XVIICongresso Nazionale del PSI che, svoltosi nelgennaio 1921 a Livorno, sancì la nascita delPartito comunista d’Italia. Sia Graziadei sia ilsegretario Giacinto Menotti Serrati, venneroaccusati di dilettantismo e di essere colpevolidella mancata approvazione della pregiudizialeanti massonica, tanto cara alla correntemassimalista e comu nista.Serrati ribadì che la mozione d’incompatibilitànon era stata presa in considerazione dai dirigentidell’Internazionale Comunista per timore dicreare una grave frattura tra i socialisti francesi,consentendo così a questi ultimi di essereaccettati, senza problemi di sorta, nel consessointernazionale, mentre «la Terza Internazionaledice di rifiutare a noi so cialisti - che non abbiamomai tradito la nostra bandiera e la bandieradell’Internazionale proletaria - l’ingresso»5.Ma la questione era solo rimandata, perché sedurante il II congresso la richiesta di epurazionedei massoni fu ritenuta ovvia, in occasione del IIIcongresso la situazione mutò radicalmente, alpunto da spingere Trotsky, all’epoca espo nente dimaggior peso dopo Lenin in senoall’Internazionale, a proporre nel corso delle assisicon gressuali che l’adesione fosse proibita a tuttimembri dei par titi membri perché «per i suoistatuti, la sua organizzazione e la maniera comesono scelti i suoi membri, la Massoneria nonrappresenta altro che un processo d’infiltrazionedella piccola borghesia in tutti gli strati sociali »6.Secondo Trotsky lo spirito borghese, la ritualità ela se gretezza massonica rappresentavano un grave
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 20172

pericolo per l’azione rivolu zionaria, e pertanto nonerano ammissibili dalla dittatura del proletariatoin quanto La solidarietà principio basico dellaMassoneria costituisce un serio ostacolo per l’azioneproletaria e che la libertà di concezione borghese si opponealla dittatura del proletariato […] La Massoneria -aggiungeva Trotsky – con i suoi riti, ricorda i costumireligiosi e sappiamo che tutte le religioni soggiogano ilpopolo e - concludendo - la Massoneria rappresentava unagran forza sociale, e per il segreto delle sue riunioni e ladiscrezione assoluta dei suoi membri era una specie diStato dentro lo Stato 7.Le direttive di Trotsky furono approvate dalCongresso e la Terza Internazionale, e diconseguenza tutti i partiti aderenti, proibirono ailoro mem bri di affiliarsi alle logge massoni che. Daquesto momento in poi, Trotsky divenne il piùaccanito avversa rio della massone ria e tutti gliscritti e le risoluzioni contro di essa adottatedall’Internazionale Comunista provennero diretta -mente dalla sua penna.Prendendo spunto dalla crisi del Partitocomunista francese, in occasione del IV Congressoche si tenne a Mosca dal 11 al 20 novembre del1922, il rivoluzionario russo risollevò il pro blemadell’incompatibilità, fissando, questa volta,precise direttive e scadenze improrogabili.Impressionati dalle no tizie raccolte checonfermavano come un rag guarde vole numero dicomu nisti francesi appartenesse alle loggemassoniche (malgrado il distacco dell’alariformista), la commissione di lavoro sulla Franciainti mava al comitato direttivo del Partitocomunista francese la rescissione di ogni contatto,individuale o di gruppo, con la masso neria entroil 1 gennaio 1923. Disponeva inoltre di espelleredal partito, en tro la medesima data, i militanti chenon avessero, attra verso gli organi di stampa dellostesso, comunicato la loro completa rottura con leObbedienze massoni che8.Una speciale commissione composta dai maggioridiri genti comunisti, tra cui Trotsky, Zinoviev eBucharin, elaborò una arti colata risoluzione sullaquestione francese, comprendente la di chiarazioned’incompatibilità tra mas sone ria e comunismo chefu ap provata dall’assise congressuale con due voticontrari e un’astensione. La risoluzione fupreceduta da un discorso di Trotsky comprendenteuno specifico capitolo sulla massoneria.Inquadrandolo nell’ampio problema del Partitocomuni sta francese, il dirigente comunista affermòche la mas soneria era una questione nuova,postasi agli occhi stupiti dei congressisti che nonso spettavano, dato che la stampa comunistafrancese non ne aveva mai parlato, che a distanza
di due anni dal congresso di Tour ci fossero an coradei massoni all’interno del partito. Un comunista, continuava l’oratore, non potevaapparte nere a un’organizzazione che fosse unostrumento della bor ghesia radica lizzante per«nascondere la sua indole reazionaria, la suameschineria, la perfidia delle sue idee, il suospirito, il suo programma»9. L’Internazionale,secondo Trotsky, aveva ordinato al partito dicreare un abisso con la classe borghese. Un abissoche però non solo non era stato creato, macontinuavano a esistere «passarelle», nascoste emasche rate, che permettevano contatti costanti.Queste «passarelle» erano la massoneria e la Legadei diritti dell’uomo e dei cittadini, chestabilivano rapporti stretti con le istituzioni delpartito, la reda zione del gior nale, il comitatodirettivo, il comitato fede rale. Un comunista nonpoteva condannare la società bor ghese corrotta edopo abbracciare nelle logge massoniche i suoirappresentanti. I comunisti dovevano, concluseTrotsky, affermare l’incompatibilità completa,assoluta e implacabile tra lo spirito rivoluzionarioe quello «piccolo -borghese massonico, strumentodella grande borghesia!»10. Questa peren toria dichiarazione suscitò, secondoil reso conto stenografico dell’assemblea, gliapplausi dei congressisti. In se guito ilrivoluzionario russo accusò i dirigenti francesi diaver sottovalu tato negli anni precedenti ilproblema consentendogli di sollevare delle riservesul loro operato su questioni fondamentali comequella sindacale o quella del Fronte unico. Lafrequentazione delle logge massoniche di moltifunzionari del partito, era per il dirigente co -munista, una delle cause di questa politica errata.L’unica soluzione era una presa di posizione nettasul pro blema, un ‘taglio chirurgico’ che avrebbeprovocato l’ostilità dei nove/decimi dell’opinionepubblica francese e avrebbe coalizzato contro ilpartito i dissidenti, socialisti e perfino i cattolici,che si sarebbero posti in difesa dei massoni. PerTrotsky, contro questa alleanza di tutte lesfumature della borghesia, il par tito dovevadifendere gli inte ressi del proletariato e procla -mare con tutte le energie lo sbaglio, compiuto inpassato, di tollerare dei massoni nei partiticomunisti. Ma, dopo aver riconosciuto tale errore,era arrivato il momento di svolgere una lottaimplacabile contro la Lega dei diritti dell’uomo ela massoneria, essendo un’arma segreta einsidiosa dell’arsenale borghese.Queste argomen tazioni, pronunciate durante il IVCongresso ottennero larga eco sulla stampacomunista internazio nale.
SAGGI 3

Secondo al cune ipotesi, sembra che alla base della‘scomunica’ di Trotsky, oltre a motivazioni moralie ideologiche, ci fosse un preciso piano per de -stabilizzare il Partito comunista francese cheall’epoca del IV Congresso, era diviso in trefrazioni e attraversato da lotte intestine che neparalizzavano la vita politica. Di fatto il par tito,contravvenendo a un principio basicodell’Internazionale, non aveva eseguito ideliberati prove nienti da Mosca. Seppure tutte lafrazioni ribadissero la lealtà all’Internazionale e lavolontà di rispettare i deliberati congressu ali, leposizioni assunte erano nettamente contra stantitra loro. La frazione di destra sosteneva che lediret tive moscovite andassero, a volte, contro gliinteressi del partito. Il centro non aveva dato vita,come ordinato dal Comitato Esecutivodell’Internazionale Comunista, a un blocco con lafra zione di sinistra, unica fedele ai voleri diMosca, soste nendo che tale diktat era contrarioalla sovranità del partito. La lotta fra le frazionirischiava di paralizzare com pletamente il la voropolitico. Jules Humbert-Droz, massone, dirigentecomunista svizzero e membro della delegazionefrancese a Mosca, confermò questa ipotesi scri -vendo nelle sue memorie che la clausola sullamas soneria fu vo luta dalla dirigenza comunista
per demolire le fra zioni in quanto l’espulsione deimassoni, presenti all’interno di tutte e tre lecorrenti, avrebbe creato un terremoto politicorafforzando la componente filo-moscovita nelpartito.Anche se le opi nioni espresse nelle me morie dichi è stato in prima per sona coinvolto nelle vi -cende dell’epoca vanno sempre analizzate con uncerto distacco storico, le tesi di Humbert-Droztrovano un riscontro in una lettera inviata daTrotsky a Zinoviev riguardante la composizionedel nuovo comitato centrale del Partito comunistafrancese. In questo documento si ipotizzasse chel’avvio di un’aspra campagna antimassonica daparte della frazione di sinistra avrebbe provocatouna grave crisi nel gruppo dirigente.La dirigenza dell’Internazionale Comunista eraseriamente pre occupata dall’effetto dirompente diquesta tattica e dalla reale possi bilità che laclausola dell’incompatibilità tra masso neria ecomuni smo potesse provocare profondi contrastie disastrose scissioni all’interno dei partiticomunisti aderenti, in particolare nelle fila diquello francese. Trotsky minimizzò la questione,ribadendo, anzi, che in un partito rivoluzionarioera preferibile Una organizza zione di 50.000 membri,ma costruita come si deve, che sa ferma mente ciò che vuole
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 20174

e che la via rivoluzionaria senza mai scartare può e deveconquistare la fiducia della maggioranza della classe ope -raia ed occupare nella rivoluzione il posto diri gente. Unaorganizza zione di 100.000 membri contenente cen tristi,pacifisti, massoni, giornalisti, borghesi, ecc... è con dannataa scalpitare sul posto, senza programma, senza idee, senzavolontà, e giammai potrà conquistare la confidenza dellaclasse operaia. La massoneria è una piaga cattiva sul corpodel comunismo francese. Occorre bruciarla al ferro rosso11. Anche se la richiesta di espulsione dei massonirien trava nel piano di bolsce vizzazione dei partiticomunisti da parte dell’Internazionale, laquestione della presenza di militanti e diri genticomunisti iniziati nella libero-muratoria era realee con di mensioni sconosciute in altri paesi.Durante il congresso di Tours del 1920, il Partitosocialista francese (SFIO) la maggio ranza guidatadal massone Marcel Cachin e da Lu dovic-OscarFrossard, die dero vita alla Sezione francesedell’Internazionale Comunista che nel maggio del1921 as sumerà il nome di Partito comunistafrancese. Vari mas soni socialisti aderi rono alnuovo Partito e ricoprirono incarichi dirigenti diassoluto rilievo. Nel primo Comitato diret tivofiguravano il già citato Cachin, direttoredell’organo centrale “L’Humanité” (il gloriosoquotidiano fondato da Jean Juares e ac quisito permerito del vecchio massone e comunardo ZéphirinCamélinat che deteneva la maggioranza delleazioni del giornale essendo te soriere della SFIO),Antonio Coen, futuro Gran Maestro della GranLoge de France, Louise Antoine Ker e VictorMéric. Malgrado il ruolo diri gente assunto da varimas soni, il Comitato Direttivo ac colse le istruzionidi Mosca di risolvere la questione entro il primogennaio 1923. La mancanza di una pubblicarottura con la massoneria comportava l’immediataespulsione, senza il diritto di aderire in futuro alpartito. Il nascondere l’appartenenza a una loggiamasso nica era conside rata come un atto deliberatodi penetra zione all’interno del par tito da parte diun agente nemico, ed esponeva l’individuoall’accusa d’ignominia davanti al prole tariato.Però anche la rottura con la massoneria non si -gnificava assoluzione completa, dal momento chel’appartenenza, anche passata, alla massoneriarivelava uno sviluppo insufficiente della co scienzacomunista e della dignità di classe. Il ‘peccatooriginale’ provocava la sospensione per due annida qua lunque incarico diri gente.Le decisioni di Mosca provocarono un vero eproprio terre moto e l’adesione incondizionatadella maggioranza del partito alle risoluzioniapprovata dall’Internazionale Comunista,delegittimarono le funzioni del se gretario
Frossard, che pur non essendo massone – lodivenne solo nel 1925 – era contrario al nuovoindirizzo politico, e senza aspettare il ConsiglioNazionale del 21 gennaio si dimise unitamente aCoen. Anche se formulati per specifiche situazioninazionali i delibe rati dell’InternazionaleComunista, come abbiamo precedentementesottolineato, avevano valore impositivo a livellomondiale e per tanto la dichiarazioned’incompatibilità con la massoneria ebbe i suoieffetti su tutti i partiti comunisti a livellomondiale, protraendosi ancora nel corso deidecenni successivi.
1 Questo articolo fa parte di un ampio lavoro di ricerca,che sarà pubblicato prossimamente, sui rapporti tramassoneria e comunismo a partire dalla Prima guerramondiale fino al secondo dopoguerra.2 Der Zweite Kongress der Kommunistischen Internationale -Protokoll der Verhandlungen von 19. Juli in Petrograd und vom23. Juli bis 7. August 1920 in Moskau, Amburgo, 1921, pp.2703 Ivi.4 Per i rapporti tra massoneria e socialismo in Italia mipermetto di rimandare ai miei lavori, Tra squadra e com-passo e sol dell’avvenire. Influenze massoniche sulla nascita delsocialismo in Italia (1864-1892), Torino, Fondazione Uni-versità Popolare di Torino, 2013 e Compagni e liberi mu-ratori. Socialismo e massoneria dalla nascita del Psi alla grandeguerra, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2015.5 Resoconto stenografico del XVII Congresso Nazionale del Par-tito socialista Italiano (Livorno 15-16-17-18-19-20 gennaio1921), Roma, Edizione della Direzione del Partito S. I.,1921, p. 3096 J.A. Ferrer Benimeli, El contubernio judeo-masónico-co-munista, Madrid, Istmo, 1982, p. 2177 Ivi.8 Résolution sur la question française, in Manifestes, thèses, ré-solutions des quatre premiers Congrès mondiaux de l’Interna-tional Communiste, 1919-1923 (Textes complets), Parìs,Bibliothèque Communiste, 1934, pp. 197-989 L.Trotsky, Le mouvement communiste en France, Paris, Ed.De Minuit, 1967, p. 25010 Ivi, p. 25111 L.Trotsky, La massoneria forza controrivoluzionaria, in“Avanti!”, 21 dicembre 1922.
SAGGI 5

Un tempo il Goi ha avuto fra le sue fila unafolta schiera di valenti maestri elementari,in particolare sino alla soppressione delle
logge attuata dal fascismo. Nell’epoca attuale,anche per il fatto che la stragrande maggioranzadei maestri è costituita da donne, i maestri ele-mentari fra i massoni sono una categoria quasiestinta, e questo è un limite che va adeguatamentevalutato e a cui bisogna far fronte.
Uno straordinario punto di riferimento al riguardoè quello di Alberto Manzi, nato a Roma nel 1924e deceduto a Pitigliano nel 1997 che era figlio diun tramviere, Ettore e di una casalinga, MariaMazzei.Una delle figure più originali e brillanti della pe-dagogia italiana, autore di oltre 120 titoli di libri,racconti e fiabe per ragazzi che gli valsero ricono-scimenti in tutto il mondo.Prese prima il diploma all’Istituto nautico (perchéallora voleva fare il capitano di lungo corso e at-traversare i mari in interminabili viaggi, materialie dell’anima), poi si laureò in biologia, poi si lau-reò in pedagogia col prof. Luigi Volpicelli, e sispecializzò in psicologia.Chiamato alle armi dalla Marina Militare, fu som-mergibilista nel battaglione da sbarco “SanMarco” e la bandiera e l’onore civile e militareispirarono quel periodo della sua vita.Ebbe quattro figli da Ida Renzi, maestra e autricedi racconti per bambini (con particolare riferi-mento al Vecchio orso che nel 1952 vinse il premio“del maestro” della Rai). Si risposò poi con SoniaBoni ed ebbe la quinta figlia Giulia che ha bril-lantemente raccontato la vita del padre.Alberto Manzi cominciò la sua attività di maestro,giovanissimo, nel 1946, presso l’Istituto di riedu-cazione Aristide Gabelli di Roma. Esperienzamolto formativa per lui perché dovette far frontead un gruppo di quasi cento allievi con specialicomplessità. Peraltro, come egli stesso dirà, avevadovuto conquistarsi il diritto all’insegnamentobattendo a pugni il caporione dei giovani che nonpoteva immaginare che quel maestrino così beneeducato era anche addestrato nelle arti marziali. Irisultati furono sorprendenti perché proprio dallacollaborazione con i giovani detenuti nacque
Grogh, storia di un castoro, Milano 19501 e anche,caso mai prima accaduto in un riformatorio, ungiornale mensile La tradotta, colmo di spunti di ri-lievo. Emblematico sarà il caso di un giovane so-prannominato “Ricotta”, che entrava e usciva dalcarcere, e di cui gli altri ragazzi gli raccontavanol’evoluzione del suo percorso, e che il maestroandrà a raccattare in luoghi particolari procuran-dogli lavori onesti, senza mai demordere, pure di-nanzi a nuove cadute.Secondo Manzi “l’intelligenza si sviluppa pen-sando. Educare a pensare non significa imporrecontenuti, non significa dire cosa si deve fare, masignifica porre un individuo in attività. Educare apensare significa anche creare un’atmosfera intel-ligente dove crescere”. In realtà Manzi era profon-damente kantiano nel ritenere che il maestro nondoveva insegnare pensieri, ma insegnare a pen-sare. Soprattutto dopo l’esperienza della guerraaveva un’idea fissa, quella cioè di contribuire acambiare tante antiche regole scolastiche, oramaiper lui stantie e desuete, una scuola da rinnovareper sollecitare al meglio “lo sviluppo di tutte le ca-pacità intellettive del bambino”.
ALBERTO MANZI:IL MAESTRO DEGLI ITALIANI E DEI LATINO-AMERICANI
di Giovanni Greco
Alberto Manzi
6

Nel 1948 aveva conosciuto Domenico Volpi, diret-tore del mitico “Vittorioso” che lo volle come col-laboratore affidandogli la rubrica “Occhi sulmondo”. Fu in quel periodo che scrisse “Orzo-wei”, il trovatello, tradotto in 32 lingue, pubbli-cato per prima da Vallecchi e premio Andersen nel1956, romanzo profondamente multiculturale.Nel 1955 ricevette dall’Università di Ginevra unincarico per ricerche nella foresta amazzonica perstudiare le formiche. Esordì quindi come natura-lista studiando la formica tangarana, una formicatristemente famosa perché veniva usata per tortu-rare povere vittime: si cospargeva il corpo dellapersona di miele, legandola ad un albero e poi ilresto lo facevano queste voracissime formiche.Una tortura al di là dell’umano. Ma ben presto passò dagli animali agli uomini,toccando con mano le reali condizioni dei conta-dini tra le Ande e l’Amazzonia, dall’Ecuador alBrasile, dalla Bolivia alla Columbia, aiutato inmodo decisivo da alcuni valenti missionari sale-siani, fra cui Giulio Pianello incontrato nell’Amaz-zonia peruviana, che gli rimarrà sempre vicino eche una volta gli inviò anche una foto da un laz-zaretto della Colombia insieme a lebbrosi ciechi,da parte di padre Savino Mombelli dal Brasile (“ilpozzo qui è la vera religione”) e altri memorabilipadri salesiani.2 Non fu un caso che a Rodas, aPedro, a Giulio Pianello, Manzi dedicò La lunanelle baracche, Firenze 1974. Ancora nel 1983 JuanCarlos da Lima: “la tua amicizia come uomo eamico significa molto per me” e nel 1994 da Ale-jandro: ”Alberto, fratello, grazie per tutto”.Aveva una straordinaria capacità di comunica-zione e di ascolto, lottava sempre per la dignitàumana e amava ripetere che “siamo angeli conun’ala sola, possiamo volare soltanto restando ab-bracciati”. Usava il sarcasmo con i potenti e l’ironia era la suacifra abituale. L’ironia come potente mezzo espres-sivo, l’ironia per tendere alla verità – come oppor-tunamente sostiene Stefano Romiti – l’ironia perun ribaltamento delle prospettive, l’ironia per unascolto più totale e libero.Tutta la sua attività culminò nella celebre trasmis-sione televisiva “Non è mai troppo tardi” nata daun’idea di Nazzareno Padellaro, pedagogista cat-tolico e responsabile di “Tempo di scuola” e diret-tore generale del Ministero della pubblicaistruzione.Allora insegnava presso la scuola elementare Ban-diera di Roma, e quando fece il provino per lanuova trasmissione televisiva, volle improvvisarela lezione a modo suo, convinto com’era che tantonon aveva nulla da perdere e che sarebbe entrato
in Rai il solito raccomandato. Chiese ed ottenneche gli comprassero dei cartoncini, dei pennarellie dei fogli di carta molto grandi. Sino al momentoin cui una voce dall’oltretomba disse ”questo èquello buono per noi, mandate a casa gli altri,l’abbiamo trovato”.L’obiettivo era quello di fare del pubblico la pro-pria classe, disegnando e scrivendo su fogli men-tre spiegava: riuscì in una impresa quasiimpossibile, entrare nel cuore, nella mente ditanta gente, guardando negli occhi una vastissimaclasse di invisibili. Alla fine dei vari cicli sarannoquasi un milione e mezzo gli italiani che grazie alui, attraverso la sua trasmissione, conseguirannola licenza elementare. Più che insegnare a leggeree a scrivere, invogliava gli allievi a farlo perché“occupare una posizione di comando è una oppor-tunità per essere utili, non uno squillo di trombaper la propria presunzione”.Fu un successo strepitoso tanto che nel 1965venne premiato anche a Tokyo, e nel 1987 il go-verno argentino, il presidente Raul Alfonsine inprimis, l’invitò a tenere un corso per docenti uni-versitari incaricati di preparare un piano di alfa-betizzazione. Questo piano verrà poi consideratocome un modello internazionale e fu accreditatodel premio Unesco nel 1989.Complessa la sua figura, quella di un uomo conampi tagli sui polpastrelli dovuti ai gessetti tenutiper decenni e decenni fra le dita davanti alle lava-gne di mezzo mondo. Dalle esperienze sul campo,trasse la volontà di raccontare, senza retorica esenza infingimenti, la vita dei raccoglitori di cauc-ciù e la vita dei detenuti per motivi politici. Ebbe un’infinità di riconoscimenti, ma quelli a cuitenne di più provenivano “dalla gente semplice,da coloro a cui dò una mano perché siano padronidel loro pensiero”: “mio fratello – scriveva una si-gnora – ha 35 anni, ha tentato il suicidio diversevolte. Sono 30 anni che è inchiodato sulla carroz-zella. Niente scuola, niente di niente. Ma daquando lei ha cominciato a parlare, da quando lovede in tv, è cambiato. Ora legge, sta tentando discrivere. Che dice, ce la farà?”. Ce la fece, imparòa leggere e scrivere, ebbe nuovi stimoli per la suavita e quando prese la maturità scientifica AlbertoManzi andò ad abbracciarlo. Su un foglietto con una calligrafia titubante, Mar-zia diceva: “Caro maestro ti volio bene e ti legosempre”, mentre la signora Margherita Popoliziogli voleva far sapere che, per merito suo, il piccolofigliolo che non poteva camminare e usare le ma-nine, vedendolo e ascoltandolo, aveva cominciatoa scrivere, tenendo in bocca la penna. La signora,madre di otto figli, parlava del piccolo Antonio
SAGGI 7

che “in compenso è intelligentissimo. E il maestrosapete chi è stato? Siete stato voi, il vostro volto,la vostra voce gli hanno insegnato la cosa piùbella, scrivere e leggere. Segue ciò che voi inse-gnate, pende dalle vostre labbra e non dimenticanulla di quanto voi dite. E’ un vostro alunno de-voto che vi rimarrà grato per tutta la vita”. Ilbimbo poi scrisse: “Vi voglio bene, firmato Popo-lizio Antonio”.3
Sempre in lotta con la burocrazia, fu persino de-nunciato perché non voleva compilare le schededi valutazione, con particolare riferimento ai casinegativi, perciò venne sospeso per alcuni mesi conripercussioni sullo stipendio. Amava mettere untimbro su quelle schede dove era scritto:FA QUEL CHE PUO’, QUEL CHE NON PUO’NON FA. Il motivo derivava dal fatto che non intendevabollare un allievo carente con un giudizio che po-teva rimanere lì nel tempo. Le persone cambiano,si evolvono, sono in continuo movimento e non ègiusto etichettare così i casi più difficili.A Pitigliano4, dove fu sindaco – sin quando le cat-tive condizioni di salute non lo avevano costrettoalle dimissioni, e dove venne commemorato a 73anni nella chiesa di S. Maria Assunta - alcuni am-bienti affermano che Manzi appartenne al Goi,così come un anziano massone dell’Oriente di Vi-terbo ha sostenuto, de oculi, la sua appartenenzalatomistica. Del resto la loggia “Giordano Bruno”all’Oriente di Ferrara ha dedicato ad AlbertoManzi una bella tavola intitolata: “Alberto Manzi,maestro nella vita e in loggia”. Non casualmenteManzi non dimenticò mai di lavorare e di rifletteresulle opere di massoni scrittori per ragazzi da Col-lodi a De Amicis, oppure come fece comprenderecol premio nobel Kipling in Storie proprio così “Ru-dyard Kipling”, Brescia 1957, senza dimenticare ta-luni massoni a lui cari via via incrociati nel suopercorso. Nell’ultima bellissima intervista poco prima dimorire (diciassette anni dopo la dipartita di unaltro grandissimo del settore, Gianni Rodari), a Pi-tigliano, il prof. Roberto Farnè dell’Università diBologna ricorda: “si ostinava a lavorare e a pen-sare, e a sorridere”. Malgrado la sua personaleforte afflizione, non mancò mai, nemmeno allora,di avere la capacità e la volontà di stringere a sé lealtrui afflizioni, con stampato sul volto l’eternosorriso che scaldava il cuore. “Il suo sorriso e ilsuo sguardo rivelavano lo stato d’animo di unapersona pacata e forte, che comunicava insieme auna eccezionale carica emotiva e affettiva, unesplicito ottimismo della volontà”. E’ proprio veroche il sorriso è l’impronta digitale del genere
umano!Sosteneva che gli insegnanti di norma lavoravanocon passione, ma a volte non avevano ben chiarol’obiettivo da perseguire e da raggiungere con i ra-gazzi: “spesso si confonde il programma conquella che deve essere la crescita intellettiva delragazzo stesso”, dimenticando di fare sino infondo il proprio dovere. In particolare per merito dei colleghi dell’Univer-sità di Bologna e della regione Emilia-Romagna,della Rai, del Ministero dell’Istruzione e dell’Uni-versità, ora a Bologna è conservato il patrimoniodocumentale di Alberto Manzi presso la Biblio-teca dell’Assemblea regionale con l’istituzione ap-punto del Centro Alberto Manzi da cui ho trattomolti spunti di pregio.5
Si tenga presente altresì che Manzi è stato uno deirari autori di racconti per ragazzi che aveva decisodi far finire male le storie da lui raccontate, con lamorte della persona o dell’animale protagonista.E faceva questo scientemente perché bisognava fi-nirla, sosteneva, con le storie che terminavano con“e vissero felici e contenti”, in tal modo la storiafiniva lì e i ragazzi smettevano di pensarci, mentredovevano continuare a interrogarsi e a meditaresul perché era morto il loro eroe. Il giovane devedivertirsi, deve poter sorridere, deve amare la vi-cenda che legge, ma deve anche riflettere e fare iconti con la realtà, che non è fatta solo di affetti edi comprensioni familiari e amicali, non è solo dirose e fiori, ma deve essere l’anticamera della vitareale.Ciò che veramente gli interessava era svilupparepiù che si poteva il senso critico delle nuove ge-nerazioni e dimostrare che la vita è fatta per essereusata, e usata bene, non per essere un inutile sup-pellettile sul comò del niente. Lo stimato amico, prof. Andrea Canevaro, peda-gogista di profilo internazionale, sostiene cheManzi vuol mettere “il povero, il derelitto, il mar-ginale in un contesto che gli dia rilievo, che lorenda bello, affascinante, utile. Il bello è ancheutile: è utile perché ti consente di guardare oltre”.Il maestro Manzi, uomo d’azione ha sempre vo-luto mettere i suoi polpastrelli nella sofferenzadella gente, in particolare dei deboli e degli emar-ginati, accettando tutte le sfide, come uomo, comemaestro, come massone, andando sistematica-mente alla ricerca di linguaggi e strategie per ri-dare dignità e partecipazione alle persone. E’ stato il primo incomparabile mito della televi-sione educativa, strada poi seguita da un altrouomo della sua stessa razza, Piero Angela, ed èsempre stato una persona capace di stupirsi conl’amabilità dei bimbi: “chi perde la capacità di
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 20178

stupirsi è un uomo interiormente morto. Chi con-sidera tutto un dejà vu e non riesce a stupirsi diniente ha perso la cosa più preziosa, l’amore perla vita” (R. Kapuscinski).Quando nel 1950 scriveva ai vertici ministerialisferzanti considerazioni (“pensierini cattivi avve-lenati dalla bile di un fegato marcio”), sostenevache “la scuola di oggi è la rovina del prossimo fu-turo. Il male è alle radici, è nel tronco, è nei rami,dovunque. Maestri impreparati e che non vo-gliono prepararsi sono dilagati nella scuola travol-gendo i pochi onesti”. Parole brucianti, attuali ogni giorno di più.
Alberto Manzi è una figura esemplare, per il pro-fondo senso critico, per l’ironia, per la problema-tica del dubbio, per il rigore e l’onestàintellettuale, per il sorriso ammaliante, per la suacapacità di stupirsi anche a settant’anni, per la suatensione ad un miglioramento continuo, perchéera eternamente curioso, perché era un sognatoree un idealista che voleva solcare mari sempre piùvasti, per lo straordinario solidarismo internazio-nale, eternamente alla ricerca dell’essenza più in-tima della sua persona e di quella degli altri.
Grazie, caro Alberto, per esserti cimentato ogni giornodella tua esistenza alla realizzazione del miracolo di dareforma d’arte e di nobiltà all’insegnamento e alla vita. Eridestinato sin da ragazzo alla sensibilità, eri destinato a di-ventare un maestro, eri destinato a diventare uno scrittore,eri destinato a diventare Alberto Manzi. Addio, fraterno amico, continua là dove sei a raccontarele tue storie che noi qui continueremo a raccontare di te!
Bibliografia
A. Manzi, I racconti della giungla, Brescia 1957;A. Manzi, Testa rossa, Milano 1957;A. Manzi, Gli animali e il loro ambiente: Gli animali intornoa noi: la terra e i suoi segreti, Milano 1968;A. Manzi, La terra e i suoi segreti, Milano 1968;A. Manzi, Vacanze, Roma 1968;D. Giancane, Alberto Manzi e il fascino dell’infanzia, Milano1975;R. Farnè, Buona maestra tv. La Rai e l’educazione da “Non èmai troppo tardi” a “Quark”Roma 2003;A cura di F. Genitoni ed E. Tulioz, Alberto Manzi. Storiadi un maestro, Modena 2009;R. Farné, Alberto Manzi. L’avventura di un maestro, Bologna2011;A. Manzi, Tupiriglio, Milano 2011;A. Manzi, E venne il sabato, Milano 2014;G. Manzi, Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vitatante vite, in collaborazione con A. Falconi e F. Taddia,Torino 2014.
1 Grogh venne poi tradotto e pubblicato persino ingiapponese da Giunko Jwasaki di Kughenuma, chescrisse una bella lettera al maestro, dichiarando di leg-gere e tradurre da anni autori italiani dalla Deledda aPirandello, da Moravia a Guareschi, e che era rimastoammirato dopo aver scoperto i suoi scritti.2 Padre Savino Mombelli è deceduto di recente ed èstato seppellito a Belem dove ha vissuto per cinquan-t’anni. E’ stata una figura splendida di missionario e alui sono legate cento e cento storie di adozioni a di-stanza, di case d’accoglienza per giovani orfani, di caseper i senza tetto. Una vita spesa per gli emarginati e peri poveri e il nostro paese può essere orgoglioso di luialla stessa stregua del salesiano Giulio Pianello, semprein prima fila ad aiutare la povera gente, ad alfabetizzarele persone, a denunciare le condizioni di schiavitù e dioppressione. Per punire padre Giulio, per dargli unalezione, soprattutto per aver insegnato a scrivere allepopolazioni indigene, arrivarono al punto di spaccarglile mani.3 Nel 1965 da Lugano il signor Bruno Bucher scrivevache il suo nipotino Robi non perdeva mai una sua le-zione, e il bimbo confermava di suo pugno: “non vadoa scuola o imparato da te”. La signora Eugenia Borelli,con molta schiettezza: “Lei scoppierà a ridere, ma in te-levisione, in tutto il numero del personale, ne amo duesoli: padre Mariano e l’insegnante Alberto Manzi”.Laura di Firenze di undici anni apprezzava particolar-mente “il messaggio contro ogni razzismo di ciascunaspecie”, mentre Barbara di Rimini di dodici anni nel1983: “Io ho capito che lei è una persona semplice,brava e paziente. La sua famiglia deve essere fiera dilei”. La professoressa Claudia Fraccon di Marzanapresso Verona, pur a distanza di molti anni da quandoera piccolina: “non ho mai dimenticato il mio maestro”,e gli confidava che all’epoca “a dirla tutta mi ero inna-morata di lei e quando mia madre, ridendo, mi rivelòche lei era già sposato, ho pianto per giorni”.4 A Pitigliano, in località Pantano, vi è un Museo Ar-cheologico, affascinante viaggio fra natura e archeolo-gia su un progetto elaborato da Manzi nel 1996.5 Tantissime le tesi di laurea effettuate su AlbertoManzi dall’università della Valle d’Aosta all’universitàdella Calabria, dalle università di Bologna alla Sa-pienza di Roma, da Perugia a Parma, dalla Cattolica diMilano a Firenze, da Palermo a Siena, da Bari a Mes-sina, da Teramo a Modena e Reggio Emilia.
SAGGI 9

Nel centro di Bologna, lungo la via a lui de-dicata, possiamo ammirare oggi, dopovarie ricollocazioni, il monumento a Ugo
Bassi, realizzato nel 1888 grazie all’impegno dellamassoneria bolognese1. Lo scultore, Carlo Parmeg-giani, scelse di rappresentare Ugo Bassi in abito da bar-nabita durante una delle sue orazioni patriottiche, conil braccio disteso e il dito puntato, idealmente, controgli oppressori del popolo italiano2. Il piedistallo ri-prende le linee e lo stile dei chiostri medievali da cuiil sacerdote veniva e la facciata di San Petronio innanzialla quale predicava. Alla base del monumento sonopresenti i simboli massonici che ne ricordano l’inizia-zione all’Arte Reale. La statua bronzea non celebra UgoBassi combattente, né il suo martirio, ma coglie, conapparente semplicità, le diverse anime del sacerdotepatriota e racconta, a chi la sa ascoltare, la storia di unodei più complessi protagonisti del nostro Risorgi-mento.Nato a Cento il 12 agosto 1801 e battezzato comeGiuseppe Piero Gregorio Baldassarre, assunse inseguito il nome di Ugo, probabilmente in omaggioa Ugo Foscolo. Nel 1805, il padre Luigi Sante, im-piegato della dogana, fu distaccato a Bologna e lafamiglia lo seguì in città. Questo trasferimentoconsentì a Ugo Bassi di ricevere un’ottima istru-zione. Il giovane fu, infatti, iscritto alla scuola deiPadri Scolopi, dove si distinse immediatamenteper la vivida intelligenza e l’impegno nello studio.Il suo interesse era tuttavia volto verso gli avve-nimenti del suo tempo, come la caduta di Napo-leone e il ritorno di Bologna al governo Pontificio. Appena quattordicenne cercò di arruolarsi nel-l’esercito di Gioacchino Murat, sognando di con-tribuire alla formazione di un Regno di Italiaindipendente. Tuttavia, a causa della sua giovaneetà e della sua costituzione poco robusta, non fuaccettato3. Questa cocente delusione non intaccòil suo spirito energico, né il suo amor di patria che,anzi, si rafforzarono grazie alla frequentazione dicoetanei animati dalle medesime passioni. Dal-l’anno successivo, infatti, frequentò il celebre Gin-nasio di Santa Lucia, diretto dai Padri Barnabiti,a fianco dei figli delle più importanti famiglie bo-lognesi4, come il conte Filippo Agucchi5 e il conteLivio Zambeccari6, in seguito ferventi patrioti emembri della loggia Concordia7, che rimasero a luilegati per tutta la vita come amici e fratelli. Ugo
Bassi ricevette una solida istruzione classica, riu-scendo a distinguersi per i brillanti risultati otte-nuti negli studi8. Nel 1817, in seguito adun’infatuazione adolescenziale conclusasi tragica-mente9, e influenzato dal proprio confessore, presela decisione di entrare nell’ordine dei Barnabiti10. Nel 1818 fu accolto come novizio e si trasferì aRoma ove, tre anni dopo, pronunciò i voti mona-stici. I superiori lo indirizzarono inizialmenteverso l’insegnamento, ma Ugo Bassi scoprì che lapredicazione rappresentava la sua vocazione piùautentica. Profuse tutte le sue energie in un lungoperiodo di formazione, terminato il quale, nel1828, egli fu finalmente autorizzato a predicare inpubblico. Da allora, per vent’anni, pronunciò ipropri quaresimali in tutte le più importanti cittàdella penisola11. La voce calda e potente e la teatralità dei gesti diUgo Bassi animavano le sue prediche, colme di ci-tazioni colte e dal linguaggio ricercato. I cronistiriportavano: «La sua voce possedeva una meravi-gliosa estensione che dalla intonazione dolce e ca-rezzevole si elevava al ruggito del leone»12. Nelleprediche Ugo Bassi riusciva a fondere, in un me-raviglioso connubio, la sua profonda fede cristianacon quell’amor di patria che, sorto in lui fin dal-
UGO BASSI:PATRIOTA, BARNABITA, MASSONE
di Alessandro Boselli
Ugo Bassi
10

l’adolescenza, non lo aveva mai abbandonato. Du-rante i quaresimali, egli sottolineava la necessitàdi riconoscere i diritti degli oppressi e degli umili,denunciava i mali della società contemporanea eaccusava «i sacerdoti, [...] gli opulenti, [...] i so-vrani che non sanno, oppur non vogliono sapergovernare i loro popoli»13. Egli si scagliò anche,in modo deciso, contro l’oppressore austriaco:«Chi è colui che di ferro armato, osa contrastare ilsacro diritto delle genti?»14. Ugo Bassi fu acclamato in tutte le piazze della pe-nisola, ma biasimato dai propri superiori e daimembri di altri ordini religiosi. I gesuiti, in parti-colare, furono i suoi oppositori più tenaci e peri-colosi. Dal quaresimale di Bologna, del 1835, simoltiplicarono le insinuazioni e le critiche neisuoi confronti, fino a sfociare in una vera e propriapersecuzione. Le prediche di Ugo Bassi furono se-gnalate alle autorità ecclesiastiche ed egli fu accu-sato di eterodossia, di settarismo e di istigaredisordini e tumulti. Per questi motivi, fu relegatoa San Severino Marche e, successivamente, ban-dito dallo Stato Pontificio. In seguito, riuscì a tro-vare rifugio presso il cardinale Filippo GiudiceCaracciolo, arcivescovo di Napoli15. Durante il soggiorno napoletano, Ugo Bassi potédedicarsi alla produzione letteraria e, usando lopseudonimo di Ugo Plantageneto, diede allastampa la sua opera più poderosa: Luce e Amore. Nel 1844, il cardinale Caracciolo morì e i gesuitiripresero la persecuzione contro di lui, accusan-dolo di appartenere alla massoneria. I Barnabiticercarono di scagionarlo e lo protessero facendoloriparare a Palermo, presso l’ordine amico dei padriAgostiniani16. Ugo Bassi risulta iniziato alla Log-gia Concordia nel periodo compreso tra il 1845 e il184817 e fino alla sua morte ebbe sempre rapportidiretti ed epistolari18 con patrioti massoni. Nel1849, durante il tentativo di fuga a Comacchio,riuscì a farsi riconoscere dai patrioti locali propriograzie alla particolare stretta di mano che lo iden-tificava come appartenente all’Ordine19.Pur nelle avversità, Ugo Bassi continuò instanca-bilmente ad agire per la realizzazione di un idealedi libertà, di uguaglianza e di fraternità. Continuòa predicare accentuando l’enfasi patriottica e riuscìad ottenere colloqui privati prima con il papa PioIX, in cui vedeva una speranza di rinnovamentoper il clero, e poi con il re di Sardegna Carlo Al-berto, che cercava di stimolare ad impegnarsi di-rettamente per la causa italiana. Nel 1848, Ugo Bassi era già una figura popolarenell’Italia del tempo, ma furono gli ultimi dueanni di impegno e di azione a consacrarlo come“martire dell’indipendenza italiana”. Mentre l’Eu-
ropa e l’Italia erano attraversate da una travol-gente ondata di sollevazioni popolari e il Regnodi Sardegna scendeva apertamente in guerra con-tro l’Austria, Ugo Bassi, dopo aver preso probabil-mente parte ai moti siciliani20, si arruolò comecappellano nel contingente pontificio che Pio IXstava inviando ai confini con il Lombardo-Veneto.Trascinato dall’emozione di partecipare a una cro-ciata per la liberazione dell’Italia dal giogo au-striaco, Ugo Bassi predicò in ogni città e in ogniborgo attraversato dalle truppe, infiammando glianimi e facendo accorrere volontari. Il 23 aprile, le truppe pontificie raggiunsero Bo-logna, dove Ugo Bassi si fermò per alcuni giorni,pronunciando, insieme all’amico padre Alessan-dro Gavazzi, una serie di discorsi patriottici voltia richiedere denaro, cavalli e oggetti utili alletruppe21. Uomini e donne di ogni età e condizionedonarono tutto ciò che potevano e il successo fusuperiore ad ogni aspettativa: si calcola che, com-plessivamente, siano state raccolte circa centomilalire, oltre a seimila scudi in oro e argento22. Ai primi di maggio giunse a Bologna la notiziadell’Allocuzione Non semel, del 29 aprile23, e tuttele speranze riposte da Ugo Bassi nel pontefice crol-larono miseramente. Il padre barnabita decise dinon conformarsi più alle direttive del papa-Re edi raggiungere i volontari romani che, acquartie-rati presso Treviso, avevano deciso di continuarea lottare per la causa dell’indipendenza24. Quandoquesti furono investiti dall’attacco di Radetzky,Ugo Bassi, con indosso l’abito talare, armato solodella propria voce e impugnando una croce nellamano destra, fu alla testa dei suoi compagni du-rante gli assalti, incitandoli e prestando aiuto aiferiti; mentre cercava di soccorrere il generale Gui-dotti, colpito a morte, fu a sua volta gravementeferito in tre parti del corpo da colpi di moschettoe di mitraglia25. La sfortunata guerra austro-piemontese del marzo-agosto 1848 terminò mentre Ugo Bassi era ancoraconvalescente. La sua unica consolazione fu la no-tizia della vittoria dei Bolognesi nella battagliadell’8 agosto e, per celebrarla, compose il sonettoA Bologna vincitrice26. Dopo avere passato alcuni mesi a prestare soccorsospirituale ai feriti negli ospedali di guerra, UgoBassi si unì alle truppe napoletane, pontificie e aivolontari che, sotto la guida del generale Gu-glielmo Pepe, avevano deciso di continuare a com-battere per spezzare l’assedio austriaco di Venezia.Nonostante il conseguimento di alcune vittorie lo-cali fu, tuttavia, presto evidente che la spropor-zione di forze era tale da rendere impossibile ilcompito e l’esercito di Guglielmo Pepe si smem-
SAGGI 11

brò. Ugo Bassi si mise in marcia, insieme al contin-gente pontificio, per rientrare a Roma ove, in se-guito alla crisi politica, il papa era fuggito a Gaeta.Durante il tragitto, egli si congedò temporanea-mente per raggiungere a Bologna l’amico LivioZambeccari che, dopo aver trascorso numerosianni a combattere nell’America del Sud, era rien-trato in Italia per contribuire alla causa dell’indi-pendenza27. In città, Ugo Bassi si attivò perpromuovere la ripresa della guerra all’Austria, or-ganizzando riunioni, pubblicando opuscoli e ma-nifesti, e pronunciando discorsi in pubblico. Eglivisse tra i soldati del battaglione Alto Reno, di cuiera comandante Livio Zambeccari28, frequentò ilCircolo popolare, il Caffè dei Servi e altri luoghi di in-contro di patrioti, carbonari e massoni29. Questesue frequentazioni, che suscitarono scandalo tra iclericali e i conservatori, furono segnalate alle au-torità religiose. Per allontanarsi da una situazione potenzialmentepericolosa e per desiderio di azione, Ugo Bassi de-cise di lasciare Bologna per raggiungere Romaove, nel frattempo, era stata proclamata la Repub-blica. Profondamente deluso dal comportamentodel papa e dei sovrani, aveva, infatti, maturato laconvinzione che l’unica via per raggiungerel’unità d’Italia fosse la scelta repubblicana. Giuntoa Roma, Ugo Bassi riprese la propria opera di pre-dicatore per alcune settimane, poi fu mandato aRieti per assumere servizio come cappellano dellaLegione italiana. Il 4 aprile il padre barnabita incontrò GiuseppeGaribaldi, rimanendone fortemente impressio-nato: «Questo è l’eroe, cui cercando andaval’anima mia»30. Garibaldi fu, a propria volta, favo-revolmente colpito da Ugo Bassi, lo nominò cap-pellano militare della Legione e suo Aiutante diCampo, ed ebbe di lui l’impressione di un uomopronto al martirio31.Il 27 aprile, la Legione italiana entrò a Roma, cheera oramai circondata dalle truppe di Francia,Spagna e Regno di Napoli. Il contingente franceseattaccò la città tre giorni dopo, presso porta SanPancrazio, e i garibaldini li fronteggiarono. UgoBassi, a cavallo della sua “Ferina”32, si impegnò di-rettamente negli scontri, spostandosi sulla lineadi battaglia, dove i combattimenti erano più in-tensi. Proprio quando il contrattacco italiano aveva spez-zato le linee nemiche, giunse a Garibaldi l’ordineperentorio di ritirata33. Ugo Bassi, rimasto indietroper soccorrere un ferito, fu catturato e portato alcospetto del generale francese Oudinot34. Que-st’ultimo, dopo averlo interrogato, lo liberò, affi-
dandoli l’incarico di recare un invito alla resa alTriumvirato che reggeva la città e facendogli pro-mettere di riconsegnarsi subito dopo. Ugo Bassi sidimostrò un uomo d’onore: svolse il suo compitoe mantenne fede alla parola data. Il generale Ou-dinot, fortemente impressionato, gli consentì diritornare dai suoi compagni. Negli ultimi scontri, che videro Roma assediatadagli eserciti congiunti nel nome della Restaura-zione, Ugo Bassi si distinse in innumerevoli occa-sioni, sempre presente dove infuriava la battaglia,volontario per le missioni più rischiose e costan-temente a fianco dell’amico Garibaldi. In un’occa-sione, con due compagni, bloccò la spoletta di unagranata francese che era caduta ai piedi del de-striero dell’eroe dei due mondi e, in questo modo,forse, gli salvò la vita35. Dopo numerosi giorni di accanita quanto vana re-sistenza, mentre l’assemblea repubblicana si risol-veva per la capitolazione, Garibaldi scelse diripiegare a Nord per continuare la lotta e UgoBassi fu con lui. La ritirata si rivelò uno stillicidio.Perennemente incalzati dalla cavalleria austriaca,oltre la metà dei membri della legione di Gari-baldi si disperse. I fuggitivi, oramai allo stremo, furono spinti finoai confini della neutrale Repubblica di San Ma-rino. Qui, grazie all’accorato appello di Ugo Bassi
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201712

ai Reggenti del piccolo Stato, i superstiti riusci-rono ad ottenere viveri e, in seguito, la conces-sione di varcare il confine, sfuggendo così ad unattacco delle truppe austriache36. Temporanea-mente al sicuro in terra neutrale, i resti della Le-gione italiana riuscirono a concordare i termini diuna resa onorevole: gli austriaci promisero l’im-munità e la possibilità di raggiungere la propriacasa a chi si fosse arreso. La maggior parte dei garibaldini accettò questecondizioni, mentre Garibaldi, Ugo Bassi e altriduecento uomini, che volevano continuare a com-battere, scelsero di fuggire nella notte per cercaredi raggiungere Cesenatico e, da lì, Venezia che an-cora resisteva all’assedio austriaco. La fortuna, tut-tavia, non arrise a questo manipolo di irriducibili.La maggior parte di essi, infatti, fu intercettata ecatturata presso le Valli di Comacchio dalla flottae dalle forze di polizia austriache. Il 3 agosto, i pochi superstiti, tra i quali Ugo Bassi,il capitano Giovanni Livraghi, Garibaldi e la mo-glie Anita, riuscirono a prendere terra presso Lidodi Magnavacca (oggi Porto Garibaldi) e deciserodi dividersi ulteriormente per avere maggiori pos-sibilità di fuga. Dopo cinque mesi, Ugo Bassi siseparò così da Garibaldi e, con il capitano Livra-ghi, si diresse a Comacchio, sperando di trovarerifugio presso amici. I due fuggitivi trovarono ristoro alla locanda dellaLenza nei pressi di Porta del Carmine di Comac-chio. Qui, Ugo Bassi, grazie alla caratteristicastretta di mano massonica, si fece riconoscere daun patriota locale che si offrì di aiutarlo37. Pocodopo, tuttavia, denunciati da alcune spie, UgoBassi e Livraghi furono arrestati dai carabinieripontifici del comando locale38. Il capitano austriaco Gürtler mise a verbale cheUgo Bassi e Giovanni Livraghi erano stati arrestaticon le armi in pugno benché ciò, come si puòevincere dai primi rapporti e da numerose testi-monianze39, non rispondesse al vero. Il giorno successivo, mentre il vicario vescovile lo-cale cercava di intercedere presso il capitano Gür-tler affinché l’arresto di Ugo Bassi fosse fattonomine ecclesiae40, sopraggiunsero messi del coman-dante austriaco di Bologna, generale Gozkowsky,che rivendicava la giurisdizione sulla sorte di en-trambi i prigionieri. Il pomeriggio del 6 agosto,Ugo Bassi e Giovanni Livraghi furono scortati aBologna, ove giunsero il giorno successivo. I dueprigionieri furono immediatamente condotti al ko-mandantur austriaco presso Villa Spada e, poi, por-tati in una cella delle carceri della Carità. Tra il 7 e l’8 agosto mentre Ugo Bassi e il capitanoLivraghi trascorrevano una notte insonne, qual-
cuno decise il loro destino. Una parte della stampalaica diffuse la notizia che, nella notte, la Curiaaveva riunito un concilio di nove prelati italiani etre cappellani miliari ungheresi e tenuto un pro-cesso segreto che si era concluso con la condannaa morte per il padre barnabita. Secondo un’altraversione, fu il monsignor Bedini, commissariostraordinario del Papa, a pronunciare la sentenzadi morte41. Bisogna, tuttavia, anche contemplarela possibilità che sia stato il generale Gorzkowkya voler dare un segnale ai patrioti proprio nelprimo anniversario dell’8 agosto 1848, giorno incui il popolo bolognese aveva cacciato la guarni-gione austriaca. Nessuna di queste ipotesi è suf-fragata da prove certe e, pertanto, non è possibiledeterminare con certezza chi abbia preso una cosìgrave decisione. Alle 11.30 dell’8 agosto 1849, senza alcun pro-cesso, il comandante austriaco lesse ai due prigio-nieri la sentenza: il capitano Giovanni Livraghisarebbe stato fucilato in quanto disertore del-l’esercito austriaco, mentre Ugo Bassi avrebbe su-bito la stessa sorte perché trovato in possesso diarmi al momento dell’arresto. Dopo la lettura dellasentenza, Ugo Bassi chiese di potersi confessare edomandò della carta per scrivere un saluto a Bo-logna e le sue estreme volontà42. Il pezzo di cartagli fu negato ma, dopo l’esecuzione, il padre ge-suita Bresciani cercò di strumentalizzare quest’ul-timo atto per affermare che Ugo Bassi si era inultimo pentito e aveva abiurato Garibaldi e l’ideadi Italia43. La falsità di queste affermazioni si può desumeredal comportamento tenuto da Ugo Bassi il giornodella fucilazione. Infatti, mentre veniva condottofuori da Porta S. Isaia44, egli disse che l’anima sua«non si sarebbe dipartita dal trono dell’Eterno fin-ché non avesse ottenuta la liberazione della Pa-tria»45. Poco dopo, di fronte al plotone diesecuzione, mentre un ufficiale austriaco ordinavaai soldati di aprire il fuoco, gridò: «Io muoio in-nocente; muoio per la libertà; muoio per la patria.Perdono a’ miei uccisori. Viva Gesù! Viva Maria!Viva l’Italia!» 46. Non riuscì a completare l’ultimaparola, forse la più cara, interrotto da sette proiet-tili che gli attraversarono il petto e il cranio47.I corpi di Ugo Bassi e di Giovanni Livraghi furonoseppelliti in una fossa vicino al luogo della fuci-lazione che, da quella stessa notte, divenne metadi pellegrinaggio per i cittadini bolognesi, cheportavano corone di fiori e palme. Dieci giornidopo Monsignor Bedini, temendo che il corpo diUgo Bassi venisse dissotterrato per farne oggettodi venerazione, in tutta segretezza, ne ordinò lospostamento in una tomba anonima all’interno
SAGGI 13

della Certosa48. Solo nel 1859, le ossa di Ugo Bassi furono, infine,deposte all’interno della sala delle Catacombe,con una semplice lapide «Ugo Bassi – Martiredella libertà -1849» a ricordare la vita e il sacrificiodi Ugo Bassi, patriota cattolico, profondamentemassone, che si sentiva italiano e che seppe mo-rire con lo stesso coraggio che lo aveva contraddi-stinto in vita.
Bibliografia
Biblioteca del Museo Civico del Risorgimento di Bo-logna, Fondo Ugo Bassi, buste 1-11; Enrico Spartaco, Livio Zambeccari, Marzorati, Torino,1859;Luigi Gualtieri (a cura di), Memorie di Ugo Bassi, apostolodel Vangelo, martire dell’indipendenza italiana, Tip. Monti,Bologna, 1861;Stefano Fioretti, Opere sacre e politiche di Ugo Bassi, Monni,Genova, 1864;Francesco Bertolini, Livio Zambeccari. Cenni biografici, Za-nichelli, Bologna, 1885; Jessie W. Mario, Della vita di Giuseppe Mazzini, Sonzogno,Milano, 1886;Didaco Facchini, Biografia di Ugo Bassi: con note ed appen-dici, Zanichelli, Bologna 1890;Lorenzo Simoncini, Giuseppe Garibaldi e Ugo Bassi in SanMarino: 29 luglio 1849. Appunti storici, Tipografia Balducci,Rimini, 1894;Giuseppe Boffito, Francesco Fracassetti, Il Collegio di SanLuigi dei PP. Barnabiti in Bologna – 1773-1873-1923. Notizieedocumenti raccolti e ordinati dai PP. Giuseppe Boffito e France-sco Fracassetti; Giuntina, Firenze, 1923;Nestore Morini, L’arresto di Ugo Bassi e Giovanni Livraghi:nei documenti dell’Archivio di Stato di Bologna, Brunelli, Bo-logna, 1928;Umberto Beseghi, Ugo Bassi. L’apostolo, Donati, Parma,1939; Umberto Beseghi, Ugo Bassi. Il martire, Marzocco, Fi-renze, 1946; Giordano Gamberini, Mille volti di massoni, Erasmo,Roma, 1975;Carlo Manelli, La massoneria a Bologna dal XVIII al XX se-colo, Analisi, Granarolo dell’Emilia, 1986;A.A.V.V., Ugo Bassi: predicatore di San Petronio, martire ga-ribaldino, PSI Comitato regionale Emilia-Romagna, Bo-logna, 1990; Arrigo Petacco, W GESÙ W MARIA W L’ITALIA. Ugo Bassi,il cappellano di Garibaldi, Nuova Edizioni del Gallo,Roma, 1990;Enrico Nassi, La massoneria in Italia, Newton Compton,Roma, 1994;A.A.V.V., 200 anni di Massoneria ad Imola: studi storici suUgo Bassi e Andrea Costa, La Mandragora, Imola, 1997;Fulvio Conti, Storia della Massoneria italiana: dal Risorgi-mento ad fascismo, il Mulino, Bologna, 2003;Fulvio Conti, Marco Novarino (a cura di), Massoneria eUnità d’Italia. La Libera Muratoria e la costruzione della na-
zione, Il Mulino, Bologna, 2011;Santi Fedele, La massoneria italiana tra Ottocento e Nove-cento, Bastogi, Foggia, 2011;Aldo A. Mola, Luigi Pruneti (a cura di), Risorgimento emassoneria, Atanor, Roma, 2013;Giovanni Greco (a cura di), Bologna Massonica: fra pas-sione e ragione, Clueb, Bologna, 2016.
1 Il monumento fu realizzato grazie ad una sottoscri-zione promossa dalla massoneria bolognese e, nell’ago-sto 1888, un comitato composto da Giosuè Carducci,Aurelio Saffi, Oreste Regnoli e Giovanni Malvezzi,consegnò l’opera al sindaco della città Gaetano Tacconi.2 Il gesto riprende una delle pose abituali del predica-tore, come riportato dai quotidiani bolognesi Il Restodel Carlino e Il Secolo del giorno successivo all’inau-gurazione dell’opera. Si veda anche il dipinto di Napo-leone Angiolini Ugo Bassi sul sagrato di S. Petronioconservato al Museo Civico del Risorgimento di Bolo-gna.3 Stefano Fioretti, Opere sacre e politiche di Ugo Bassi,Monni, Genova, 1864, pp. 33-34 e Luigi Gualtieri (acura di), Memorie di Ugo Bassi, apostolo del Vangelo, martiredell’indipendenza italiana, Tip. Monti, Bologna, 1861, pp.11-12.4 Giuseppe Boffito, Francesco Fracassetti, Il Collegio diSan Luigi dei PP. Barnabiti in Bologna – 1773-1873-1923. No-tizie e documenti raccolti e ordinati dai PP. Giuseppe Boffito eFrancesco Fracassetti; Giuntina, Firenze, 1923, pp. 224-225.5 Destinato a divenire colonnello comandante dellaGuardia Civica di Bologna nel 1847-48.6 Una delle figure più illustri della storia del nostro ri-sorgimento e personaggio di grande caratura morale.Fervente patriota, combatté in Spagna, Sud America eItalia, impegnandosi inoltre per la rifondazionedella massoneria italiana. Fondatore della loggia Con-cordia (poi Concordia Umanitaria) di Bologna e dellaSocietàOperaia, fu Gran Maestro ad interim del GrandeOriente d’Italia tra il 1861 ed il 1862.7 Carlo Manelli, La massoneria a Bologna dal XVIII al XXsecolo, Analisi, Granarolo dell’Emilia, 1986, pp. 58 e 65-66.8 Giuseppe Boffito, Francesco Fracassetti, op. cit., p.221.9 La morte per tisi della giovane Annetta Bentivogli, so-rella di un proprio amico e compagno di studi. Si vedaStefano Fioretti, op. cit., pp. 42-43.10 Arrigo Petacco, W GESÙ W MARIA W L’ITALIA. UgoBassi, il cappellano di Garibaldi, Nuova Edizioni del Gallo,Roma, 1990, pp. 19-21.11 Umberto Beseghi, Ugo Bassi. L’apostolo, Donati, Parma,1939, p. 23.12 Articolo di giornale, Biblioteca del Museo Civico delRisorgimento di Bologna, Fondo Ugo Bassi, serie A,busta 2.
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201714

13 Si veda la Memoranda Predica di Ugo Bassi fatta inBologna nel 1840, in Biblioteca del Museo Civico delRisorgimento di Bologna, Fondo Ugo Bassi, serie A I,busta 1.14 Ibidem.15 Arrigo Petacco, op. cit., p. 31.16 Ivi, p. 32.17 Carlo Manelli, op. cit., pp. 173, 175-176 e 180-181.La Biblioteca del Museo Civico del Risorgimento diBologna conserva, nel Fondo Ugo Bassi, serie G, busta11, un documento in cui si riporta l’impressione di unantico timbro di legno della loggia Concordia apparte-nuto a Ugo Bassi.18 Si veda la lettera di Ugo Bassi al conte AlessandroAgucchi, in Biblioteca del Museo Civico del Risorgi-mento di Bologna, Fondo Ugo Bassi, serie A, busta 1.Il conte Alessandro Agucchi era uno dei più autorevolimassoni dell’epoca: prefetto di Bologna nel 1815 emembro della Commissione di governo di Bologna che,durante i moti del 1830-31, votò per la decadenza deldominio pontificio.19 Umberto Beseghi, Ugo Bassi. Il martire, Marzocco, Fi-renze, 1946, p. 169.20 Arrigo Petacco, op. cit., p. 45.21 Ivi, pp. 48-49.22 Umberto Beseghi, Ugo Bassi. L’apostolo, op. cit., p. 242.23 Pio IX, chiarì pubblicamente che non intendeva in-traprendere una guerra offensiva contro il cattolico im-pero asburgico: “ […] Noi, ai nostri soldati mandati alconfine pontificio raccomandammo soltanto di difen-dere l’integrità e la sicurezza dello Stato della Chiesa.Ma se a quel punto, alcuni desideravano che noi as-sieme con altri popoli e principi d’ Italia prendessimoparte alla guerra contro gli Austriaci, giudicammo con-veniente palesar chiaro ed apertamente in questa so-lenne radunanza che ciò è lontano dalle Nostreintenzioni […].24 In giugno il comando del presidio della città fu as-sunto dal colonnello conte Livio Zambeccari. Si vedaEnrico Spartaco, Livio Zambeccari, Marzorati, Torino,1859, p. 31.25 Arrigo Petacco, op. cit., pp. 54-55.26 Biblioteca del Museo Civico del Risorgimento di Bo-logna, Fondo Ugo Bassi, serie A, busta 2.27 Francesco Bertolini, Livio Zambeccari. Cenni biografici,Zanichelli, Bologna, 1885, p. 23.28 Umberto Beseghi, Ugo Bassi. Il martire, op. cit., pp. 9-10.29 Alcuni delatori segnalarono la particolare intimitàdel padre barnabita con i massoni Livio Zambeccari ePietro Pietramellara e con il patriota Pietro Scarselli. Siveda Carlo Manelli, op. cit., pp. 65-66 e Umberto Be-seghi, Ugo Bassi. Il martire, op. cit, pp. 48-49.30 Ugo Bassi, Lettera del 24 aprile, in Umberto Beseghi,Ugo Bassi. Il martire, op. cit., p. 67.31A.A.V.V., Ugo Bassi: predicatore di San Petronio, martire ga-
ribaldino, PSI Comitato regionale Emilia-Romagna, Bo-logna, 1990; p. 9.32 La cavalla avuta in dono da Gioacchino Rossini nel-l’aprile 1848.33 Jessie W. Mario, Della vita di Giuseppe Mazzini, Sonzo-gno, Milano, 1986, p.341.34 Arrigo Petacco, op. cit., pp.67-68.35 Biblioteca del Museo Civico del Risorgimento,Fondo Ugo Bassi, busta 8, estratto di un verbale d’AstaChristies’s di Roma del 16/12/97, articolo 580. Una ver-sione leggermente differente di questo episodio è ri-portata nell’articolo Bologna per Ugo Bassi, pubblicatada Il Secolo. Gazzetta di Milano, del 7-8 agosto del1888. 36 Lorenzo Simoncini, Giuseppe Garibaldi e Ugo Bassi in SanMarino: 29 luglio 1849. Appunti storici, Tipografia Balducci,Rimini, 1894, pp. 11-13.37 Umberto Beseghi, Ugo Bassi. Il martire, op. cit., p. 169.38 Ivi, p. 174.39 Nestore Morini, L’arresto di Ugo Bassi e Giovanni Livra-ghi: nei documenti dell’Archivio di Stato di Bologna, Brunelli,Bologna, 1928; pp. 10; 13; 14. 40 Bettino Craxi in A.A.V.V., Ugo Bassi: predicatore di SanPetronio, martire garibaldino. op. cit., p.10.41 Arrigo Petacco, op. cit., p.86-87 e Carlo Manelli, op.cit., p. 175.42 Arrigo Petacco, op. cit., p.87.43 Addirittura padre Bresciani fece scrivere all’ultimoconfessore del padre barnabita una ritrattazione, co-stringendolo a sostenere che fossero parole dettate daUgo Bassi. Il padre gesuita, in realtà, non mostrò maiquesta falsa prova. 44 Dietro il muro dell’arcata 66 e 67 del portico che dalMeloncello va alla Certosa. In A.A.V.V., Ugo Bassi. Pre-dicatore di S. Petronio, martire garibaldino, op. cit., p. 38.45 Cit. in Arrigo Petacco, op. cit., p.89.46 Ultime parole del padre Ugo Bassi. Pronunciate nelgiorno di sua gloriosa morte l’8 agosto 1849, in Biblio-teca del Museo Civico del Risorgimento, Fondo UgoBassi, serie A, busta 2. 47 Ibidem.48 Lettera di Monsignor Bedini alla Commissione Go-vernativa di Stato sul dissotterramento del Cadaveredel P. Bassi. Si veda Luigi Gualtieri (a cura di), op. cit.,pp. 187-188.
SAGGI 15

“In Kümmernis und Dunkelheit”, ovvero “Nel doloree nell’oscurità”. È il titolo di quello che molto pro-babilmente è il più antico inno repubblicano te-desco. In realtà, ancora oggi in Germania lacanzone è più nota con un altro nome: “Schwarz-Rot-Gold”, “Nero-Rosso-Oro”: oltre ad essere i co-lori della bandiera della Repubblica federale,rappresentano quelli delle coccarde della rivolu-zione costituzionale del 1848 e dei vessilli dellasfortunata Repubblica di Weimar. Il testo dell’inno era stato scritto sotto forma dipoesia da Ferdinand Freiligrath, uno scrittore epoeta nato nel 1810 a Detmold, nell’attuale Nor-dreno-Wastfalia. Sedotto dalle grandi rivoluzioniamericana e francese e dai movimenti democraticiemersi dall’età napoleonica, il giovane intellet-tuale era stato iniziato alla Massoneria il 14 mag-gio 1842 nella loggia Zum Wiederbauten Tempel derBrüderliebe (“Al ricostruito Tempio dell’amore fra-terno”) di Worms. Quasi subito, tuttavia, si era di-stinto per una certa vis polemica nei confronti deiFratelli di loggia, dal giovane criticati a causadella loro eccessiva propensione alla speculazioneesoterica e dello scarso impegno politico. Nono-stante le sue origini indiscutibilmente teutoniche(era nato nei pressi della leggendaria foresta diTeutoburgo da un maestro di scuola dell’Essen eda una donna originaria della Ruhr), Freiligrathera un libero muratore di stampo più latino chegermanico: la lotta politica era vista dallo scrittorecome la naturale risultante della crescita interioreche si compiva tra le colonne del Tempio. Non èquesta la sede per ripercorrere la vita, avventurosae movimentata, dell’intellettuale di Detmold.Basti qui ricordare che il suo peregrinare da esuledemocratico lo avrebbe spinto in Inghilterra, Sviz-zera, Belgio (in quel Paese conobbe Karl Marx),Olanda e negli Stati Uniti, prima di tornare in pa-tria, dove fu più volte processato e perseguitatoquasi fino alla sua morte avvenuta nel 1876. Tra i tanti lasciti di questo sorta di Goffredo Ma-meli tedesco, vogliamo qui ricordare per l’ap-punto l’inno Schwarz-Rot-Gold, e in particolare unastrofa:
Die Freiheit ist die Nation,ist Aller gleich gebieten.
Die Freiheit ist die AuctionVon dreißig Fürstenhütten.Die Freiheit ist die RepublikUnd abermals: die Republik!
La Libertà è la NazioneDove tutti contano allo stesso modo.La Libertà è la vendita all’astadi trenta castelli dei principi.La Libertà è la Repubblica,e ancora una volta [lo ripeto]: la Repubblica!
E soprattutto è il ritornello, dal significato alche-mico e politico al contempo, che andrebbe eviden-ziato:
Pulver ist schwarz,
MASSONI, SOCIALDEMOCRATICI E LIBERALI CONTRO
IL NAZISMO. L’ORGANIZZAZIONE REPUBBLICANA DEL
REICHSBANNER NELLA GERMANIA DI WEIMAR.
di Marco Cuzzi
Manifesto dell’Eiserne Front
16

Blut ist rot, Golden flackert die Flamme!
La polvere [da sparo] è nera,il sangue è rosso,l’oro sfavilla la fiamma!
Non è quindi un caso che l’autore di questa “Mar-sigliese tedesca” fosse un massone. E non è uncaso se questo componimento sarebbe diventatol’inno del movimento di massa repubblicano pro-tagonista dell’ultima stagione democratica dellaGermania prima dell’avvento di Hitler: lo “Sten-dardo del Reich Nero-Rosso-Oro” (“ReichsbannerSchwarz-Rot-Gold”).
È il 1924. La giovane repubblica tedesca nata dallasconfitta della Grande guerra sta vivendo uno deisuoi momenti più oscuri. La Nazione è isolata nelcampo internazionale: incalzata dalla Francia e dalBelgio, che chiedono i pagamenti delle riparazionidi guerra, l’anno precedente si è vista occuparedalle truppe di quei Paesi la preziosissima Ruhr,bacino carbonifero e industriale di vitale impor-tanza. Le conseguenze finanziare di questa ulte-riore amputazione non si fanno attendere.L’inflazione galoppa come un cavallo imbizzarrito:nel novembre 1923 ci vogliono quattromila e due-cento miliardi di marchi per cambiare un dollaroamericano; per comprare cinque etti di margarinanon bastano dieci ore di lavoro e per un paio distivali a malapena è sufficiente la paga di sei set-timane; un uovo costa dagli otto ai dieci milionidi marchi e gli stipendi vengono ritirati con car-riole e carretti. La moneta tedesca, il glorioso Rei-chsmark, non vale più nulla, è carta straccia. Ecome uno straccio viene rappresentata della destranazionalista la bandiera nera-rossa-oro della Re-pubblica. In un manifesto del Partito popolare te-desco-nazionale (DNVP, la formazione politica piùreazionaria e monarchica della nuova compagineparlamentare, fondata nel novembre 1918 da ungruppo di nostalgici guglielmini) la gloriosa ban-diera è stata trasformata in un ridicolo pannolinoche sembra fasciare un’aquiletta starnazzante,quasi una gallina, simbolo della traballante Re-pubblica: ad essa contrapposta, sul manifestocompare con ali spiegate un’inquietante, marziale,teutonica aquila imperiale che trattiene trai pode-rosi artigli il vessillo rosso-bianco-nero del depo-sto Secondo Reich. La destra più estrema, nel giovane Stato democra-tico, è forte, ancorata alle vestigia del passato, do-minata dalla certezza che la sconfitta sia sorta daun tradimento ordito dal solito complotto giu-
daico-marxista: sui fogli dei movimenti degli excombattenti e sui periodici della DNVP appaionoricostruzioni dei fatti di novembre 1918 ed evoca-zioni della cosiddetta “leggenda della pugnalataalle spalle” (libera traduzione del termine tedescoDolchstoßlegende) che oggi potremmo definire clas-sici esempi di “post-verità”. La pace non l’hannochiesta i generali resisi conto del collasso strate-gico (come in realtà è avvenuto), ma è stata impo-sta all’imperatore dai “traditori di novembre”, iNovemberverräter (detti anche Novemberverbrecher, i“criminali di novembre”): ovvero i socialdemocra-tici (sovente, guarda caso, ebrei), i liberali di sini-stra, la borghesia repubblicana e progressistainfarcita dai miti della rivoluzione costituzionaledel 1848. Una rivoluzione, quest’ultima, giudicatadai nazionalisti – non del tutto a torto, peraltro –come una contaminazione franco-massonica delletradizioni vőlkisch della grande Germania. Ma la destra radicale non si ferma all’insulto. Nelmarzo 1920 un politico prussiano monarchico,Wolfgang Kapp, ha tentato un putsch di stampoproto-fascista contando su ampi settori ammuti-nati della Reichswehr, l’esercito regolare. Lo storicoErich Eyck, nella sua monumentale ricostruzione,definisce l’iniziativa di Kapp una “delittuosasciocchezza”. Tuttavia quando il governo socialde-mocratico chiede al generale von Seekt, capo deldipartimento operativo del ministero della Difesa,di far intervenire le unità lealiste per reprimerel’insurrezione, si sente rispondere dall’alto uffi-ciale che “la Reichswehr non spara sulla Reichswehr”.Il putsch sarà fatto fallire da uno sciopero generaledei sindacati, ma l’atteggiamento del vertice del-l’esercito dimostra la crisi di legittimità e la fragi-lità del giovane Stato democratico. L’eversionequindi prosegue quasi indisturbata: il 26 agosto1921 Matthias Erzberger, leader della sinistradella partito cattolico di Centro (Zentrum) viene as-sassinato da un commando terrorista di estremadestra perché colpevole di essere stato uno dei fir-matari dell’armistizio di Compiègne. Il 24 giugnodell’anno seguente è la volta di Walther Rathenau,esponente di punta del Partito democratico tede-sco (DDP) e al momento ministro degli Esteri.Membro del “B’nai-B’rith” ebraico, figlio del mas-sone fondatore dell’AEG Emil, Rathenau appareagli occhi dell’estrema destra come la quintes-senza del Novemberverbrecher: ebreo, membro dellapotente fratellanza ebraica, figlio di un noto mas-sone, repubblicano convinto. Infine, l’8 novembre1923 è la volta di un giovane, arruffato e fanaticoreduce, l’austriaco Adolf Hitler, che tenta con ilsuo piccolo partito nazionalsocialista (NSDAP) unputsch nazionalista e vagamente separatista a Mo-
SAGGI 17

naco di Baviera. Ma non basta. Anche la sinistra più estrema mettein discussione l’istituzione repubblicana. Il partitosocialdemocratico (SPD, a lungo maggioritario nelPaese e di fatto principale “socio fondatore” dellaRepubblica), per diversi anni ha avuto alla sua si-nistra una formazione socialista indipendente(USPD) che ha sempre messo in discussione l’ap-poggio della SPD al conflitto e il suo eccessivo le-galitarismo istituzionale. Da una frazione radicaledella USPD è nato un Partito comunista (KPD) cherifiuta categoricamente ogni collaborazione con isocialdemocratici, ponendosi di fatto su posizionianti sistema. Non si tratta affatto di uno sparutogruppuscolo di agitatori: alle elezioni federali delmaggio 1924 la KPD otterrà oltre il dodici percento dei voti, equivalenti a 62 deputati. Anche inquesto caso l’opposizione di sinistra non disdegnainiziative extra legali. Tra il 1918 e il 1919 una“Lega di Spartaco” (Spartakusbund) ha tentato diinstaurare nel nord del Paese una repubblica distampo sovietico (seguendo i dettami trotzkystidella “rivoluzione esportabile”). E in Baviera il so-cialista indipendente Kurt Eisner ha provato acompiere un’operazione simile. Nel 1921 e poi nel1923 altre insurrezioni comuniste si verificano adAmburgo, mentre si forma nel Nordreno una “Ar-mata rossa della Ruhr”. Il coraggioso ministrodegli interni socialdemocratico Gustav Noske(“qualcuno dovrà pure fare la parte del mastino”,aveva detto) riesce a reprimere la rivolta di Ber-lino, ma per farlo ha dovuto affidarsi a quei reduci(i Freikorps, cioè i “Corpi franchi”) che solo in partesi dimostreranno leali nei confronti della Repub-blica. La maggioranza di questi paramilitari, almomento opportuno, si schiereranno con la piùconvinta reazione.In sintesi, nel 1924 (anno in cui il popolo tedescoè chiamato a votare due volte, in maggio e in di-cembre, a causa della profonda instabilità politica)tra i nazionalisti della DNVP, i comunisti dellaKPD e i seguaci di Hitler, mascherati sotto unasigla di comodo in quanto la NSDAP è fuorilegge,le forze dichiaratamente anti democratiche possocontare su oltre un terzo di deputati al Reichstag. Ele cose sono destinate a peggiorare. Soprattutto te-nendo conto che la tendenza dei partiti di Weimarè quella di dotarsi di unità paramilitari da affian-care ai militanti nel corso delle manifestazioni:un’inquietante, ulteriore ipoteca che si stendesulle istituzioni. La DNVP può fare affidamentosu varie organizzazioni paramilitari di reduci, lapiù famosa delle quali è senza dubbio la Stalhelm- Bund der Frontsoldaten (“Elmo d’acciaio - Lega deisoldati del fronte”, con circa 400 mila aderenti);
Hitler, temporaneamente in prigione dopo il fal-lito putsch di Monaco, ha creato con altri reduciprima le Saalschutz-Abteilungen (una cosa tipo “Re-parti di protezione della sala”), ribattezzate nel1921 Sturmabteilungen (SA, “Reparti d’assalto”,dall’inconfondibile camicia bruna, il cui numeroda 170 mila nel 1930 ben presto supererà il mi-lione). I comunisti, dal canto loro, daranno origineal Rotfrontkämpferbund (“Lega dei combattenti delFronte rosso”, con circa 100 mila militanti). LaGermania sembra trasformata in un’immane ca-serma, dove tutti sfilano, sovente minacciosi, conuniformi e non di rado armi. L’ennesima con-ferma, semmai ce ne sia bisogno, della crisi isti-tuzionale che domina il Paese.I governi che si susseguono dal novembre 1918(ce ne sono stati dieci in cinque anni) fanno il pos-sibile per arginare questa guerra civile strisciante.Nel 1923 si è tentato di risolverla proibendo i par-titi estremisti (DNVP, NSDAP, KPD), ma il legali-tarismo democratico del presidente federaleFriedrich Ebert (il leader socialdemocratico chegestirà fino alla sua morte il primo lustro di vitadella Repubblica) li ha fatto riapparire più fortiche mai. La Repubblica ha bisogno quindi di una mano. LaSPD ne è convinta. Il Partito socialdemocratico haabbracciato da tempo la via riformista e da quandoha ereditato lo Stato dal deposto Impero (“SignorEbert”, aveva solennemente detto il principe ere-ditario al futuro presidente durante le concitategiornate del novembre 1918, “le affido il DeutschesReich”; “Ho perduto due figlioli per questo Reich!”era stata la laconica risposta del capo della SPD)si sente l’architrave e al contempo l’antemuraledelle istituzioni. La Repubblica è anzitutto Re-pubblica del popolo, e va difesa. Imperfetta, certo.Ancora da perfezionare, riformare. Finanche datrasformare in un libero Stato socialista. Ma per ilmomento, questa va difesa da qualsiasi insidia, didestra o di sinistra. I sindacati sono per buonaparte al fianco del partito (e quindi, delle istitu-zioni): lo hanno dimostrato mobilitandosi controKapp e nei continui scontri all’interno delle fab-briche con i non trascurabili comunisti bolscevi-chi. Ma non bastano. Ne è convinto il presidente del Land della Sasso-nia, il socialdemocratico Otto Hőrsig, che il 22febbraio 1924 a Magdeburg, riunisce vari gruppisorti spontaneamente in tutta la Germania , tal-volta dai circoli della SPD, della DDP o del Zen-trum, oppure attorno ai Freikorps lealisti. I nomisono i più disparati: “Guardia repubblicana”,“Truppa ausiliaria repubblicana”, “Servizio d’or-dine socialdemocratico”, “Leghe dei reduci repub-
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201718

blicani”, “Nuovo Elmo d’acciaio”, “Unione repub-blicana”, “Organizzazione Sveva” eccetera. Sitratta di almeno 500 mila militanti, che hanno ri-sposto al celebre appello di Hőrsig : “Fronteilneh-mer, Republikaner!” (“Reduci, Repubblicani!”),sinceramente convinti di difendere le istituzionidemocratiche da ogni attacco possibile e dotati ingran parte di una lunga, drammatica esperienza alfronte. Non una semplice associazione di suppor-ters, quindi, ma una milizia, una sorta di Guardiapretoriana della fragile Repubblica di Weimar.Il richiamo è alla tradizione della rivoluzione del1848 sin dal nome che Hőrsig impone all’organiz-zazione: “Stendardo del Reich Nero-Rosso-Oro”(“Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold”), con l’inno delFratello Freiligrath. Nella propaganda del Rei-chsbanner (RB) il richiamo alla retorica giacobinae quarantottesca sarà difatti continuo, dai cappellifrigi (alternati al tradizionale mütze, il copricapocon la visiera degli operai tedeschi) agli alberidella Libertà fino al culto laico della Repubblica,celebrato in feste, adunate giovanili, memoriali emonumenti (come quelli dedicati a Erzberger, Ra-thenau e Ebert, celebrati dal RB come i tre eroidella Repubblica). Il tutto in un tripudio di sten-dardi neri-rossi-oro (sovente accompagnati dalmotto “Eingkeit und Recht und Freiheit”, “Unità e Di-ritto e Libertà”) con trombe, e fanfare intonantimarziali inni facenti appello ai lavoratori, ai citta-dini, ai reduci e, per l’appunto, ai “repubblicani”di tutto il Paese. Il RB viene presto organizzato indue livelli: quello politico, con un presidente(Hőrsig fino al 1927 e poi il suo più muscolarecompagno di partito Karl Hőltermann) e una strut-tura territoriale assai ben ramificata; e quello mi-litare, con unità presenti ovunque (Gruppen, Zügee Kameradenschaften, ovvero squadre, plotoni ecompagnie) e il cui comandante in capo è lo stessopresidente. Organizzazioni collaterali sono inoltrele unità giovanili (Jungbanner) e il servizio di la-voro volontario (Freiwilliger Abeitsdienst des RB). Per motivi di spazio ci limitiamo solo a qualchecenno storico su questa organizzazione. Il RB as-sumerà vieppiù le caratteristiche di un’organizza-zione di massa (alcune fonti riportano la cifra di 3milioni di aderenti nel 1932, equivalenti alla mas-sima forza delle camicie brune nello stesso anno),e parteciperà alle manifestazioni di sostegno a unasempre più precaria Repubblica. Dal 1930 le strut-ture paramilitari del RB si trasformano in “Forma-zioni di protezione” (Schutzformationen) cheiniziano a scontrarsi con le SA e i comunisti quasiquotidianamente. Sebbene la sua massima forzatragga origine dalla SPD (il 90 per cento dei mem-bri dell’organizzazione sono socialdemocratici), il
RB inizia subito dopo il fallimento dell’ultimaGroße Coalition del socialdemocratico HermannMüller (1928-1930) a criticare il sistema dei par-titi, invocando la nascita di una “Seconda Repub-blica”. Tuttavia, l’insorgenza nazista (nell’ottobre1931 nella cittadina di Harzburg viene siglata l’al-leanza tra NSDAP, DNVP e Stahlhelm) spinge il RBa creare un fronte più ampio, coinvolgendo i sin-dacati e tutte le forze democratiche disponibili.Nasce così il 25 gennaio 1932 il “Fronte di Ferro”(Eiserne Front), con come simbolo tre frecce che do-vrebbero colpire i nemici della Repubblica: nazi-sti, monarchici e comunisti. L’ultima grandevittoria del RB e del Fronte di Ferro sarà la vittoriadi Hindenburg alle presidenziali contro Hitler: ilparadosso è che un’organizzazione democratico-repubblicana come il RB si ritrovi a sostenere l’an-ziano feldmaresciallo monarchico, pur dicontrastare l’ascesa del futuro Führer. Infine, l’ul-tima dimostrazione di coerenza e di coraggio il RBla darà il 19 febbraio 1933. Venti giorni prima Hi-tler è stato nominato cancelliere e la Repubblicasi avvia al suo tramonto nell’oscurità dell’immi-nente Terzo Reich. Hőltermann, che presto dovràandare in esilio, convoca a Berlino una grande ma-nifestazione del RB inneggiante alla libertà. Die-cimila persone riempiono la piazza in un tripudiodi bandiere nere-rosso-oro. Sarà l’ultima volta chequei colori appariranno in una città tedesca, al-meno fino al dopoguerra. In marzo il Reichsban-ner è messo fuorilegge in tutto il territorio delReich e i suoi dirigenti o fuggono o vengono arre-stati.Nell’impianto ideale del RB ci sono molte traccedi quella che Helmut Neuberger nel suo studio hadefinito la “minoranza liberale della Massoneriatedesca”. Minoranza perché, come è noto, la tradi-zionale tendenza apolitica dei massoni tedeschi –contestata dal Fratello Freiligrath già più di un se-colo prima –, è molto diffusa anche nelle logge deitempi di Weimar. Inoltre, quando si occupano dipolitica, sovente i Fratelli tedeschi appaiono piùnostalgici del passato imperiale che fautori dellenuove istituzioni. Per non parlare delle sugge-stioni spiritualiste, delle tradizioni “illuminate”,elitarie e vőlkisch, dell’esoterismo di fine Ottocentoulteriormente rafforzato da quella catastrofe deivalori che è stata la Grande guerra: fattori che com-binati “alchemicamente” hanno prodotto Obbe-dienze e Fratelli di frangia, o comunquelontanissimi dagli “immortali principi” del 1789:il caso del feldmaresciallo Erich Ludendorff, mas-sone e primo sostenitore di Hitler, ne è un esem-pio più che lampante. A differenza di altri Paesi (Francia, Spagna, Italia),
SAGGI 19

l’incontro tra il sole dell’avvenire e la volta stellatanon è stato così proficuo e anche le pulsioni libe-ral-repubblicane del 1848, che pure avevano sca-tenato suggestioni “giacobine” di esplicitaderivazione libero-muratoria, sembrano sopitenella fioca luce degli eclettici templi delle valli delReno, del Danubio, della Vistola, dell’Elba edell’Oder. Tuttavia, se di “minoranza” liberale (esocialdemocratica) si può parlare, questa mino-ranza sarà presente ai massimi livelli, tanto nelleistituzione di Weimar quanto nella vicenda delRB. E, a giudicare dai temi delle battaglie con-dotte da quell’organizzazione, il loro ruolo non èstato poi così “minoritario”. Pur non potendo indugiare troppo, per ragioni dispazio, sulla prosopografia del RB nella sua com-ponente massonica, ci basti qui ricordare che lapresenza tra i fondatori dell’organizzazione di nu-merosi esponenti della DDP (un Partito democra-tico d’ispirazione liberal-progressista nato nel1918 e discendente diretto della tradizione costi-tuzionale del 1848) rappresenta già di per sé unaconferma della presenza libero-muratoria nellefila, e soprattutto nei vertici del RB: la DDP, cosìcome l’altro troncone liberale, quello conservatoredella DVP (Deutsche Volkspartei, Partito popolare te-desco, estraneo tuttavia al RB) del massone excancelliere e ministro degli Esteri Gustav Strese-mann, è il partito di Weimar con il più alto nu-mero di iniziati. Nell’organizzazione di H�rsig eH�ltermann numerosi sono i massoni provenientidalla DDP. Tra questi ve ne sono due che vale la pena ricor-dare in modo particolare. Il primo è Thomas De-hler. Nato nel 1897 nella cittadina bavarese diLichtenfels, Dehler è un reduce, si è laureato ingiurisprudenza e a soli ventidue anni è entrato nelPartito democratico. Sposato con una donna d’ori-gine israelita si distingue per la sua tenace ostilitàverso ogni forma di razzismo e di estremismo. Èun repubblicano convinto e nel 1924 partecipaalla fondazione del RB. Viene iniziato all’ArteReale nel 1926 nella loggia Zur Verbrüderung an derRegnitz (“Fratellanza sul fiume Regnitz”) di Bam-berg, in Baviera. Perseguitato dal regime nazistaa causa del suo matrimonio e della sua triplice mi-litanza (DDP, RB e loggia massonica) va in rovina.Alla fine degli anni Trenta entra nella resistenzadella sinistra liberale antinazista (il gruppo Ro-binsohn-Strassmann). Arrestato più volte vienearruolato (a quarant’anni) e spedito in primalinea. Nel dopoguerra collaborerà con le autoritàalleate per ricostruire la Germania. Quando nel1946 la sua loggia madre rinasce, Dehler vi rientrarestandovi fino alla morte avvenuta nel 1967. Nel
frattempo, è stato ministro della Giustizia conAdenauer (dal 1949 al 1953, distinguendosi perla sua tenace opposizione alla introduzione nel co-dice penale della pena di morte) e presidente fe-derale del nuovo partito liberale (FDP) dal 1954al 1957. Il secondo massone della DDP che aderisce al RBè Paul Eugen von Hoverbeck barone di Schoe-naich, nato in Prussia occidentale nel 1866. Mili-tare di carriera, membro del ministero dellaGuerra nel 1914-18, raggiunge il grado di mag-giore generale della Reichswehr negli anni di Wei-mar. Iniziato in una loggia di Ludwigslustappartenente all’Obbedienza massonica riformataFreimaurerbundes “Zur Aufgehenden Sonne” (Unionemassonica “Sole nascente”), ha aderito alla DDPsino dalla fondazione del partito e nel 1924 par-tecipa alla nascita del RB. Raro esempio di mili-tare pacifista, il nobiluomo entra nel 1922 nellaSocietà tedesca per la pace (DFG), organizzazionedove non pochi sono gli iniziati. Nel 1930 contestala svolta a destra della DDP e partecipa alla fon-dazione del piccolo Partito radicaldemocratico
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201720
Friedrich Ebert, 1920

(RDP), parimenti aderente al RB e anch’esso conuna certa presenza massonica tra le sue fila. Incar-cerato sotto il nazismo, von Schoenaich torna inlibertà nel dopoguerra, continuando la sua du-plice militanza pacifista e massonica fino allamorte (1954).Ma anche la SPD ha i suoi liberi muratori e moltidi loro aderiscono al RB. In questo senso non sipuò non citare Julius “Jules” Leber, senz’altro lafigura più rappresentativa di questo “Pantheon”massonico, socialista e repubblicano. Alsaziano,di famiglia tedesca irredentista (l’Alsazia era fran-cese fino al 1871), iscritto alla SPD dal 1912, Leberè stato volontario in guerra e ha ottenuto le crocidi ferro di prima e seconda classe per il valore di-mostrato in combattimento. Nel corso del putsch diKapp del 1920, Leber (promosso tenente e al co-mando di una batteria d’artiglieria) rifiuta di ade-rire al colpo di Stato e si dichiara leale alleistituzioni democratiche. Patriota, ex combattentevolontario, socialdemocratico, repubblicano: ilsuo curriculum non può che vederlo a Magdeburgnel 1924 per partecipare alla nascita del RB. Nelfrattempo è stato iniziato in una loggia dell’obbe-dienza riformata “Zur Aufgehenden Sonne»” la stessadel barone von Schoenaich. Redattore capo di ungiornale socialdemocratico di Lubecca, Leberviene eletto per il suo partito al Reichstag, doveresterà ininterrottamente dal 1924 al 1933. Parte-cipa agli scontri del 1° febbraio 1933 tra il RB, lapolizia e le SA (nel corso dei quali verrà ferito) ea tutte le ultime manifestazioni antinaziste. Fattodecadere dalla carica di deputato, viene arrestatoe rinchiuso nel campo di concentramento di Ester-wegen (con altri socialdemocratici e massoni) epoi in quello di Sachsenhausen. Liberato dall’am-nistia del 1938, apre una bottega di carbone a Ber-lino, sempre controllato dall’occhiuta vigilanzadella Gestapo. Incurante di ciò, entra in contattocon il gruppo antinazista capeggiato da GustavDahrendorf (il padre del filosofo Karl) e in seguitocon il “circolo di Kreisau”, il celebre centro cospi-rativo di von Moltke, attraverso il quale conosceil conte Stauffenberg e i congiurati del luglio1944. Il piano prevede l’assassinio di Hitler, uncolpo di Stato, l’armistizio con gli Alleati e l’in-staurazione di un nuovo governo di stampo social-liberale, nel quale Leber dovrà ricoprire il ruolochiave di ministro dell’Interno. Denunciato dauna spia, viene processato dal tribunale nazista econdannato alla pena capitale, eseguita per impic-cagione (con le tristemente note corde da piano-forte, su espresso desiderio del Führer) il 5gennaio 1945, nella famigerata prigione berlinesedi Plőtzensee. Al Fratello Julius Leber sono dedi-
cate in Germania decine di strade, piazze, memo-riali, monumenti e targhe e ancora oggi è celebratocome un eroe e un martire della libertà. Un liberale che costruirà una nuova Germania de-mocratica, un militare che si batterà per la pace eil disarmo, un socialdemocratico che si farà ucci-dere per la libertà. Tre storie significative che rac-contano la vicenda del Reichsbanner e più ingenerale dell’opposizione massonica al nazismo.Pulver ist schwarz, Blut ist rot, Golden flackert dieFlamme!
Bibliografia
Stefan Appelius, Der Friedengeneral Paul Freherr von Schoe-naich. Demokrat und Pazifist in der Weimarer Republik, in:«Demoktratische Geschichte» [7/1992]Dorothea Beck, Julius Leber. Sozialdemokrat zwischen Re-form und Widerstand, Siedler, Berlin, 1983Enzo Collotti, La socialdemocrazia tedesca, Einaudi, Torino,1959Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Begleitmaterialienzur Ausstellung «Widerstand gegen Nationalsozialismus»,GDW, Berlin, 2008Giovanni Greco (a cura di), Breve ma veridica storia dellaMassoneria internazionale, Persiani, Bologna, 2012Erich Eyck, Storia della Repubblica di Weimar 1918-1933,Einaudi, Torino, 1966Adolph Kohut, Freimaurerische Skizzen in Vergangenheitund Gegenwart, Claudius Verlag, Wamdbek i.H., 1911Hans Mommsen, The rise and fall of Weimar democracy, TheUniversity of North Carolina Press, Chapel Hill & Lon-don, 1969Helmut Neuberger, Winkelmaß und Hakenkreuz. Die Frei-maurer und das Dritte Reich, Herbig, München, 2001William L. Shirer, Storia del Terzo Reich, vol. I, Fabbri,Milano, 1978Hagen Schulze, La Repubblica di Weimar. La Germania dal1917 al 1933, Il Mulino, Bologna, 1987Hugo Wengst, Thomas Dehler 1897-1967. Eine politische Bio-graphie, Oldenbourg, München, 1997Heinrich August Winkler, La Repubblica di Weimar. 1918-1933: storia della prima democrazia tedesca, Donzelli, Roma,1998Benjamin Ziemann, Die Zukunft der Republik? Das Reichs-banner Schwarz-Rot-Gold 1924–1933, Friedrich-Ebert-Stif-tung, Bonn, 2011
SAGGI 21

Assumendo per mito un processo di idealizza-zione, una figurazione ideologica che si producein un determinato contesto socioculturale avendoper oggetto un evento o, come nel nostro caso, unpersonaggio che viene assunto a simbolo di deter-minati valori che si intendono veicolare e propa-gandare attraverso, per l’appunto, unarappresentazione mitico-simbolica, si pone il pro-blema di comprendere le ragioni della centralitàdel mito di Giordano Bruno nella Massoneria ita-liana dopo l’Unità. Si tratta cioè non solo di co-gliere le dinamiche del processo di percezioneideologica, e perciò mitica, della figura di Brunoda parte della Liberamuratoria italiana, ma soprat-tutto di verificare come essa viene “adoperata” neldibattito e nella lotta politico-ideologica dell’Italiapostunitaria.In tale contesto, la prima questione da affrontareattiene alla scelta stessa di Giordano Bruno qualemito centrale, quasi vera e propria bandiera uffi-ciale della Massoneria nell’Italia unita. PerchéGiordano Bruno, solo idealmente assimilabile allaMassoneria italiana ottocentesca, e non piuttostomassoni autentici, nel senso di storicamente do-cumentabili in quanto tali, come Tommaso Cru-deli o Raimondo di Sangro di San Severo,anch’essi vittime illustri dell’intolleranza?La ragione di ciò sta nel fatto che rispetto ai sud-detti personaggi, noti ad una minoranza di per-sone colte e probabilmente neppure a tutti glistessi massoni italiani, di gran lunga più vasta èla notorietà di Bruno, gigante della cultura euro-pea, personalità di uno spessore tale da poter reg-gere il confronto con gli altri numi tutelari dellaLiberamuratoria internazionale: Lessing, Goethe,Mozart, Voltaire. Senza considerare poi che la tra-gica fine di Bruno, “brusciato vivo” nel cuore dellaRoma papalina, aveva una straordinaria capacitàdi presa e di suggestione nell’immaginazione po-polare.Ma quali sono le forze – ed è l’altra questione cuicercare risposta – che la Massoneria italiana riescea coinvolgere e mobilitare nell’assunzione delmito bruniano a simbolo della lotta contro l’oscu-rantismo clericale e per la libertà di pensiero? Sitratta di uno schieramento quanto mai vasto e ar-ticolato, che va da letterati insigni come Giosuè
Carducci e Francesco De Sanctis, a esponenti diprimissimo piano della Sinistra risorgimentale digoverno quali Agostino De Pretis, Giovanni Nico-tera, Francesco Crispi; dai repubblicani GiovanniBovio, Aurelio Saffi, Ubaldo Comandini, EttoreFerrari, ai radicali Felice Cavallotti, Agostino Ber-tani, Ernesto Nathan. Con l’aggiunta non poco si-gnificativa che sul nome di Giordano Bruno sirealizza la convergenza tra le diverse componentidella Liberamuratoria italiana: non solo quelle li-beralcostituzionali, radicali e repubblicano-maz-ziniane di cui si è detto, ma financo le altrepoliticamente riconducibili all’estrema sinistraanarchica e socialista di cui sono espressione iFratelli Errico Malatesta, Andrea Costa, Enrico Bi-gnami, Leonida Bissolati.Anarchici internazionalisti, socialisti rivoluzio-nari, mazziniani intransigenti li troviamo infattipresenti a fianco di radicali, liberaldemocratici,monarchico-costituzionali ecc. nelle varie associa-zioni che apertamente si ispirano a GiordanoBruno quale simbolo di indomito spirito di ricercacontro ogni forma di imposizione dogmatica e dioppressione clericale. Sicché non deve sorpren-dere, come ha giustamente fatto rilevare AldoAlessandro Mola, che netta sia l’impronta masso-nica di un sodalizio che Giordano Bruno assume
LA CENTRALITÀ DEL MITO DI GIORDANO BRUNONELLA MASSONERIA ITALIANA DOPO L’UNITÀ
di Santi Fedele
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201722
Giordano Bruno, monumento a Campo de’ Fiori

a bandiera e simbolo, quale per l’appunto l’Asso-ciazione del Libero Pensiero Giordano Bruno, co-stituitasi nel 1880 dalla confluenza di diverseassociazioni preesistenti e aperta a persone diorientamento assai diverso: atei, agnostici, deistio semplicemente anticlericali, e sostenuta da entidisparatissimi quali, assieme alle logge massoni-che, società razionaliste, circoli positivisti, societàdi cremazione, associazioni studentesche, legheper la scuola laica1. Singole persone e sodalizi al-quanto diversi e però accomunati dall’intento dicombattere la superstizione organizzata, vale adire la Chiesa cattolica, conducendo una battagliaanticlericale che nelle sue manifestazioni estremetroverà la propria punta di diamante nell’Associa-zione Giordano Bruno, costituita nel 1888 qualecentro di raccolta dell’anticlericalismo più accesoed esasperato e financo non immune da manife-stazioni goliardicamente chiassose come il di-sturbo di cortei religiosi o le incursionicarnevalesche in periodo quaresimale2. Espres-sioni queste decisamente minoritarie e tutto som-mato alquanto marginali rispetto ad un impegnodi lotta, quello dei massoni italiani, dalle forticonnotazioni laiche e anticlericali, che segnerà in-contestabilmente il punto più alto nella realizza-zione del monumento a Giordano Bruno, scolpitoda Ettore Ferrari per essere eretto a Roma a Campode’ Fiori, “dove il rogo arse”. Il 9 giugno 1889 allacerimonia di inaugurazione, «clamoroso atto disfida verso il papato e la curia romana, partecipa-rono oltre tremila fratelli convenuti da tutta Italiae per le vie della capitale sfilarono un centinaio dibandiere e di labari massonici. Fu un’eloquentemanifestazione di forza e al tempo stesso il mo-mento culminante di quell’azione di pedagogialaica e patriottica, affidata a pubbliche cerimoniee all’erezione di statue e monumenti, che propriodurante la gran maestranza di Lemmi conobbeuna significativa accelerazione»3. Le parole di Ful-vio Conti ci introducono alla questione centrale,che è quella di cogliere e di definire quali siano ivalori, il messaggio ideologico che con il simbolodi Giordano Bruno la Massoneria italiana intendeveicolare. Non sono soltanto la libertà di pensiero,la lotta contro la superstizione, il rifiuto dell’intol-leranza, la rivendicazione della ricerca scientificae della speculazione filosofica libere da ogni vin-colo dogmatico; tema quest’ultimo in cui il nomedi Giordano Bruno si associa a quello di GalileoGalilei in una situazione in cui, per come ha scrittoFranco Bertolucci «da una parte il “matematico,che aveva aperto la strada alla nuova cosmologia”,e dall’altro il “monaco ribelle al cristianesimo”, as-surgono in breve a “guide spirituali” del “nuovo
razionalismo” e del “libero pensiero” nella lottacontro l’oscurantismo della Chiesa cattolica»4
In aggiunta a tutto ciò, Giordano Bruno per i mas-soni italiani nella seconda metà dell’Ottocento èsoprattutto il simbolo della lotta per la difesa dellalaicità dello Stato e delle sue istituzioni, a partiredalla scuola laica, in una situazione in cui la difesadella laicità dello Stato coincide con la difesastessa dell’eredità storica del Risorgimento nazio-nale e della compagine statuale da esso scaturita.Quella che la Massoneria svolge in tutta la se-conda metà dell’Ottocento, con i suoi uomini e peril tramite delle sue Logge, è una funzione non par-titica e però incontestabilmente “politica” di so-stegno e di legittimazione ideale della compaginestatale prodotta dal movimento risorgimentale.Su questo punto occorre essere molto chiari. Perqualche tempo, in particolare sul finire del secoloscorso, in un momento in cui lo scoppio delloscandalo P2 suscitava interrogativi angosciosi emetteva a dura prova la capacità di tenuta dellaMassoneria italiana, ha riscosso non pochi con-sensi, anche all’interno di essa e, per essere piùprecisi, della sua componente più antica, nume-rosa e internazionalmente accreditata costituita dalGrande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, unatteggiamento spiccatamente critico nei confrontidei presunti eccessi di politicizzazione, dell’ecces-siva proiezione profana della Massoneria italianapost-risorgimentale; fenomeni valutati alla stre-gua di deviazioni dall’ortodossia liberomuratoriada cui prendere le distanze, quasi da “condannare”a posteriori. Si trattava di una posizione astrattamente morali-stica, pericolosamente subalterna agli imperantipregiudizi e ai consolidati luoghi comuni di certapubblicistica sui presunti “intrighi politici” deimassoni. Un metro di giudizio assolutamente an-tistorico, perché non teneva conto del fatto che neidecenni successivi al compimento dell’unità na-zionale la Massoneria italiana fu chiamata dallecircostanze ad assolvere, in ambito profano, unatriplice funzione: di difesa, di supplenza, di pro-gresso.Una funzione di difesa di uno Stato unitario nonriconosciuto dalla Chiesa, che mentre viene fattooggetto dell’attacco concentrico dell’intransigen-tismo cattolico e del legittimismo borbonico, deveaffrontare e risolvere problemi immani: dal com-pletamento dell’unità territoriale con Venezia eRoma all’unificazione legislativa tra i territoridegli ex Stati preunitari, dal grave squilibrio esi-stente in termini di sviluppo economico tra il Set-tentrione e il Meridione al superamento di unacondizione di pressoché generale analfabetismo.
SAGGI 23

In siffatto contesto, lo sforzo compiuto nei primidecenni dopo l’Unità dalla classe politica risorgi-mentale, sia di governo che d’opposizione, dicreare quasi dal nulla una coscienza nazionale ita-liana veicolando i concetti basilari costitutivi del-l’identità nazionale tra ampi strati di popolazionerimasti ai margini dei processi risorgimentali, siavvalse in larga misura dell’apporto di un’orga-nizzazione capillarmente diffusa come quella mas-sonica, in cui il sentimento forte dello Statounitario prodotto dal Risorgimento quale valoreprimario da difendere dai suoi tanti nemici pre-valeva nettamente sulle differenziazioni internealla Liberomuratoria italiana tra monarchici e re-pubblicani, moderati e progressisti.Una funzione di supplenza rispetto all’assenza inItalia nella seconda metà dell’Ottocento – per mo-tivi che qui non è dato neppure accennare – digrandi partiti moderni su scala nazionale (comead esempio i conservatori e i liberali in Inghil-terra), che comportò per l’organizzazione masso-nica l’assolvimento di un ruolo di raccordo, dicollegamento tra personalità anche di diversaestrazione politica e ideologica e però accomunatedalla condivisione degli ideali di libertà e di lai-cità dello Stato.Una funzione di progresso, perché quella perse-guita dai massoni italiani non fu una difesa staticadell’eredità risorgimentale ma una ricerca costanteper allargare le basi del consenso al nuovo Stato,aprendo la strada a decisi interventi riformatoriquali, per fare solo qualche esempio, quelli neisettori cruciali dell’istruzione gratuita e obbliga-toria (legge legata al nome del massone ministrodell’Istruzione Michele Coppino) e del riconosci-
mento dei diritti di associazione e di sciopero(sanciti nel nuovo codice penale redatto dal mas-sone ministro della Giustizia Giuseppe Zanar-delli).Nella genuina vocazione laica e democratica, nellamai venuta meno fedeltà alle ragioni della libertàe del progresso, nell’ambizioso disegno tenace-mente perseguito di modernizzazione del Paese,vanno del resto ricercate le ragioni dei violenti at-tacchi ai quali andrà soggetta nei decenni succes-sivi la Massoneria italiana, fatta bersagliodell’offensiva concentrica dei clericali, dei nazio-nalisti e dei fascisti, vale a dire di forze diverse maaccomunate dall’avversione a quei principi di lai-cità, di cosmopolitismo e di libertà insiti nell’Isti-tuzione massonica e da essa tenacemente difesi.
1 Aldo Alessandro Mola, Storia della Massoneria italianadall’Unità alla Repubblica, Bompiani, Milano, 1976, p.161.2 Pedro Alvarez Lazaro, Libero Pensiero e Massoneria, Gan-gemi, Roma-Reggio Calabria, 1991, P. 65; Aldo Ales-sandro Mola, op. cit., p. 161.3 Fulvio Conti, Storia della Massoneria italiana. Dal Risorgi-mento al fascismo, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 127-128.4 F. B. [Franco Bertolucci], Introduzione, in Galilei e Brunonell’immaginario collettivo dei movimenti popolari tra Otto eNovecento, a cura di Franco Bertolucci, BSF Edizioni,Pisa 2001, p. 7. Non è certo un caso che a GiordanoBruno sia intitolata la più alta onorificenza conferitadal Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani aisuoi affiliati e a Galileo Galilei quella riservata ad emi-nenti personalità estranee all’Istituzione.
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201724

26 luglio 1943: è all’indomani, nel senso letterale e non metaforico del termine,della caduta del fascismo che un gruppo di massoni appartenuti al Grande Oriente d’Italia diPalazzo Giustiniani dirama un documento che preannuncia la rinascita della Massoneria ita-liana. Di quella Libera Muratoria che il fascismo ha tentato vanamente con le violenze e lepersecuzioni di cancellare dalla storia del Paese, senza tuttavia riuscire ad impedire né cheuna minuscola ma determinata pattuglia di massoni rialzasse il vessillo del Goi nell’esilio an-tifascista, né che Fratelli rimasti fedeli al trinomio Libertà-Eguaglianza-Fratellanza tenesseroviva in Italia una fiaccola che il regime liberticida non riuscì mai a spegnere.
1943LA RINASCITA DELLA MASSONERIA ITALIANA
IL RIORDINO DELLA MEMORIA 25
Comitato di Maestranza (1943/1945):Umberto Cipollone, Guido Laj, Gaetano Varcasia

26 luglio 1943IL GOVERNO DELL’ORDINE MASSONICO ITALIANOprende atto della costituzione del nuovo Governo d’Italia, che riafferma il ritorno alla libertà;riserva la normale ripresa dei lavori attraverso le Logge (poste in sonno dal Gran Maestro nel 1925)che saranno riattivate non appena sarà liberamente consentito;rivolge il suo primo commosso pensiero a tutti i Fratelli defunti vittime del regime di tirannia, e dicui a suo tempo promuoverà Solenne Commemorazione;ricorda con reverente e pietoso affetto i defunti FratelliGran Maestro Domizio Torrigiani 33.·. Sovrano Gran Commendatore Ettore Ferrari 33.·.che prende impegno di degnamente sostituire attraverso una nuova Costituente da indirsi a paceconclusa, mentre per intanto l’Ordine sarà diretto da un Comitato della Gran Maestranza, affiancatodal Governo dell’Ordine;constata con compiacimento che in tutti i Centri più importanti d’Italia i Fratelli rimasti puri sonostati e sono in stretti contatti; e, mentre ricorda che da parte Sua ha mantenuto ininterrotti i rapporticon i più autorevoli Fratelli, nell’un tempo per la regolare riorganizzazione della propria Famiglia (eappena sarà regolarmente consentito), proclama il principio della selezione più rigorosa, con esclu-sione più assoluta di quanti abbiano militato nelle file del deprecato regime, e comunque avesserodato a questo la loro adesione, salvo eccezioni da esaminare caso per caso rigorosamente; e connuova ammissione solo di elementi che per qualità personali e per posizione sociale e politica si tro-vino in grado di contribuire al raggiungimento delle alte idealità della Famiglia.Richiamando gli immortali principi di Libertà, di Uguaglianza e di Fratellanza, postulati basilari del-l’Ordine Massonico che, per il contenuto programmatico delle sue costituzioni Generali, intende alperfezionamento morale, intellettuale e materiale della Umana Famiglia e propugna il principio de-mocratico nell’ordine sociale e politico, senza identificarsi con alcun partito, riafferma oggi più chemai i principi della solidarietà sociale ed umana, attraverso ordinamenti in cui la libertà di pensieroe di fede, e la vita umana siano sacre ed inviolabili, il lavoro (come da antica e costante affermazionedell’Ordine) sia considerato per tutti come dovere e fonte di diritti; con lotta senza tregua contro tuttii dispotismi politici, le intolleranze religiose e i privilegi di qualunque genere;dichiara di propugnare ogni sincera e onesta corrente innovatrice per l’attuazione di un programmadi radicale rinnovamento e rinascita della Patria, per la conquista della prosperità, civiltà e giustizia,e per le conseguenti rivendicazioni dell’ordine sociale politico.
Il documento è presente in Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generaledella Pubblica Sicurezza, Casellario Politico Centrale, busta 2763, fascicolo “Lenzi Ugo”.
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201726
La Stampa del 26 Luglio 1943

Da Gian Mario Cazzaniga, autorede La religione dei moderni, editonel 1999 da Ets, e direttore per la
Storia d’Italia Einaudi di due Annali col-lettanei: Massoneria, del 2006, ed Esoteri-smo, del 2010, viene ora un nuovo,fondamentale contributo alla storia dellaLibera Muratoria italiana ed europea.
Il libro La catena d’unione. Contributi per unastoria della Massoneria contiene trentunosaggi, attraverso i quali l’Autore ricostrui-sce una storia generale della Massoneria
e di altre società ad essa correlate (Carbo-neria, Fratelli Cacciatori, Cavalieri del La-voro). Il volume è diviso per sezionitematico-cronologiche, così da riassu-merne una storia dagli inizi al primo No-vecento: I. Origini della massoneria II.Massoneria e illuminismo III. Massoneriae università a Pisa IV. Massoneria e rivo-luzioni moderne V. Massoneria e Risorgi-mento VI. Massoneria e movimentooperaio. In questi saggi la Massoneriaviene collocata all’interno della fiorituradell’associazionismo volontario nel XVIII
GIAN MARIO
CAZZANIGA
LA CATENA
D’UNIONE
CONTRIBUTI PERLA STORIA DELLA
MASSONERIA
ETS, Pisa, 2016
TRA GLI SCAFFALI 27

secolo, espressione del fenomeno costitutivodella modernità: l’invenzione del legame so-ciale e l’affermarsi di una visione della comu-nità umana come autopoiesi, checioè ridefinisce continuamente se stessa e sisostiene e riproduce dal proprio interno.La catena d’unione, simbolo di fraternità uni-versale e legame che unisce fra loro sia ritual-mente i membri di una loggia sia idealmentetutti i massoni sparsi per il mondo, ne è im-magine esemplare. Il programma di perfezio-namento dell’uomo che aspira a riacquistarelibertà ed eguaglianza naturali, maturatonelle logge settecentesche, finirà per incon-trare, con esiti alterni, le rivoluzioni atlanti-
che, il sorgere di stati-nazione e il tentativodi unirli in associazioni sovranazionali di ar-bitrato e difesa della pace. Ciò che resta comegrande eredità è il modello associativo mas-sonico, di cui avremo filiazioni molteplicinell’Ottocento, dalle società operaie dimutuo soccorso alle prime società sportive eal partito di massa, in cui la politica si costi-tuisce come religione dei moderni. Dopo glistudi di Francovich e Giarrizzo sulla Masso-neria settecentesca italiana ed europea, ilnuovo libro di Cazzaniga cerca ora di deli-neare una storia mondiale della Libera Mu-ratoria inserita nella vita culturale e socialedel mondo occidentale.
MassonicaMente n.1 - Gen./Apr. 201728
Iniziazione d’Apprendista. Stampa Settecentesca.

Pagina de L'ASINO del 25 marzo 1917

Il BolscevicoDipinto di Boris Kustodiev, 1920, Galleria Tret'jakov