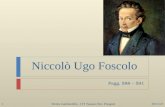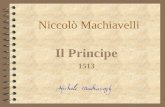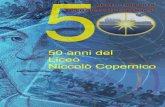Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico Viale ......1 Liceo Scientifico Statale "Niccolò...
Transcript of Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico Viale ......1 Liceo Scientifico Statale "Niccolò...

1
Liceo Scientifico Statale "Niccolò Copernico" Viale Borgovalsugana, 63 - 59100 Prato (PO)
tel. 0574 596616 - fax 0574 592888 - C.F. 84009230487
e-mail: [email protected]
posta certificata: [email protected]
ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2016/2017
DOCUMENTO DEL 15 maggio 2017
CONSIGLIO DI CLASSE della 5E scientifico
. Il coordinatore di classe
Prof.ssa Chiara Pagani

2
PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO
Il Liceo “Niccolò Copernico” forma i giovani dell’area pratese e dei comuni limitrofi da quasi un
cinquantennio. Nato come liceo scientifico nel 1969 in seno al Convitto “Cicognini”, nella storica
sede in piazza del Collegio, fu trasferito dopo poco tempo in un nuovo edificio in Via Bicchierai. A
seguito del rapido aumento del numero degli iscritti, agli inizi degli anni ’70 vi fu un nuovo
spostamento, in un ex-complesso industriale di Via Costantini. Nel 1975 alcune classi del
“Copernico” furono trasferite in Via Reggiana, formando il primo nucleo di quello che più tardi
divenne una nuova istituzione scolastica autonoma, il LS “Carlo Livi”. La scuola rimase in Via
Costantini fino al 1999, quando fu resa disponibile, opportunamente ristrutturata, la sede attuale. La
posizione del Liceo, prossima alla stazione centrale, offriva facilità di collegamenti urbani ed extra-
urbani con i mezzi pubblici. Ciò ha contribuito nel tempo ad ulteriori incrementi della popolazione
scolastica. Già nei primi anni ’70 al “Copernico” prese il via una mini-sperimentazione dell’area
scientifica. L’indirizzo linguistico fu introdotto, in forma di maxi-sperimentazione, nell’anno
scolastico 1985. Gli anni successivi videro un rapidissimo incremento della popolazione scolastica,
attratta anche dall’introduzione di tre nuove mini-sperimentazioni nelle sezioni del liceo scientifico
(PNI, sperimentazione di scienze, sperimentazione bilingue). Negli anni ’90 anche l’indirizzo
linguistico fu oggetto di ulteriori modifiche, che sono rimaste in vigore fino alla riforma liceale del
2010. Negli ultimi decenni, vista la considerevole affluenza di alunni, il “Copernico” è stato oggetto
di diversi dimensionamenti, con scorporo di alcune classi a favore di altri licei del territorio. Al
contempo è stato deciso di utilizzare come succursale un edificio limitrofo, comunicante attraverso il
giardino con la sede centrale.
L’OFFERTA FORMATIVA
L’Offerta formativa della nostra scuola insiste da un lato su una solida base culturale in linea con uno
studio di tipo liceale, dall’altro si apre alle nuove esigenze della contemporaneità con un ampio raggio
di attività per rendere sempre più attuale, completa e flessibile la preparazione degli studenti.
I corsi di studio del Liceo Niccolò Copernico sono, per scelta e tradizione consolidata, il Liceo
Scientifico e il Liceo Linguistico, secondo i quadri orari indicati dalla riforma. Il Liceo Copernico si
connota prevalentemente come scuola preparatoria al percorso universitario. Anche per questo motivo
la didattica curriculare è integrata da numerosi progetti e iniziative di respiro locale, nazionale,
europeo, spesso in rete sinergica con altre Scuole Superiori Statali, con l’Università degli Studi o gli
Enti Pubblici territoriali e, da qualche anno, con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Il Liceo Scientifico forma gli alunni con una solida preparazione di base e apre un ampio orizzonte
culturale, sviluppando un metodo di studio rigoroso e un’attitudine critica secondo un progetto
collaudato, che bene integra le scienze e la tradizione umanistica del sapere per adeguarsi ad una
società in rapida evoluzione. I buoni risultati sono attestati dalle rilevazioni della Fondazione Agnelli
(progetto Eduscopio), da cui risulta il migliore liceo scientifico nel raggio di 30km, con una
percentuale di immatricolazione all’università del 91% e con indice FGA (media dei voti e crediti
ottenuti normalizzati in scala da 1 a 100) pari a 80.08. Il Liceo intrattiene, inoltre, rapporti con
l’Unione Europea mediante la partecipazione a bandi per la realizzazione di progetti rivolti a studenti
e docenti ed è una delle poche scuole italiane ammesse a Progetti Erasmus+ KA1 e KA2. Da alcuni
anni ha stretto un rapporto di collaborazione con la sede pratese dell’Università Monash e con la sede
madre della University of Melbourne. Nell’ultimo anno è stata stipulata una convenzione anche con
il campus pratese dell’Università americana New Haven.
Nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 il Liceo Copernico ha ottenuto la Certificazione di Qualità
ISO 9001:2000, modificata successivamente in ISO 9001:2008. Nell’anno scolastico in corso, nel
mese di marzo, ha ricevuto una nuova Certificazione di Qualità secondo la norma ISO 9001:2015. Il
Liceo Copernico è inoltre accreditato sia come test center ECDL e Certificazioni linguistiche (inglese,
francese e tedesco) sia come Agenzia formativa presso la Regione Toscana.

3
1. PROFILO DELLA CLASSE
1.1. Quadro Orario Settimanale delle Discipline curriculari
QUADRO ORARIO CORSO SCIENTIFICO
Materie curriculari
Primo biennio Secondo biennio Monoennio
Prima Seconda Terza Quarta Quinta
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3 - - -
Storia - - 2 2 2
Filosofia - - 3 3 3
Matematica (informatica al 1°biennio)
5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica o Attività alternative
1 1 1 1 1
Totale Ore 27 27 30 30 30
1.2. Elenco docenti
Prof.ssa Roberta Tuccella (Lingua e letteratura italiana/Lingua e cultura Latina)
Prof.ssa Simona Pucci (Lingua e cultura straniera/Inglese)
Prof.ssa Giuseppa Chiaramonte (Filosofia)
Prof.ssa Maria Rita Venneri (Storia)
Prof.ssa Elena Gargini (Matematica/Fisica)
Prof.ssa Anna Pecchioli (Scienze Naturali)
Prof.ssa Chiara Pagani (Disegno e Storia dell’Arte)
Prof.ssa Susanna Piccioli (Scienze motorie e sportive)
Prof.ssa Cristina Pieri (IRC)

4
1.3. Elenco alunni
1. Lorenzo Bellini
2. Ambra Bigagli
3. Lorenzo Bini
4. Edoardo Calugi
5. Teresa Campeggi
6. Costanza Chiarella
7. Sabrina Corsi
8. Veronica Corsini
9. Chiara Culivicchi
10. Noemi De Filippis
11. Federica Di Leo
12. Francesco Funghi
13. Matteo Giacomelli
14. Enrico Giuliani
15. Marika Grassi
16. Giulia Guidotti
17. Vittoria Meoni
18. Alessandro Oliva
19. Filippo Siano
20. Camilla Micol Turi
21. Giulia Vannini
22. Virginia Vannucchi
23. Ayesh Srimal Warnakulasuriya Jansz
1.4. Storia della classe
La classe 5Es, che è composta da 23 alunni (14 ragazze e 9 ragazzi), all’inizio del quinquennio era
formata da 27 studenti. Il numero attuale è il risultato di trasferimenti, nuove iscrizioni e qualche
bocciatura, avvenuti soprattutto nel corso dei primi due anni di corso, durante il triennio, invece, la
composizione della classe è rimasta sostanzialmente invariata.
La continuità didattica è stata mantenuta per tutto il quinquennio per Scienze, Storia dell’Arte,
Educazione Fisica e IRC, nel triennio per Italiano e Latino (cattedra congiunta), Storia, Inglese e
Filosofia.
Per quel che riguarda Matematica, la classe ha avuto negli ultimi due anni, la stessa docente che, nel
monoennio conclusivo, ha assunto anche l’insegnamento di Fisica, quest’ultima è l’unica materia
per cui la classe ha cambiato insegnante nei tre anni conclusivi del corso.
1.5. Situazione didattico-disciplinare della classe
La classe si è sempre contraddistinta per un comportamento corretto e affidabile, sia in classe che
nelle diverse attività extra-scolastiche in cui è stata coinvolta.
Positivi e solari nella socializzazione, alcuni studenti hanno però dimostrato talvolta un
atteggiamento eccessivamente ansioso nei confronti delle verifiche, che ha penalizzato in parte la
loro evoluzione verso un metodo di studio più maturo e autonomo, ancorandoli ad un lavoro non
sempre convintamente partecipativo e maggiormente legato all’acquisizione mnemonica delle
conoscenze.
Forse anche per questo, mancano nella classe elementi di eccellenza, anche se un piccolo gruppo di
studenti si distingue per i buoni risultati raggiunti e per una preparazione affidabile e sistematica.
La maggior parte della classe, si attesta su livelli di profitto mediamente discreti, mentre un
gruppetto ristretto, non è riuscito, per motivi diversi, a trovare sempre la continuità d’impegno e un
metodo di studio adeguato al raggiungimento di una preparazione convincente.

5
1.6. Attività di recupero e/o di approfondimento
Per gli alunni in difficoltà sono state effettuate attività di recupero e consolidamento in itinere e/o in
orario pomeridiano, secondo le modalità e i criteri previsti dal POF del liceo, come risulta dalla
parte del documento riguardante le singole materie.
1.7. Iniziative complementari e integrative
Il Consiglio di Classe nel corso degli anni ha promosso la partecipazione a:
attività sportive e iniziative sulla neve
film, concerti e spettacoli teatrali
visite a musei e monumenti storici e religiosi
Adesione al progetto Inglese per la cittadinanza globale in collaborazione con la Monash
University e la UniMelbourne
Attività previste dal Progetto “Educazione alla salute”
Partecipazione dei singoli studenti alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica e della
Chimica.
Certificazioni linguistiche di livello PET e FCE
Visita alla mostra “Roma caput mundi”
Viaggio d’istruzione a Pompei Ercolano, Capri, Positano e Amalfi.
Viaggio d’istruzione a Venezia Verona e Mantova.
Visita a Milano e ai padiglioni dell’EXPO 2015.
In quest’ultimo anno sono state attuate le seguenti iniziative:
messa in scena delle Operette morali di G. Leopardi
spettacolo teatrale tratto dal romanzo Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello al Teatro
di Rifredi a Firenze
musical Notre Dame de Paris di R. Cocciante
conferenze del progetto Pianeta Galileo
• 100 anni dopo: Blake Holes. Onde gravitazionali, relatore prof. Ruggero Stanga
del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’ Università di Firenze
• I vulcani italiani: testimoni dell'evoluzione geologica del Mediterraneo relatore
Prof. Sandro Conticelli del Dipartimento di Scienze della Terra dell’ Università
di Firenze
lezione-teatro nell’ambito del progetto Insieme. Dal Porrajmos alla strategia nazionale con
rom e sinti ad una sulle vicende di sterminio e persecuzione dei rom e sinti, a cura di Pino
Petruzzelli e Luca Bravi, con un incontro con il testimone Ernesto Grandini (sinti) sul tema
dell'esclusione/inclusione oggi.
visita guidata alla mostra tenutasi a Firenze in Palazzo Strozzi, Ai Weiwei libero
adesione di parte della classe all’abbonamento a quattro spettacoli serali (Il berretto a
sonagli di L. Pirandello, Smith e Wesson di A. Baricco, Casa di bambola di H. Ibsen, Chi ha
paura di V. Woolf di E. Albee), del Teatro Metastasio di Prato
partecipazione ai tornei interni proposte dal Centro Sportivo Scolastico, ai Giochi Sportivi
Studenteschi e al Trofeo Città di Prato.
Viaggio d’istruzione in Grecia – Monasteri delle Meteore, Delfi, Atene, isole del golfo
saronico (Idra, Poros, Egina).
Clil
• 4 ore di lezione sugli integrali proposte da una tirocinante del MIT di Boston all’interno
dell’orario curricolare di Matematica
• 10 ore all’interno dell’orario curricolare di Disegno e Storia dell’Arte

6
2. TRAGUARDI DI COMPETENZE TRASVERSALI
I seguenti traguardi costituiscono un quadro sintetico riguardante il complesso della classe e si
devono considerare raggiunti dagli alunni in gradi diversi, in rapporto al livello di rendimento e in
relazione ai risultati illustrati nelle diverse relazioni disciplinari.
2.1. Competenze chiave di cittadinanza
Sapersi attenere alle regole, rispettando persone, luoghi e oggetti.
Avere senso di responsabilità ed autocontrollo.
Avere la capacità di ascolto valutando l’opportunità di interventi personali.
Sapere collaborare con i compagni e con gli insegnanti, assumendosi responsabilità e
contribuendo con le proprie conoscenze ed esperienze.
Interessarsi ai problemi della società, valorizzando a tal fine anche gli strumenti culturali
forniti dalle discipline scolastiche.
essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
2.2. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre
ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi
superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero
arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
2.3. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
2.4. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda
dei diversi contesti e scopi comunicativi;
• saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre
lingue moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.

7
2.5. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici,
immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi
storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui
si studiano le lingue.
2.6 Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di
approfondimento.

8
3. CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI
3.1 Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Roberta Tuccella
Presentazione della classe Ho insegnato Italiano in questa classe per l’intero triennio. Nel corso di questi anni ho avuto modo
di conoscere i ragazzi in modo molto approfondito, seguendoli non solo nel loro percorso scolastico,
ma anche nel loro percorso di formazione e crescita umana. Ho intessuto con loro un dialogo piuttosto
intenso, volto sempre ad attualizzare e rendere vive le problematiche affrontate nell’ambito della
disciplina, utilizzando spesso la riflessione in campo filosofico e letterario per dibattere questioni e
tematiche di forte attualità ed impatto emotivo sul loro vissuto di adolescenti in crescita. La
partecipazione della classe al dialogo educativo si è mantenuta costante nel corso dell’intero triennio
ed è sempre stata volta a favorire l’acquisizione di un sapere critico e ragionato, piuttosto che alla
mera acquisizione libresca degli argomenti di studio. La mia relazione con la classe è stata incentrata
sempre sui principi dell’onestà e della trasparenza, sia nella gestione della comunicazione
interpersonale che sul piano più strettamente didattico. A tale proposito occorre rilevare che il livello
della relazione con i ragazzi si è mantenuto sempre alto ed ha contribuito ad instaurare un clima di
correttezza, fiducia, armonia e collaborazione in ogni momento della vita scolastica e nello
svolgimento di tutte le attività affrontate nel percorso, finanche dei viaggi di istruzione. Senza dubbio
soddisfacente risulta pertanto il livello di maturità raggiunto sul piano della crescita umana. Quanto
al rendimento scolastico, sebbene diversificato per ciascun singolo studente, esso si è mantenuto
costante nel tempo ed in taluni casi ha fatto registrare notevoli miglioramenti rispetto ai livelli di
partenza. In generale si può affermare che la classe abbia raggiunto un discreto livello di preparazione,
conseguendo, in taluni casi, risultati buoni o addirittura ottimi. Permangono in qualche singolo
studente difficoltà nell’elaborazione del testo scritto e del discorso orale, conseguenza di uno studio
ed un impegno non sempre costanti ed adeguati. Per quanto mi riguarda ho sempre cercato di
valorizzare i ragazzi più deboli e il meglio delle loro prestazioni, facendo leva sui loro punti di forza
piuttosto che focalizzarmi sulle loro debolezze.
Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe
Come precisato nel Piano di lavoro annuale, al quale si rimanda, le attività proposte alla classe sono
state volte soprattutto al consolidamento di competenze nell’ambito della comunicazione orale,
della comprensione e interpretazione dei testi e della produzione di testi scritti, prevalentemente
analisi del testo, saggi brevi, articoli di giornale, testi argomentativi.
E’ d’obbligo sottolineare che il livello di conoscenze e competenze complessivamente raggiunto dai
ragazzi risulta molto eterogeneo, soprattutto quando si fa riferimento alle competenze più alte e
complesse che richiedono consapevolezza, visione interdisciplinare e una riflessione metacognitiva.
Va altresì precisato, tuttavia, che ciascun ragazzo ha mostrato nel tempo un progressivo
miglioramento e affinamento delle proprie abilità, considerate rispetto ai propri livelli di partenza, e
pertanto il livello conseguito da ciascun alunno risulta nel complesso sufficiente.
Di seguito si riportano le conoscenze e le competenze, acquisite in maniera diversificata da ciascun
alunno, relative ai tre ambiti e che hanno costituito gli obiettivi del lavoro svolto nel corrente anno
scolastico.
Conoscenze:
1. Conoscenza degli aspetti più significativi del Romanticismo, Verismo, Decadentismo e dei
principali aspetti della letteratura del Novecento.
2. Padronanza della lingua italiana.
3. Conoscenza dei testi antologici in programma e delle varie tipologie testuali affrontate.

9
Competenze:
1. Utilizzare con sicurezza e proprietà gli strumenti espressivi ed argomentativi, adeguando l’uso
della lingua ai diversi contesti e scopi
a) Ascoltare consapevolmente per focalizzare in modo critico i nuclei concettuali del
messaggio
b) Esprimersi con chiarezza e correttezza, variando, a seconda dei diversi contesti e scopi,
l’uso personale della lingua
c) Compiere analisi e sintesi con metodo
d) Organizzare e motivare un ragionamento personale
e) Illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico.
2. Leggere, comprendere e interpretare criticamente e in un’ottica interdisciplinare testi
complessi di vario tipo
a) Acquisire la consapevolezza della lettura come conoscenza di sé e del mondo
b) Operare una riflessione metalinguistica sulla funzione dei diversi livelli espressivi
c) Acquisire piena consapevolezza della dimensione sincronica e diacronica della letteratura e
della lingua italiana
d) Utilizzare in modo appropriato le tecniche di analisi di un testo letterario e non letterario
e) Contestualizzare in modo critico la produzione dei vari autori
f) Esprimere valutazioni critiche, logicamente argomentate.
3. Produrre elaborati curandone la dimensione testuale, ideativa e linguistica
a) Controllare in modo consapevole le strutture grammaticali e utilizzare in modo selettivo il
lessico e il registro a seconda della tipologia richiesta
b) Padroneggiare con sicurezza i processi logico/elaborativi: efficacia progettuale, coerenza e
coesione, sviluppo argomentativo, completezza
c) Analizzare e contestualizzare un testo con pertinenza, esaustività e consapevolezza critica
(tipologia A)
d) Elaborare un articolo e/o un saggio (tipologia B) con correttezza ed efficacia: uso dei
documenti; pertinenza nella scelta del titolo, della destinazione editoriale (articolo di
giornale); capacità argomentativa; originalità; visione interdisciplinare; uso di un registro
linguistico coerente con la tipologia testuale
e) Sviluppare un tema di argomento storico e/o generale con elaborazione delle conoscenze e
dei dati in prospettiva storica (tipologia C-D) o con riflessione personale in rapporto a
problematiche contemporanee.
Metodi, mezzi e tempi
Per quanto riguarda le metodologie adottate, si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, utilizzate
soprattutto nella presentazione dei quadri storici di riferimento, che a lezioni interattive, volte a
sollecitare la partecipazione attiva dei ragazzi nell’analisi ed interpretazione dei testi proposti.
Inoltre la presentazione di alcune parti di programma, nonché analisi di testi, sono state affidate a
gruppi di alunni che, dopo aver lavorato in gruppo, si sono cimentati in esposizioni autonome e
personali rivolte alla classe. Oltre all’utilizzo del libro di testo in adozione, che ha comunque
rappresentato il principale strumento di lavoro, si è fatto talvolta ricorso alla visione di film e di
spettacoli teatrali (c.f.r. programma svolto) e alla lettura di testi d’autore in versione integrale.
Per quanto riguarda i tempi, bisogna sottolineare che lo svolgimento del programma ha subito
rallentamenti in vari momenti dell’anno per ragioni diverse, pertanto, la trattazione di alcuni
argomenti è stata meno approfondita.
Libri di testo G. Baldi, S. Giusto, M. Razetti, G. Zaccaria, Il piacere dei testi, Ed. Paravia
1. Vol. 4 L’età napoleonica e il Romanticismo
2. Vol. Giacomo Leopardi
3. Vol. 5 Dall’età postunitaria al primo Novecento

10
4. Vol. 6 Dal periodo tra le due guerre ai giorni nostri.
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso, qualunque edizione.
Oltre ai testi in adozione, si è fatto uso di testi di narrativa in versione integrale.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
La verifica formativa è stata continua e volta a coinvolgere collettivamente il gruppo-classe nella
lettura e spiegazione dei testi, in fase di revisione del lavoro svolto a casa o a scuola e di
esercitazione sui testi in classe.
Le verifiche sommative scritte sono state due per il trimestre, tre per il pentamestre e hanno previsto
l’elaborazione di testi di varia tipologia (secondo le indicazioni del Ministero per l’esame di Stato):
esercizi di analisi del testo, produzione di saggi brevi, articoli di giornale, testi argomentativi.
L’ultima verifica scritta, che sarà effettuata il 17 maggio, avrà la durata di sei ore, e varrà come
simulazione della prima prova dell’esame di Stato. Le tracce da assegnare saranno comuni a tutte le
classi quinte e verranno concordate in sede di Dipartimento.
Le verifiche sommative orali, sono state due per il trimestre e tre per il pentamestre, e hanno mirato
alla verifica dell’acquisizione e comprensione dei contenuti proposti, all’analisi stilistica e
contenutistica dell’opera letteraria, alla contestualizzazione della stessa nel periodo di riferimento,
all’inquadramento storico dell’autore, sottolineandone elementi essenziali della biografia e della
poetica.
Per i criteri di valutazione seguiti ci si è attenuti alla programmazione disciplinare per le classi
quinte dell’indirizzo scientifico e alla programmazione educativa del Consiglio di Classe. La
valutazione è stata espressa con votazione numerica da 1 a 10 e sempre comunicata agli alunni, e ha
mirato sempre a rendere gli studenti più responsabili e consapevoli delle competenze acquisite o da
acquisire.
Nella valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi specifici
della disciplina, dell’interesse, della partecipazione, della continuità, dell’impegno, sia in classe che
a casa, e dell’evoluzione rispetto al livello di partenza.
Attività integrative La classe ha assistito ad una messa in scena delle Operette morali di G. Leopardi che si è tenuta a
scuola nel mese di gennaio e, nel mese di febbraio, ad uno spettacolo al teatro di Rifredi tratto dal
romanzo Uno, nessuno, centomila di Luigi Pirandello.
Circa metà della classe ha assistito, inoltre, a quattro spettacoli serali presso il Teatro Metastasio di
Prato (Il berretto a sonagli di L. Pirandello, Smith e Wesson di A. Baricco, Casa di bambola di H.
Ibsen, Chi ha paura di V. Woolf di E. Albee), che sono stati occasione di approfondimento e
discussione in classe. Infine, nel mese di maggio, i ragazzi assisteranno al musical Notre Dame de
Paris di R.Cocciante
Contenuti disciplinari
N. B. Le parti di programma evidenziate sono quelle che si prevede di svolgere nel periodo
successivo al 15 maggio; sarà pertanto mia cura segnalare alla Commissione eventuali
modifiche e decurtazioni del programma, al momento non prevedibili.
L’età del Romanticismo 1. Aspetti generali del Romanticismo europeo
Le tematiche “negative”
Le grandi trasformazioni storiche
Le contraddizioni reali e le tensioni della coscienza collettiva
Il Romanticismo come espressione della grande trasformazione moderna
Il mutato ruolo sociale dell’intellettuale e dell’artista

11
I temi del Romanticismo europeo: Il rifiuto della ragione e l’irrazionale; inquietudine
e fuga dalla realtà presente; l’infanzia, l’età primitiva e il popolo
L’eroe romantico. Titanismo e vittimismo
Il lato oscuro della realtà
Il Romanticismo positivo.
2. L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’età risorgimentale
Il Risorgimento e le guerre d’indipendenza
Divisione politica e arretratezza economica
La formazione della classe borghese
I ceti popolari
3. Le ideologie
4. Le istituzioni culturali
5. Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale
6. Il pubblico
7. Lingua letteraria e lingua d’uso comune.
Il Romanticismo 1. La concezione dell’arte e della letteratura nel Romanticismo europeo
La poetica classicistica
La poetica romantica
A.W. Schlegel: dal Corso di Letteratura drammatica, La “ melancolia” romantica e l’ansia
d’assoluto;
Novalis: dai Frammenti, Poesia e irrazionale
W. Wordsworth: dalla Prefazione alle Ballate Liriche, La poesia, gli umili, il quotidiano
V. Hugo: dalla Prefazione a Cromwell, Il “grottesco” come tratto distintivo dell’arte
moderna.
2. Il movimento romantico in Italia
La polemica con i classicisti
La poetica dei Romantici italiani
Madame de Stael: dalla “Biblioteca italiana”, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni
P. Giordani: “Biblioteca italiana”, Un “italiano” risponde al discorso della de Stael
G. Berchet: dalla Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo, La poesia popolare.
3. La poesia in Italia
La poesia patriottica
La poesia dialettale
G. Gioacchino Belli: dai Sonetti, Le cappelle papale - Er giorno der giudizzio - Chi cerca
trova
4. Il romanzo nell’età romantica
Il romanzo in Europa
Il romanzo storico
Il romanzo realistico di ambiente contemporaneo
Il romanzo in Italia
La polemica sul romanzo
Il romanzo storico
Il romanzo sociale e il romanzo psicologico.
Alessandro Manzoni : la vita, le opere, il pensiero, la poetica. Dall’Epistolario: La funzione della letteratura: render le cose “un po’ più come dovrebbono
essere”
Dalla Lettre a M. Chauvet: Il romanzesco e il reale; Storia e invenzione poetica
Dalla Lettera sul Romanticismo: L’utile, il vero, l’interessante.

12
Gli Inni sacri : La Pentecoste
Le Odi: Il cinque Maggio
Le tragedie: L’adelchi, Il conte di Carmagnola
La novità della tragedia manzoniana
Dall’ Adelchi, atto V, Morte di Adelchi: la visione pessimistica della storia
I Promessi Sposi, genesi, struttura e contenuto dell’opera
Giacomo Leopardi: la vita,il pensiero, le opere, la poetica. Dalle Lettere, “ Sono così stordito dal niente che mi circonda…”; “ Mi si svegliarono alcune
immagini antiche…”
Dallo Zibaldone: la teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
L’antico; Indefinito e infinito;Il vero è brutto; Teoria della visione; Parole poetiche, Ricordanza e
poesia; Teoria del suono; Indefinito e poesia; Suoni indefiniti; La doppia visione; La rimembranza.
Dai Canti: L’ Infinito
La sera del dì di festa
Ultimo canto di Saffo
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
Il passero solitario
A se stesso
La ginestra o il fiore del deserto
Le Operette morali e l’ “arido vero”
Dalle Operette morali:
Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di Plotino e di Porfirio
Dialogo di Tristano e di un amico
Dialogo di Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez
Nel corso della classe terza i ragazzi hanno assistito alla visione del film: Il giovane favoloso di
Mario Martone incentrato sulla vita di G. Leopardi.
L’età postunitaria 1. Le strutture politiche, economiche e sociali
2. Le ideologie
3. Le tendenze filosofiche
4. Le istituzioni culturali
5. La lingua
La Scapigliatura: aspetti generali La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
E. Praga: Preludio
A. Boito: Dualismo
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano Il Naturalismo francese e la poetica di Zola
E. Zola: da Il romanzo sperimentale, Prefazione: Lo scrittore come “operaio” del progresso
sociale
Il Verismo italiano: aspetti generali.
La poetica di Verga e Capuana

13
L’assenza di una scuola verista.
L. Capuana: Scienza e forma letteraria: l’impersonalità.
Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
Da L’amante di Gramigna, Prefazione: Impersonalità e “regressione”
Dalle Lettere, L’ “eclisse” dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato
Da Vita dei campi: Fantasticheria
L’ideologia verghiana
Il “Diritto di giudicare” e il pessimismo
Il valore conoscitivo e critico del pessimismo
Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano
Da Vita dei campi: Fantasticheria – Rosso malpelo
Il ciclo dei vinti
I Malavoglia: lettura integrale del romanzo durante l’estate scorsa
Da I Malavoglia: analisi della Prefazione, I “ vinti “ e la “fiumana del progresso”
Dalle Novelle rusticane: La roba
Da Mastro don Gesualdo: La tensione faustiana del self made man – La morte di mastro don
Gesualdo
In occasione della rappresentazione teatrale di Casa di bambola di H. Ibsen, è stata fatta una
presentazione dell’opera e si eseguita in classe l’interpretazione della scena conclusiva dell’atto III,
La presa di coscienza di una donna.
Il Decadentismo: aspetti generali 1. L’origine del termine “ Decadentismo”
2. La visione del mondo decadente
3. Gli strumenti irrazionali del conoscere
4. La poetica del Decadentismo (l’Estetismo, l’oscurità del linguaggio, le tecniche espressive)
5. Temi e miti della letteratura decadente
6. Decadentismo e Romanticismo
7. Decadentismo e Naturalismo
Cenni sulla poesia simbolista
C. Baudelaire, da I Fiori del male, Corrispondenze – L’albatro – Spleen
P. Verlaine, da Un tempo e poco fa, Arte poetica
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero, la poetica Da Il Piacere : Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
Da Le vergini delle rocce : “Il programma politico del superuomo”
Da Alcyone, La pioggia nel pineto – Pastori
Il periodo “notturno”
Dal Notturno, La prosa “notturna”
Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, le opere, la poetica Da Il Fanciullino: Una poetica decadente
Da Myricae:
Novembre; Arano; Lavandare;
X agosto; L’assiuolo; Temporale; Il lampo
Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno
Il primo Novecento 1. La situazione storica e sociale in Italia .
2. L’ideologia
3. Le istituzioni culturali
4. La lingua

14
La stagione delle avanguardie I Futuristi:
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo
Manifesto tecnico della letteratura futurista
da Zang tumb tuum: Bombardamento
C. Govoni, da Rarefazioni e parole in libertà, Il Palombaro
Le avanguardie in Europa: Dadaismo e Surrealismo T. Tzara: Manifesto del Dadaismo
A Breton: Manifesto del Surrealismo
La lirica del primo Novecento in Italia I Crepuscolari:
G. Gozzano: La signorina Felicita ovvero la felicità, strofe I-III
S. Corazzini: da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale
Italo Svevo: la vita, il pensiero, le opere, la poetica
Il primo romanzo: Una vita
Lettura integrale dei romanzi Senilità e La coscienza di Zeno durante la scorsa estate
Luigi Pirandello: la vita,il pensiero, le opere, la poetica Dal saggio L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale
Da Novelle per un anno: La trappola; Ciaula scopre la Luna; Il treno ha fischiato
Il romanzo pirandelliano
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale durante la scorsa estate
Da: Uno nessuno e centomila, “ Nessun nome”
Nel corso del corrente anno i ragazzi hanno assistito ad un allestimento teatrale del romanzo Uno,
nessuno e centomila al teatro di Rifredi.
Il teatro pirandelliano
Lettura integrale della piece teatrale, Così è ( se vi pare)
Nel corso della classe quarta e quinta circa metà della classe ha assistito alla rappresentazione
teatrale delle seguenti opere: L’uomo, la bestia e la virtù; Il berretto a sonagli; Enrico IV
La poesia del Novecento: tra le due guerre La realtà politico- sociale in Italia
La cultura
Saba: la vita, la poetica e le opere Dal Canzoniere:
A mia moglie
La capra
Città vecchia
Mia figlia
Amai
Mio padre è stato per me l’assassino
Ungaretti: la vita, la poetica e le opere Da L’allegria: Noia
In memoria
Il porto sepolto
Veglia
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Natale
Da Il dolore: La madre

15
Non gridate più
Montale: la vita, la poetica e le opere
Da Ossi di seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere
Forse un mattino andando
Da Le occasioni:
La casa dei doganieri
Da Satura:
Ho sceso dandoti il braccio
L’Ermetismo
Quasimodo: la vita, la poetica e le opere
Da Acque e terre: Ed è subito sera
Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici
Il dopoguerra
Il quadro politico, le trasformazioni economiche e sociali
Percorsi tematici:
La guerra e la Resistenza
Lettura di pagine significative tratte da romanzi
I. Calvino, da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV e VI, Fiaba e Storia
B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny, Il “ settore sbagliato della parte giusta”
E Vittorini, da Uomini e no, capp. CI-CIV, L’offesa all’uomo
P. Levi, da Se questo è un uomo, cap. II, Il canto di Ulisse
Il dibattito delle idee nell’Italia del dopoguerra
A. Gramsci, dai Quaderni del carcere, Il carattere non nazionale- popolare della letteratura
italiana
E. Vittorini, da Il Politecnico, L’ “impegno” e la nuova cultura
Il Neorealismo
Considerata la mancanza di tempo rimanente, insufficiente per poter approfondire la
letteratura del secondo dopoguerra, ho deciso di presentare ai ragazzi alcuni tra i film più
significativi del Neorealismo, in quanto ritengo che attraverso le immagini i ragazzi possano
costruirsi in modo più immediato il quadro e il senso di un’epoca.
Il cinema neorealista
Visione dei seguenti film:
Roma città aperta di R. Rossellini 1945
Ladri di biciclette di V. De Sica 1948
La terra trema di L. Visconti 1948
Dante Alighieri, Paradiso, I, II (sintesi) III, IV, VI VIII, XV, XVI (sintesi), XVII, XXIII, XXXII (in
sintesi), XXXIII (il canto è stato presentato nella versione commentata e recitata da Roberto
Benigni in Santa Croce).
Da Tutto Dante, canto XXXIII del Paradiso commentato e recitato da Roberto Benigni
Ritengo doveroso precisare che la lettura del testo di Dante è stata sempre volta a mettere in luce il
contenuto profondo del testo, il significato e il messaggio grandioso che il sacrato poema ci
trasmette. Ciò vuol dire che pur non trascurando l’aspetto formale del testo, ho evitato un approccio
pedante all’opera, trascurando a volte questioni tecniche e filologiche che avrebbero fatto venir
meno quell’ attenzione che i ragazzi hanno sempre manifestato durante la lettura.

16
3.2 Lingua e Letteratura Latina Prof.ssa Roberta Tuccella
Presentazione della classe Anche per quanto riguarda l’insegnamento del Latino ho seguito la classe per l’intero triennio.
L’approccio alla disciplina, come spesso accade, è risultato piuttosto problematico per una parte dei
ragazzi, soprattutto per quanto attiene alle questioni di ordine linguistico. Si è cercato, pertanto, di
far leva sullo studio della letteratura e delle problematiche ad essa connesse al fine di rendere meno
ostico il rapporto con la disciplina stessa. Sono stati affrontati brani di autore in lingua originale che
gli alunni sono in grado di tradurre e analizzare proprio perché preparati con la guida
dell’insegnante durante l’anno scolastico e brani in traduzione, al fine di consentire una più vasta
conoscenza delle opere studiate e della cultura latina.
Nel complesso i risultati raggiunti possono dirsi discreti e in molti casi buoni, per quanto riguarda la
conoscenza della storia letteraria, meno apprezzabili e diversificati, per quanto attiene le conoscenze
grammaticali e la competenza di traduzione.
Obiettivi raggiunti
Conoscenze Conoscenza degli aspetti più significativi della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia
all’età tardoantica
Conoscenza dei testi antologici presenti nel programma (in traduzione italiana o in latino)
Conoscenza delle strutture fondamentali della lingua latina
Competenze
Si precisano le competenze che gli alunni hanno acquisito in misura diversa, in base alla loro
serietà, costanza e assiduità nell’affrontare il lavoro scolastico, in relazione ai tre ambiti
fondamentali di studio.
Leggere e comprendere un testo d’autore
1. Comprendere il valore della lettura come conoscenza del mondo antico
2. Operare una riflessione sui generi letterari
3. Padroneggiare le tecniche di analisi di un testo letterario (morfologia, articolazione
del periodo, figure retoriche)
4. Collocare un testo nella produzione dell’autore e nel contesto culturale
5. Esprimere valutazioni critiche, anche semplici, ma logicamente argomentate
Interpretare un passo latino in un’ottica di traduzione e di contestualizzazione
1. Individuare il messaggio globale di un testo letterario
2. Avvalersi di conoscenze extratestuali (letterarie, mitologiche, storico-filosofiche etc.)
3. Cogliere i tratti distintivi del genere letterario, del lessico e dello stile di un autore
4. Sviluppare confronti tematici
Rilevare i tratti di alterità e continuità della lingua e cultura latina
1. Riconoscere lo sviluppo diacronico nella lingua letteraria
2. Avvertire il lessico come veicolo di cultura nel sistema di usi, costumi, pensiero
3. Sviluppare la consapevolezza della diversità nel confronto fra modernità e classicità.
Metodi, mezzi e tempi
Per quanto riguarda il metodo di lavoro, si è fatto ricorso sia alla lezione frontale che alla lezione
interattiva, privilegiando, ove possibile, i momenti di discussione e confronto. L’analisi e la
traduzione dei testi è stata sempre preceduta da un’ampia trattazione del periodo storico, del
pensiero dell’autore e dell’opera in questione, al fine di favorire la comprensione del testo e la
riflessione su di esso. Come già affermato, alcuni brani sono stati forniti in traduzione al fine di
consentire il confronto con un più ampio numero di testi. Anche di questi, tuttavia, si è proceduto
all’analisi testuale e alla contestualizzazione.

17
Strumenti di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche formative sono state continue e volte a coinvolgere collettivamente il gruppo-classe
in tutti i momenti dell’attività didattica.
Le verifiche sommative scritte sono state due nel trimestre e tre nel pentamestre e sono state
articolate in esercizi di traduzione di varia tipologia, brani noti e non noti d’autore da tradurre dal
latino o brani noti d'autore da analizzare nelle strutture sintattiche e stilistiche, da tradurre dal latino
e da contestualizzare sul piano storico e letterario. Sono state somministrate anche verifiche scritte
della stessa tipologia proposta nella simulazione della terza prova dell’esame di stato (Tipologia B)
Le prove orali hanno previsto colloqui e interrogazioni per accertare le conoscenze e le competenze
sul programma di letteratura svolto (conoscenza dei quadri storici di riferimento, individuazione dei
caratteri fondamentali di un autore o di un genere letterario) e prove di traduzione su brani già
tradotti in classe, con domande di comprensione ed analisi del testo. Nella valutazione si è tenuto
conto, oltre che delle conoscenze e competenze acquisite, anche della partecipazione, dell’impegno
e dell’interesse dimostrati dallo studente nel corso dell’intero anno scolastico. I criteri di
valutazione e i punteggi assegnati sono presenti nella tabella formulata collegialmente dagli
insegnanti di area.
Contenuti
N. B. Le parti di programma evidenziate sono quelle che si prevede di svolgere nel periodo
successivo al 15 maggio; sarà pertanto mia cura segnalare alla Commissione eventuali
modifiche e decurtazioni del programma, al momento non prevedibili.
Testo in adozione: A Diotti, S. Dossi, F. Signoracci, Libera Lectio, Ed. Sei
La prima età imperiale. Da Tiberio a Nerone (16-68 d.C)
I nodi della storia
Società e cultura
Pubblico, generi letterari e scrittori nella prima età imperiale.
Fedro L’autore, l’opera
Prologus
Tiberio Cesare e il portinaio (II,5)
La vedova e il soldato (Appendix perottina, 13)
Lupus et agnus (I, 13)
L’asino al vecchio pastore (I, 5)
Lucio Anneo Seneca L’autore, l’opera
Percorsi antologici
1. La vita interiore sotto il principato Consolatio ad Helviam matrem, 8, Nessun luogo è esilio (in traduzione italiana)
De ira III, 36, Necessità dell’esame di coscienza (in traduzione italiana)
De vita beata, 17-18, Parli in un modo e vivi in un altro! (in traduzione italiana)
Epistulae morales ad Lucilium, 23, I-8, Qual è la vera gioia? (in traduzione italiana)
Epistulae morales ad Lucilium, 80, 5-10, Il teatro della vita (in traduzione italiana)

18
2. Il senso del tempo Epistulae morales ad Lucilium, I, Solo il tempo è nostro (in traduzione italiana)
De brevitate vitae I, Una protesta sbagliata ( in latino)
De brevitate vitae 2, Il tempo sprecato ( in latino)
De brevitate vitae, 11, Perché ingannare se stessi? ( in latino)
De brevitate vitae,15, Il saggio è come un dio (in traduzione italiana)
3. La provvidenza e il dolore del giusto
Epistulae morales ad Lucilium,41, Dio è dentro di te (in traduzione italiana)
De providentia, I, 1; 5-6, Se la provvidenza regge il mondo…( in latino)
De providentia 6, 1-5, L’uomo buono non subisce il vero male ( in latino)
De providentia 6, 6-8, All’uomo resta sempre una via di fuga (in latino)
4. Il prossimo è anche lo schiavo Epistulae morales ad Lucilium, 95, 51-53, In comune nati sumus (in traduzione italiana)
Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6, Gli schiavi sono uomini I (in latino)
Epistulae morales ad Lucilium 47, 16-19, Gli schiavi sono uomini III (in latino)
5. Il filosofo e il principe De clementia, I, 5, 2-5, la clemenza si addice ai potenti(in traduzione italiana)
De tranquillitate animi, 4, Il sapiente e la politica(in traduzione italiana)
6. Lo spettacolo della natura Naturales quaestiones, VI, 2, L’uomo, fragile creatura (in traduzione italiana)
7. La tragedia nascosta nell’animo umano Phaedra, vv. 589.672, La confessione di Fedra (in traduzione italiana)
Medea, vv.891-977, Il lucido delirio di Medea (in traduzione italiana)
Marco Anneo Lucano
L’autore, l’opera
La Pharsalia
Aulo Persio Flacco
L’autore, l’opera
Le Satire
Il romanzo dalla Grecia a Roma.
Petronio L’autore, l’opera
Il Satyricon
Percorsi antologici
1. Scene da commedia Satyricon, 12-15, Un mantello rubato (in traduzione italiana)
Satyricon, 137-137, Una battaglia contro le oche(in traduzione italiana)
2. I personaggi del Satyricon: Trimalchione Satyricon, 27-28, 1-5 Alle terme (in traduzione italiana)
Satyricon, 32-33, 1-4 Trimalchione si unisce al banchetto (in traduzione italiana)
Satyricon ,34 “Vive più a lungo il vino dell’ometto!” (in traduzione italiana)
Satyricon,75, 8-11; 76 L’apologia di Trimalchione (in traduzione italiana)

19
Satyricon, 77, 7; 78, Il funerale di Trimalchione (in traduzione italiana)
3. I personaggi del Satyricon: Fortunata Satyricon,37-38 La descrizione di Fortunata (in traduzione italiana)
Satyricon,74 Alterco tra coniugi (in traduzione italiana)
4. Una fabula milesia nel romanzo: la matrona di Efeso
Satyricon, 111, 1-5 Una donna fedele (in latino)
Satyricon,111, 6-13 Il soldato innamorato (in latino)
Satyricon,, 112, 1-3 “ Non si lotta contro l’amore” (in latino)
Satyricon,112, 4-8 L’astuzia della matrona (in latino)
L’età flavia. Da Vespasiano a Domiziano (69-96)
I nodi della storia
Società e cultura
Pubblico, generi letterari e scrittori nell’età flavia
Plinio il vecchio La Naturalis Historia
L’epica nell’età flavia: Stazio La Tebaide, L’Achilleide, Le Silvae
Marco Fabio Quintiliano L’autore, l’opera
L’Institutio oratoria
Percorsi antologici
1. Sulle orme di Quintiliano: l’educazione a Roma Institutio oratoria, I, 2, 1-8 E’ meglio educare in casa o alla scuola pubblica? (in traduzione
italiana)
Institutio oratoria,II,2, 1-4 La scelta del maestro (in latino)
Institutio oratoria,II, 2, 5-8 Il maestro sia come un padre (in latino)
Institutio oratoria, I, 3, 6-13 Tempo di gioco, tempo di studio (in traduzione italiana)
Institutio oratoria,I, 3, 14-17 Inutilità delle punizioni corporali (in traduzione italiana)
Institutio oratoria, II, 2, 9-10; 15 Il giudizio sia solo del maestro (in latino)
Institutio oratoria, I, 8, 5-6;I, 9, 1-2, II, 4,2, L’importanza e la qualità delle letture (in traduzione
italiana)
2. Quintiliano critico e storico della letteratura
Institutio oratoria, X,1, 125-131 Un difficile giudizio su Seneca (in traduzione italiana)
L’epigramma
Marco Valerio Marziale L’autore, l’opera
I tipi umani:
Elia
Acerra
L’ ipocrita
Lettura in traduzione italiana di epigrammi tratti dagli Xenia (Il pepe, La fava, La lenticchia, Le

20
rape, I funghi…) e dagli Apophoreta (Un lumino a olio, Una palla di piume, Un’ oliera di avorio,
Le coppe di Sorrento)
Il “secolo d’oro” dell’impero. Da Traiano a Commodo (96-192)
I nodi della storia
Società e cultura
Pubblico, generi letterari nel “secolo d’oro” dell’impero
Decimo Giunio Giovenale L’autore, l’opera
Le Saturae
Pubblio Cornelio Tacito L’autore, l’opera
Percorsi antologici
1. La Germania di Tacito
Germania 1, I confini della Germania (in latino)
Germania 4, Origine e aspetto fisico dei Germani (in latino)
Germania 5, Risorse del suolo e del sottosuolo; le ricchezze (in traduzione italiana)
Germania 7, I comandanti e il comportamento in battaglia (in traduzione italiana)
Germania 9, Gli dei e il senso del sacro (in latino)
Germania 20, L’educazione dei figli e l’eredità (in latino)
Germania 22, Vita quotidiana e ingenuità dei Germani (in traduzione italiana)
Germania 37, “ Da tanto tempo la Germania viene sconfitta!” (in latino)
2. Le Historiae: un nuovo progetto storiografico Historiae I, 1, Il proemio: l’argomento e l’incorrupta fides (in traduzione italiana)
Historiae I, 2-3, Il proemio: “ Affronto un’epoca atroce” (in traduzione italiana)
3. I principi negli Annales Annales I, 9-10, Augusto (in traduzione italiana)
Annales VI, 50-51, Tiberio (in traduzione italiana)
Annales XVI, 4; 6 , Nerone (in traduzione italiana)
4. Una tragedia nella storia: l’assasinio di Agrippina
Annales XIV, 3-4 Il piano è ordito (in traduzione italiana)
Annales XIV, 5-6 Fallisce il primo tentativo (in traduzione italiana)
Annales XIV, 7-10 Il matricidio (in traduzione italiana)
5. L’incendio di Roma
Annales XV, 38, 1-3 Roma in fiamme (in latino)
Annales XV, 38, 4-7 Il panico della folla (in latino)
Annales XV, 39 La reazione di Nerone (in latino)
Annales XV,44, 1-3 Le accuse ai cristiani (in latino)
Plinio il giovane e il genere epistolare
L’autore, l’opera
Gaio Svetonio Tranquillo e il genere autobiografico
L’autore, l’opera

21
Apuleio
L’autore, l’opera
Metamorphoseon libri XI, IV,28-35 passim Le nozze “mostruose” di Psiche (in trad. italiana)
Metamorphoseon libri XI, V, 21-23 Psiche contempla di nascosto Amore (in trad. italiana)
Metamorphoseon libri XI, VI, 16-21 Psiche scende agli inferi (in trad. italiana)
Fra l’antichità e il Medioevo
Agostino
L’autore, l’opera
---------------

22
3.3 Lingua e Cultura Inglese Prof.ssa Simona Pucci
Profilo della classe
La classe, composta attualmente da 23 alunni, 14 ragazze e 9 ragazzi, ha lavorato con me negli ultimi
due anni.
La quasi totalità degli alunni ha sempre mostrato interesse verso la materia e la partecipazione attiva
in classe è andata crescendo in quest’ultimo anno anche se alcuni alunni devono ancora essere
stimolati a dare un loro contributo. Il lavoro svolto in classe è generalmente proficuo e gli alunni si
sono dimostrati pronti a collaborare con l’insegnante e fra di loro nel lavoro in gruppo o a coppie.
L’impegno e il rispetto delle consegne dei compiti assegnati è stato regolare per la maggioranza degli
studenti, ma alcuni alunni hanno mostrato un impegno alterno e, soprattutto, un consolidamento di
quanto appreso non sempre adeguato. Nel corso dei due anni diversi alunni hanno mostrato inoltre di
aver migliorato la propria capacità di esprimere opinioni e di argomentarle e la rielaborazione
personale di quanto appreso.
Oltre al corso di lingua e alla parte relativa alla cultura, la classe ha lavorato per sostenere gli esami
di certificazione Cambridge. 15 alunni hanno conseguito la certificazione del livello B1 al termine
del biennio. Al termine del terzo anno scolastico, 7 alunni hanno conseguito la certificazione B2
(FCE) e lo scorso anno due alunni hanno conseguito la certificazione C1 sostenendo l’esame CAE.
Negli ultimi due anni la classe ha aderito sia al progetto Cittadinanza Globale che prevede lezioni
tenute da docenti tirocinanti della Monash University che al progetto di collaborazione con il MIT
per l’attuazione di moduli di CLIL nelle materie scientifiche.
Al momento della stesura di questo documento la classe presenta varie fasce di profitto.
Un gruppo di alunni ha sviluppato capacità comunicative scritte ed orali buone; si sanno esprimere
efficacemente, in modo sostanzialmente accurato, mostrando di possedere un ampio vocabolario; fra
questi, alcuni in particolare hanno lavorato con costanza, mostrando di possedere oltre a competenze
comunicative molto buone, anche buone capacità analitiche e critiche.
Un altro gruppo ha raggiunto competenze comunicative più che sufficienti e/o discrete: riescono ad
esprimersi in modo fluido e abbastanza accurato, pur con qualche errore che non compromette la
comprensibilità e con un vocabolario discretamente ampio; sono capaci di produrre testi scritti
sufficientemente organizzati pur con qualche errore nell’uso delle forme linguistiche; sono capaci di
comprendere ed analizzare un testo letterario cogliendone gli aspetti più significativi e di esprimere
il proprio giudizio, anche operando confronti con altre opere e/o autori.
Il terzo gruppo è composto da un gruppo più esiguo di alunni per i quali il profilo delle competenze
coincide con quello degli obiettivi minimi stabiliti nel POF. Questo gruppo si caratterizza anche per
una partecipazione decisamente sporadica al dialogo didattico. Pur presentando incertezze nella
produzione orale, a causa di un vocabolario poco ampio e dell’uso di strutture linguistiche
decisamente più semplici, riescono quasi sempre ad esprimersi in modo globalmente sufficiente, pur
ricorrendo a riformulazioni; mostrano conoscenze complessivamente sufficienti e sono in grado di
cogliere i nuclei essenziali del testo. La produzione scritta risulta talvolta scarsamente sufficiente
perché caratterizzata dall’uso di strutture linguistiche semplici e dalla presenza di errori nell’uso delle
strutture e del vocabolario. Alcuni di questi alunni hanno, tuttavia, lavorato con impegno durante
l’anno scolastico per migliorare la propria competenza linguistica e colmare lacune pregresse, anche
con l’aiuto e il sostegno dei compagni in modalità di peer education.
Raggiungimento degli obiettivi
Rispetto quanto richiesto dal profilo in uscita del Liceo Scientifico, la maggioranza degli studenti ha
acquisito competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento, mentre 2 hanno già acquisito il livello C1.
Gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi, sebbene in gradi diversi in rapporto al livello di
rendimento. Sono in grado di

23
produrre messaggi orali in modo efficace e adeguati al contesto, pur con errori che non ne
compromettano la comprensibilità
esprimere il proprio giudizio e formulare ipotesi
partecipare a discussioni su argomenti affrontati in classe esprimendo il proprio accordo o
disaccordo
interagire in modo efficace con parlanti madrelingua
utilizzare la lingua straniera come lingua veicolare per apprendere discipline non linguistiche,
caratterizzanti il corso di studi
comprendere film e video autentici in lingua straniera, talvolta con l’ausilio dei sottotitoli
comprendere il significato generale di testi scritti autentici di vario genere
produrre brevi elaborati scritti, su tematiche affrontate in classe
analizzare testi letterari da un punto di vista linguistico e contenutistico in modo personale,
individuando parole chiave e ricavandone le tematiche principali.
confrontare testi, individuando nessi e relazioni, anche con altri generi artistici, in particolare
cinema e arte figurativa
chiarire, parafrasando, il significato di parole ed espressioni
riorganizzare quanto appreso utilizzando schemi personali e parole chiave
individuare i principali aspetti della cultura inglese
riconoscere gli aspetti essenziali dei principali movimenti letterari dell’Ottocento e del
Novecento nel Regno Unito e alcune fra le opere degli autori più significativi
Metodi, mezzi e tempi
Il corso di inglese di questo ultimo monoennio ha avuto come argomento principale la conoscenza
della cultura britannica, principalmente tramite lo studio della letteratura di lingua inglese
dell’Ottocento e del Novecento, che è stata lo spunto per far conoscere agli studenti i cambiamenti
sociali e culturali e le espressioni artistiche di questo arco temporale. I contenuti sono stati affrontati
seguendo di norma l’ordine cronologico, anche per permettere agli alunni il confronto con altre
discipline studiate. Sono stati scelti come spunto di riflessione testi degli autori o opere degli artisti
più rappresentativi, cercando di contestualizzarli nel loro periodo storico e culturale e confrontati,
laddove possibile, con le manifestazioni artistiche europee dello stesso periodo.
I vari moduli sono stati introdotti da una breve presentazione del periodo, talvolta tramite Expertrunde
o brainstorming, utilizzando quanto già conosciuto dai ragazzi e/o utilizzando immagini o materiale
video autentico, soprattutto presente in rete. Quasi la totalità del lavoro in classe e l’analisi dei testi
sono stati affrontati con modalità di pair work o group work per sollecitare i ragazzi ad un approccio
interpretativo personale, talvolta seguendo attività di comprensione predisposte dall’insegnante o dal
libro di testo, ma anche lasciando che ricavassero le informazioni sul testo sia in modo autonomo che
dal confronto con i punti di vista dei compagni.
Successivamente si è cercato di riflettere sui testi, sulla lingua e sulle tematiche al fine di stimolare
l’interesse e favorire la comunicazione in classe, invitando gli alunni ad esprimere un’opinione su
quanto appreso. In diversi casi gli studenti, in modo autonomo, hanno ricercato connessioni e/o
approfondito aspetti che li hanno interessati per poi presentarli ai compagni, contribuendo ad
arricchire ed integrare il corso.
L’approccio seguito implica che la conoscenza della produzione di un autore coincide
prevalentemente quanto individuato dagli studenti nei testi e nelle opere affrontate, mentre le
caratteristiche principali della loro produzione letteraria e la conoscenza della biografia sono state
presentate solo come aiuto per una miglior comprensione dei testi.
Per quanto riguarda la programmazione, le numerose attività effettuate nel pentamestre, quali Agorà,
periodi dedicati al recupero, i viaggi di istruzione, e le simulazioni delle prove d’esame, hanno avuto
come conseguenza una riduzione delle ore di lezione effettivamente svolte, per cui il programma
iniziale verrà in parte ridotto.

24
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche orali formali si sono basate su presentazioni su argomenti trattati in classe nelle quali
emergesse la capacità di selezionare elementi rilevanti insieme ad una resa personale e critica di
quanto trattato. Parte importante della valutazione è la partecipazione al dialogo didattico, gli
interventi durante le lezioni e, in alcune occasioni, il monitoraggio del lavoro a coppie o in gruppi.
Le verifiche scritte sono state principalmente produzioni scritte sulla base delle tipologie previste
dalla terza prova di Esame. Tali prove hanno talvolta previsto la comprensione di un breve testo da
cui poter prendere spunto per ricavare quegli elementi ritenuti rilevanti dagli studenti per trattare
l’argomento richiesto o operare possibili collegamenti, così da poter valutare, non solo le
conoscenze, ma la capacità di esprimere opinioni e, per gli alunni più capaci, quella di trovare
conessioni. Come stabilito dal Dipartimento di Lingue gli studenti possono utilizzare il dizionario
monolingue.
I criteri di valutazione sono quelli decisi nel Dipartimento di Lingue.
Materiali didattici e spazi utilizzati
I materiali utilizzati sono stati principalmente i libri di testo in adozione, testi aggiuntivi forniti
dall’insegnante, materiale video autentico di approfondimento reperibile online (documentari BBC,
video lezioni,); materiale iconografico; presentazioni ppt; schede di lavoro, film.
Vista la possibilità di utilizzare la connessione Internet e il proiettore in dotazione, le lezioni si sono
svolte prevalentemente in aula o in cineforum per la visione di film.
Contenuti
Module 1
The Romantic Age
A new sensibility; the emphasis on the individual. The two generations of Romantic poets; the
importance of nature. The Gothic novel.
Mary Shelley
Frankenstein or the Modern Prometheus: the influence of science, literary sources, narrative structure
and literary genre, main themes
from Frankenstein “ The Creation of the Monster” p. A286
William Wordsworth
Lyrical Ballads: a revolutionary work; the poet’s relationship with nature, the importance of senses
and memory, the poet’s task
From The preface: the poet, poetry, the language and content of poetry
I Wandered Lonely as A Cluod p. A249
The Solitary Reaper p. 251
Dorothy Wordsworth’s Journal Entry wordsworth.org.uk/dorothyjournal.html
Samuel Taylor Coleridge
Biographia Literaria: the willing suspension of disbelief; the Rime: the mariner; supernatural and
realistic elements; nature, the ballad form, possible interpretations of the poem
The Rime of the Ancient Mariner part 1 p. A 255
Part 2
Percy Bysshe Shelley
Freedom and rebellion; social criticism
England in 1819
John Keats
Poet of the senses
Bright Star
When I have Fears I may Cease to Be

25
La Belle Dame sans Merci
Romantic Painting
Constable, "The Hay Wain," 1821 Video https://www.youtube.com/watch?v=FKIHHeBe674
Turner, Slave Ship, 1840 Video https://www.youtube.com/watch?v=NoCW80MEGXY Art Fund UK Video: Turner and Constable: Who was the greater artist?
youtube watch?v=wLiN378TRSg
Module 2
The Early Victorian Age
The second industrialisation; an age of improvement; social progress and its downsides, social
context: the two nations; reforms to avoid revolution; Victorian frame of mind and middle class
values.
BBC The Victorians: Painting the town (first 15 minutes)
The Victorian novel
Charlotte Bronte
Jane Eyre: a mixture of literary genres; an unconventional character
From Jane Eyre “Life at Lowood”
“The Punishment”
“The madwoman in the attic”
Jean Rhys
Wide Sargasso Sea: how the novel relates to Jane Eyre; main events in the plot.
Video: a student’s review of the book (youtube.com/watch?v=EcxkuGp0DxA)
From Wide Sargasso Sea Extract: the end of the novel
Charles Dickens
Main features of his novels; social commitment; characterisation and style
from Oliver Twist “Before the board” p. A339
from Hard Times “Square principles” p.A343
“Coketown”
Module 3
The Late Victorian Age
Exploding contradictions. Late Victorian fiction
Thomas Hardy
Jude the Obscure: controversial issues, Hardy’s deterministic view, language and style
from Jude The Obscure “Suicide” phot
Aestheticism and Decadence.
Oscar Wilde
The rebel and the dandy. The Picture of Dorian Gray: hedonism, allegorical meaning of the novel.
Style.
from The Picture of Dorian Gray “The studio” p. A355
“ A New Hedonism” p.A358
Robert Luis Stevenson
The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Victorian hypocrisy, narrative techniques, the double,
influences and interpretations
from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde “ The Duality of Man”p.A375
“Jeckyll’s Experiment”

26
Module 4
War Poetry
Britain and World War I
The War Poets
Wilfred Owen Dulce et Decorum est
Module 5
The Age of Anxiety
The Age of Anxiety. A deep cultural crisis. Modernism. Modern poetry and Imagism
Ezra Pound In the Station of a Metro p.B20
Thomas Sterne Eliot
Sterility and alienation in modern society. Style: the mythical method and the objective correlative.
The Waste Land Extract from The Burial of the Dead ll. 1-7 ; 60/76
The modern novel.
Virginia Woolf
The modernist novelist, the literary critic, the feminist author. Mrs Dalloway: moments of being
from Mrs Dalloway “Clarissa Dalloway”
“Exactly the Same”
“Death in the Middle of Life”
Film The Hours (Daldry, 2002). Links with the novel Mrs Dalloway. How the three
stories are related. Each student developed a theme.
Programma che verrà svolto nei mesi di maggio e giugno. Ci si riserva di apportare modifiche che
verranno successivamente comunicate alla commissione.
James Joyce
Joyce’s Dublin. Style and technique. Dubliners: the use of epiphany, the theme of paralysis.
from Dubliners Eveline
“Gabriel’s Epyphany”
from Ulysses “The funeral” p.449
Module 7
Towards Contemporary Britain
Britain between the wars; World War II and after. Video: W. Churchill’s Speech: Blood, Tears, Toil..
George Orwell
The role of the artist, social themes. Animal Farm: a political fable. Nineteen Eighty-Four: dystopian
novels, themes
Video: Nineteen Eighty-Four plot - Sparknotes
from Animal Farm “Old Mayor’s Speech”
from Nineteen Eighty-Four “Big Brother is watching you” p. 534
Overview: The Present Age
The Cultural revolution; The Angry Young Men. The Thatcher years and beyond
---------------------

27
3.4 Filosofia Prof.ssa Giuseppa Chiaramonte
Profilo della classe La classe, è composta da 23 alunni/e che conosco fin dalla terza e dei quali, grazie alla
continuità nell’insegnamento della disciplina, ho potuto vedere il percorso di progressiva
maturazione. Il rapporto sodale con gli studenti ha reso possibile il dialogo costruttivo e il confronto
sereno.
Nel corso del triennio gli studenti hanno rafforzato la propria motivazione allo studio,
manifestando una buona disponibilità all’ascolto, non sempre accompagnata da attiva partecipazione.
Il loro atteggiamento solo apparentemente passivo, non ha però tradito l'interesse per la disciplina.
Il ritmo di apprendimento della classe è stato buono: curiosi e interessati durante la
presentazione dei temi e dei problemi, gli alunni hanno, però, di rado integrato tale disponibilità
all’ascolto con l’approfondimento personale.
Con interventi mirati ho cercato di rafforzare le tecniche di studio degli alunni più in difficoltà e
di recuperarne le carenze, nel tentativo di far conseguire a tutti un più adeguato livello di preparazione.
Dal punto di vista della condotta, il comportamento degli alunni è stato corretto per la qualità
delle relazioni interpersonali, ma non sempre per quel che riguarda il rispetto delle regole e le
consegne. Alcuni studenti hanno accumulato assenze, messo in atto strategie per evitare o
procrastinare le interrogazioni.
Raggiungimento degli obiettivi Gli studenti, nel complesso, hanno mostrato di aver acquisito un corretto metodo di studio, di
aver rafforzato le capacità argomentative e l’attitudine al pensiero astratto.
Un piccolo gruppo di alunni ha acquisito buone capacità di riflessione e argomentazione,
nonché ottime competenze anche a livello lessicale. La maggior parte, invece, ha progressivamente
maturato sufficienti o discrete capacità cognitive, conseguendo risultati complessivamente positivi
rispetto alle attese e alle potenzialità individuali. Gli alunni che hanno incontrato iniziali difficoltà,
hanno in parte recuperato le carenze nella preparazione, raggiungendo un risultato sufficiente sul
piano espositivo, ma non del tutto a livello logico-argomentativo. La costanza nell’applicazione ha
riguardato la maggioranza degli alunni, mentre un gruppo di studenti ha fatto più fatica a mantenere
un impegno efficace.
Metodologie didattiche
Lezione frontale
Lezione interattiva
Discussione guidata in classe
Letture critiche relative ai contenuti e agli strumenti interpretativi
Scrittura di brevi testi con tema mirato (domande, riflessioni critiche, analisi di testi, fonti
ecc..)
Facendo riferimento alle finalità generali stabilite dal Collegio dei Docenti, dall’Area Disciplinare e
dal Consiglio di Classe, e in continuità con quanto già operato negli anni precedenti, ho assegnato
all’insegnamento della Filosofia le seguenti finalità specifiche:
educare a
pensare in modo autonomo, argomentando le proprie posizioni
discutere in maniera ordinata, competente, rispettosa degli altrui punti di vista
tenere un atteggiamento problematico, aperto e critico di fronte ad una realtà complessa, in
rapido cambiamento, dagli aspetti talvolta contraddittori
riflettere sul senso e sulle possibili alternative che si presentano rispetto a un problema dato
acquisire un lessico appropriato ed un uso consapevole del linguaggioPer una corretta praticabilità

28
della didattica della filosofia è stato sfoltito il numero degli autori da studiare, privilegiando il
miglioramento delle tecniche espositive e argomentative.
Per sviluppare l’attitudine alla problematizzazione degli argomenti, all’interno del pensiero degli
autori selezionati, sono stati individuati problemi e temi calibrati sulle reali capacità, motivazioni e
interessi della classe.
Lo sviluppo dell’insegnamento/apprendimento ha seguito prevalentemente una strategia di tipo
sequenziale, ma alcuni momenti della lezione sono stati dedicati alla ricostruzione di nuclei tematici
trasversali agli autori.
Materiali didattici e spazi utilizzati
Il testo in adozione
Gli appunti delle lezioni tenute dall’insegnante
Video documenti
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Interrogazione orale
Questionari scritti non strutturati
Compiti scritti di simulazione terza prova esame di Stato
Per saggiare le capacità sintetiche e la costanza e la regolarità nello studio sono state utilizzate come
prove la partecipazione alla discussione organizzata e gli interventi personali dal posto.
Nel valutare il processo formativo degli alunni ho distinto momenti di misurazione, (consistenti
nell’attribuire punteggi predefiniti a determinate prestazioni e prove) da momenti di valutazione e
apprezzamento di singole prove e prestazioni in ordine a criteri più complessivi volti a riconoscere
l’evoluzione nell’apprendimento e la maturazione dell’alunno.
Contenuti
UNITA’ DIDATTICA 1: Georg Wilhelm Friederich Hegel
Gli scritti teologici giovanili
Il confronto tra religione greca, e cristianesimo
La religione ebraica e lo spirito di scissione
L’esaltazione del mondo cristiano germanico
Il periodo di Jena
Differenze tra il sistema filosofico di Fichte e quello di Schelling
Il rapporto tra lo scetticismo e la filosofia
Fede e Sapere e la critica al romanticismo filosofico
Il diritto naturale e la critica alla morale kantiana
Sulla costituzione della Germania e la lode al realismo politico di Machiavelli
La fenomenologia dello Spirito
La prefazione: critica all’idealismo di Schelling; le distanze dalla ragione illuministica; la
concezione dialettica della conoscenza; ossatura logico-razionale del reale; visione storicistica e
dialettica della conoscenza
Le 6 tappe della fenomenologia
Alcune figure della fenomenologia: certezza sensibile; percezione; intelletto; signoria e servitù;
stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice; l’Illuminismo e il Terrore
Le opere di sistema e i due approcci espositivi: la logica e la filosofia del Reale
Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio
Cenni alla filosofia della Natura
La filosofia dello Spirito

29
Lo Spirito Oggettivo: Diritto; Moralità; Eticità (filosofia della Storia)
Lo Spirito Assoluto: Arte; Religione; Filosofia
Il sapere assoluto
UNITA’ DIDATTICA 2: L’eredità hegeliana La Destra e la Sinistra hegeliana
Ludwig Andreas Feuerbach La critica al sistema hegeliano
La filosofia come antropologia
L’alienazione religiosa e il suo superamento
UNITA’ DIDATTICA 3: Karl Marx Il giovane Marx tra impegno politico e giornalismo
Il rapporto Hegel Marx, tra rottura e continuità
Gli Annali Franco-tedeschi e la critica alla liberal democrazia e allo Stato moderno
Il distacco da Feuerbach e l’interpretazione della religione in chiave sociale
I Manoscritti economico filosofici: la critica all’economia borghese e il tema dell’alienazione
L’ideologia tedesca e la struttura economica della storia
Il Manifesto e l’interpretazione della storia come conflitto originario
La funzione storica della borghesia
Il carattere anarchico del modo di produzione capitalista
L’economia pianificata
L’idea di rivoluzione e la dittatura del proletariato
Il Capitale: la teoria del plusvalore e del pluslavoro; la caduta tendenziale del saggio del profitto
L’internazionale e l’analisi del fallimento della Comune di Parigi
La Critica al Programma di Gotha e la polemica all’interno dell’SPD tedesco
UNITA’ DIDATTICA 4: Il Positivismo Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo
Positivismo e illuminismo
Positivismo e romanticismo
Auguste Comte Il metodo di tutte le scienze e la legge dei tre stadi
La sociologia come “fisica sociale”
La filosofia della storia e la sociocrazia
Cenni all’utilitarismo inglese
J. Stuart Mill
La teoria epistemologica
Il programma utilitarista
La filosofia politica e il modello liberal democratico
Charles Darwin e l’evoluzione per selezione naturale
Herbert Spencer e il darwinismo sociale
UNITA’ DIDATTICA 5: L’opposizione alla filosofia come sistema e il recupero dell’esistenza
Arthur Schopenhauer La critica alla filosofia hegeliana
Sulla quadruplice radice del principio di ragion sufficiente: legame e distanza dalla filosofia kantiana
L’influenza della cultura orientale: i Veda, le Upanisad e la tradizione buddista
La struttura del mondo come volontà e rappresentazione
La sezione metafisica: la Wille zum Leben e la rappresentazione

30
La sezione soteriologica: arte e ascesi
La Sehnsucht cosmica e la menzogna dell’ottimismo
Amore genio freddo della specie
Pessimismo sociale e la concezione della storia
Friedrich Wilhelm Nietzsche La formazione di Nietzsche: Burckardt e Wagner
La nascita della tragedia: spirito dionisiaco e apollineo
La filosofia nell’età tragica dei greci: il razionalismo come decadenza
La seconda inattuale e la critica allo storicismo
Su verità e menzogna in senso extramorale: la demolizione dell’idea filosofica di verità
La polemica antiwagneriana e la critica alla filosofia di Schopenhauer
La scuola del sospetto e lo smascheramento della morale della metafisica; la morte di Dio
Così parlò Zarathustra: l’Übermensch e la dimensione tragica della vita
L’emancipazione dalla morale e la Wille zur Macht
L’eterno ritorno dell’eguale e il rifiuto della concezione lineare del tempo
Nichilismo e superamento del nichilismo
Soren Aabye Kierkegaard La critica all’idealismo: irriducibilità del singolo e asistematicità della filosofia
La riflessione esistenziale: esistenza umana come possibilità e la minaccia del nulla; l’angoscia come
puro sentimento della possibilità
Il tema della scelta: vita estetica e vita etica
La vita religiosa e l’accettazione dell’assurdità dell’esistenza: disperazione e fede
UNITA’ DIDATTICA 6: La rivoluzione psicanalitica
Sigmund Freud La psicoanalisi come luogo dell’interpretazione dell’umano
Gli Studi sull’isteria: il trauma infantile e il metodo catartico
Il determinismo psichico: sogni, atti mancati, sintomi nevrotici
Il sogno e la censura onirica
La vita psichica guidata dalla libido: le fasi della sessualità
La terapia psicanalitica e la fondazione della società di psicanalisi
La topologia psichica: Es, Io, Superio
Gli studi sulle nevrosi di guerra: Eros e Tanathos
Processo di civiltà e repressione
Alfred Adler e Carl Gustav Jung e il rifiuto del pansessualismo Adler: la volontà di potenza e il complesso di inferiorità; le costellazioni familiari
Jung: psiche e inconscio collettivo; archetipi e simboli della libido
UNITA’ DIDATTICA 7: Max Weber
Weber e il dibattito sulle scienze storiche
Cenni a Wilhelm Dilthey e alla critica alla ragione storica
Cenni a Windelband e Rickert e alla versione non ontologica dello storicismo
L’avalutatività delle scienze sociali
Il metodo delle scienze storiche e l’uso dei modelli
Gli effetti della diffusione del protestantesimo sulla vita economica in Europa (Capitalismo
ed etica protestante)
Gli studi di sociologia: partiti; istituzioni politiche
Prognosi sullo sviluppo dell’Occidente: razionalità degli scopi e processo di disincantamento

31
UNITA’ DIDATTICA 8: La Scuola di Francoforte
Caratteri generali della Scuola e il progetto di una teoria critica della società
La produzione sociologica: gli studi sull’autorità della famiglia e sulla personalità autoritaria
La dialettica dell’illuminismo: il concetto di illuminismo; lo smascheramento dei miti
dell’Occidente; il dominio della tecnica
UNITA’ DIDATTICA 9: L’esistenzialismo Atmosfera generale e tratti comuni di alcuni pensatori
Le cifre della trascendenza; il mistero dell’Essere e la sacralità dell’esistenza
Il primo Heidegger Heidegger “pensatore inattuale”: riproposizione del problema dell’Essere e rifiuto dell’Ontologia
tradizionale
Approccio fenomenologico-descrittivo: l’oggetto interno alla coscienza
Essere e tempo: dal progetto di una fenomenologia dell’Essere a quello di una fenomenologia del
Dasein
L’analitica dell’esistenza: essere-nel-mondo; essere-fra-gli-altri
Esistenza come possibilità-progetto e la “gettatezza” o progettualità storicamente qualificata;
l’“ermeneutica del precompresso”
Esistenza inautentica: curiosità; chiacchiera; abbandono e disagio
L’esistenza autentica: l’Essere-per-la-morte
Jean Paul Sartre La formazione fenomenologica
La filosofia come descrizione della condizione umana
Ingiustificabilità e gratuità dell’esistenza
La struttura dell’Essere e la nullificazione coscienziale del mondo
La fenomenologia dell’amore e delle sue delusioni: il rapporto conflittuale tra le coscienze
La critica della ragione dialettica*
I caratteri dell’umanismo esistenzialista*
Esistenza e libertà; scelta e responsabilità
Angoscia, abbandono, disperazione
Oggettività e intersoggettività: la morale esistenzialista*
Nota: i contenuti contrassegnati da asterisco verranno svolti solo se il tempo sarà sufficiente
Testo in adozione: Abbagnano, Fornero, La ricerca del pensiero, voll. 3A e 3B, Paravia.
Quesiti Simulazioni Terza prova
Tipologia B (dicembre 2016)
Individua un elemento di affinità tra romanticismo e positivismo
Esponi la critica di Marx ai “Giovani hegeliani”
-------------------

32
3.5 Storia - Educazione civica Prof.ssa Maria Rita Venneri
Profilo e Obiettivi della classe
Sul piano degli stili di apprendimento, dell'applicazione allo studio e dei risultati conseguiti è
emersa una configurazione della classe divisa sostanzialmente in tre fasce di livello: un gruppo che
ha dimostrato di riuscire a elaborare con una certa coerenza e correttezza argomentativa i contenuti
affrontati, studiando con apprezzabile continuità e raggiungendo una preparazione sostanzialmente
buona, sostenuta da un utilizzo corretto del lessico specifico; un secondo gruppo che non ha ancora
maturato una piena autonomia, sia come gestione dei tempi e sia come modalità di studio, con
inevitabili ripercussioni sulla preparazione che risente, talune volte, di una certa memorizzazione;
infine troviamo un terzo gruppo che ha messo in luce una certa fragilità a causa soprattutto di un
impegno alquanto discontinuo e non adeguato.
Metodologie didattiche/Materiali didattici/Tempi
Metodi
lezione frontale
· lezione dialogata
Materiali didattici
· manuale
· schede sintetiche
· letture critiche
Tempi
La vastità del programma, in confronto al tempo a disposizione (2 ore alla settimana), mi ha
imposto di scegliere una prospettiva con la quale procedere, selezionando i temi e i problemi più
rilevanti in un'ottica che ha privilegiato la Storia d’Italia nel contesto europeo – mondiale.
Tipologia delle prove di verifica/Criteri di valutazione/Recupero
Prove
Per la verifica in itinere sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
· interrogazioni
· questionari
· una Simulazioni di Terza prova
Criteri di valutazione
La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione dei concetti fondamentali degli argomenti
affrontati, delle competenze raggiunte, nonché dei progressi compiuti.
Per il sistema valutativo mi sono avvalsa delle griglie elaborate collegialmente per il colloquio e di
quelle per la terza prova per gli scritti.
Interventi di recupero
Sono stati attivati gli interventi di recupero (con le successive prove) con le modalità stabilite dal
Collegio Docenti e dal Dipartimento.
Contenuti Manuale adottato: Giardina – Sabbatucci – Vidotto: I mondi della Storia (volume 2) - Laterza
scolastica
Europa alla vigilia della Prima guerra mondiale
a)Seconda Rivoluzione industriale
Capitolo 16 = 2
b)Società di massa
Capitolo 16 = 3-5-6
c)Partiti e Movimenti di massa

33
Capitolo 16 = 7-8-9-10-11
d)Quadro storico((Francia/Gran Bretagna/Germania/Austria/Russia)
Capitolo 20 = 1-2-3-4-5-6
Italia alla vigilia della Prima guerra mondiale
a)Età giolittiana
Capitolo 21 = 7-8-9-10
Manuale adottato: Giardina – Sabbatucci – Vidotto: I mondi della Storia (volume 3) - Laterza
scolastica
Prima guerra mondiale
a)Prima guerra mondiale
Capitolo 1 = 2-3-4-5--8-11-12
b)Rivoluzione russa
Capitolo 1 = 9-10
Europa post bellica
a)Conseguenze
Capitolo 2 = 1-2-4
b)Paesi sconfitti: Austria/Ungheria
Capitolo 2 = 4
c)Paesi vincitori: Francia/Gran Bretagna
Capitolo 2 = 6
Russia: Russia comunista/Stalinismo
a)Terza Internazionale
Capitolo2 = 4
b)Russia comunista: Lenin/Stalin
Capitolo 2 = 7-8
c)Stalinismo
Capitolo 5 = 6-7
Italia: Dopoguerra/Fascismo
a)Dopoguerra: Marcia su Roma
Capitolo 3 = 1-2-3-4
b)Dittatura fascista
Capitolo 3 = 5-6
c)Regime fascista
Capitolo 6 = 1-2-3-4-5-6-7
Germania: Nazismo a)Dopoguerra: Repubblica di Weimar
Capitolo 2 = 4-5
b)Ascesa del nazismo
Capitolo 5 = 3-4
c)Terzo Reich
Capitolo 5 = 5
America: New Deal
a)America ‘29
Capitolo 4 = 2-3-4

34
b)Roosevelt: New Deal
Capitolo 4 = 5-6
Europa: vigilia della Seconda Guerra mondiale
a)Fronti popolari
Capitolo 5 = 8
b)Guerra civile spagnola
Capitolo 5 = 9
Seconda guerra mondiale
a)Vigilia:
Capitolo 5:10
b)Seconda guerra mondiale
Capitolo 8 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
Il Mondo diviso
a)Guerra fredda
Capitolo 9 = 1-2-3-4
b)Distensione
Capitolo 8 = 7-8
Repubblica italiana
a)Repubblica/Costituzione
Capitolo 13 = 1-2-3-4
-----------------

35
3.6 Matematica Prof.ssa Elena Gargini
Profilo della classe
Ho insegnato nella classe matematica negli ultimi due anni. La continuità didattica ha
senz’altro favorito la socializzazione e una buona risposta al dialogo educativo, che è stata positiva
per la maggior parte dei componenti del gruppo. Tutta la classe, anche se con diverse modalità, si è
mostrata collaborativa, interessata e si è impegnata a mettere a frutto, con un lavoro nel complesso
serio e metodico, i concetti appresi durante le lezioni a scuola. Nei soggetti più fragili, più che un
disinteresse durante le ore di lezione in classe, è emersa una certa difficoltà nell’organizzazione del
lavoro domestico, che è risultato talvolta sporadico, superficiale e frammentario. Solo un piccolo
gruppo manifesta ancora carenze, in certi casi gravi, e non solo nella fase di elaborazione dei concetti,
ma anche nella semplice riproduzione di conoscenze di base, oltre a lacune che in quest’ultimo anno
si sono fatte più evidenti. Le difficoltà maggiori si riscontrano ovviamente negli scritti, leggermente
migliori sono invece le prestazioni nelle verifiche orali.
Il clima che si è instaurato è stato comunque sempre sereno, anche se, soprattutto nei primi
mesi, è stato difficile renderlo dialettico, essendo spesso caratterizzato da una partecipazione passiva
alla lezione, all’interno però di un quadro sempre assolutamente collaborativo.
Nel complesso si delinea pertanto una classe costituita da un ristretto gruppo di studenti
che ha conseguito risultati complessivamente buoni, escludendo i pochi alunni che ancora non
sono riusciti a colmare le lacune di base, la maggior parte dei ragazzi è dotato di capacità logiche
e di ragionamento pienamente sufficienti e ha anche una sufficiente conoscenza del programma
svolto.
Raggiungimento degli obbiettivi
Conoscenze
Limiti e continuità.
Successioni e principio di induzione.
Derivate
Integrali
Equazioni differenziali
Rette e piani nello spazio, condizione di parallelismo e perpendicolarità, Il sistema di
riferimento cartesiano nello spazio, equazione di rette, piani e superfici sferiche
Distribuzioni di probabilità discrete. Distribuzione binomiale e distribuzione di Poisson.
Distribuzioni di probabilità continue. Distribuzione uniforme, esponenziale e normale
Competenze
Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.
Individuare strategie appropriate per risolvere problemi.
Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone invarianti e relazioni
Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli
Abilità
Calcolare limiti di funzioni.
Studiare la continuità di una funzione in un punto.
Calcolare la derivata di una funzione.
Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di de l’Hopital.
Eseguire lo studio di una funzione e tracciarne il grafico.
Calcolare gli integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni.
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi e a problemi tratti da altre

36
discipline.
Risolvere semplici equazioni differenziali.
Scrivere l’equazione di una retta o di un piano nello spazio, soddisfacente condizioni date
(in particolare parallelismo e perpendicolarità)
Determinare la distanza di un punto da un piano o una retta nello spazio riferito a un sistema
di riferimento cartesiano.
Scrivere l’equazione di una superficie sferica
Calcolare probabilità di eventi espressi tramite variabili aleatorie di tipo binomiale e di
Poisson,
Metodologie didattiche
Il processo di insegnamento si è basato su:
lezione interattiva, lezione frontale, esercitazioni alla lavagna;
svolgimento in classe di numerosi esercizi a completamento ed ampliamento della parte teorica,
la maggior parte dei quali svolti dagli alunni stessi;
richiesta allo studente dell’analisi del testo, della giustificazione dei vari passaggi del
procedimento di risoluzione utilizzato;
impostazione delle lezioni per obiettivi o per unità didattiche;
individuazione di un collegamento fra argomenti noti per dare continuità all’apprendimento;
individuazione di prove esperte per l’esercizio di competenze della disciplina, conformemente
alle indicazioni del nuovo Esame di Stato;
individuazione di eventuali difficoltà incontrate dalla classe e di opportune strategie per superarle.
Materiali didattici e spazi utilizzati
Per la didattica , oltre al manuale, si è cercato di integrare le lezioni con dispense riguardanti
la nuova tipologia di Esame di Stato utilizzando il più possibile materiale che introducesse l’uso di
prove esperte. Durante le prime settimane del pentamestre, a gennaio, anche questa classe come la
maggior parte delle quinte dell’istituto, ha seguito per quattro ore lezioni sugli integrali proposte da
una studentessa proveniente dal MIT di Boston, ovviamente in inglese, come proposta per attività di
Clil.
Relativamente agli spazi utilizzati le lezioni si sono svolte sempre in classe e sono state,
quanto più possibile, di tipo dialettico. Si è cercato per lo più di creare un collegamento fra argomenti
noti al fine di dare continuità all’apprendimento. Per quanto riguarda la scansione temporale del
programma, gli argomenti curricolari sono stati suddivisi in unità didattiche che venivano proposte
per una durata di circa quattro settimane, al termine delle quali veniva somministrata una prova di
verifica formativa seguita da un compito scritto di verifica sommativa.
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Le prove di verifica sommativa sono state una orale e tre scritte nel primo trimestre, due orali
e tre scritte nel secondo pentamenstre. La classe parteciperà alle simulazioni di seconda prova di
Esame di Stato del 25 maggio organizzata dall’Istituto. Per la correzione delle simulazione si terrà
conto della griglia valutativa fornita dal Miur.
Per la valutazione globale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi in termini di
conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione, acquisizione di un linguaggio rigoroso e
corretto, capacità di individuare corrette strategie di risoluzione. Alla valutazione finale concorrono
anche i progressi fatti rispetto ai livelli di partenza, l'impegno nello studio personale, la partecipazione
alle attività.

37
Criteri di valutazione delle prove scritte
Acquisizione dei contenuti oggetto del compito
Proprietà di linguaggio
Abilità operative
Abilità di calcolo
Capacità logico – deduttive
Criteri di valutazione delle prove orali
Pertinenza delle risposte
Acquisizione dei contenuti
Comprensione e uso della terminologia specifica
Rielaborazione delle conoscenze (capacità logico – deduttive)
Contenuti
Funzioni reali di una variabile reale:
concetto di funzione reale di variabile reale e rappresentazione analitica;
funzioni periodiche, pari, dispari, composte, monotone, invertibili;
ricerca del dominio di una funzione, intersezione con gli assi e positività.
Definizioni relative alla retta topologica:
intervallo aperto e chiuso. Intorno completo, sinistro e destro di un punto o di infinito;
punto d’accumulazione e punto isolato di un insieme,
massimo e minimo assoluto di un insieme;
estremo superiore ed estremo inferiore di un insieme;
estremi di una funzione, estremi relativi di una funzione.
Limiti delle funzioni di una variabile reale:
definizione di limite finito e di limite infinito per una funzione in un punto;
definizione di limite destro e sinistro di una funzione;
definizione di limite per una funzione all’infinito;
presentazione unitaria delle diverse definizioni di limite;
teoremi sui limiti: unicità, permanenza del segno e confronto (con dimostrazione);
algebra dei limiti;
forme di indeterminazione;
calcolo dei limiti;
limiti notevoli: con x misurato in radianti (con dimostrazione)
e
Funzioni continue
definizione di funzione continua;
continuità delle funzioni elementari;
teoremi relativi all’algebra delle funzioni continue;
punti di discontinuità, relativa classificazione e asintoti.
teorema dell’esistenza degli zeri;
teorema di Weierstrass;
teorema dei valori intermedi;

38
Derivate delle funzioni
di una variabile:
definizione di derivata di una funzione in un punto;
significato geometrico di derivata;
continuità e derivabilità;
punti di non derivabilità
derivate delle funzioni elementari (con dimostrazione in particolare: y=k, y=x, y=x2, y=x3,
y=senx, y=cosx, y=ex, y=lnx )
algebra delle derivate (con dimostrazione la derivata della somma e del prodotto di
funzioni);
derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse;
derivate di ordine superiore;
definizione di differenziale di una funzione e relativo significato geometrico;
teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle, di Lagrange e Cauchy
(tutti con dimostrazione);
legame tra il segno della derivata prima di una funzione e la sua monotonia;
corollari al teorema di Lagrange (con dimostrazione);
teorema di De L’Hopital (dimostrazione solo per la forma 0/0 per x che tende a quantità
finita)
criterio sufficiente per la derivabilità in un punto.
Studio del grafico di una funzione:
Definizioni di massimi e minimi assoluti e relativi;
Teorema di Fermat (con dimostrazione);
studio del massimo e del minimo delle funzioni a mezzo delle derivate successive;
problemi di massimo e minimo;
concavità, convessità, punti di flesso;
asintoti;
punti di una curva a tangente verticale;
studio di una funzione.
Integrali indefiniti:
definizione di primitiva di una funzione;
definizione di integrale indefinito;
integrali indefiniti immediati;
integrazione per scomposizione, sostituzione, per parti;
integrazione delle funzioni razionali fratte.
Integrali definiti:
definizione di integrale definito e relative proprietà;
primo teorema fondamentale del calcolo integrale (con dimostrazione);
funzioni integrabili e integrali impropri;
funzione integrale e secondo teorema fondamentale del calcolo integrale (con
dimostrazione);
teorema della media (con dimostrazione);
applicazioni degli integrali al calcolo di aree e volumi;
applicazioni del calcolo delle derivate e degli integrali alla fisica.
Equazioni differenziali:
equazioni lineari del primo e secondo ordine;

39
equazioni a variabili separabili.
Geometria analitica nello spazio:
equazione di un piano e di una retta;
mutue posizione tra rette e piani;
distanza tra punti, rette, piani;
la sfera.
Calcolo approssimato:
delle radici di un’equazione con il metodo di bisezione;
di un integrale con il metodo dei rettangoli.
Ancora da affrontare:
Variabili aleatorie:
Variabili aleatorie binomiali e di Poisson
TESTO IN ADOZIONE: “LA MATEMATICA A COLORI ” di Leonardo Sasso, Petrini editore.
----------------

40
3.7 Fisica Prof.ssa Elena Gargini
Profilo della classe
Purtroppo questa è stata l’unica materia per la quale gli studenti non hanno potuto beneficiare
di una continuità didattica, avendo avuto nel triennio insegnanti sempre diversi. Ciò ha comportato
in quinta una certa difficoltà nel richiamare i concetti e soprattutto per l’elettromagnetismo è stato
necessario, nei primi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, un consistente lavoro di
consolidamento dei fondamentali. Ciò è andato a discapito dell’aspetto più prettamente laboratoriale
della disciplina, avendo dovuto dare la preminenza alla formalizzazione del problema fisico e alla
risoluzione degli esercizi di applicazione dei concetti, aspetto su cui gli studenti manifestavano con
evidenza disagio e difficoltà.
Dal punto di vista della disponibilità al dialogo educativo tuttavia, le caratteristiche
precedentemente rilevate in matematica si sono riproposte anche per fisica.
Per quanto concerne il profitto emerge che circa un terzo degli studenti hanno conseguito
risultati buoni e stanno raccogliendo i frutti di un lavoro serio e continuo; la rimanente parte della
classe, se si eccettuano un paio di casi, è costituita da studenti che hanno conseguito una preparazione
complessivamente più che sufficiente in alcuni casi discreta, raggiungendo in generale gli standard
minimi della disciplina.
Le lezioni sono state, quanto più possibile, di tipo dialettico. Si è cercato di creare, dove
possibile, il collegamento ad argomenti noti per dare continuità all’apprendimento, utilizzando i
concetti dell’analisi introdotti nel corso dell’anno a matematica, per fornire un quadro quanto più
organico e unitario delle due discipline.
Raggiungimento degli obbiettivi
Conoscenze
Definizione operativa di campo magnetico.
Proprietà del campo magnetico terrestre.
Campo magnetico generato da correnti elettriche, esperienza di Örsted, linee di campo
magnetico e analogie con calamite.
Interazione fra corrente e campo magnetico, seconda legge di Laplace.
Interazione magnetica fra correnti elettriche ed esperienza di Ampère.
Legge di Biot-Savart.
Teorema della circuitazione di Ampère.
Campo magnetico generato da filo rettilineo, spira e solenoide percorsi da corrente.
Prima legge di Laplace.
Principio di funzionamento di un amperometro analogico con la forza di Laplace.
Flusso del campo magnetico attraverso una superficie chiusa e assenza di monopoli
magnetici.
Principio di funzionamento di un motore elettrico in continua.
Campo magnetico nella materia, materiali diamagnetici, paramagnetici e ferromagnetici,
polarizzazione per orientamento e per deformazione, ferromagnetismo e ciclo di isteresi.
Forza di Lorentz, moto di una particella carica in un campo magnetico
Forza elettromotrice indotta e legge di Faraday-Neumann-Lenz
Autoinduzione e induttanza
Energia associata ad un campo magnetico
Corrente alternata, alternatore e trasformatore
Campo magnetico variabile come sorgente di campo elettrico e campo elettrico variabile
come sorgente di campo magnetico.
Corrente di spostamento.

41
Le equazioni di Maxwell.
Produzione, ricezione e propagazione di onde elettromagnetiche.
La polarizzazione delle onde elettromagnetiche
Definizione di densità di energia ed energia e impulso trasportato da un’onda
elettromagnetica.
Relazione fra campo magnetico e campo elettrico di un’onda elettromagnetica.
Classificazione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche in funzione della loro
lunghezza d’onda.
Esperimento di Michelson e Morley, risultati e soluzioni proposte, etere.
Relatività di Einstein: postulati della relatività ristretta, trasformazioni di Lorentz.
Implicazioni dei postulati relativistici nei concetti di simultaneità, intervallo di tempo e di
lunghezza.
Legge di addizione relativistica delle velocità.
Masse ed energia nella relatività.
Conservazione della quantità di moto relativistica.
Carenze concettuali della fisica classica nella descrizione dello spettro del corpo nero,
dell’effetto fotoelettrico, effetto Compton.
Formule empiriche di Planck, Wien e Stefan-Boltzman.
Complementarità fra onde e particelle, lunghezza d'onda di De Broglie.
Enunciato e implicazioni del principio di indeterminazione di Heisenberg.
Competenze
Osservare e identificare i fenomeni.
Formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari
rilevanti per la sua risoluzione.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui
si vive.
Abilità
Applicare la legge che descrive l’interazione fra fili rettilinei percorsi da corrente.
Determinare il campo magnetico prodotto in un punto dalla corrente che scorre in un filo
rettilineo o in un solenoide.
Sfruttare il teorema di Ampere per determinare i campi magnetici generati da particolari
distribuzioni di corrente.
Determinare la forza su un filo percorso da corrente o su una carica elettrica in moto in un
campo magnetico uniforme.
Determinare le variabili del moto circolare uniforme di una carica elettrica in un campo
magnetico
Discutere il significato fisico degli aspetti formali della legge di Faraday-Neumann-Lenz
Calcolare le variazioni di flusso di campo magnetico
Calcolare correnti e forze elettromotrici indotte
Determinare l’induttanza di un solenoide, note le sue caratteristiche geometriche e
costruttive.
Calcolare l’energia immagazzinata i un solenoide percorso da una corrente.
Determinare la potenza media erogata da un generatore a corrente alternata e la potenza
media assorbita da un carico.
Calcolare la forza fra le armature di un condensatore e la forza fra due spire.
Comprendere il vantaggio della corrente alternata per trasportare potenza su lunghe distanze.
Risolvere problemi vari comprendenti meccanica ed induzione elettromagnetica con
equazioni differenziali.
Comprendere la necessità della corrente di spostamento in dinamica.

42
Saper discutere il significato delle equazioni di Maxwell.
Calcolare le grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane
Determinare la quantità di energia trasportata da un’onda elettromagnetica
Saper descrivere lo spettro elettromagnetico
Applicare la legge di composizione relativistica delle velocità e le trasformazioni di Lorentz
Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni concrete
Illustrare come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia ed
energia
Saper applicare le leggi fenomenologiche di Stefan-Boltzmann e di Wien, saper illustrare
l’emissione del corpo nero secondo il modello di Planck
Applicare a casi particolari l’equazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico e la legge che
esprime l’effetto Compton.
Discutere il dualismo onda-corpuscolo
Calcolare la lunghezza d’onda di De Broglie di una particella e analizzare fenomeni di
interferenza e diffrazione che coinvolgano elettroni o altre particelle.
Calcolare l’indeterminazione quantistica sulla posizione/quantità di moto di una particella
Metodologie didattiche
Il processo di insegnamento si è basato su:
lezione interattiva, lezione frontale, esercitazioni alla lavagna.
svolgimento in classe di problemi a completamento ed ampliamento della parte teorica, la
maggior parte dei quali svolti dagli alunni stessi;
introduzione degli argomenti, ove possibile, a partire da situazioni problematiche reali;
richiesta allo studente dell’analisi del testo, della giustificazione dei vari passaggi del
procedimento di risoluzione utilizzato;
approfondimento di alcuni argomenti mediante la collocazione degli stessi nel loro contesto
storico attraverso letture;
impostazione delle lezioni per obiettivi o per unità didattiche;
creazione, ove possibile, di un collegamento fra argomenti noti per dare continuità
all’apprendimento;
individuazione di eventuali difficoltà incontrate dalla classe e studio di opportune strategie
per superarle.
Materiali didattici e spazi utilizzati
Per la didattica , oltre al manuale, si è cercato di integrare le lezioni con dispense riguardanti la nuova
tipologia di Esame di Stato utilizzando il più possibile materiale che introducesse l’uso di prove
esperte. In particolare nella prima parte dell’anno si è fatto uso delle simulazioni ministeriali ad
integrazione dell’eserciziario del manuale.
La classe ha assistito alla conferenza del prof.Stanga Ruggero dell’Università degli Studi di Firenze
sul tema “Cento anni dopo: Black Hols, onde gravitazionali” in aula Magna.
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
Le prove di verifica sommativa sono state almeno due scritte e una orale durante il trimestre,
due orali e tre scritte per il pentamestre; sono state utilizzate prove scritte di verifica (di tipologia
mista: prove strutturate o semi strutturate) anche al di fuori delle simulazioni della terza prova; nelle
simulazioni questa disciplina è comparsa due volte sempre in tipologia A ed è stata valutata
conformemente alla griglia in uso all’interno dell’istituto.

43
Questi i comandi delle due prove:
27/2/’17
Dalle equazioni di Maxwell alle onde elettromagnetiche: lo studente, dopo aver illustrato le quattro
equazioni, spieghi come queste prevedano l’esistenza delle onde elettromagnetiche.
26/4/’17
Dopo aver spiegato perché la scoperta che la luce si propaga a velocità costante, mini le fondamenta
della fisica classica, il candidato spieghi come l'impostazione eisteniana dei principi relativistici
costituisca un modello predittivo coerente, in grado di racchiudere al suo interno anche il modello
teorico della fisica classica.
Per la valutazione globale si terrà conto del raggiungimento degli obiettivi in termini di
conoscenza dei contenuti, capacità di rielaborazione, acquisizione di un linguaggio rigoroso e
corretto, capacità, di individuare corrette strategie di risoluzione. Alla valutazione finale concorrono
anche i progressi fatti rispetto ai livelli di partenza, l'impegno nello studio personale, la partecipazione
alle attività.
Contenuti
ELETTROSTATICA
Ripasso: forze elettriche e campi elettrici - Energia potenziale elettrica e potenziale elettrico.
IL MAGNETISMO
Magneti naturali ed artificiali- Le linee del campo magnetico- Interazioni magnete – corrente e
corrente- corrente- La definizione di Ampere- Definizione di campo di induzione magnetica-
Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente- Il flusso e la circuitazione del campo
d’induzione magnetica- Momento torcente di un campo su una spira percorsa da corrente e relative
applicazioni- Magnetismo della materia diamagnetismo, paramagnetismo, ferromagnetismo.
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Le correnti indotte- Il ruolo del flusso del campo magnetico- La legge di Faraday- Neumann- La legge
di Lenz- Induttanza, autoinduzione - Energia e densità di energia del campo magnetico- L’alternatore
e la dinamo- Circuiti in alternata RCL- La risonanza nei circuiti elettrici.- La trasformazione della
corrente alternata e il trasporto dell’energia elettrica- Circuiti elettrici domestici.
LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Il campo elettrico indotto- La corrente di spostamento e il campo magnetico- Le equazioni di Maxwell
-Le onde elettromagnetiche- La velocità delle onde elettromagnetiche. -Produzione, ricezione e
propagazione di onde elettromagnetiche. -Definizione di densità di energia e intensità di un’onda
elettromagnetica. -Relazione fra campo magnetico e campo elettrico di un’onda elettromagnetica. -
Classificazione e caratteristiche delle onde elettromagnetiche in funzione della loro lunghezza
d’onda.- La polarizzazione delle onde elettromagnetiche.
LA RELATIVITA’ RISTRETTA
Significato dell’esperimento di Michelson e Morley. -Enunciati dei due postulati della relatività
ristretta.- Concezione relativistica dello spazio-tempo. -Implicazioni dei postulati relativistici nei
concetti di simultaneità, intervallo di tempo e distanza. -La massa e la quantità di moto relativistica-
Energia cinetica relativistica.- Energia a riposo ed energia totale.
PARTICELLE E ONDE
Il dualismo onda corpuscolo.- La radiazione del corpo nero e l’ipotesi di Planck.- I fotoni e l’effetto
fotoelettrico.- La quantità di moto di un fotone e l’effetto Compton. - La lunghezza d’onda di de

44
Broglie e la natura ondulatoria dei corpi materiali. -Il principio di indeterminazione di Heisemberg.
TESTO IN ADOZIONE:
“I PROBLEMI DELLA FISICA” di John D. Cutnell, Kenneth W. Johnson, David Young, Shane
Stadler. Edizione Zanichelli.
---------------------

45
3.8 Scienze Naturali Prof.ssa Anna Pecchioli
PROFILO DELLA CLASSE
Ho conosciuto la classe fin dal primo anno di liceo e nel corso di questi cinque anni la fisionomia
della classe ha mantenuto in linea di massima le stesse caratteristiche. Fin dall’inizio gli alunni hanno
dimostrato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e hanno manifestato interesse per
gli argomenti trattati anche se non sempre hanno partecipato in modo attivo alle lezioni. Questa loro
disponibilità è perdurata nel tempo e anche durante questo anno scolastico hanno affrontato le
problematiche proposte lavorando e applicandosi con una certa costanza.
Durante questi anni alcuni di loro hanno partecipato con esperienze di laboratorio alle Giornate della
Scienza e partecipato alle selezioni interne delle Olimpiadi della Chimica.
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
La preparazione conseguita, eccetto pochi casi che hanno manifestato situazioni di fragilità a livello
di comprensione e di rielaborazione delle tematiche più complesse, risulta adeguata agli obiettivi
specifici preposti
Competenze e abilità
descrivere le caratteristiche dei principali composti organici e le loro relazioni col mondo dei
viventi;
distinguere i principali processi metabolici aerobici ed anaerobici ed interpretare i processi di
respirazione e fotosintesi in termini energetici;
riconoscere le caratteristiche delle principali rocce trattate nel corso dell’anno;
esporre la teoria della tettonica delle placche nonché l’evoluzione storica della stessa, dimostrando
la correlazione del modello ai fenomeni endogeni ed esogeni del pianeta,
utilizzare correttamente il linguaggio specifico;
ricondurre le conoscenze alle problematiche scientifiche;
saper effettuare confronti fra le varie teorie;
utilizzare l’apporto di discipline diverse nella discussione di temi complessi;
consolidare la capacità di misurare, classificare, tabulare, leggere e interpretare grafici.
Per quanto riguarda l’impegno, le capacità e il profitto la classe si distribuisce secondo uno schema
consueto di fasce di livello: un primo gruppo è costituito da alunni che si sono dimostrati
sostanzialmente responsabili e autonomi nella gestione dello studio ed hanno mostrato interesse e
motivazione nei confronti della disciplina riuscendo ad ottenere un livello di preparazione buono e
in alcuni casi anche ottimo; ; un secondo gruppo è costituito da alunni che hanno lavorato in
maniera più discontinua, presentando qualche difficoltà espressiva e minore autonomia critica, e
ottenendo pertanto un profitto da discreto a sufficiente; infine solo un esiguo numero di studenti,
ha dimostrato maggiori difficoltà sia per la mancata acquisizione di un corretto metodo di
rielaborazione personale ma soprattutto per un impegno discontinuo ed una applicazione saltuaria .
Il comportamento è stato corretto, la frequenza abbastanza regolare ed, eccetto alcuni casi, non
si sono mai sottratti alle verifiche finali.
METODOLOGIE DIDATTICHE
Per quanto riguarda la metodologia usata è risultata preponderante la lezione frontale data anche la
complessità di alcuni argomenti trattati. Ho cercato sempre comunque di stimolare l'interesse e la
partecipazione ponendo domande ed esigendo risposte sulla base delle loro conoscenze e delle loro
osservazioni. Sono stati utilizzati nella maggior parte dei casi i supporti multimediali presenti nella
scuola (computer e videoproiettore presente nella classe).
Il programma svolto ha riguardato le unità didattiche del piano di lavoro concordato all'inizio
dell'anno scolastico con la seguente scansione:
-primo quadrimestre: chimica organica e biochimica (metabolismo cellulare)

46
- secondo quadrimestre: scienze della Terra
MATERIALI DIDATTICI E SPAZI UTILIZZATI
I libri di testo utilizzati sono i seguenti:
1)per la parte di chimica organica e biochimica:
G. Valitutti, M. Falasca, A. Tifi, A. Gentile - Chimica: concetti e modelli- Chimica organica –
Zanichelli
La parte del metabolismo cellulare è stata trattata utilizzando appunti elaborati da:
G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D. M. Hillis, H. C. Heller, M. R.
Berenbaum - Dal carbonio agli OGM- Zanichelli
D. Sadava, H. C. Heller, G. H Orians, W. K Purves, D. M. Hillis - Biologia.blu – Zanichelli
2) per la parte di Scienze della Terra:
Bosellini - Le Scienze della Terra, vol B e D. Italo Bovolenta Editore.
Oltre alla lezione in classe, eseguita spesso utilizzando supporti multimediali quali ppt o video, sono
state effettuate anche alcune attività di laboratorio per quanto riguarda sia la parte di biochimica sia
la parte di scienze della Terra.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le verifiche sono state effettuate usando
- test scritti relativi a specifici argomenti trattati con domande prevalentemente aperte
nell’ottica della preparazione alla terza prova e test strutturati a crocette e domande aperte.
- interrogazioni individuali.
Nella valutazione ho tenuto conto della correttezza nell'esposizione dei contenuti, del rigore scientifico
della terminologia usata, della capacità di collegare tra di loro i vari argomenti trattati anche
avvalendosi di conoscenze relative ad altre discipline. Importante ai fini valutativi è risultato anche
l'atteggiamento complessivo dell'alunno nei confronti del processo educativo attuato; per tale motivo
l'impegno e la costanza dimostrata nel portare avanti il lavoro durante l'intero anno scolastico hanno
rappresentato un momento di valutazione fondamentale nella stesura del giudizio finale.
In due delle tre simulazioni di terza prova effettuate in questa classe sono stati posti quesiti di
scienze ( che risultano allegati al documento generale):
Simulazione del 9.12.2016 TIPOLOGIA B
1) Parla dei saponi descrivendone le caratteristiche chimiche, come si formano, la loro particolare
struttura e da che cosa deriva la loro azione detergente.
2) Definisci le principali differenze tra le molecole dei polisaccaridi glicogeno, amido e cellulosa.
Simulazione del 26.04.2017 TIPOLOGIA A
Parla delle principali differenze tra magma primario e magma secondario
CONTENUTI
1 Chimica del carbonio. Le caratteristiche principali del carbonio. Le ibridazioni sp, sp2 e sp3
Gli idrocarburi: alifatici ed aromatici (caratteristiche generali e loro nomenclatura)
Le principali isomerie: di posizione, geometrica, ottica.
I principali gruppi funzionali: alogenoderivati, alcoli, fenoli, eteri, acidi carbossilici,
esteri e saponi, ammine, ammidi, composti eterociclici (caratteristiche generali e loro
nomenclatura).
Cenni sui tipi di reazione: sostituzione, ossidazione
I polimeri
2 Chimica biologica. L'isomeria ottica e la sua importanza nel metabolismo di base.
I carboidrati, semplici e complessi

47
Le proteine, legame peptidico e strutture diverse
I lipidi, in particolare i trigliceridi e l'esterificazione
Gli acidi nucleici, diverse strutture e funzioni.
3 Il metabolismo cellulare
Le vie metaboliche
Gli enzimi
L’ATP
I coenzimi: NAD, FAD, NADP
4 Il metabolismo di base: respirazione cellulare e fermentazione Energia e metabolismo, considerazioni.
Le tappe della respirazione cellulare
La fermentazione
Visione di insieme del metabolismo della cellula
5 Il metabolismo di base: la fotosintesi Introduzione alla fotosintesi: pigmenti fotosintetici e fotosistemi
Le due fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin
Piante C3, C4, CAM
6 La terra solida
Cristalli, minerali e loro proprietà: i minerali - struttura cristallina dei minerali -
proprietà dei minerali
Sistematica dei minerali: la classificazione dei minerali - i silicati e la loro
classificazione Introduzione allo studio delle rocce: le rocce: definizione e
classificazione
Cenni sul processo sedimentario (fasi del processo sedimentario, tipi di rocce
sedimentarie)
Cenni sul processo metamorfico (tipi di metamorfismo)
7 Processo magmatico e rocce ignee Genesi ed evoluzione dei magmi
Classificazione delle rocce ignee
8 I vulcani Morfologia, attività e classificazione dei vulcani
I prodotti dell'attività vulcanica
9 I terremoti Genesi dei terremoti e propagazione delle onde sismiche
La forza dei terremoti
10 L'interno della Terra Costruzione di un modello dell'interno terrestre: studio delle onde sismiche e
superfici di discontinuità
Caratteristiche della crosta , del mantello e del nucleo.
Litologia dell'interno della Terra
Il magnetismo terrestre
ARGOMENTI DA SVOGERE DOPO IL 15.05.2017
11 La deriva dei continenti e i suoi precedenti storici Cenni sulle teorie fissiste.
La teoria della deriva dei continenti e prove a suo favore.
12 L'espansione del fondale oceanico

48
Morfologia e struttura del fondo oceanico
Modalità e prove della espansione oceanica
13 La Tettonica delle placche come teoria unificante La suddivisione della litosfera in placche
Terremoti, attività vulcanica e tettonica delle placche
14 Il movimento delle placche
Margini continentali: passivi, trasformi e attivi
Orogenesi
---------------------

49
3.9 Disegno e Storia dell’Arte Prof.ssa Chiara Pagani
Profilo della classe
La classe, con cui ho lavorato per la durata dell’intero quinquennio, è formata da studenti corretti e
disponibili con cui è stato possibile costruire un positivo rapporto di collaborazione. Quasi metà
degli alunni ha conseguito un buon livello di preparazione, un quarto della classe si è attestato su un
livello discreto e solo una piccola parte, ha faticato un po’ a raggiungere una preparazione decorosa.
Il limite della classe, in generale, è stata la difficoltà ad affrontare una didattica realmente
partecipativa, preferendo istintivamente, anche a causa di un’insicurezza emotiva condivisa da gran
parte degli studenti, la sicurezza fittizia di un approccio sostanzialmente passivo all’apprendimento
e di un eccessivo attaccamento al libro di testo. Tuttavia, seppur con qualche fatica, nel corso
dell’ultimo anno, a più riprese, molti studenti hanno dimostrato di poter raggiungere un’autonomia
critica e una capacità di rielaborazione più consapevole e, conseguentemente anche migliori
capacità espositive.
Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe
Gli obiettivi del corso sono stati quelli di rendere gli studenti capaci di:
saper esprimere le proprie conoscenze e competenze con un linguaggio chiaro e che faccia
adeguato uso della terminologia tecnico-artistica specifica della disciplina.
saper analizzare il linguaggio figurativo delle opere d’arte prese in esame e saperle collocare
correttamente nel proprio contesto artistico attraverso rapporti stilistico-comparativi.
saper inserire adeguatamente l’opera d’arte nel proprio contesto storico-culturale.
saper leggere e rappresentare lo spazio e gli oggetti attraverso il disegno tecnico.
Tutti gli studenti hanno dimostrato di possedere sia le conoscenze di base che il lessico specifico
richiesto, seppur con diversi livelli di sicurezza. Non tutta la classe, invece, è stata capace di
sviluppare un livello di competenze adeguatamente autonomo per articolare confronti e
approfondimenti sia a livello concettuale che espositivo.
Metodologie didattiche
Per favorire un apprendimento organico ed interdisciplinare, il programma si è adeguato, per quanto
possibile, a quello delle altre materie, così da dar modo agli studenti di comprendere come a
determinati momenti storici corrispondano particolari fenomeni artistici e come questi, a loro volta,
si leghino a correnti letterarie e di pensiero, evidenziando il significato dell’opera d’arte come
manifestazione, sia del genio e della creatività dell’artista che di un contesto storico - sociale
particolare.
L’insegnamento della Storia dell’Arte è stato, nel corso del 5° anno, fortemente prevalente rispetto
a quello di Disegno, al fine di permettere una più approfondita preparazione per gli studenti in vista
dell’Esame di Stato.
Per quanto riguarda il Disegno, il suo studio si è svolto nel primo quadrimestre ed è stato finalizzato
alla comprensione del disegno architettonico e alla capacità di utilizzarlo correttamente.
Materiali didattici e spazi utilizzati
I libri di testo in adozione sono Itinerario nell’arte, versione gialla di Cricco, Di Teodoro, vol. 4 e 5,
Edizioni Zanichelli, e Il Nuovo - le forme del disegno, vol. 1 e 2 di Rolando Secchi e Valerio Valeri,
edizioni La Nuova Italia. Questi testi sono stati integrati con allegati riguardanti argomenti non
presenti sul libro di testo.
Le lezioni si sono svolte anche con l’ausilio di proiezioni di immagini al fine di illustrare nel modo
più ampio possibile le caratteristiche di un artista o di una corrente pittorica.
La classe ha partecipato ad una visita guidata alla mostra Ai Wei WEi libero tenutasi a Firenze in
Palazzo Strozzi.

50
Nella programmazione sono stati inseriti 4 moduli CLIL – P. Picasso (3 ore), W. Gropius e il
Bauhaus (3 ore), l’Arte Degenarata (2 ore), Peggy Guggenheim, Art Addicted (2 ore) – oltre che
attraverso testi in lingua sugli argomenti scelti lo svolgimento delle lezioni si è svolto
prevalentemente attraverso la proiezione di documentari in inglese.
Tipologia delle verifiche e criteri di valutazione
Le verifiche di Storia dell’Arte sono state eseguite, sia attraverso prove scritte svolte in classe,
domande a risposta aperta (in accordo con le tipologie A e B previste per la terza prova dell’Esame
di Stato), che attraverso interventi orali, sollecitati dall’insegnante o spontanei, durante le lezioni.
Per quello che riguarda il Disegno, gli studenti sono stati chiamati a realizzare tavole grafiche, da
eseguire sia a casa che a scuola, riguardanti il rilievo architettonico, in scala 1:50, di una parte
dell’edificio scolastico.
I criteri di valutazione si sono basati sulla comprensione della domanda e sulla coerenza della risposta,
la conoscenza dell’argomento, la chiarezza espositiva e il possesso del linguaggio specifico, oltre alle
migliorate competenze rispetto al livello di partenza e alle capacità elaborative.
Le valutazioni, che hanno registrato i risultati raggiunti in base a conoscenze, competenze e capacità,
sono state espresse con votazione numerica da 0 a 10.
Simulazioni di terza prova dell’Esame di Stato:
27 febbraio 2017 - Tipologia A – 1 quesito
Prendendo spunto dall’osservazione delle opere proposte, esponi le tue considerazioni circa
l’evoluzione del linguaggio figurativo nel corso del XIX secolo, sia per quel che riguarda la
rappresentazione della figura femminile che in merito ai profondi cambiamenti subiti dal linguaggio
e della tecnica pittorica.
[Ingres, La bagnante di Valpinçon,1808; Degas, La tinozza, 1886; Kichner, Marcella e Franzi nello
studio 1908]
26 aprile 2017 - Tipologia A – 1 quesito
Inquadra dal punto di vista storico e artistico il Futurismo e definiscine le caratteristiche
distintive generali, completando le tue affermazioni con riferimenti più specifici ad autori ed
opere che appartengono al movimento.
Contenuti
DISEGNO
Elementi di disegno architettonico.
STORIA DELL’ARTE
ROMANTICISMO
J. Constable - La chiusa e il mulino di Flatford*, La cattedrale di Salisbury, La baia di Weymouth*.
W. Turner - Naufragio*, La valorosa Temeraire*, La nave negriera*, Pioggia, vapore, velocità*.
C. D. Friedrich - Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia, Il naufragio della
Speranza*.
J. A. Ingres - La bagnante di Valpinçon*, Grande odalisca, Monsieur Bertin.
T. Géricault - La zattera della Medusa, Alienati con monomanie*.
E. Delacroix - La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo.
F. Hayez - I profughi di Parga, Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni.
REALISMO
C. Corot - Studio per Il ponte di Augusto a Narni*, Il ponte di Augusto a Narni*, La cattedrale di
Chartres.
G. Courbet - Gli spaccapietre, Fanciulle in riva alla Senna.
H. Daumier - Il vagone di terza classe.
F. Millet - Le spigolatrici.

51
I Macchiaioli: caratteri generali
G. Fattori - Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta, La rotonda dei bagni Palmieri, In
vedetta.
ARCHITETTURA DELL’OTTOCENTO
L’Architettura dello Storicismo: dal Neoclassicismo all’Eclettismo
Le grandi ristrutturazioni urbane: Parigi.
L’architettura degli ingegneri: dal Crystal Palace alla Tour Eiffel.
IMPRESSIONISMO
Le premesse: E. Manet - Colazione sull’erba, Olympia.
La diverse interpretazioni dell’Impressionismo:
C. Monet - Impressione: levar del sole, La Grenouillére, le Cattedrali di Rouen.
E. Degas - Alle corse in provincia, La lezione di danza, L’assenzio.
A. Renoir - Il ballo al Moulin de la Galette, La Grenouillére, Colazione dei canottieri a Bougival.
POST-IMPRESSIONISMO
Caratteri generali
G. Seurat – Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.
P. Cèzanne - I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves.
P. Gauguin - L’onda, Aha oe feii?
V. Van Gogh - I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio Notte stellata.
ART NOUVEAU E SIMBOLISMO
Caratteri generali
G. Klimt - Giuditta, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio.
Il Divisionismo italiano
G. Segantini – Trittico della Natura
G. Pellizza da Volpedo - Il Quarto Stato.
ESPRESSIONISMO
Le premesse dell’Espressionismo
E. Munch - Sera nel corso Karl Johann, L’ urlo.
L’esperienza francese, i Fauves.
H. Matisse - Gioia di vivere*, La stanza rossa, La danza.
La pittura espressionista in Germania, il gruppo Die Brücke.
E.L. Kirchner - Due donne per strada, Strada a Berlino.
E. Schiele - Abbraccio.
CUBISMO
Caratteri generali.
P. Picasso - Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia
impagliata, Natura morta con uva e clarinetto, Guernica.
FUTURISMO
Caratteristiche generali.
U. Boccioni - La città che sale, Stati d’animo (II versione), Forme uniche nella continuità dello
spazio.
G. Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio.
ASTRATTISMO
W. Kandinsky - Primo acquerello astratto, Punte nell’arco.
P. Klee - Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie.
SURREALISMO
Il movimento Dada.
Marcel Duchamp e Man Ray.
Caratteri generali della pittura surrealista.
J. Mirò - Il carnevale di Arlecchino, Pittura.

52
S. Dalì - Costruzione molle con fave bollite: presagio di guerra civile, Apparizione di un volto e di
una fruttiera sulla spiaggia.
R. Magritte - L’uso della parola, La condizione umana.
ARCHITETTURA DEL NOVECENTO
Gropius e il Bauhaus.
CLIL
Picasso
Bauhaus and Modern Architecture
Degenerate Art
Peggy Gugghenheim and the americans collectors.
* opere non presenti sul libro di testo, ma sui testi integrativi.
----------------

53
3.10 Scienze motorie e sportive Prof.ssa Susanna Piccioli
Profilo della classe Ho lavorato con questi ragazzi per l’intero corso di studi ed ho riscontrato, da parte loro, un interesse vivo e partecipe.
La classe ha mostrato di impegnarsi in modo costante ed ha avuto un atteggiamento decisamente positivo nei confronti
del dialogo educativo. Il comportamento è sempre stato corretto e responsabile.
Il profitto risulta molto buono, per gran parte della classe, proprio per questa applicazione costante
ed anche perché molti degli alunni praticano tuttora o hanno praticato, in passato, attività sportiva a
livello personale, anche di notevole livello, e questa preparazione di base ha consentito loro di
raggiungere risultati positivi nelle varie prove in cui si sono cimentati.
Obiettivi disciplinari raggiunti dalla classe Gli obiettivi raggiunti sono stati: lo sviluppo della socialità e del senso civico, la presa di coscienza
dei propri mezzi, l’affinamento della coordinazione, il miglioramento ed il potenziamento delle
capacità fisiologiche, la conoscenza e la pratica delle varie discipline sportive, con l’eventuale
applicazione delle relative tattiche di gara.
Metodi, mezzi e tempi La preparazione è stata curata senza una scansione temporale precisa, ma alternando, di volta in volta,
le varie discipline a seconda delle necessità della scuola in funzione delle gare programmate nel
gruppo sportivo.
Per quanto riguarda le modalità di lavoro, sono state utilizzate: lezioni frontali e interattive,
discussioni guidate, esercitazioni pratiche individuali e di gruppi numericamente variabili.
La prima parte delle lezioni è stata sempre dedicata al riscaldamento ed alla preparazione atletica di
base e la seconda al miglioramento dei gesti tecnici specifici dei vari sport e all’applicazione della
tattica.
Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati: le 2 palestre della scuola, la palestrina
degli attrezzi ed il cortile esterno.
Alcuni alunni di questa classe, nell’intero corso di studi, hanno partecipato anche alle attività
extracurriculari del gruppo sportivo, finalizzate alla partecipazione ai tornei interni, ai Giochi Sportivi
Studenteschi e al Trofeo Città di Prato, ottenendo risultati molto positivi.
Strumenti di verifica e criteri di valutazione Per quanto riguarda la valutazione ho tenuto conto: dell’interesse mostrato nei confronti della materia,
della disponibilità a lavorare con impegno durante le lezioni curriculari, dell’incremento anche
minimo delle proprie capacità, dell’acquisizione di abilità specifiche, delle conoscenze riguardanti le
attività motorie, dell’applicazione delle tattiche di gara e della partecipazione al gruppo sportivo
scolastico.
Libri di testo Nell’intero corso di studi non sono stati adottati libri di testo, ma si sono trattati alcuni argomenti
teorici durante lo svolgimento delle lezioni.
Contenuti CONTENUTI METODI
TEST D’INGRESSO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ FISICHE Andature varie, esercizi d’impulso,

54
(forza, velocità, resistenza, elasticità muscolare, mobilità corsa di resistenza, corsa veloce,
articolare, ecc.) saltelli vari, es. a corpo libero, es.
con piccoli e grandi attrezzi, es. di
opposizione e resistenza, es. addo-
minali e dorsali, es. di mobilizza-
zione ed allungamento, circuiti di
destrezza, ecc..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE Capovolte avanti ed indietro, verti-
cale alla spalliera, es. di equilibrio.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONOSCENZA E PRATICA DEI GIOCHI SPORTIVI Fondamentali individuali e di squa-
(pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, hockey, dra, regolamenti tecnici, tattiche.
tennis, ultimate frisbee, madball, badminton, ping pong)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONOSCENZA E PRATICA DELL’ATLETICA Es. pre-atletici generali e specifici.
LEGGERA
(corse piane, salto in alto, salto in lungo,
lancio del peso)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARGOMENTI TEORICI Informazioni sulla tutela della salute
e sulla prevenzione degli infortuni;
elementi essenziali di anatomia dell’
apparato muscolo-scheletrico; aspetti
tecnici e regolamenti delle varie
discipline sportive.
---------------

55
3.11 IRC Prof.ssa Cristina Pieri
Profilo della classe L’interesse mostrato è stato significativo per il processo di apprendimento e di sviluppo di
conoscenze, abilità e competenze adeguate, la partecipazione al dialogo educativo è stata positiva e
costruttiva, la frequenza è stata costante ed il livello di preparazione raggiunto è stato
complessivamente ottimo.
Raggiungimento degli obiettivi
Il corso ha presentato agli allievi i principi morali e i valori etici del cattolicesimo, esplicitandone
soprattutto gli aspetti razionali e corrispondenti alla natura dell’uomo, facendo maturare negli
allievi le capacità applicative di tali principi alle più importanti sfere della vita personale e sociale,
in ordine anche alla comprensione della loro incidenza sulla cultura e sulla storia.
In ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio di Classe in merito alla programmazione didattica,
la classe, al termine del corso, ha dimostrato di:
- conoscere e saper valutare criticamente i principali sistemi di significato che producono giudizi
etici; sapersi orientare tra le varie proposte e problematiche etiche del mondo attuale.
- aver acquisito proprietà di linguaggio nell’utilizzazione dei termini specifici del linguaggio
morale; aver acquisito le più adeguate definizioni delle componenti morali nella vita spirituale
dell’uomo;
- essere in grado di interpretare in modo adeguato i giudizi morali presenti in testi ed ambiti
culturali e sociali;
Metodologie didattiche
La metodologia fondamentale è quella della lezione interattiva, con continue sollecitazioni agli
alunni a domande, osservazioni, interventi e commenti personali. La prima parte del corso è stata
finalizzata alla definizione del concetto di etica e di morale. La seconda ha dettagliato la concezione
della vita cristiana come amore al Tutto. Da ciò sono stati tratti percorsi esplicativi nel campo della
morale della vita personale e sociale. Alcuni tempi sono stati spesi per svolgere in lezioni interattive
le opportune applicazioni a situazioni o esperienze della vita individuale e collettiva. Durante questo
lavoro sono stati comunicati anche i giudizi emergenti dalla dottrina della Chiesa Cattolica sulle
principali problematiche contemporanee.
Materiali didattici e spazi utilizzati
È stato utilizzato come materiale didattico il libro di testo di Luigi Giussani, Scuola di religione,
S.E.I, Gli spazi utilizzati: Cineforum, aula, Aula LIM
Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione
La disciplina Religione Cattolica prevede una valutazione dell’interesse e del profitto e le verifiche
sono esclusivamente di tipo orale, prevedendo brevi risposte a domande, osservazioni personali e
commenti, valutazioni di situazioni concrete.
Contenuti
1) Definizione della morale
Fondamenti filosofici della morale
Relativismo e concezioni relativistiche del mondo
Soluzioni razionalistiche del problema morale
2) Fondamenti della morale cristiana
La concezione della vita secondo Gesù Cristo
La vita come vocazione

56
Il valore assoluto della persona; il valore della vita
La realtà come dipendente da Dio; la preghiera
La sequela e l’imitazione di Gesù
3) Elementi della morale cristiana
La coscienza; definizioni psicologiche e spirituali
L’uomo, la coscienza e la moralità dei suoi atti
La libertà; definizioni ed applicazioni
L'autorità; la legge e la norma morale
La dignità umana e i suoi diritti fondamentali
Il significato ed il destino dell'uomo
4) Etica dell’amore
L'amore umano: definizioni e fenomenologia
Verginità consacrata e vocazioni speciali
5) Etica della sessualità
Visione biblica della sessualità
L’educazione all’amore: sessualità e affettività
6) Etica del lavoro
La concezione cristiana del lavoro
Etica dell'economia, l’attività economica e la giustizia sociale
La dottrina sociale della Chiesa
Il principio di sussidiarietà
7) Etica politica
Il bene comune e lo Stato
Giustizia e solidarietà tra le nazioni
Etica della ricerca scientifica
----------------

57
4. INDICE
Presentazione del Liceo Scientifico “N. Copernico”………..………..………,.pag. 2
Profilo della classe……………………………………………………….…… pag. 3
Traguardi competenze trasversali…………………………………………..…. pag. 6
Lingua e Letteratura Italiana…………………………………………………...pag. 7
Lingua e cultura Latina……………………………………….…..…….………pag. 16
Lingua e letteratura Inglese……………………………………...………...……pag. 22
Filosofia………………………………………………….………..……..……..pag. 27
Storia ………………………………………………………………...…….….. pag. 32
Matematica…………………………………………………………………….. pag. 35
Fisica ……………………………….…………………………………………..pag. 40
Scienze Naturali…………………………………………………………...…....pag. 45
Disegno e Storia dell’Arte…………………………………………………...…pag. 49
Educazione Fisica……………………………………………………………....pag. 53
IRC……………………………………………………………………………..pag. 55
Allegati
a. Testo delle simulazioni della terza prova
b. Griglie d’esame (prima, seconda, terza prova e colloquio)

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI STATO
9 dicembre 2016
Tipologia B ---------- 5 materie ---------- 2 quesiti con risposta di massimo 10 righe
Latino 1. Spiegate i motivi per cui la Pharsalia di Lucano può essere definita un’anti-
Eneide?
2. Perché si può affermare che il Satyricon è un’opera che oscilla tra realismo e
parodia?
Inglese Both The Rime of the Ancient Mariner by S.T. Coleridge and La Belle Dame
Sans Merci by J. Keats deal with the supernatural, which is a very relevant
component of Romantic poetry. Compare or contrast one aspect of the two
poems you think it is particularly relevant. If you want you may consider
whether the supernatural is attractive or if it changes the people who experience
it.
Filosofia 1. Individua un elemento di affinità tra romanticismo e positivismo
2. Esponi la critica di Marx ai “Giovani hegeliani”
Matematica 1. Dopo aver fornito la definizione di funzione derivabile in un punto x0, si dimostri
la regola di derivazione della funzione y=lnx.
2. Dopo aver enunciato il teorema di derivazione delle funzioni inverse, lo si
applichi per dimostrare la regola di derivazione della funzione y=arcosx.
Scienze 1. Parla dei saponi, descrivendone le caratteristiche chimiche, come si formano, la
loro particolare struttura e da che cosa deriva la loro azione detergente.
2. Definisci le principali differenze tra le molecole dei polisaccaridi glicogeno,
amido e cellulosa.

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI STATO
27 febbraio 2017
Tipologia A ---------- 4 materie ---------- 1 quesito con risposta di massimo 20 righe
Inglese In the second part of the Victorian Age both Thomas Hardy and Robert Luis
Stevenson criticised the hypocrisy and bigotry of the middle classes.
Select one (or more) significant aspect(s) in the literary production of each author
and discuss this topic. Write a twenty-line essay, also referring to the extracts we
have read in class.
Storia Italia post-bellica: Fascismo agrario e politica del governo giolittiano con la nascita
dei Blocchi nazionali
Fisica
Dalle equazioni di Maxwell alle onde elettromagnetiche: lo studente, dopo aver
illustrato le quattro
equazioni, spieghi come queste prevedano l’esistenza delle onde elettromagnetiche.
Storia dell’Arte
Ingres, La
bagnante di
Valpinçon,180
8.
Degas, La tinozza,
1886.
Kichner, Marcella
e Franzi nello
studio 1908
Prendendo spunto
dall’osservazione delle opere
proposte, esponi le tue
considerazioni circa
l’evoluzione del linguaggio
figurativo nel corso del XIX
secolo, sia per quel che
riguarda la rappresentazione
della figura femminile che in
merito ai profondi
cambiamenti subiti dal
linguaggio e della tecnica
pittorica.

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ ESAME DI STATO
26 aprile 2017
Tipologia A ---------- 4 materie ---------- 1 quesito con risposta di massimo 20 righe
Inglese Unreal City,
Under the brown fog of a winter dawn1,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
Sighs2, short and infrequent, were exhaled,
And each man fixed his eyes before his feet.
Flowed up the hill and down King William Street,
To where Saint Mary Woolnoth3 kept the hours
With a dead sound on the final stroke of nine.
[…] (from The Waste Land, T. S. Eliot)
1.sunrise 2.long deep breath 3.an Anglican church in London
In the final episode of the first section, T. S. Eliot finally establishes the true wasteland
of the poem: the modern city. After identifying which elements of the text, in your
opinion, make us understand why London is such a desolate place, present what you
consider the most relevant element(s) in T.S. Eliot’s poetry. Discuss it, also considering
other works by other authors we have come across together in our English classes, and/or its context.
Fisica Dopo aver spiegato perché la scoperta che la luce si propaga a velocità costante, mini
le fondamenta della fisica classica, il candidato spieghi come l'impostazione eisteniana
dei principi relativistici costituisca un modello predittivo coerente, in grado di
racchiudere al suo interno anche il modello teorico della fisica classica.
Scienze Parla delle principali differenze tra magma primario e magma secondario
Storia dell’Arte Inquadra dal punto di vista storico e artistico il Futurismo e definiscine le
caratteristiche distintive generali, completando le tue affermazioni con riferimenti più
specifici ad autori ed opere che appartengono al movimento

Liceo Scientifico Statale “Copernico”-Prato
Griglia di valutazione della Prima Prova scritta –Italiano- per l’Esame di Stato- Tipologia A -B-C-D
Candidato/a.....................................................................Classe: ……….Sez. ………
GIUDIZI SINTETICI Gravemente
insufficiente =<6
Insufficiente 7 8
Non del tutto sufficiente 9
Sufficiente 10
Più che suff./ Discreto 11 12
Buono 13
Ottimo/ Eccellente 14-15
INDICATORI A. Competenza grammaticale:
1) ortografia 2) morfo-sintassi 3) punteggiatura 4) repertorio lessicale 5) registro e stile
0.5-2
2.5 3
3.25
3.5
3.5 4
4.5
Tipologia A-B-C-D 5 B. Competenza logico-elaborativa:
1) efficacia progettuale 2) coerenza e coesione 3) sviluppo argomentativo 4) completezza
0.5-2 0.5-2
2.25 2.25 2.75
2.5 3.25
3 3.75
3.25 4.25 4.75
3.5 5
Tipologia A 3.5-4 Tip. B-C-D 5.5-6 C. Competenze specifiche della tipologia A: analisi del testo
1) Comprensione (sintesi/parafrasi); 2) Analisi (pertinenza, esaustività) 3) Interpretazione ed approfondimento (capacità interpretativa;
contestualizzazione; visione interdisciplinare)
0.5-2
2.25 2.75
3.25
3.5
4.25 4.75
5
Tipologia A 5.5-6
C. Competenze specifiche della tipologia B: saggio breve/articolo di giornale
1) Uso della documentazione e correttezza delle citazioni 2) Originalità e capacità critica 3) Visione interdisciplinare e contestualizzazione
0.5-2
2.25
2.5
2.75
3.25
3.5
Tipologia B 3.5-4
C. Competenze specifiche della tipologia C: tema storico 1) conoscenze e rielaborazione dei dati 2) individuazione dei nessi storici 3) capacità critico-interpretativa
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Tipologia C idem
C. Competenze specifiche della tipologia D: tema di ordine generale
1) originalità e capacità critica 2) livello di approfondimento (rapporto tra prove soggettive e
prove oggettive)
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Tipologia D idem

Simulazioni di matematica a.s. 2015-2016- Rubrica di valutazione
CLASSE 5 sez. _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____
1
Sezione A: Valutazione PROBLEMA
INDICATORI LIVELLO DESCRITTORI Evidenze Punti
Comprendere
Analizzare la situazione problematica,
identificare i dati ed interpretarli.
L1 (0-4)
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali, o, pur avendone individuati alcuni, non li interpreta correttamente. Non stabilisce gli opportuni collegamenti tra le informazioni. Non utilizza i codici matematici grafico-simbolici.
L2 (5-9)
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei concetti chiave e delle informazioni essenziali, o, pur avendoli individuati tutti, commette qualche errore nell’interpretarne alcuni e nello stabilire i collegamenti. Utilizza parzialmente i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze e/o errori.
L3 (10-15)
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando correttamente i concetti chiave, le informazioni e le relazioni tra queste; utilizza con adeguata padronanza i codici matematici grafico-simbolici, nonostante lievi inesattezze.
L4 (16-18)
Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, le informazioni essenziali e le relazioni tra queste; utilizza i codici matematici grafico–simbolici con buona padronanza e precisione.
Individuare
Mettere in campo strategie risolutive e
individuare la strategia più adatta.
L1 (0-4)
Non individua strategie di lavoro o ne individua di non adeguate Non è in grado di individuare relazioni tra le variabili in gioco. Non si coglie alcuno spunto nell'individuare il procedimento risolutivo. Non individua gli strumenti formali opportuni.
L2 (5-10)
Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora sviluppandole in modo poco coerente; ed usa con una certa difficoltà le relazioni tra le variabili. Non riesce ad impostare correttamente le varie fasi del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore gli strumenti formali opportuni.
L3 (11-16)
Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le più adeguate ed efficienti. Dimostra di conoscere le procedure consuete ed le possibili relazioni tra le variabili e le utilizza in modo adeguato. Individua gli strumenti di lavoro formali opportuni anche se con qualche incertezza.
L4 (17-21)
Attraverso congetture effettua, con padronanza, chiari collegamenti logici. Individua strategie di lavoro adeguate ed efficienti. Utilizza nel modo migliore le relazioni matematiche note. Dimostra padronanza nell'impostare le varie fasi di lavoro. Individua con cura e precisione le procedure ottimali anche non standard.
Sviluppare il processo risolutivo Risolvere la situazione problematica in maniera coerente, completa e corretta, applicando le regole ed eseguendo i calcoli necessari.
L1 (0-4)
Non applica le strategie scelte o le applica in maniera non corretta. Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o errato. Non è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo errato e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta non è coerente con il problema.
L2 (5-10)
Applica le strategie scelte in maniera parziale e non sempre appropriata. Sviluppa il processo risolutivo in modo incompleto. Non sempre è in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o li applica in modo parzialmente corretto e/o con numerosi errori nei calcoli. La soluzione ottenuta è coerente solo in parte con il problema.
L3 (11-16)
Applica le strategie scelte in maniera corretta pur con qualche imprecisione. Sviluppa il processo risolutivo quasi completamente. È in grado di utilizzare procedure e/o teoremi o regole e li applica quasi sempre in modo corretto e appropriato. Commette qualche errore nei calcoli. La soluzione ottenuta è generalmente coerente con il problema.
L4 (17-21)
Applica le strategie scelte in maniera corretta supportandole anche con l’uso di modelli e/o diagrammi e/o simboli. Sviluppa il processo risolutivo in modo analitico, completo, chiaro e corretto. Applica procedure e/o teoremi o regole in modo corretto e appropriato, con abilità e con spunti di originalità. Esegue i calcoli in modo accurato, la soluzione è ragionevole e coerente con il problema.
Argomentare Commentare e giustificare opportunamente la scelta della strategia applicata, i passaggi fondamentali del processo esecutivo e la coerenza dei risultati.
L1 (0-3)
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva e la fase di verifica, utilizzando un linguaggio matematico non appropriato o molto impreciso.
L2 (4-7)
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva o la fase di verifica. Utilizza un linguaggio matematico per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
L3 (8-11)
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva e la fase di verifica. Spiega la risposta, ma non le strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza un linguaggio matematico pertinente ma con qualche incertezza.
L4 (12-15)
Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed esaustivo tanto le strategie adottate quanto la soluzione ottenuta. Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio scientifico.
TOTALE

Simulazioni di matematica a.s. 2015-2016- Rubrica di valutazione
CLASSE 5 sez. _______________Candidato: _________________________________________________________________Data: __ / __ /____
2
Sezione B: QUESITI
Calcolo del punteggio Totale
PUNTEGGIO SEZIONE A (PROBLEMA)
PUNTEGGIO SEZIONE B (QUESITI)
PUNTEGGIO TOTALE
Tabella di conversione dal punteggio grezzo al voto in quindicesimi
Punti 0-4 5-10 11-18 19-26 27-34 35-43 44-53 54-63 64-74 75-85 86-97 98-109 110-123 124-137 138-150
Voto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Voto assegnato ____ /15
CRITERI
Quesiti
(Valore massimo attribuibile 75/150 = 15x5)
P.T.
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
COMPRENSIONE e CONOSCENZA (0-4)
Comprensione della richiesta. Conoscenza dei contenuti matematici.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
ABILITA' LOGICHE e RISOLUTIVE(0-4)
Abilità di analisi. Uso di linguaggio appropriato. Scelta di strategie risolutive adeguate.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
CORRETTEZZA dello SVOLGIMENTO (0-4)
Correttezza nei calcoli. Correttezza nell'applicazione di Tecniche e Procedure anche grafiche.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
ARGOMENTAZIONE (0-3)
Giustificazione e Commento delle scelte effettuate.
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
Punteggio totale quesiti
Il docente
___________________________

Liceo Scientifico Statale “N.Copernico” - Prato Griglia di valutazione della terza prova per l'esame di stato (tipologia A e B)
Candidato/a............................................................................................................ Classe ….. sez.... Indicatori Descrittori punti Conoscenza degli argomenti. 6 punti di punteggio massimo
Ampia e approfondita Completa e sicura Essenzialmente corretta Incompleta e piuttosto generica Lacunosa e imprecisa Scarsa e/o del tutto errata
6 5 4 3 2 0/1
Competenza sia linguistica sia tecnica nella applicazione specifica delle discipline. 5 punti di punteggio massimo
Applica le conoscenze correttamente; lessico
complessivamente ampio, ricco e specifico Applica le conoscenze in modo generalmente corretto; lessico
vario e specifico Sa applicare le conoscenze con qualche errore non grave;
lessico complessivamente adeguato Applica le conoscenze solo parzialmente; lessico talvolta
ripetitivo e generico Inadeguata applicazione delle conoscenze; lessico non
specifico e/o scorretto
5 4 3 2 0/1
Capacità di analisi e sintesi, focalizzazione e organizzazione del testo. 4 punti di punteggio massimo
Esegue analisi e sintesi efficaci; l'espressione è coerente e
coesa Sa eseguire analisi globalmente corrette, sa sintetizzare in
modo semplice, ma funzionale con un’esposizione nel complesso efficace
Coglie solo parzialmente gli aspetti richiesti, la sintesi e l’organizzazione del pensiero e l’esposizione non sempre sono chiare
Ha gravi difficoltà sia di analisi sia di sintesi; il testo risulta frammentario e/o del tutto sconnesso
4 3 2 0/1
La prova “in bianco” verrà valutata 1 punto. TOTALE ...../ 15

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO
Candidato/a: ………………………………….. Classe: ……. sez. …..
20 sufficiente
La prova nulla verrà valutata 1 punto
A. CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE
DEI CONTENUTI max. 12 punti
40,00%
A. Conoscenze approfondite, ben strutturate e documentate B. Conoscenze complete e coerenti; C. Conoscenze generalmente corrette D. Conoscenze essenziali E. Conoscenze superficiali e disorganiche F. Conoscenze lacunose; erronea comprensione dei contenuti di base G. Conoscenze disorganiche ed incoerenti
12
11
9
8
7
6
4
B. COMPETENZA LINGUISTICA
(linguaggio specifico delle singole discipline)
max. 9 punti
30,00%
A. Esposizione personale e consapevole, ricchezza lessicale, uso sicuro e disinvolto dei linguaggi specifici B. Esposizione fluida, lessico vario, uso efficace dei linguaggi specifici C. Esposizione abbastanza scorrevole e consequenziale, lessico pertinente, uso appropriato dei linguaggi specifici D. Esposizione semplice e generalmente corretta; lessico abbastanza appropriato anche nei termini tecnici E. Esposizione poco corretta, lessico elementare F. Esposizione confusa e scorretta; lessico limitato G. Esposizione frammentaria, lessico improprio
9
8
7
6
5
4
2
C. COMPETENZA LOGICO-
ELABORATIVA (capacità di
rielaborazione,di analisi, di sintesi, di argomentazione, di
collegamento interdisciplinare)
max. 9 punti
30,00 %
A. Applicazione autonoma ed efficace, argomentazione stringente e molto attenta ad evidenziare collegamenti significativi B. Personale capacità di applicazione, argomentazione organica e coerente, collegamenti motivati e pertinenti C. Efficace capacità di applicazione, argomentazione coerente, capacità di individuare le principali relazioni tra i contenuti e le discipline D. Applicazione schematica, argomentazione elementare, semplice individuazione dei rapporti tra i contenuti e le discipline E. Modesta capacità di applicazione; argomentazione logicamente debole; collegamenti poco pertinenti o erronei F. Applicazione asistematica e argomentazione molto incerta e carente G. Applicazione confusa e argomentazione assente
9
8
7
6
5
4 2
TOTALE:
Liceo Scientifico Statale “N. Copernico” – Prato

5. F'IRMA DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE E DEL D.S.
Prof.ssa Roberta Tuccella (Lingua e letteratura italianalLingua e cultura latina)
Prof.ssa Elena Gargini (Matematica/Fisica)........
Prof.ssa Anna Pecchioli lScienze Naturali).. ....
Prof.ssa Cristina Pieri (lRC) .. ... ..V
Il Dirigen
Dr. S
Prato, 15 maggio 2017
\_r' ,irAFcr-,t-\"'\_y
Prof.ssa Chiara Pagani (Disegno e Storia dell'A
Prof.ssa Susanna Piccioli (Scienze motorie e spo
t4 sw