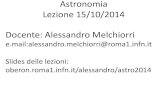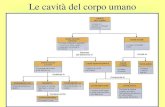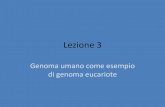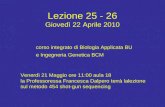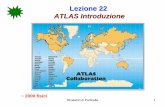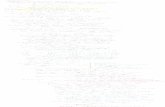Lezione 1 22-10-10
-
Upload
roberta-rossi -
Category
Documents
-
view
1.911 -
download
12
Transcript of Lezione 1 22-10-10

FACOLTA’ DI SCIENZE
MOTORIE
Corso di laurea in Scienze delle
attività motorie e sportive

Corso di Laurea in Scienze delle
Attività Motorie e Sportive
Corso Integrato di Anatomia umana
(12 CFU)
Modulo Anatomia I (6 CFU)
Docente: Prof. Giampiero La Rocca

Organizzazione del Corso:
Lezioni Frontali per un totale di 48 ore
I semestre (orario provvisorio):
Venerdì dalle 8 alle 10
Venerdì dalle 10 alle 12

Ricevimento Studenti:
Lunedì dalle 10 alle 12 presso Sezione di
Anatomia Umana del DiMeS
Via del Vespro 129 (Policlinico)
Tel 0916553506
email: [email protected]

Libri di Testo Consigliati:
Martini, Timmons, Tallisch. Anatomia Umana,
IV Ed. Edises, 2009
Barni et al. Anatomia dell’apparato locomotore,
EdiSES, 2008

Testi di consultazione consigliati:
Tillman. Atlante di Anatomia umana,
Zanichelli, 2008
Sobotta. Atlante di Anatomia Umana. 22°
Ed. Elsevier, 2008

Cambi di corso:
• I cambi di corso (ad esempio da A a B)
possono avvenire se si verifica
contemporaneamente il cambio inverso da
parte di un altro studente.
• Le richiese di cambio di corso vanno
presentate in segreteria didattica, Via Maggiore
Toselli.

Organizzazione degli esami: preesame ed
esame con voto
Preesame: si svolge all’inizio delle sessioni
principali (Febbraio-Giugno-Settembre)
Il voto vale per la stessa sessione e la
successiva.
Il programma del preesame è tutto tranne
l’apparato locomotore ed il sistema nervoso.

Anatomia Umana:
studio del corpo umano

Anatomia umana
Attraverso la conoscenza del corpo
umano è possibile non solo far fronte alle
malattie, ma anche raggiungere e
mantenere un migliore stato di benessere
fisico.

Anatomia:
dal greco (anatemno)
cioè
taglio, disseziono, separo

La tecnica della dissezione ha permesso, fin
dall’antichità, la descrizione delle strutture
che costituiscono il corpo umano.

Anatomia umana
Attraverso la dissezione prima e,
successivamente, attraverso tutti gli altri
strumenti che la tecnologia ha reso
disponibili, è possibile osservare e studiare
tutte le strutture che costituiscono il corpo
umano e comprendere sempre meglio la
realtà biologica dell’uomo


I livelli
di organizzazione
del corpo umano:
dall’organismo
all’atomo

Programma di Anatomia
1- Anatomia generale
2- Anatomia sistematica

1- Anatomia Generale
• Introduzione allo studio dell’anatomia
• La cellula, i tessuti e le loro modalità
di organizzazione

2- Anatomia Sistematica
• Apparato locomotore
- sistema scheletrico
- sistema articolare
- sistema muscolare
scheletrico

2- Anatomia Sistematica
• Sistema cardiovascolare
- cuore
- vasi e circolazione
• Sistema linfatico

2- Anatomia Sistematica
• Apparato respiratorio
• Apparato digerente
• Apparato urinario
• Apparato riproduttivo
- apparato genitale femminile
- apparato genitale maschile
• Apparato tegumentario

2- Anatomia Sistematica
• Sistema nervoso
- centrale
- periferico
- organi di senso
• Sistema endocrino

OBIETTIVI
1. Conoscenza delle componenti strutturali del
corpo umano:
- cellule
- tessuti
- organi
- sistemi ed apparati
con particolare riguardo all’apparato locomotore
2. Capacità di correlare le componenti strutturali a
specifiche funzioni

Lo studio dell’Anatomia umana prevede
la conoscenza del linguaggio anatomico,
che utilizza termini stabili, comuni,
inequivocabili.
E’ indispensabile, quindi, comprendere
ed imparare i termini da utilizzare, cioè
la terminologia anatomica.

La terminologia anatomica permette la
descrizione del corpo umano e la precisa
individuazione di ogni sua parte costitutiva
E’ necessario per questo avere punti di
riferimento precisi, univoci e facilmente
individuabili.

Per raggiungere tale obiettivo bisogna
utilizzare punti di riferimento costanti sul
corpo di tutti i soggetti, di qualunque età e
condizione fisica, in stazione eretta, supina o
prona, sia a riposo che in movimento.

E’necessario quindi distinguere,
nella descrizione del corpo o delle
sue parti, una terminologia statica
ed una terminologia dinamica

La posizione anatomica è una
posizione convenzionale, tuttavia
universalmente riconosciuta, che
rende possibile la descrizione statica
del corpo e delle sue parti.
Terminologia statica

La posizione anatomica, cui ci si riferisce,
è quella nella quale il corpo umano è posto
in stazione eretta, con lo sguardo volto
all’infinito, con gli arti superiori
leggermente divaricati rispetto all’asse del
corpo e le palme delle mani rivolte in avanti
con il primo dito posto all’esterno e le piante
dei piedi appoggiate al suolo con le punte
leggermente divaricate.

La posizione
anatomica

Il parallelepipedo di Van Loon
• Il corpo umano in posizione anatomica
può essere immaginato come inscritto
all’interno di un parallelepipedo
rettangolare: il parallelepipedo di Van
Loon.
• Esso rappresenta lo strumento ideale per
descrivere il corpo umano nelle tre
dimensioni.

In qualunque parallelepipedo rettangolare si riconoscono:a- il piano della base ed il piano dell’apice (piani trasversali), paralleli tra loro;
b- il piano anteriore ed il piano posteriore (piani frontali), paralleli tra loro;
c- due piani laterali (piani sagittali), paralleli tra loroTra ogni coppia di piani esiste un numero elevatissimo ma finito di piani paralleli

Piani anatomici

Tra i piani sagittali, il piano sagittale
mediano rappresenta il piano di simmetria
bilaterale
Questo permette di individuare nel corpo
umano due antimeri (emisoma destro e
emisoma sinistro). Gli organi o parti del
corpo presenti in ambedue gli antimeri sono
organi pari, quelli invece presenti in uno
solo dei due antimeri o sul piano sagittale
mediano sono organi impari

Il piano sagittale
mediano
Omolaterale e
controlaterale:
definisce strutture
situate,
rispettivamente, nello
stesso antimero o
nell’antimero opposto,
rispetto ad un’altra
struttura,

Organi pari ed
organi impari
Le strutture pari sono in
genere simmetriche per
forma e posizione (es.
tonsille palatine). Alcune
lo sono solo per la forma
(es. i reni), altre solo per la
posizione (es. polmoni).

Organi
impari

Termini di posizionePiano frontale o coronale
Anteriore Posteriore
ventrale dorsale
palmare nucale

Piano frontale o coronale

Termini di posizionePiano trasversale o orizzontale
Superiore Inferiore
craniale caudale
prossimale distale
plantare

Piano trasversale

Termini di posizione
Piano sagittale
Laterale Mediale
(esterno) (interno)

Piano
sagittale

I piani costituiscono anche superfici di sezione
del corpo umano o di sue parti.


Quando il corpo è in movimento, cioè
non è più in posizione anatomica, quale
terminologia si utilizza?

Assi anatomici
L’intersezione dei piani permette
di individuare gli assi anatomici.

Assi anatomici
1- asse longitudinale
o verticale
2- asse trasversale
3- asse sagittale o
anteroposteriore

• I piani ed gli assi anatomici permettono di
definire l’orientamento dinamicodelle parti del nostro corpo

Il corpo umano in movimento

Termini di movimento
A- Movimenti angolari
B- Movimenti in asse

Terminologia anatomica per definire
l’orientamento dinamico di parti del corpo:
A) MOVIMENTI ANGOLARI
1 – Nel piano sagittale sull’asse trasversale
Movimenti di flessione
Movimenti di estensione
2 – Nel piano frontale sull’asse sagittale
Movimenti di adduzione
Movimenti di abduzione

Movimenti angolari

Terminologia anatomica per definire
l’orientamento dinamico di parti del corpo:
A) MOVIMENTI ANGOLARI
3 – Nei piani sagittale e frontale e sugli assi
trasversale e sagittale
Movimento di circumduzione

Movimenti angolari

Terminologia anatomica per definire
l’orientamento dinamico di parti del corpo:
B) MOVIMENTI IN ASSE
1 – Nel piano orizzontale sull’asse
longitudinale
- Movimenti di rotazione
(mediale o laterale)

Movimenti in asse

PRIMO APPROCCIO ALLA
CONOSCENZA DEL CORPO
UMANO

Intuitivamente, il corpo
umano è suddivisibile in
alcune parti principali
facilmente individuabili.
1. Busto- testa- collo- tronco
2. Arti - superiori- inferiori

La presenza sulla
superficie del corpo di
solchi, pieghe,
depressioni, rilievi etc.
permette di individuare
punti di riferimento
precisi, chiari e
ripetitivi, comuni a tutti
i corpi umani.

Tali solchi, pieghe,depressioni, rilievi etc. costituiscono veri limiti anatomici, che suddividono in parti la superficie del corpo umano.
Talvolta, quando non esistono veri limiti anatomici, la suddivisione in parti del corpo umano viene operata tracciando linee e piani convenzionali.

Le parti del corpo
umano: il busto

Le parti del
corpo umano
La testa è separata dal collo attraverso un piano che decorre dalla sinfisi del mento alla protuberanza occipitale esterna.

Le parti del
corpo umano
Anteriormente, il collo
è separato dal tronco e
dagli arti superiori dal
margine superiore dello
sterno e delle due
clavicole.

Le parti del corpo
umano

Le parti del
corpo umano
Posteriormente, il
limite tra collo e tronco
è dato da un piano
convenzionale che
unisce le articolazioni
acromionclavicolari.

Le parti del
corpo umano
Il tronco comprende due
parti: una superiore, il
torace, ed una inferiore,
l’addome.

Il tronco
Il torace e l’addome sono separati dalla linea
toraco-addominale che, partendo dal processo
xifoideo dello sterno, segue l’arcata costale ed
il margine inferiore della dodicesima costa e
raggiunge la dodicesima vertebra toracica.

La linea
toraco-addominale

La linea
toraco-addominale

Le parti del
corpo umano
Il tronco è separato
dall’arto superiore da
un piano sagittale che
passa per la parte
media della clavicola.

Le parti del
corpo umano
Anteriormente, l’arto
inferiore è separato
dal tronco dalla piega
inguinale.

Le parti del
corpo umano
Posteriormente, l’arto
inferiore è separato
dal tronco dalla piega
glutea.

Le parti del corpo umano
Ciascuna delle parti in cui abbiamo
suddiviso il corpo umano viene a sua
volta ulteriormente suddivisa in parti di
minore estensione, tuttavia omogenee e
ben delimitabili attraverso precisi punti
di riferimento (punti di repere).

Le parti del corpo
umano

Le parti del corpo
umano

L’arto
superiore
5- regione deltoidea
7- regione brachiale anteriore
10- regione cubitale anteriore
12- regione antebrachiale anteriore
17- regione carpale anteriore

L’arto inferiore
1- regione subinguinale
2- triangolo femorale
4- regione femorale anteriore
6- regione anteriore del
ginocchio
8- regione anteriore della gamba

La cavità del corpo umano

Le cavità del corpo
umano
1- cavità dorsale o
neurale
2- cavità ventrale o
splancnica

La cavità dorsale

La colonna vertebrale
contiene la cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale

La cavità spinale ed il suo
contenuto

La cavità spinale ed il suo contenuto

La cavità
cranica

La cavità cranica

La cavità cranica ed il suo contenuto

Le cavità del corpo umano

La cavità ventrale

La cavità ventrale

La cavità ventrale

Il diaframma

La cavità toracica

Le cavità del corpo umano

La cavità
toracica

Il mediastino

La cavità
toracica

La cavità
pericardica

I polmoni

Le pleure

Le pleure

Le cavità del corpo umano

La cavità
addominopelvica

Quadranti
addominopelvici

La cavità
addominopelvica



OBIETTIVI
1. Conoscenza delle componenti strutturali del corpo umano
CELLULETESSUTIORGANI
APPARATI E SISTEMI
2. Capacità di correlare le funzioni a specifiche strutture

COMPOSIZIONE CHIMICA DEL CORPO UMANO

I livelli di organizzazione del Corpo Umano:dall’Organismoall’atomo

Caratteristiche degli organismi pluricellulari
Le cellule si riuniscono in tessuti con
specializzazione funzionale
Il patrimonio genetico delle cellule si
esprime in maniera differenziale in
maniera da acquisire caratteristiche
distintive (differenziamento)
La moltiplicazione cellulare
(accrescimento) si differenzia dalla
moltiplicazione dell’organismo
(riproduzione)

UNITA’ DI MISURA
• 1 = 1/1.000 di mm
• 1Å = 1/10.000 di
• 1 nm = 10 Å

Citologia
La cellula è la più piccola entità capace di manifestare in modo autonomo le funzioni vitali e costituisce l’unità di struttura e di funzione di tutti gli organismi viventi

Funzioni vitali degli organismi viventi
1- Irritabilità o responsività2- metabolismo ed escrezione3- movimento4- crescita e differenziamento5- riproduzione6- morte

La cellula “tipo”
Gli elementi strutturali che costituiscono le
caratteristiche comuni alla maggior parte delle
cellule sono rappresentati da:
- la membrana plasmatica o membrana
cellulare
o plasmalemma
- il citoplasma
- il nucleo

Il tessuto epiteliale
• Origina da tutti e tre i foglietti embrionali ed è
costituito prevalentemente da cellule fittamente
stipate e unite tra loro attraverso giunzioni
intercellulari.
• Nel tessuto epiteliale, il materiale intercellulare è
presente in quantità molto limitata.

Caratteristiche del tessuto epiteliale
Cellularità
Polarità
Ancoraggio
Avascolarità
Rigenerazione

Il tessuto epiteliale
• Forma lamine cellulari e cordoni solidi.
• Le lamine cellulari rivestono la superficie
esterna del corpo e le cavità interne,
costituendo gli epiteli di rivestimento.
• I cordoni solidi sono formati da cellule
secernenti e costituiscono gli epiteli
ghiandolari

Il tessuto epiteliale
• Oltre agli epiteli di rivestimento ed agli
epiteli ghiandolari, il tessuto epiteliale
comprende gli epiteli sensoriali e gli epiteli
particolarmente differenziati

Gli epiteli
di rivestimento

Gli epiteli di rivestimento
• Possono presentarsi sotto due aspetti:
- monostratificati o semplici
- pluristratificati o composti

• La forma delle cellule dà il nome all’epitelio.
Cellule pavimentose o piatte
- cubiche o isoprismatiche
- cilindriche o batiprismatiche

Gli epiteli di rivestimento:
morfologia delle cellule

Classificazione degli epiteli di
rivestimento
• Gli epiteli si classificano in base al numero
degli strati cellulari sovrapposti e alla forma
delle cellule che costituiscono la lamina
cellulare o, nel caso di un epitelio composto,
della forma delle cellule dello strato
superficiale

Classificazione degli epiteli di
rivestimento
Epitelio cubico semplice
Epitelio pavimentoso stratificato

Epitelio pavimentoso semplice

Epitelio cubico semplice

Epitelio cilindrico semplice

Epitelio cilindrico semplice con orletto a spazzola

Epitelio cilindrico semplice con ciglia

Epitelio pavimentoso stratificato non cheratinizzato

Epitelio pavimentoso stratificato cheratinizzato

Epitelio pseudostratificato

Epitelio di transizione

Epiteli di rivestimento: le caratteristiche
morfologiche sono strettamente correlate alla
funzione

• Tutte le lamine epiteliali poggiano su
tessuto connettivo, con l’interposizione di
una membrana basale

La membrana basale (mb)
• Si trova nei punti in cui le cellule (tranne
quelle connettivali) vengono in contatto con
la sostanza intercellulare del tessuto
connettivo. E’ formata da molecole
complesse secrete sia dalle cellule epiteliali
che connettivali.
• E’ formata da una lamina basale ed una
lamina reticolare.

• Gli epiteli di rivestimento sono avascolari.
Pertanto, la loro nutrizione viene assicurata
dai vasi sanguiferi del tessuto connettivo
sottostante.

• Negli epiteli stratificati, gli scambi nutritizi
vengono facilitati dal fatto che tali tessuti
inviano nel connettivo delle propaggini, le
creste epiteliali, tra le quali si interpongono
le papille connettivali.

Gli epiteli di rivestimento
• Gli epiteli di rivestimento ed il sottostante
tessuto connettivo costituiscono strutture
funzionalmente inscindibili, definite
membrane

Gli epiteli di rivestimento
• La membrana che riveste la superficie esterna del
corpo prende il nome di cute o pelle.
La lamina epiteliale forma l’epidermide e quella
connettivale forma il derma.
Il tessuto connettivo che si trova sotto il derma
prende il nome di ipoderma e contiene tessuto
adiposo in varia quantità (pannicolo adiposo
sottocutaneo)

CUTE

La cute
Costituisce una barriera che protegge i tessuti
sottostanti dall’invasione batterica, da offese di
natura chimica, meccanica, termica e fotica, regola
le perdite di calore ed impedisce l’evaporazione
dei liquidi tissutali.
Svolge anche funzioni biochimiche specializzate,
tra cui la produzione di vitamina D.

L’epidermide
• E’ un epitelio pavimentoso stratificato detto
cheratinizzato, perché le sue cellule
subiscono il processo di cheratinizzazione.
Attraverso questo processo, le cellule vive
si trasformano in lamelle cornee prive di
vita che desquamano.

L’epidermide
A- strato basale
B- strato spinoso
C- strato granuloso
D- strato lucido
E- strato corneo

Citomorfosi

Citomorfosi
Cellula cornea
Cellula basale

L’epidermide
I diversi strati dell’epidermide, dalla
profondità alla superficie libera, rappresentano
stadi differenti della maturazione dei cheratinociti.
I primi tre strati sono metabolicamente attivi,
mentre quelli più superficiali costituiscono la zona
corneificata

Oltre ai cheratinociti, nell’epidermide si trovano altre cellule, meno numerose, che non partecipano al processo di costante sostituzione
Queste cellule sono rappresentate da:
- Melanociti
- Cellule di Langerhans
- Cellule di Merkel

I melanociti
Sono le cellule produttrici di pigmento.
Il loro citoplasma contiene i melanosomi,
organuli delimitati da membrana e
contenenti il pigmento.

Cellule di Langerhans o cellule
dendritiche
Si trovano sparse in tutta
l’epidermide, alla base
dello strato spinoso,
derivano dal midollo osseo
e vengono continuamente
ricambiate
Sono importanti nei
meccanismi di difesa cellulare

Cellule di Merkel
Si trovano alla base
dell’epidermide e sono in
rapporto con terminali
nervosi del tipo dei
meccanocettori

Gli epiteli di rivestimento
• Le membrane che rivestono le superfici
interne del corpo in comunicazione con
l’esterno prendono il nome di mucose

Gli epiteli di rivestimento
• Le membrane che rivestono superfici
interne del corpo non comunicanti con
l’esterno prendono il nome di sierose
(pleure, pericardio e peritoneo)

Il tessuto epiteliale: epiteli sensoriali
• Sono formati da cellule specializzate nella
recezione degli stimoli dall’ambiente
esterno.
• Tali cellule sono definite cellule sensoriali
secondarie, per distinguerle dalle cellule
nervose con funzione recettoriale che si
definiscono cellule sensoriali primarie.

Il tessuto epiteliale: epiteli sensoriali
Tra le cellule sensoriali secondarie sono
comprese:
- le cellule gustative
- le cellule acustiche
- le cellule sensoriali dell’apparato
vestibolare

Epiteli particolarmente differenziati
• Sono compresi in questo gruppo alcuni
epiteli, con caratteristiche diverse tra loro,
che si differenziano per svolgere funzioni
specializzate, come lo smalto dei denti, i
peli, i capelli, le unghie e il cristallino
dell’occhio.