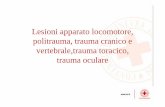LA GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DEL TRAUMA … · controllo delle vie aeree ... Anatomia • Trauma...
Transcript of LA GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DEL TRAUMA … · controllo delle vie aeree ... Anatomia • Trauma...

Gestione Intra-NOS del Trauma
LA GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DEL
TRAUMA
APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
ALL’INTERNO DEL NOS

VIE AEREE,
OSSIGENAZIONE E
VENTILAZIONE
Dott. A. Marchetti

3
• Identificare i pazienti che richiedono il
controllo delle vie aeree
• Comprendere la necessità di aumentare
l’ossigenazione nel paziente traumatizzato
• Elencare i metodi manuali e meccanici di
trattamento delle vie aeree mantenendo
un’immobilizzazione della colonna cervicale
• Elencare i metodi di ossigenazione e
ventilazione nel paziente traumatizzato
• Definire il significato di “via aerea definitiva”
Obiettivi

4
Anatomia
• Trauma maxillo-facciale
• Trauma del collo
• Trauma del laringe
vie aeree superiori
• Trauma cranico

5
Scenario
• Vieni inviato sulla scena di un incidente con una
moto. I presenti riferiscono che la moto
viaggiava a circa 70 km/h quando un gatto ha
improvvisamente attraversato la strada.
• Il motociclista ha perso il controllo del mezzo ed
è andato a sbattere contro un cassonetto della
spazzatura.
• Il paziente è a terra, il suo casco è danneggiato
ed è stato già rimosso dai presenti.

6
Valutazione primaria
Non risponde alla chiamata
Cianosi alle labbra ed alle estremità
Respiro russante, rapido e difficoltoso
CRITICO NON CRITICO
Le vie aeree sono compromesse?
Impressione rapida

7
Valutazione primaria
• Prima priorità: assicurare una via aerea pervia.
• Le morti precoci prevenibili per problemi relativi
alle vie aree, in seguito ad eventi traumatici,
derivano spesso da:– Mancato riconoscimento di un intervento sulle vie aeree
– Incapacità di inserire una via aerea
– Mancato riconoscimento della necessità di una strategia
alternativa per la gestione delle vie aeree in caso di fallimento
– Dislocazione di una via aerea inserita in precedenza
– Mancato riconoscimento della necessità di ventilazione
– Inalazione del contenuto gastrico
Valutazione e Trattamento - A

8
Trattamento
• Ispezione delle vie aeree
• Manovre manuali di apertura
• Aspirazione
• Presidi di base
Tecniche essenziali

9
Ispezione Vie Aeree
Rapida ispezione visiva della cavità orofaringea

10
Ispezione Vie Aeree
• Nella bocca di un paziente si possono trovare corpi estranei, come pezzi di cibo, o denti rotti e sangue

11
Manovre Manuali
Nei pazienti incoscienti la lingua
diventa flaccida, cade all’indietro e
blocca l’ipofaringe, occludendo la via
aerea e impedendo il passaggio di
ossigeno nella trachea e nei polmoni

12
Manovre Manuali
• La lingua rappresenta la causa più comune di
ostruzione delle vie aeree.
• Si possono facilmente utilizzare i metodi manuali
per risolvere questo tipo di ostruzione poiché la
lingua è attaccata alla mandibola e si muove
solidalmente con essa.
• NECESSARIO PROTEGGERE SEMPRE LA
COLONNA CERVICALE!

13
Manovre Manuali
• Non iperestendere il capo
• Apri le vie aeree e proteggi la colonna cervicale: sublussa la mandibola da dietro o frontalmente
Sublussazione della mandibola

14
Manovre Manuali
Sublussazione della mandibola
Questa manovra consente al soccorritore
di liberare le vie aeree con poco
movimento della testa e del rachide
cervicale. La mandibola viene portata in
avanti.

15
Manovre Manuali
Sollevamento del mento

16
Manovre Manuali
Sollevamento del mento
A due soccorritori :
• Il primo protegge la colonna cervicale
• Il secondo apre le vie aeree afferrando il
mento con una mano, sollevando la
mandibola

17
Aspirazione
• Ha lo scopo di rimuovere le secrezioni dalla
cavità buccale (i paziente traumatizzati
possono vomitare ed inalare)
• Non inserire il sondino troppo in profondità,
può scatenare il vomito

18
Aspirazione
• Aspira solo in fase di ritiro del sondino e per
un tempo massimo di 15 sec. (attento
all’ipossia)
• Assicurati di non “risucchiare” i tessuti molli

19
Garantita la pervietà con le manovre manuali, il
passo successivo è rappresentato dall’utilizzo di
un presidio temporaneo per garantire
l’ossigenazione:
CANNULA OROFARINGEA
Rappresenta la via aerea più comunemente
utilizzata; può essere inserita con tecnica ”diretta”o “inversa”
Presidi di Base

20
Presidi di Base
Cannula orofaringea
INDICAZIONI
Paziente che non è in grado di mantenere
pervie le proprie vie aeree
CONTROINDICAZIONI
Paziente cosciente o in stato di semi
incoscienza (riflesso faringeo)
COMPLICANZE
Nei pazienti coscienti può stimolare tosse e
vomito (non protegge la trachea)

21
Cannula orofaringea

22
Presidi di Base
Cannula nasofaringea
•Introduzione dalle cavità nasali
•Spesso ben tollerata dal paziente
•Mai nei traumi facciali ove si sospetti frattura della
lamina cribra o del basicranio anteriore

Maschera laringea Tubo laringeo
23
Presidi sovraglottici

Tubo multilume
24
Presidi sovraglottici
• I presidi sovraglottici
vengono utilizzati
soprattutto
nell’extraospedaliero
in caso di intubazione
difficile o impossibilità
all’intubazione dopo
ripetuti tentativi
• Non assicurano una
via aerea definitiva.

25
Via aerea definitiva
Si definisce via aerea definitiva un tubo in trachea,
con il palloncino insufflato al di sotto delle corde
vocali, connesso ad un dispositivo di ventilazione
assistita arricchita con ossigeno e fissata con un
cerotto.
Ne sono esempi l’intubazione orotracheale e la via
aerea chirurgica (cricotiroidotomia chirurgica e
tracheostomia)

26
Intubazione orotracheale
• Indicata in caso di mancato controllo delle vie aeree (GCS <=8)
• Protezione rachide cervicale• BURP (pressione della cartilagine tiroidea in
senso posteriore, verso l’alto e verso destra) • Presidi videolaringoscopici o introduttore
tracheale di Eshmann (GEB) in caso di mancata visualizzazione del piano glottico
• Sequenza di intubazione farmacoassistita (pazienti coscienti, con riflesso attivo della tosse)

27
Intubazione orotracheale
LEMON

28
Intubazione orotracheale
Verifica del
corretto
posizionamento
del tubo
laringeo
• Auscultazione
epigastrica
• Auscultazione dei
campi polmonari
• Saturimetria ed end-
tidal CO2

29
Via aerea chirurgica
• Cricotiroidotomia con ago (Jet Insufflation)
• Cricotiroidotomia chirurgica (sconsigliata < 12
anni)
• Tracheostomia

30
Algoritmo decisionale trattamento delle vie aeree

31
Scenario
Un giardiniere è caduto da un albero da
circa 3 metri d’altezza. Lo trovi a terra
supino, non cosciente, pallido e con un
respiro russante.
Come puoi gestire le sue vie aeree?

32
Ossigeno terapia
• Un trauma può compromettere la capacità
del sistema respiratorio di provvedere
adeguatamente all’ossigenazione
• Come risultato si instaura l’ipossia:
inadeguata ossigenazione dei tessuti
• Pervietà delle vie aeree ed erogazione
supplementare di ossigeno sono di vitale
importanza per ottenere risultati
soddisfacenti dopo un trauma

33
Ossigeno terapia
• Tutti i pazienti traumatizzati devono ricevere ossigeno supplementare
• L’obiettivo è mantenere una Sp02 95%
• Se in dubbio, utilizzare un dispositivo in grado di erogare ossigeno a concentrazioni di almeno 85% di Fi02
• L’ossigeno è sicuramente il medicamento più sicuro e più indicato da somministrare al paziente traumatizzato

34
Ossigeno terapia
• L’aria atmosferica fornisce una concentrazione di ossigeno non superiore al 21%
• Nel decidere quale metodo e attrezzatura usare devi almeno conoscere i dispositivi e le rispettive concentrazioni di ossigeno erogate
• Al di la del limite fisico di ogni dispositivo, ricorda che ad ogni aumento del flusso di ossigeno di 1 lt/min, la concentrazione di ossigeno viene aumentata del 4% circa:
• 1 lt/min 24% 2 lt/min 28%
• 3 lt/min 32% 4 lt/min 36%

35
Presidi per la ventilazione
Anch’essa poco
usata nel trauma
perché è in grado
di somministrare
solo moderate
concentrazioni di
O2 (dal 40 al 60%)
con una portata di
6-8 lt/min.
Maschera semplice

36
Presidi per la ventilazione
• A parte l’Ambu è il miglior
strumento di cui un
soccorritore dispone per
somministrare alte
concentrazioni di ossigeno
dall’80 al 95%
• La portata minima è di 8
lt/min. il flusso massimo può
variare dai 12 ai 15 lt/min.
Maschera con valvola antireflusso + reservoir

37
• Pallone autoespandibile con valvola unidirezionale,
utilizzato insieme a supporti per le vie aeree di
base (maschera) o avanzati
• E’ il presidio utilizzato più comunemente
• Impiegare la più alta portata di ossigeno (15 lt/min)
• AMBU + ossigeno = 40-60%
• AMBU + ossigeno + reservoir = 90-100%
Pallone-valvola-maschera (AMBU)

38
• Consente sia la ventilazione assistita che
la ventilazione controllata
• Il suo corretto utilizzo può richiedere 2
soccorritori
• Mantenere la stabilizzazione della colonna
cervicale
Pallone-valvola-maschera (AMBU)

39
?
Domande