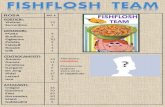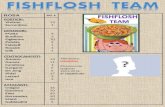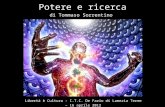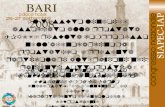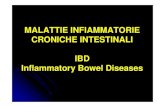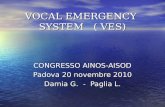L I C E O S T A T A L E “Pitagora - B. Croce” FINALE VEs … · Laboratorio Teatrale “Anita...
Transcript of L I C E O S T A T A L E “Pitagora - B. Croce” FINALE VEs … · Laboratorio Teatrale “Anita...

Classe V Sez. E
Anno Scolastico 2017/18
COORDINATORE Prof.ssa Raiola Annamaria
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

2
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(Regolamento art. 5)
Classe: V SEZ. E Anno Scolastico: 2017/2018
Coordinatore di classe: Prof. ssa Raiola Annamaria
Si forniscono le indicazioni e le valutazioni di fine anno scolastico finalizzate alla pre-parazione delle prove per gli esami di stato dell’anno scolastico 2017/2018.
- Esse fanno riferimento al progetto di Istituto, alla programmazione dell’anno in corso e alle relazioni individuali di fine anno dei docenti membri del Consiglio.
- Per le indicazioni e valutazioni specifiche delle varie materie si allegano le rela-zioni sintetiche individuali dei docenti.
1. Presentazione sintetica della classe
Situazione iniziale e pregressa della classe nel terzo e quarto anno. All’inizio del triennio la classe risultava composta da 25 alunni, 24 provenienti dal nucleo originario del biennio e nella classe terza è stata inserita l’alunna Cascone, ripetente, proveniente da un’altra classe del Li-ceo e trasferitasi,poi, in altra scuola. Nella classe IV è poi rientrato l’alunno Marra M. trasferitosi l’anno pre-cedente in Sardegna per motivi familiari. L’adattamento al triennio è stato, nel complesso, agevole e quasi tutti i discenti hanno operato, in tale periodo, rispondendo per lo più positivamente alle sollecitazioni dei do-centi, dimostrando interesse per le attività didattiche e partecipando al lavoro che si andava svolgendo.
Situazione della classe nell’ anno in corso. La classe, attualmente formata da 25 alunni, ha partecipato, pur con la normale differenziazione nelle varie discipline, all’attività didattica, mostrandosi interessata e motivata all’apprendimento; inoltre è stata sollecita nell’accogliere e nel coltivare iniziative, attività e progetti curriculari che contribuissero all’arricchimento ed alla crescita culturale dei componenti. Gli allievi sono scolariz-zati e disciplinati e molti di essi sono dotati di buone capacità logico-critiche ed analitiche, nonché di discrete abilità espositive in quanto hanno elaborato un metodo di studio proficuo ed organico. In relazione agli obiettivi conseguiti, la classe si presenta abbastanza eterogenea e, all’interno di es-sa si distinguono differenti gruppi che, nel corso del quinquennio, hanno sempre lavorato in modo diverso. Alcuni alunni hanno dimostrato buone capacità critiche, sensibilità culturale, volontà di crescita e vivaci interessi personali. I docenti li hanno visti acquisire, con gli anni, senso di respon-sabilità, capacità di ragionamento e apertura mentale; per questi alunni il triennio è stato caratte-rizzato da un lavoro costante e approfondito che spesso è approdato a risultati soddisfacenti. Un gruppo più esiguo, invece, ha raggiunto una preparazione accettabile in quanto nel corso di quest’anno scolastico questi discenti si sono limitati ad un impegno non sempre adeguatamente approfondito e supportato da un costante rendimento

3
Inoltre si fa presente che nel corso dell’ultimo trimestre si è dato spazio al percorso CLIL così come
da programmazione condivisa, sviluppando un’attività di approfondimento in Storia dell’Arte il cui
tema è “The Cubism: Pablo Picasso and his masterpiece Guernica. Gli studenti coinvolti in questa
sperimentazione CLIL hanno accolto tale integrazione con curiosità e propositività. I programmi corrispon-
dono effettivamente a quelli presentati e in regola con quanto proposto nella programmazione individuale dei
docenti e ciò grazie alla frequenza complessivamente regolare della classe.
Continuità didattica nel triennio. Per quel che concerne la continuità didattica, va segnalata l’alternanza delle Docenti di Fisica Ce-sarano Patrizia al terzo anno, al quarto anno Bisogno Rita e Fenda Wilma al quinto anno. Questi cambiamenti non hanno generato negli alunni alcuna difficoltà nell’apprendimento in quan-to, superata la fase iniziale di adattamento, si sono subito instaurati rapporti di stima e di fiducia reciproci tra i docenti e gli alunni.
2. Obiettivi generali (educativi e formativi) raggiunti:
(Capacità trasversali: relazionali, comportamentali e cognitive) Acquisizione di cognizioni di sé e del mondo esterno
Acquisizione delle tematiche oggetto di studio
Potenziamento dei mezzi espressivi
Sviluppo di capacità logico e creative attraverso la rielaborazione delle informazioni e il loro riutilizzo adeguato alle varie circostanze
Sviluppo delle capacità di analisi e sintesi
3. Conoscenze, competenze e capacità raggiunte:
a)….. nell'ambito delle singole discipline si rinvia alle schede di ogni docente (allegato A) b)……Nell'ambito di attività in più Aree disciplinari, si rinvia alle schede dei nuclei e dei percorsi pluridisciplinari di approfondimento
4. Attività pluridisciplinari curriculari svolte nell’anno : I docenti dell’area umanistica, nel corso dell’anno scolastico, hanno concordato le unità didattiche programmate.
5. Attività di recupero svolte nell’anno e risultati ottenuti:
Nell’intento di ridurre le differenze nelle condizioni di partenza, i docenti, senza ovviamente trascurare gli alunni più brillanti, hanno incoraggiato quelli con qualche carenza a ritrovare fiducia in se stessi anche impegnando metodologie di studio differenziate ed individualizzate.

4
6. Attività di approfondimento svolta nell’anno e risultati
ottenuti: Nel corso dell'anno scolastico si è attuata un’attività extracurriculare riguardante l'area scientifica (risoluzione di problemi per la preparazione all’esame di Stato).
7. Attività extracurricolari effettivamente svolte e risultati ottenuti: Viaggio di istruzione(3 giorni) in Emilia Romagna (Luoghi della Resistenza Italiana). Gli alunni Cinoboli Roberto e Coppola Giuseppe hanno partecipato al viaggio d’Istruzione in Grecia (Accensione della Fiaccola Olimpica). . L’alunno Riso ha partecipato al viaggio delle eccellenze a Strasburgo. Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro:”Madein (SOUTH) Italy” (allegato E).
Orientamento universitario Partecipazione a dibattiti, Seminari e manifestazioni culturali. Corso di approfondimento di Storia tenuto dal Prof. Palmisciano (n°7 lezioni che si sono svolte presso il Liceo). Cineforum. Laboratorio Teatrale “Anita Sorrentino”
8. Criteri e strumenti di valutazione approvati dal Collegio dei docenti e fatti propri dal Consiglio di classe:
Si rimanda alla tabella (allegato D) con i criteri di valutazione ed i caratteri della prestazione approvata dal Collegio dei docenti e fatta propria dal Consiglio di classe.
9) Metodologie, strumenti e tipologie di verifica degli appren-dimenti adottati nelle varie discipline, in relazione ai piani di lavoro annuali dei singoli docenti
Metodologie utilizzate per favorire l’apprendimento degli alunni spesso
Alcune volte
mai
Lezione frontale x
Lezione dialogata x
Dibattito in classe x
Lezioni di laboratorio x
Esercitazioni individuali in classe x
Esercitazioni in piccoli gruppi x
Insegnamento per problemi x
Analisi del testo x
Analisi di casi x
Relazioni su ricerche individuali x
Relazioni su ricerche di gruppo x
Applicazioni al computer x
Simulazioni x
Spazi utilizzati
Biblioteca
Palestra x
Laboratori informatici
Laboratorio di………………………..
Laboratorio di……………………….
Sala video x

5
10 . Simulazioni di terza prova effettuate:
(per i testi delle prove effettuate vedere allegato E)
Tipologia e durata Tipologia B ( Quesiti a risposta singola con breve trattazione ) Durata : ore 2,00 Materie coinvolte 1a simulazione: Latino, Inglese, Storia, Fisica, Scienze.
2 simulazione: Inglese, Filosofia, Fisica, Storia dell’Arte, Ed. Fisica
Criteri di progettazione e valutazione adottati: La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso il consiglio , pertanto, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali definiti nella propria pro-grammazione didattica ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esi-stenti fra le seguenti discipline :
Strumenti adoperati per favorire l’apprendimento
spesso Alcune
volte mai
Lavagna e gesso x Lavagna luminosa x Proiettore per diapositive x Registratore audio x Video registratore x Proiettore film Altri testi oltre al manuale x Fotocopie x Dispense x Computer x Sistema multimediale x …………………………………………. …………………………………………..
Metodologie di la-boratorio per le ma-terie che lo preve-dono
Lezioni frontali Dimostrazioni ex-cattedra
Esercitazioni individua-li
Esercitazioni in gruppi Attività di ricerca gui-data
………………………… …………………………. ………………………….
Strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento
spes-so
Alcu-ne
volte mai
Interrogazioni orali x Prove scritte (temi e/o versioni) x Prove strutturate e/o semistrutturate ( di tipo mi-sto: con esercizi, schemi-frasi da completare, pro-blemi)
x
Prove strutturate con quesiti a risposta singola x Prove strutturate con quesiti a risposta multipla x Saggi brevi (problemi a soluzione rapida) x Trattazione sintetica di argomenti x Relazione individuale di laboratorio x Griglie di osservazione e di correzione x Schede di lettura x Prove multidisciplinari x

6
1. Latino, Inglese, Storia, Scienze, Fisica. 2. Inglese, Filosofia, Fisica,Storia dell’Arte, Ed. Fisica. e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica , in preparazione della terza prova scritta degli esami di stato conclusivo del corso di studi Per la valutazione di questa prova è stato adottato il seguente criterio:
Risultati conseguiti: Il risultato delle prove rispecchia mediamente il rendimento fatto registrare dagli studenti nel cor-so dell’anno scolastico per le singole discipline con risultati migliori nelle discipline per le quali da tempo gli allievi sono abituati alla trattazione sintetica di argomenti. 1° Simulazione: i risultati sono, in linea generale, sufficienti. 2° Simulazione: i risultati sono, in linea generale, pienamente sufficienti. Torre Annunziata: 07/05/2018 Firma del coordinatore Firma del Dirigente scolastico …………………….. ……………………
Timbro della scuola
VALUTAZIONE MOTIVAZIONE PUNTI
ASSOLUTAMENTE INSUFFICIENTE Se la risposta non è stata fornita 0
INSUFFICIENTE
se la presentazione delle informazioni basi-lari riferite alla domanda in oggetto risulta inadeguata e confusa
0,5
SUFFICIENTE
Se la risposta presenta dati informativi esposti con sufficiente chiarezza ed evi-denzia una adeguata comprensione degli elementi strutturali richiesti
1
PIU’ CHE SUFFICIENTE
Se la risposta presenta concetti e contenuti condotti con padronanza e in un quadro di efficacia formale
1,5

7
Allegato A
RELAZIONE
SULL’ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO
Liceo Scientifico
CLASSE: V E A.S. 2017/2018
Titoli dei nuclei di approfondimento (intensivi)
1) area scientifica: Problemi di preparazione all’esame di Stato
Materie coinvolte:
1) Matematica
Obiettivi raggiunti in termini di:
CONOSCENZE:
Contenuti specifici pluridisciplinari
Terminologia specifica
Contesti culturali
COMPETENZE:
Elaborare e formulare concetti astratti
Giungere alla comprensione dei fenomeni attraverso l'applicazione di conoscenze e procedi-menti logico intuitivi
Comprendere ed individuare legami e correlazioni tra cultura scientifica ed altre forme di cultu-ra
Rendere evidente i legami dei concetti con l'esperienza.
CAPACITA':
Orientarsi sul panorama culturale, operando confronti interdisciplinari
Concettualizzare le informazioni
Operare collegamenti tra fenomeni concetti, discipline, sia a livello sincronico, sia a livello dia-cronico

8
1) Contenuti per ciascuna disciplina e tempi di realizzazione
(con riferimento ad una eventuale durata e calendarizzazione)
unità didattiche , moduli, percorsi degli apprendimenti periodo/ore
MATEMATICA: Problemi di preparazione all’esame di Stato Maggio
ore 10
1) Metodi (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di integrazione e di approfondimento)
Lezione frontale
Gruppi di lavoro
Attività di approfondimento
2) Mezzi (strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali,etc..)
Testi di preparazione alla seconda prova d’esame
Testi adottati
3) Spazi (Laboratori, biblioteca, stage, visite guidate, mostre,…)
Aula
4) Criteri e strumenti di valutazione adottati (prove scritte, verifiche orali, prove struttura-te, prove pratiche, prove di laboratorio, etc..) Sono state effettuate frequenti verifiche scritte. L'ac-quisizione dei contenuti è avvenuta con colloqui orali che hanno coinvolto i partecipanti alle lezio-ni.

9
ORDINAMENTO DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO STATALE PITAGORA-CROCE
LICEO SCIENTIFICO
Ore settimanali Materie e gruppi di materie 1a
classe 2a
classe 3a
classe 4a
classe 5a
classe Prove di
esami interni
Religione 1 1 1 1 1
Lingua e lettere Italiane 4 4 4 3 4 S.O.
Lingua e lettere Latine 3 3 3 3 3 S.O.
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 4 S.O.
Storia 3 2 2 2 3 O.
Filosofia === === 2 3 3 O.
Geostoria 3 === === === === O.
Scienze nat. chim. e geo. 2 2 3 3 2 O.
Fisica 2 2 3 3 3 O.
Matematica 5 4 3 3 3 S.O.
Disegno 1 3 2 2 2 O.
Educazione fisica 2 2 2 2 2 O.
TOTALE 29 26 28 28 30

10
SCHEDA DI VALUTAZIONE – ITALIANO (secondo biennio e quinta classe) Voto Competenze Capacità/Abilità Conoscenze
1 2 3 Molto negativo
Non riesce ad esprimere i con-cetti e commette gravissimi er-rori. Non riesce a comprendere e decodificare i testi.
Non è capace di effettuare alcuna analisi né di sintetizzare gli ele-menti essenziali dei testi letterari.
Nessuna conoscenza o pochissime conoscenze
4 Insufficiente
Si esprime con difficoltà e ri-conosce solo parzialmente gli elementi specifici della lingua letteraria. Non sa collocare au-tonomamente un autore e un’opera nel contesto di appar-tenenza.
Memorizza in modo lacunoso senza cogliere i nuclei concettua-li fondamentali. Anche sol-lecitato e guidato, non effettua valutazioni. È disorganico nella produzione scritta.
Frammentarie e molto su-perficiali
5 5,5 Mediocre
Sa esprimersi in modo lineare e semplice con qualche errore non grave. Guidato, riesce ad elaborare le conoscenze.
Analizza e sintetizza in modo incompleto. Individua i nuclei concettuali, se guidato.
Superficiali e non com-plete
6 Sufficiente
Decodifica i testi in modo es-senziale esprimendosi in forma semplice e senza fare errori. Colloca autori e opere nel con-testo, pur con qualche incertez-za.
Analizza e sintetizza gli elementi essenziali dei testi proposti ed opera qualche collegamento, se guidato. Produce testi coerenti con le va-rie tipologie senza commettere errori ricorrenti
Complete, ma non appro-fondite
7 Discreto
Rielabora le conoscenze acqui-site, ma cade in qualche im-precisione. Espone con chia-rezza e si esprime in maniera abbastanza articolata.
Comprende, analizza e interpreta i testi, in modo autonomo, pur con qualche incertezza. Effettua valutazioni parziali, se guidato. Produce testi scritti coerenti.
Complete e chiare
8 Buono
Rielabora in modo autonomo i contenuti e sa applicare le pro-cedure nell’esecuzione delle varie tipologie di prove. Espo-ne in maniera organica con un linguaggio specialistico e ben articolato.
Analizza e sintetizza in modo completo e puntuale i testi. Effet-tua autonomamente valutazioni, anche se non approfondite. Pro-duce testi ricchi, coesi e ben or-ganizzati
Complete, chiare e appro-fondite
9 10 Ottimo / Eccellente
Utilizza le conoscenze e le pro-cedure in nuovi contesti plu-ridisciplinari senza errori e an-che con l’uso di strumenti mul-timediali. Esprime opinioni e giudizi critici con linguaggio fluido ed incisivo.
Effettua analisi e sintesi comple-te ed approfondite. Stabilisce re-lazioni, organizza autono-mamente e completamente le co-noscenze e le procedure acquisi-te. Effettua valutazioni au-tonome, complete, approfondite e personali. Produce testi originali.
Complete, approfondite, coordinate, ampliate e personalizzate.
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

11
SCHEDA DI VALUTAZIONE – LATINO (secondo biennio e quinta classe)
Voto Competenze Abilità/Capacità Conoscenze
1 2 3
Molto negativo
Non riesce ad utilizzare le conoscen-ze e commette gravissimi errori. Non riesce a comprendere e decodificare i testi latini.
Non è capace di effettuare alcuna analisi dei testi latini, né di sinte-tizzare il discorso letterario. Non ap-plica le procedure per la traduzione.
Nessuna conoscenza o pochissime conoscen-ze
4 Insufficiente
Si esprime con difficoltà e riconosce solo parzialmente gli elementi propri della disciplina. Commette errori gra-vi nella comprensione e nell’analisi dei testi.
Analizza e sintetizza in modo la-cunoso. Coglie solo parzialmente il significato complessivo di un testo d’autore. Commette gravi errori nelle procedure per la traduzione.
Frammentarie e molto superficiali
5 5,5
Mediocre
Si esprime in modo semplice e com-mette qualche errore non grave nell’individuare i concetti essenziali. Guidato, riesce a comprendere ed analizzare i testi.
Analizza e sintetizza in modo in-completo. Riconosce gli elementi morfosintattici costitutivi, se guida-to.
Superficiali e non complete
6 Sufficiente
Usa gli strumenti di indagine lingui-stica e stilistica ed esegue l’analisi testuale e la decodifica dei testi, pur con qualche incertezza.. Espone in forma semplice e corretta.
Riconosce gli elementi morfosintat-tici e stilistici costitutivi. Opera sem-plici collegamenti intertestuali e di contesto, se guidato.
Complete, ma non ap-profondite
7 Discreto
Applica i contenuti e le procedure, ma cade in qualche imprecisione. Espone con chiarezza e in maniera appropriata.
Effettua analisi complete ed è in gra-do di cogliere i nessi logici e tempo-rali, pur con qualche incertezza. Ef-fettua valutazioni parziali, se guida-to.
Complete e chiare
8 Buono
Sa applicare in modo autonomo i contenuti e le procedure anche in prove complesse. Espone in maniera organica con un linguaggio speciali-stico e ben articolato.
Effettua analisi e sintesi complete. Coglie autonomamente le relazioni intertestuali e contestuali. Applica con sicurezza le procedure.
Complete, chiare e approfondite
9 10
Ottimo / Eccel-lente
Esegue compiti complessi, applica le conoscenze e le procedure in nuovi contesti senza errori e in modo origi-nale. Produce autonomamente espres-sioni, opinioni e giudizi con linguag-gio fluido ed incisivo.
Effettua analisi e sintesi complete ed approfondite. Stabilisce relazioni, organizza autonomamente e comple-tamente le conoscenze e le procedure acquisite. Effettua valutazioni auto-nome, complete, approfondite, per-sonali e originali.
Complete, approfon-dite, coordinate, am-pliate e personalizzate.
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

12
Firma dei docenti componenti il consiglio di classe
Religione (Prof. Michele Lanese) ______________________________ Italiano e Latino (Prof.ssa Annamaria Raiola) ______________________________ Lingua e Letteratura Inglese (prof. Domenico Polimeno) ______________________________ Matematica e Fisica (Prof.ssa Wilma Fenda) ______________________________ Storia e Filosofia (Prof. Nicola Piccinino) ______________________________ Scienze (Prof.ssa Amalia Marino) ______________________________ Disegno e Storia dell’Arte (Prof.ssa Ida Buonocunto) ______________________________ Educazione Fisica (Prof.ssa Tania Mastellone) ______________________________
Torre Annunziata,07/05/2018

13
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. Lanese
Materia :Religione Classe : V E a.s.2017-2018
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:La classe, ben scolarizzata, ha acquisito le conoscenze fondamentali
dell’etica cristiana e dell’agire umano, alla luce dell’insegnamento di Cristo e della Chiesa.
Attraverso questi fondamenti, la classe, conosce il significato dell’amore per una promo-
zione dell’uomo nella giustizia e nella verità; conosce il primato dei diritti fondamentali del-
la persona come fatto inalienabile.
COMPETENZE:
Le competenze acquisite dalla classe in relazione alla programmazione curriculare sono:
l’uso del linguaggio specifico inteso come competenza lessicale,corretto uso dei termini e
decodificazione dei simboli. La classe ha acquisito un atteggiamento critico e consapevole
di fronte agli orientamenti valoriali mostrando, attraverso il dialogo ed il confronto,di pos-
sedere le competenze per una riflessione critica e personale.
CAPACITA’:
La classe ha sviluppato le capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche ed ai docu-
menti; è capace di collegare fatti ed informazioni; è capace di assumere un atteggiamento
critico e consapevole di fronte alle varie esperienze. La classe è capace di elaborare
,attraverso la libera espressione, un giudizio critico e personale.
1) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione (con riferimento ad una eventuale
durata o calendarizzazione quadrimestrale, trimestrale, bimestrale mensile o altro) esposti
per: trimestre e pentamestre
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti Periodo/ore
Il concetto di morale; la peculiarità della morale cristiana: un progetto per
la vita.
Set-ott-nov-
Dic.
12 ore
Persona e relazione; il Decalogo e la legge dell’amore come affermazione
dei diritti dell’uomo.
Gen.-Febb.
6 ore
La pace, la giustizia,la bioetica,la politica. La dottrina sociale della Chiesa Marzo- Apr.

14
Maggio
12 ore
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 30 ore
2) Metodi: (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recu-
pero, sostegno e integrazione, ecc.)
La classe è stata sollecitata ad assumere un atteggiamento critico e consapevole svi-
luppando la capacità dialogica di confonto con l’altro da sé. Sono state privilegiate tut-
te quelle metodologie che hanno favorito la ricerca ed il confronto.
3) Mezzi: (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature,tecnologie audiovi-
sive e/o multimediali, ecc. ) libro di testo , attrezzature audiovisive.
4) Spazi: (Laboratori,biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre, …)
5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: (Prove scritte, verifiche orali, prove
strutturate, prove grafiche, prove pratiche, ….)
Un primo indicatore dei risultati conseguiti è stato acquisito dal grado di interesse e parte-
cipazione della classe; successivamente , le verifiche sono state attuate attraverso i collo-
qui o la libera espressione accertando ,così, le conoscenze essenziali dei contenuti della
Religione cattolica, la capacità di riferimento alle fonti bibliche e la capacità di rielaborazio-
ne e di critica personale.
6) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove
e delle verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie:
Trattazione sintetica di argomenti
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Sviluppo di progetti
…………………………..
Torre Annunziata 07 Maggio 2018 Firma del docente
Michele Lanese

15
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. Annamaria Raiola
Classe V E In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE:
Gli allievi, in generale, conoscono:
lo sviluppo dei fenomeni letterari dal periodo romantico al Neorealismo; i caratteri generali dei testi letterari; la terminologia specifica dei vari testi letterari e critici; gli elementi linguistici, morfologici, lessicali, sintattici presenti in un qualsiasi brano,
letterario e non; la biografia, il pensiero, il contenuto e il significato delle opere maggiori degli autori più
rappresentativi delle varie fasi letterarie (v. contenuti svolti); i contesti storico-sociali entro cui si colloca ciascuna produzione letteraria.
COMPETENZE:
Gli allievi complessivamente sono in grado di:
individuare i caratteri specifici di un testo letterario; interpretare i testi letterari in maniera personale, fornendone letture diverse e motivate; analizzare vari e complessi generi letterari tramite una lettura diretta dei testi, servendosi dei me-
todi e degli strumenti fondamentali per l'interpretazione delle opere letterarie; riferire i concetti in forme linguistiche appropriate, sia in relazioni scritte, sia con esposizioni
orali; commentare qualsiasi tipo di produzione artistica e letteraria, partendo dall'analisi del
testo; adoperare un linguaggio consono alla complessità degli argomenti da trattare; produrre testi scritti di vario tipo (in particolare quest’anno hanno prodotto articoli,
relazioni, saggi), rispondenti a diverse funzioni.
CAPACITÀ
Complessivamente gli alunni
sono autonomi nell’acquisire le conoscenze; sanno orientarsi nel panorama culturale (storico, artistico, letterario) operando confronti
interdisciplinari; sanno analizzare qualsiasi aspetto culturale e non; sono in grado di concettualizzare le informazioni; sanno operare collegamenti tra fenomeni, concetti, discipline, sia a livello sincronico,
sia a livello diacronico; sanno ricavare sintesi, anche grafiche, attraverso momenti intuitivi o percorsi ragionati.
Materia: ITALIANO a.s. 2017/18

16
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione:
Unità didattiche, moduli, percorsi formativi ed eventuali approfondi-
menti
periodo
Modulo 1 – Ragione e cuore nell’eroe romantico U.D.I:Caratteri e temi del Romanticismo
U.D.II:Manzoni:la vita e l’ideologia manzoniana
Romanzo storico:I Promessi Sposi:Trama generale del romanzo e analisi dei personaggi principali.
U.DIII:Dualismo Natura-Ragione in Leopardi
La noia Dai Canti: L’Infinito. A Silvia Il sabato del villaggio. Canto
notturno di un Pastore errante dell’Asia.
Dallo Zibaldone:la natura e la civiltà La teoria del piacere Il vago,l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza
Il giardino della sofferenza Dalle Operette morali:Dialogo della Natura e di un Islandese La Ginestra(vv1-51-vv158-201-vv237-317)
Settembre otto-bre novembre dicembre
I Trimestre
Modulo 2 – Tipologie di scritture U.D. 1 – Il saggio breve U.D. 2 – L’articolo di giornale U.D. 3 – L’analisi testuale
Intero Anno
Modulo 3 – Lectura Dantis:Il Paradiso
UD1 Introduzione allo studio della seconda cantica U.D. 2 – CantoI U.D. 3 – CantoIII UD.4 –CantoVI U:D.5-Canto XI U.D.6 –Canto XII U.D 7 Canto XV U.D.8 CantoXVII U.D..9 CantoXXXIII
Intero anno
Modulo 4 – La rappresentazione del “reale” nella cultura dell’Italia po-stunitaria U.D. 1 – Quadro storico-culturale del periodo post-uni- tario La Scapigliatura:caratteri e temi U.D.2:L’analisi “scientifica” della realtà nel Naturalismo Francese:Realismo e Naturalismo Il discorso indiretto libero
Dicembre Gennaio
I e Trimestre e II Trime-stre

17
Emile Zola:da Thérese Raquin: La Prefazione.Lettera- tura e scienza. La Prefazione di Rougon-Macquart:ereditarietà e determi- nismo ambientale U.D3:L’illusione della realtà nella narrativa verista. La poetica del Verismo italiano. La tecnica narrativa di Verga. Raffronto tra Verismo e Naturalismo. Giovanni Verga: Da Vita dei campi:Rosso Malpelo. Il passaggio dal post romanticismo al Verismo. La tecnica dello straniamento. “L’eclisse”dell’autore e la”regressione”. Dai Malavoglia:I Malavoglia e la comunità del Villaggio:valori ideali e interesse economico. L’addio di Ntoni. Il progetto dei Vinti:lotta per la vita e darwinismo Sociale. I<<vinti>> e la<<fiumana del progresso>>. Da Novelle rusticane:la Roba. Da Mastro don Gesualdo:La morte di Mastro don
Gesualdo Lo straniamento rovesciato. La <<religione della roba>>
Modulo 5 – La crisi dell’uomo contemporaneo U.D. 1 – La figura del poeta nel Decadentismo
Baudelaire:l’Albatros- Corrispondenze.
Pascoli:il fanciullino
U.D. 2 – La sensibilità Decadente di D’Annunzio Da<<Il piacere>>:Andrea Sperelli Da<<Le vergini rocce>>:il programma politico del Superuomo Netzsche:Da<<Così parlò Zarathustra>>”Il verbo di
Zarathustra” La pioggia nel pineto. U.D. 3 – Il simbolismo decadente:Pascoli Da<<Myricae>>:Novembre L’assiuolo X Agosto Dai<<Canti di Castelvecchio>>:Il gelsomino notturno U.D. 4 – Italo Svevo
Da<<una vita>>:Le ali del Gabbiano
Da<<Senilità>>:Il ritratto dell’inetto
Gennaio / Febbraio Marzo
III Trimestre

18
Da<<La coscienza di Zeno>>:Lo schiaffo del padre
U.D. 5 – Pirandello Da<L’umorismo>>:L’arte epica<<compone>> Quella umoristica<<scompone>> Dalle<<Novelle per un anno>>:Il treno ha fischiato Dal<<Il fu Mattia Pascal><:La costruzione della nuova identità e la sua crisi. Modulo 6 – Fra le due guerre: la dimensione della coscien-
za, la solitudine la lacerazione dell’io.(Corso inten-sivo)
U.D. 1:G.Ungaretti Da L’Allegria:Veglia I fiumi San Martino del Carso Soldati Da: Il dolore:Tutto ho perduto U.D. 2 –E. Montale Da Ossi di seppia:Meriggiare pallido e assorto Spesso il male di vivere ho incontrato Non chiederci la parola Da “Le occasioni”:La casa dei doganieri U.D.3:U. Saba: A mia moglie La capra
Aprile IIITrimestre
Modulo 7 – La rappresentazione del “reale” nella cultura del Secon-do’900 U.D. 1 – Caratteri generali del Neorealismo
U.D 2- Elio Vittorini <<Da Conversazioni in Sicilia>>:Gli <<astratti furo-
ri>>e <<il mondo offeso>> Da “uomini e no”:L’offesa all’uomo U.D. 3 –Cesare Pavese Da<<La casa in collina>>:”Ogni guerra è una guerra é una guerra civile” Da<<La luna e i falò>>:”Il falò della Gaminella” U.D. 4 – Elsa Morante: La Storia ( lettura dell’intero roman-
zo).
Maggio III Trimestre

19
Metodi: Nello svolgere l’attività didattica non mi sono limitata alla classica e scontata lezione frontale, né ho preteso all’orale la pura e semplice esposizione mnemonica degli argomenti storico-letterari, ma ho sollecitato gli allievi a sperimentare in prima persona le proprie attitudini e capacità, facendo ampio ricorso alla metodologia della ricerca e del problem solving (proposizione in termini problematici di questioni cui gli alunni stessi, opportunamente sollecitati – spesso attraverso la tecnica del brain
storming –, dovevano dare risposte-soluzioni valide e motivate). Lo studio della letteratura è stato affrontato dando particolare rilievo alla conoscenza diretta dei testi, scelti tra quelli più rappresentativi del patrimonio letterario appartenenti a generi ed opere diverse per contenuto e per forma. Sono stati sottolineati, ove possibile e necessario, anche i rapporti con le altre letterature coeve e con ulteriori e diverse manifestazioni artistiche o del pensiero umano, secondo una im-postazione interdisciplinare dell’intervento didattico. Ho cercato di arricchire il lessico usato dagli alunni stimolandoli a riflettere sull'etimologia di particolari termini tecnici (specie quelli derivati dal latino e dal greco) e fornendo loro le in-formazioni necessarie sulla formazione delle parole, così che possano sentirsi più sicuri sia nel comprendere che nell'adoperare essi stessi terminologie più complesse. Mezzi: Libri di testo, fotocopie di altri testi distribuite per approfondimenti, appunti, mappe concettuali. Spazi: Aula. Criteri e strumenti di valutazione adottati: Al termine di ciascun segmento didattico sono state effettuate delle verifiche sia scritte che orali. L’accertamento orale è avvenuto non solo attraverso vere e proprie interrogazioni, ma anche ricor-rendo a momenti di colloquio e di dialogo che hanno consentito di volta in volta più immediati ri-scontri sulle fasi, i ritmi e le modalità di apprendimento degli allievi. Allo scritto si sono utilizzati tipi di prove molto vari, a volte anche in esercitazioni domestiche: la relazione, il commento, la sintesi, il saggio, la recensione. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie: - analisi testuali - saggi Torre Annunziata, 07/05/2018 Firma della Docente Annamaria Raiola

20
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. Annamaria Raiola
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: CONOSCENZE:
Gli allievi, in generale, conoscono:
gli autori, gli aspetti storico-letterari e i contesti culturali della letteratura latina dal periodo giulio-claudio a quello cristiano (v. contenuti svolti);
i caratteri generali di un testo letterario latino, i metodi e gli strumenti utili e necessari all’inter-pretazione dei testi letterari;
la terminologia specifica dei testi di critica; le strutture fondamentali della lingua latina e i principali elementi morfologici, lessicali,
sintattici presenti nei testi studiati. COMPETENZE
Gli allievi complessivamente sono in grado di:
organizzare un discorso orale in forma corretta, dimostrando adeguatezza di informazioni, organicità di argomentazione, autonomia nelle osservazioni, chiarezza nell’esposizione;
cogliere il messaggio culturale della letteratura latina e rapportarlo alle culture posteriori e a quella moderna.
in un testo latino, elaborare ipotesi di riconoscimento intuitivo dei significati delle parole sconosciute, fornendo una plausibile spiegazione dell’intuizione;
rendere correttamente in italiano le strutture sintattiche individuate nei testi latini; comprendere, tradurre e interpretare un testo latino. CAPACITÀ:
Complessivamente gli alunni
sono autonomi nell’acquisire le conoscenze; sanno orientarsi nel panorama culturale (storico, artistico, letterario) operando confronti
interdisciplinari; sanno analizzare qualsiasi aspetto culturale e non; sono in grado di concettualizzare le informazioni; sanno operare collegamenti tra fenomeni, concetti, discipline, sia a livello sincronico,
sia a livello diacronico; sanno ricavare sintesi, anche grafiche, attraverso momenti intuitivi o percorsi ragionati.
Materia: LATINO Classe: V E a.s. 2017/2018

21
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: Modulo 1 – Il quadro storico-culturale dell’età giulio-claudio
U.D. 1 – aspetti storico-culturali dell’età giulio-claudia U.D. 2 – Seneca Da “De tranquillitate animi:”La noia(II,6-16) Dalle “Epistulae:”: Il vero bene,una divinità che può albergare in ogni corpo umano” U.D.3 - Lucano U.D. 4 – Petronio Dal <<Satyricon>> : “Ecco Trimalcione”
(32-33) (Lettura in Italiano)
SettembreOtto-bre/novembre
I Trimestre
Modulo 2 – La ricerca della felicità in Lucrezio
U.D. 1 – Dal “De rerum natura”: U.D. 2 – La noia(Libro III vv.1054-1084) U.D. 3 – L’ostilità della natura(libro vv195-234) U.D. 4 – La peste di Atene(LibroVIvv.1264-1286)
Novembre Dicembre
I Trimestre
Modulo 3 – Il quadro storico-culturale della civiltà imperiale dall’età dei Flavi all’età dei Severi U.D. 1 – aspetti storico-culturali dell’età dei Flavi – La prosa:Quintiliano:”Il ruolo del pedagogo nel proces-
so formativo del fanciullo” (Institutio oratoria:I,1,8-9) Gli enciclopedisti:Plinio il Vecchio “La natura matrigna”(Naturalis historia VII,16,4-20)
(Lettura in Italiano) U.D.2 –Aspetti storico-culturali dell’età di Traiano: La biografia:Plinio il Giovane “L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio(Epistulae,VI,16,4-20) (Lettura in in italiano) La storia:Tacito U.D. 3: Aspetti storico-culturali dell’età di Adriano e degli Antonini Apuleio e le Metamorfosi.
Gennaio/ Feb-braio/marzo
II Trimestre
Modulo 4 – La storia:Tacito U.D. 1 – Dalla”Germania:”Origini dei Germani
Purezza della razza germanica
Importanza della donna fra i Germani
Marzo Aprile III Trimestre
Modulo 5 – L’età del Medio e basso Impero U.D. 1 – L’Apologetica del III secolo:Tertulliano
U.D. 2 – La Patristica:Sant’Agostino Da “Confessiones:”La ricerca di Dio come libera- zione dall’inquietudine”(I,1)
Maggio III Trimestre

22
Metodi: Nello svolgere l’attività didattica, non mi sono limitata alla classica e scontata lezione frontale, né ho preteso all’orale la pura e semplice esposizione mnemonica degli argomenti storico-letterari, ma ho sollecitato gli allievi a sperimentare in prima persona le proprie attitudini e capacità. Ho anche cercato di far scaturire la conoscenza delle strutture sintattiche, morfologiche, lessicali e semantiche della lingua latina dalla lettura diretta di testi classici adeguati alle effettive conoscenze degli allievi: ciascun testo è stato prima letto, compreso intuitivamente, poi scomposto, analizzato in ogni suo elemento morfologico, linguistico e strutturale, tradotto alla lettera ed infine rifinito e commentato anche alla luce di altri testi dello stesso tipo o sullo stesso argomento proposti in traduzione. Lo studio della letteratura è stato affrontato dando particolare rilievo alla conoscenza diretta dei te-sti, scelti tra quelli più rappresentativi del patrimonio letterario appartenenti a generi ed opere di-versi per contenuto e per forma. Mezzi: Libri di testo, fotocopie di altri testi distribuite per approfondimenti, appunti. Spazi: Aula Criteri e strumenti di valutazione adottati: Al termine di ciascun segmento didattico sono state effettuate delle verifiche sia scritte che orali. L’accertamento orale è avvenuto non solo attraverso vere e proprie interrogazioni, ma anche ricor-rendo a momenti di colloquio e di dialogo che hanno consentito di volta in volta più immediati ri-scontri sulle fasi, i ritmi e le modalità di apprendimento degli allievi. Allo scritto non si è rinunciato alla prova tradizionale, cioè la classica versione intesa come tradu-zione in italiano di un testo latino, ma quasi sempre la si è collegata al programma che si andava via via svolgendo, traendo i brani da opere degli autori che si stavano studiando, e si è sperimentata an-che una nuova forma di prova, fornendo agli allievi una traduzione “d’autore” del brano proposto e chiedendo loro di elaborarne una propria e più vicina al modello sintattico latino. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche effettuate Torre Annunziata, 07/05/2018 Firma della Docente Annamaria Raiola

23
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. Polimeno Domenico
Materia: Inglese Classe: 5a E a.s. 2017-18
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: CONOSCENZE:
Bisogna premettere che la classe 5a Eha frequentato le lezioni con sufficiente regolarità e la sua partecipazione al dialogo educativo è stata apprezzabile da parte di un ristretto gruppo di alunni,che ha profuso impegno adeguato alle sue capacità e complessivamente accettabile in un altro gruppo, il cui rendimento è stato a volte caratterizzato da una certa incostanza. Di conseguenza, la programmazione curricolare ha subito qualche rallentamentoanche se è stato dato spazio complessivamente adeguato alla trattazione di buonaparte degli aspet-ti del panorama letterario. Obiettivo dell’insegnamento della letteratura inglese è il pervenire ad una conoscenza esaustiva del panorama letterario della civiltà anglosassone, sviluppando nel contempo la competenza comunicativa, il riuscire cioè ad esporre i contenuti acquisiti in lingua straniera con adeguata proprietà di linguaggio. Considerando queste premesse, si può affermare che alcuni discenti sono pervenuti ad una conoscenza sicuramente soddisfacente e adeguata del panorama letterario e dello sfondo sociale, politico e storico dei periodi letterari. Tale conoscenza risulta priva in altri alunni, di un’adeguata capacità di rielaborazione per-sonale dei contenuti. Una parte della classe è pervenuta all’acquisizione dei punti essen-ziali del programma mentre solo un piccolo gruppo è stato capace di operare gli opportuni approfondimenti sì da poter attuare raccordi interdisciplinari più esaurienti.
COMPETENZE
La competenza comunicativa, obiettivo primario dell’insegnamento della lingua e letteratu-ra inglese, è stata conseguita in maniera non omogenea. Attuando una classica ripartizione in tre fasce della classe, si può affermare che un nume-ro non elevato di alunni ha oramai acquisito sicura padronanza nell’espressione in lingua straniera. Le scelte linguistiche adottate da questo gruppo di discenti rivelano eccellente attitudine verso la lingua straniera, attitudine corroborata da interessi extrascolastici che hanno loro permesso di potenziare e affinare la competenza comunicativa. La loro esposizione in lingua risulta, pertanto, scorrevole e quasi sempre priva di quelle in-certezze e dipendenze dalla lingua madre che spesso caratterizzano le esposizioni in lin-gua straniera. Un altro gruppo è pervenuto ad un’espressione quasi soddisfacente ma non esente da im-perfezioni di pronuncia e da incuria per l’aspetto grammaticale. Si tratta di alunni in genere molto volenterosi, che sono riusciti gradualmente a discostarsi da un modo di esporre preminentemente mnemonico e capaci di andare al di là di una trattazione meramente superficiale degli argomenti. Il terzo grupponon ha evidenziato marcata attitudine verso la disciplina: il grado di compe-tenza comunicativa raggiunto risulta nel complesso accettabile. Se da un lato bisogna rile-

24
vare un’esposizione mnemonica e spesso non corretta dal punto di vista grammaticale e della pronuncia, va d’altro canto sottolineato il fatto che questi discenti non sempre hanno profuso tutto l’impegno possibile cercando di sfruttare al massimo le loro capacità. CAPACITA’
L’insegnamento della letteratura straniera mira a instillare nei discenti le capacità di anali-si, sintesi, di giudizio personale, di organizzazione dei contenuti e di riuscire a procedere ad opportuni raffronti interdisciplinari. Per quanto già esposto, sembra ovvio che tali capacità siano state conseguite in maniera non sempre omogenea. In generale, non manca nei discenti la capacità di saper sintetizzare un contenuto e di analizzarlo in maniera, se non personale, almeno differente dalla spiegazione del testo. Le difficoltà maggiori derivano dal doversi esprimere in lingua straniera e da un’eccessiva fe-deltà a quanto esposto dal manuale e dai testi consultati. Se ne deduce che non tutti gli alunni possono essere considerati in possesso di queste capacità: il gruppo trainante è oramai in grado di procedere autonomamente, rielaborando criticamente i contenuti e fornendo le opportune valutazioni e gli adeguati raccordi interdi-sciplinari. La maggioranza è pervenuta all’acquisizione delle capacità di sintesi, riuscendo solo in al-cuni casi a fornire interpretazioni personali. Il terzo gruppo possiede in misura inferiore tali capacità, avendo basato il proprio metodo di studio su un approccio mnemonico e alquanto superficiale.

25
1) Contenuti disciplinari
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
Il Romanticismo
W. Wordsworth: temi e opere. Analisi dei seguenti brani: “The solitary reaper”, “Lines writ-ten a few miles above Tintern Abbey”, “A Certain Colouring of Imagination”, “Our Birth is but a Sleep”, “Genesis of the Lyrical Ballads”, “Daffodils”
P.B. Shelley. temi e opere. Analisi di “Ode to the West Wind” (1st, 4th, 5th stanzas)
S.T. Coleridge: temi e opere. Analisi di alcuni passi tratti da “The Rime of the Ancient Ma-
riner” (Part 1 & 7)
J. Keats: temi e opere. Analisi di “Ode on a Grecian Urn”
The Victorian Age: features and themes: Chartism; Second and Third Reform Bills; Labour
Party; Social achievements; Social problems; Religious and ethical changes;
C. Dickens: temi e opere. Analisi di “Lunch Time” da “Oliver Twist”
T. Hardy: temi e opere. . Visione del film “Tess”
A. Tennyson. Analisi di “Ulysses”
O. Wilde: temi e opere. Analisi della “Preface” tratta da “The Picture of Dorian Gray”
Modernism
J. Joyce: temi e opere. Analisi di “I think he died for me” (“Dubliners”) e “Mr Bloom’s train
of thought” (“Ulysses”)
D.H. Lawrence: temi e opere. Analisi del brano “Tevershall”
G. Orwell: temi e opere. Visione del film “1984”
S. Beckett: temi e opere.

26
2) Metodi: (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recu-
pero, sostegno e integrazione, ecc.)
La metodologia si è sviluppata utilizzando la lezione frontale e cercando sempre di stimo-lare i discenti ad una partecipazione più attiva alle varie problematiche emerse. Si è quasi sempre cercato di partire dal brano di un autore per ricavarne, attraverso le tecniche dell’analisi guidata e dell’approccio linguistico, le principali tematiche. Solo in un secondo momento si è fatto ricorso al manuale per ulteriori approfondimenti sul-la produzione e sulla tematica dell’autore e del periodo. 3) Mezzi: (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature,tecnologie audiovisive
e/o multimediali)
Le lezioni sono state principalmente incentrate sul testo adottato e su nutriti gruppi di foto-copie che integravano le notizie ricavate dal manuale. La classe ha anche assistito alla proiezione in lingua originale dei seguenti film concenenti tematiche del programma: “Tess”, “1984”. 4) Spazi: (Laboratori,biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre, …)
Come già esposto in precedenza, il Liceo Pitagora non dispone, al momento, di un labora-torio linguistico né di una biblioteca adeguatamente fornita. Non sono stati effettuati stage o viaggi specificamente attinenti la lingua straniera, anche se le “eccellenze” della classe hanno potuto usufruire di un viaggio a Strasburgo. Alcuni alunni hanno anche partecipato a concorsi in lingua inglese ottenendo anche dei riconoscimenti (Olimpiadi della Filoso-fia).Un nutrito gruppo di discenti ha acquisito nel corso del passato anno scolasticola certi-ficazione B2 Cambridge.
5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: (Prove scritte, verifiche orali, prove
strutturate, prove grafiche, prove pratiche)
È stato effettuato un numero congruo di verifiche scritte oltre ad alcune esercitazioni di ve-rifica delle conoscenze. Tali prove sono state incentrate su una particolare tipologia, sì da abituare i discenti alla terza prova del prossimo esame di stato. Sono state, pertanto, somministrate agli alunni prove aventi per oggetto argomenti di letteratura con quesiti a ri-sposta singola con breve trattazione (Tipologia B). Le verifiche orali sono state di solito ef-fettuate alla fine di 1-2 unità didattiche e in numero congruo. Si è quasi sempre partiti dall’analisi testuale con commento ed analisi linguistica del brano proposto per poi passa-re a discutere dell’autore in maniera più generale. 6) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie: xTrattazione sintetica di argomenti x Quesiti a risposta singola □ Quesiti a risposta multipla □ Problemi a soluzione rapida □ Sviluppo di progetti □ Analisi del testo Torre Annunziata, 07-05-2018 Firma del Docente Prof.Domenico Polimeno

27
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. PICCININO NICOLA
Materia : STORIA Classe : 5 E scientifico a.s. 2017-2018
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Lo svolgimento e l’organizzazione del lavoro scolastico si sono svolti senza problemi particolari da rile-
vare , secondo uno spirito complessivamente collaborativo , nonostante la presenza di gruppi diversi
corrispondenti a diverse proposte organizzative del lavoro programmato.
Tutti gli allievi si sono impegnati secondo le proprie capacità e possibilità; nel complesso si può dire che
le conoscenze minime di base programmate siano state acquisite da tutti i componenti della classe.
COMPETENZE:
La classe, pur se a livelli diversificati, è competente nell’utilizzo di materiali informativi, di tabelle,
schede, carte geopolitiche, ecc; gli allievi sono in grado di ricostruire i contesti temporali con corret-
tezza e citando le opportune fonti informative e documentarie.
CAPACITÁ: Gli allievi, pur se a livelli differenziati, sono riusciti ad individuare elementi di continuità e di disconti-nuità nei processi storici, hanno saputo selezionare per categorie i dati informativi, cogliere le specifi-cità concettuali di date epoche storiche, individuare le premesse teoriche su cui sono state costruite analisi storiografiche.
1) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi tematici
Testo in adozione: DE LUNA MERIGGI, I segni della storia , Paravia
Periodo/ore
1° modulo: L’EUROPA NELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO Sett-ott.
1 U.D. Seconda rivoluzione economica e Grande depressione ( La belle époque; la se-
conda rivoluzione industriale e la teoria ciclica del capitalismo; Petrolio ed elettricità;
la concentrazione industriale)
2 U.D. Imperialismo e Colonialismo ( L’Imperialismo nelle sue diverse forme; il dibatti-
to sulle cause dell’Imperialismo – economiche e politiche; percorso di fonti e di docu-

28
menti storiografici).
2° modulo: L’ETA’ GIOLITTIANA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE Ott-dic
1.U.D. L’Italia giolittiana (la strategia politica di Giolitti; la collaborazione politica con i
socialisti riformisti; la crescita industriale; il sistema giolittiano; la guerra di Libia; la
riforma elettorale ed il patto Gentiloni; ragioni del crollo del sistema giolittiano).
2.U.D. La prima guerra mondiale (le origini del conflitto; la politica di potenza della
Germania; la polveriera balcanica; la dinamica militare del conflitto; la guerra di trin-
cea; la guerra totale; l’intervento americano; la fine del conflitto. L’Italia in guerra: il
problema dell’intervento; la questione della neutralità e gli interventisti; il patto di
Londra; le operazioni militari; la disfatta di Caporetto; l’ultimo anno di guerra.)
3.U.D. La rivoluzione russa (la Russia prerivoluzionaria; la rivoluzione del febbraio
1917; Lenin e le tesi di aprile; la rivoluzione d’ottobre; dall’assemblea costituente alla
guerra civile; il comunismo di guerra; la NEP; lo stalinismo; l’industrializzazione; la li-
quidazione dei kulaki; la collettivizzazione delle campagne; i gulag)
3° modulo: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI Dic- Mar
1. U.D. Crisi del Liberalismo e avvento dei fascismi. La crisi economica del 1929.
(Il Fascismo in Italia; le delusioni postbelliche e la questione di Fiume; la situazio-
ne economico-sociale; l’occupazione delle fabbriche; l’ultimo governo Giolitti; la na-
scita dei Fasci di combattimento; lo squadrismo; la marcia su Roma; il delitto Mat-
teotti; la distruzione dello stato liberale; la politica economica del Fascismo; la co-
struzione dello stato totalitario). Il Nazionalsocialismo in Germania (la situazione
postbellica; Hitler e la NSDAP; la presa del potere; la questione razziale; la co-
struzione del regime).
2. U.D.la seconda guerra mondiale. L’annientamento pianificato. (Le origini del
conflitto; la politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936; la conquista italiana
dell’Etiopia; la guerra civile spagnola; il patto di non aggressione russo-
tedesco; la guerra lampo in Polonia; l’intervento sovietico; la guerra in Occi-
dente nel 1940; l’attacco tedesco all’URSS; l’allargamento del conflitto nel
1941; l’entrata in guerra del Giappone; la fine della guerra in Europa e in Asia;
la questione della shoah).
L’Italia nella seconda guerra mondiale: la non belligeranza; l’intervento; la
guerra parallela; le sconfitte del 1942-43; il fronte interno e lo sbarco

29
degli Alleati; l’armistizio; la RSI; la svolta di Salerno; la Resistenza; la fi-
ne della guerra in Italia).
3. U.D. Le conseguenze della seconda guerra mondiale e la nascita della Repubbli-
ca italiana.
Aprile
4° Modulo: Il mondo del dopoguerra Maggio
1. U.D. L’immediato dopoguerra
La guerra fredda
Il miracolo economico in Italia
Il Sessantotto
2) Metodi: Lezione frontale, lezione “partecipata”, gruppi di lavoro (per analisi della documenta-
zione storica).
3) Mezzi: testo in adozione, fotocopie, schede sintetiche riassuntive, audiovisivi, materiale tratto
da internet.
5) Spazi: classe.
5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: Prove scritte (test secondo le indicazioni del
nuovo esame di stato), verifiche orali.
6) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifi-
che effettuate secondo le seguenti tipologie:
Quesiti a risposta singola
Torre Annunziata, 07/05/2018 Firma del docente
Nicola Piccinino
X

30
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof. PICCININO NICOLA
Materia : FILOSOFIA Classe : 5 E scientifico a.s. 2017-2018
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Lo svolgimento e l’organizzazione del lavoro scolastico si sono svolti senza problemi particolari da rile-
vare , secondo uno spirito complessivamente collaborativo , nonostante la presenza di gruppi diversi
corrispondenti a diverse proposte organizzative del lavoro programmato.
Tutti gli allievi si sono impegnati secondo le proprie capacità e possibilità; nel complesso si può dire che
le conoscenze minime di base programmate siano state acquisite da tutti i componenti della classe.
COMPETENZE:
Il gruppo degli allievi più capaci è competente nell’utilizzo di materiali informativi, di testi, di percorsi
concettuali ecc; riescono a contestualizzare l’autore nel loro tempo, a costruire contesti culturali con
correttezza , citando le opportune fonti informative e documentarie. Il gruppo di allievi che ha fatto
registrare incertezze nella preparazione complessiva ha evidenziato qualche difficoltà nell’uso dei ma-
teriali concettuali, nella lettura dei brani antologici, nonché nell’estrapolazione di dati necessari alla co-
struzione dei contesti teorici dei periodi culturali, ma ha dimostrato ugualmente di aver raggiunto le
competenze minime richieste.
CAPACITÁ:
Il gruppo di allievi più capaci è riuscito ad individuare elementi di continuità e di discontinuità nei di-battiti filosofici, ha saputo selezionare per categorie i dati informativi, ha saputo cogliere le specifici-tà concettuali delle scuole e delle tendenze, ha saputo individuare le premesse teoriche su cui sono sta-te costruite analisi. Per gli altri le capacità di discussione, di indagine, di analisi dei temi filosofici si so-no attestate ad un livello sufficientemente soddisfacente.

31
1) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi tematici
(Testo in adozione: Abbagnano-Fornero, PERCORSI DI FILOSOFIA 3 VOLUME 3 A E VOLUME 3 B , Paravia)
Periodo
1. U.D. Problemi del kantismo , postkantiani e la soluzione dell’Idealismo.
- Fichte: l’infinità dell’Io; la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la scelta
tra idealismo e dogmatismo (con percorso antologico in fotocopia)
- Schelling: la critica a Fichte; la soluzione dell’Assoluto indifferenziato; la teoria
dell’arte.
Sett-Ott.
2. U.D. Hegel : i capisaldi del sistema; finito e infinito; ragione e realtà; la fun-
zione della filosofia e il problema del giustificazionismo; le partizioni del si-
stema; la dialettica; la Fenomenologia (Coscienza e Autocoscienza; la coscienza
infelice); lo spirito oggettivo e sua articolazione; lo spirito assoluto e sua arti-
colazione. (con percorso antologico in fotocopia)
Nov/dic.
4. U.D. La sinistra hegeliana
- Feuerbach: il rovesciamento della filosofia speculativa; l’origine umana delle reli-
gioni; un nuovo umanesimo
- Marx: la critica al misticismo logico di Hegel; il distacco da Feuerbach; la critica
dell’economia borghese e il concetto di ideologia; struttura-sovrastruttura; la dia-
lettica della storia; il Manifesto ; il Capitale: il problema della rivoluzione del pro-
letariato (con percorso antologico sul Manifesto )
Genn.
5. La critica della Grande Narrazione e nuove prospettive critiche (Trattazione
monografica dei seguenti autori: Schopenhauer; Kierkegaard; il Positivismo
come tentativo di restaurazione della Grande Narrazione).
- Schopenhauer: radici culturali del sistema e rapporti col kantismo; il mondo
come volontà e rappresentazione; la scoperta della via d’accesso alla cosa in
sé; il pessimismo; le vie di liberazione dal dolore. (con percorso antologico in
fotocopia)
- Kierkegaard: l’esistenza come possibilità; il singolo e l’antihegelismo; dialettica
qualitativa; i tre stadi dell’esistenza; angoscia e disperazione. (con percorso
antologico in fotocopia)
- Positivismo: caratteri generali del movimento e la teoria dei tre stadi di Com-
te.
Febb/marzo

32
6. Nietzsche
Filosofia e malattia; caratteristiche del pensiero e della scrittura di N.; il periodo
giovanile: tragedia e storia; il periodo illuministico; il periodo di Zarathustra;
l’ultimo N.: la volontà di potenza ed il prospettivismo. (con percorso antologico in
fotocopia)
Marzo/aprile
7. Freud
Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi; l’inconscio e i modi per accedervi; i sogni e
gli atti mancati; la teoria della sessualità e il complesso edipico; le topiche; i pro-
blemi della civiltà.
( lettura ed analisi di una sintesi in fotocopia delle Cinque conferenze sulla psicoa-
nalisi).
Aprile
8. U.D. Tendenze del 900: L’esistenzialismo
- L’Esistenzialismo: caratteri generali della corrente e principi fondativi.
Maggio
9. Percorso tematico: la filosofia al femminile (percorso tematico n. 5 dal testo:
Itinerari di filosofia: Verso una liberazione delle differenze: femminismo e fi-
losofia)
- S. de Beauvoir: Il secondo sesso
- L. Irigaray : dall’eguaglianza alla differenza .
- Differenza sessuale, affidamento tra donne ed etica della cura nel Femmini-
smo di seconda generazione
- C. Lonzi : Sputiamo su Hegel.
Marzo
2) Metodi: Lezione frontale, lezione “partecipata”, gruppi di lavoro.
3) Mezzi: testo in adozione fotocopie, schede sintetiche riassuntive, audiovisivi, quotidiani, mate-
riali tratti da internet.
6) Spazi: classe.
7) Criteri e strumenti di valutazione adottati: Prove scritte (test secondo le indicazioni del
nuovo esame di stato), verifiche orali.
8) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle ve-
rifiche effettuate secondo le seguenti tipologie:
Quesiti a risposta singola
Torre Annunziata 07/05/2018 Firma del docente
Nicola Piccinino
X X

33
FINALE DEL DOCENTE
Prof.ssa Felicia Wilma Fenda
Materia: Matematica Classe: 5^ sez. E a.s. 2017/2018
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Gli alunni devono conoscere: - concetto di funzione; - significato di limite di una funzione; - concetto di continuità e discontinuità di una funzione; - concetto di derivata di una funzione; - concetto di integrale; - concetto di equazione differenziale. La 5^E è una classe che si è rivelata eterogenea per la diversificazione dei temperamenti, per la personalità dei singoli allievi, per la varietà di risposte che ha offerto alle diverse stimolazioni cul-turali ed educative. La classe è costituita da alcuni alunni sempre pronti ad intervenire durante la le-zione e che si distinguono per le buone capacità e per l’impegno costante nello studio con un grado di preparazione nel complesso buono. Tra questi spiccano pochi elementi, che, grazie a capacità cri-tiche, analitiche e sintetiche hanno conseguito una preparazione ottima, con spunti critici e persona-li. Un altro gruppo ha mostrato buona volontà ed ha cercato di colmare le lacune e di superare le difficoltà espositive, pervenendo a risultati complessivamente accettabili; infine, vi sono anche ele-menti che hanno raggiunto un grado di preparazione non del tutto sufficiente. COMPETENZE
Agli allievi è stato richiesto di: - comprendere il significato degli elementi fondamentali dell’analisi; - fare classificazioni; - usare correttamente metodi e procedimenti; - adoperare un linguaggio appropriato; - acquisire un metodo di studio. Solo una parte della classe ha acquisito maturità e capacità critica, si esprime con un linguaggio ri-goroso, utilizzando termini specifici. Nell’applicazione degli argomenti teorici trattati, alcuni rive-lano maturità logica e senso critico. Buona parte degli allievi sa discutere con consapevolezza gli argomenti trattati ed alcuni hanno aggiunto allo studio scolastico approfondimenti, con spunti critici e personali. CAPACITA’
Agli alunni è stato richiesto di: - sapersi orientare nella risoluzione di un problema; - collegare proprietà formali con l’espressione analitica e la rappresentazione grafica di una funzio-ne. La maggioranza della classe ha acquisito discrete capacità analitiche e sintetiche. E in alcuni alunni ho notato propensione alla riflessione ed al ragionamento, ma il dato senza dubbio più positivo è che essi hanno affrontato lo studio come scelta, arricchendolo con l’acquisizione di nozioni, stando, però, ben lontani dal cadere nell’arido nozionismo. Solo pochi alunni hanno evidenziato sino alla fine delle incertezze nell’applicazione degli argomenti teorici trattati.

34
1) Contenuti disciplinari
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
Funzioni esponenziali e logaritmiche equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche
Funzioni reali di una variabile reale Concetto di funzione reale di una variabile reale - Insieme di esistenza di una funzione - Grafico di una funzione - Funzioni pari e dispari - Funzioni monotone – Funzioni Inverse. Limiti delle funzioni di una variabile Intervalli - Intorni - Estremo inferiore e superiore di un insieme numerico -Punto di accumulazione di un insieme e punto isolato - Limiti delle funzioni reali di una variabile reale - Limite destro e li-mite sinistro di una funzione – Limite infinito e limite per una funzione all’infinito. Teoremi sui limiti Teorema unicità del limite (con dimostrazione) - Teorema del confronto – Teorema della perma-nenza del segno (con dimostrazione) - Operazioni sui limiti - Calcolo dei limiti relativi a funzioni
razionali ∞ fratte e irrazionali Limiti notevoli: dimostrazione di 1sin
lim0
x
x
x - Forme indeterminate
(0
0,
, -∞+∞, 00, 1∞,∞0 )

35
Funzioni continue Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo - Continuità delle funzioni elementa-ri - Punti di discontinuità di una funzione – Teorema di Weierstrass (s. d.) – Teorema dei valori in-termedi (s. d.) – Teorema di esistenza degli zeri (s. d.). Derivate Definizione di derivata – Significato geometrico e cinematico della derivata - Derivata sinistra e de-stra - Continuità e derivabilità - Derivata della funzione costante e della funzione potenza - Regole di derivazione della somma, del prodotto del quoziente di due funzioni, della potenza di una fun-zione, della funzione di funzione - Derivata del seno, del coseno, della tangente e della cotangente – Derivata della funzione logaritmo e della funzione esponenziale – Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche. Applicazioni delle derivate Equazione della tangente e della normale ad una curva – Applicazione delle derivate alla fisica – Derivate di ordine superiore. Differenziale di una funzione. Teoremi sulle derivate Teorema sulla derivabilità e continuità – Punti stazionari, angolosi e cuspidi - Teorema di Rolle (s.d.) -Teorema del valor medio o di Lagrange e i due corollari che da esso derivano (s.d.) - Teore-ma di Cauchy (s.d.) – Teorema di De l’Hospital (s. d.) Studio del grafico di una funzione Crescenza e decrescenza di una funzione - Determinazione degli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente - Massimi e minimi relativi Criterio per la ricerca dei massimi e minimi relativi con lo studio del segno della derivata prima - Massimi e minimi assoluti - Concavità di una curva e flessi – Asintoti verticali, orizzontali ed obli-qui.
Integrale indefinito Funzione primitiva - Definizione di integrale indefinito – Alcune proprietà degli integrali – Integrali immediati – Integrazione delle funzioni razionali fratte – Integrazione per parti – Integrazione per sostituzione.
Integrale definito Definizione di integrale definito e suo significato geometrico – Proprietà dell’integrale definito – Il teorema della media (con dimostrazione) – Definizione di funzione integrale - Il teorema fondamen-tale del calcolo integrale (con dimostrazione) – Formula di Leibnizt-Newton (con dimostrazione) - Calcolo dell’integrale definito utilizzando quello indefinito – Calcolo delle aree - Area della parte di piano delimitata da due curve –Lunghezza di un arco di curva e l’area di una superficie di rota-zione. Il calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.- Integrale improprio. Calcolo combinatorio e probabilità Fattoriale di un numero – Coefficiente Binomiale – Permutazione – Combinazioni e disposizioni – La concezione classica di probabilità – La probabilità della somma logica di eventi – La probabilità condizionata – La probabilità del prodotto logico di eventi – Il teorema di Bayes.
Cenni di equazioni differenziali Equazioni differenziali del primo ordine – Equazioni differenziali del tipo xfy ' - Equazioni dif-ferenziali a variabili separabili - Il problema di Cauchy – Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete. Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee.

36
2) Metodi: (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, soste-gno e integrazione, ecc.) Ho sviluppato i vari argomenti con le relative dimostrazioni e ho proposto agli allievi molti esercizi di analisi, disposti in ordine di difficoltà crescente, per far assimilare in maniera vera e profonda i vari argomenti trattati teoricamente. Gli alunni con frequenza hanno conferito su argomenti specifici, sui quali intessevano ampie discussioni con dovuti riferimenti. Per la maggioranza della classe, infat-ti, gli argomenti trattati hanno suscitato un così vivo interesse che le discussioni scaturite hanno mo-strato la maturità della classe e la sua buona recettività. Per agevolare gli alunni nel lavoro di eserci-tazione, nel quale trovano spesso difficoltà, si sono svolti continui esercizi durante le lezioni, affin-ché gli alunni potessero superare le difficoltà sotto la guida dell’insegnante. A partire dal 02/05/2017 è stato attivato il corso di potenziamento pomeridiano costituito da 10 ore di lezioni, rivolte alla risoluzione di problemi relativi all’esame di maturità. Una buona parte della classe mi ha manifestato interesse acquisendo più consapevolezza degli argomenti trattati, arricchen-dosi nell’interagire e rivelando almeno per alcuni, maturità logiche e senso critico. 3) Mezzi: (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc. ) E’ stato adoperato il libro di testo e, sia per favorire che per verificare l’apprendimento, sono stati largamente usati lavagna e gesso. 9) Spazi: (Laboratori, biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre, …) Aula 10) Criteri e strumenti di valutazione adottati: (Prove scritte, verifiche orali, prove strutturate, prove grafiche, prove pratiche, ….) Da un sereno dialogo, instaurato quotidianamente in classe, sono scaturiti elementi preziosi per la valutazione di ogni allievo; inoltre la continua verifica ha costituito uno stimolo costante ad ap-prendere. Sono state effettuate come prove scritte, due nel primo trimestre , due nel secondo e due nel terzo trimestre. Le verifiche orali sono state o a carattere monotematico, per accertarsi che un determinato argomento era stato ben assimilato, o a carattere più complesso, per verificare se la cre-scita delle conoscenze, capacità e competenze era stata globale. Le verifiche, sia quelle scritte che quelle orali, sono state valutate tenendo conto del grado di raggiungimento degli obiettivi. Per esprimere un giudizio di merito a fine di ogni trimestre si è tenuto conto: della partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno profuso; dell’uso corretto del linguaggio scientifico e delle capacità espressive e comunicative; delle conoscenze, capacità e competenze acquisite, verificate attraverso le prove. Torre Annunziata 07/05/2018 Firma del docente Prof.ssa Felicia Wilma Fenda

37
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof.ssa Felicia Wilma Fenda
Materia: Fisica Classe : 5^E A.S.: 2017/18
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE
Agli alunni è stato chiesto di conoscere: i fenomeni elettrostatici e la legge di Coulomb il concetto di campo elettrico, di potenziale e flusso il significato di corrente e resistenza elettrica il concetto di campo magnetico le relazioni tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico l’induzione elettromagnetica il campo elettromagnetico la relatività.
La programmazione e la realizzazione degli argomenti trattati in questa classe, ha tenuto conto del programma svolto lo scorso anno, di conseguenza sono stati svolti molti argomenti non affrontati l’anno precedente. Alla fine dell’anno scolastico la conoscenza della disciplina da parte degli alunni appare più che soddisfacente. Infatti, la classe è costituita da alcuni alunni che si sono mostrati sempre pronti ad in-tervenire durante le lezioni, si sono distinti per le buone capacità e per l’impegno costante nello stu-dio. I risultati raggiunti sono nel complesso buoni. Tra questi spiccano alcuni elementi che, grazie alle particolari capacità critiche, analitiche e sintetiche, hanno raggiunto una preparazione ottima, ricca di spunti critici e personali. Un altro gruppo, più esiguo, fornito di buona volontà, è riuscito con l’impegno a raggiungere risultati nel complesso sufficienti; infine, vi sono anche alunni che non hanno raggiunto un grado di preparazione sufficiente. COMPETENZE Agli allievi è stato richiesto di: - comprendere il significato dei fenomeni elettrici e magnetici fondamentali ; - saper cogliere analogie e differenze tra campo gravitazionale, elettrico e magnetico; - adoperare un linguaggio appropriato-acquisire un metodo di studio; Gli alunni hanno acquisito maturità e capacità critica. Si esprimono con un linguaggio consono, uti-lizzando termini specifici. La loro esposizione è ordinata e il discorso lineare rivelano maturità lo-gica e senso critico. Molti hanno aggiunto allo studio scolastico approfondimenti, con spunti critici e personali. CAPACITA’
Agli allievi è stato richiesto di: - sapersi orientare nella risoluzione di un problema; - saper utilizzare concetti, termini e teoremi nello studio dei fenomeni elettrici e magnetici. La maggioranza della classe ha acquisito discrete capacità analitiche e sintetiche. In alcuni alunni ho notato propensione alla riflessione ed al ragionamento; essi sono in grado di condurre un dialo-

38
go vivace e brillante, grazie alla buona padronanza dei mezzi espressivi e alla spiccata personaliz-zazione del bagaglio culturale. Solo pochi alunni hanno evidenziato qualche incertezza nell’esposizione degli argomenti trattati.
1) Contenuti disciplinari
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
Interazioni elettriche Elettrizzazione, interpretazione del fenomeno di elettrizzazione, elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione, legge di Coulomb, costante dielettrica, la polarizzazione. Campo elettrico
Descrizione del campo elettrico, campo elettrico dovuto a più cariche, linee di forza, flusso del campo elettrico e teorema di Gauss, la distribuzione delle cariche elettriche su un conduttore in equilibrio elettrostatico; gabbia di Faraday; campo elettrico generato da: una lastra metallica piana caricata positivamente, calcolo del campo elettrico di un condensatore piano. Il potenziale elettrico Campo elettrico conservativo, il lavoro di un campo elettrico uniforme, energia potenziale in un campo uniforme, energia potenziale generata da una carica puntiforme; potenziale elettrico, superfi-ci equipotenziali, potenziale di un conduttore sferico; circuitazione del campo elettrico. Capacità elettrica – condensatori Capacità elettrica di un conduttore, capacità elettrica di un conduttore sferico, condensatore, capaci-tà di un condensatore piano, condensatori in serie e in parallelo, energia immagazzinata nel conden-satore. Corrente continua La corrente elettrica, la funzione del generatore elettrico, circuito elettrico, intensità della corrente elettrica, la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, gli elettroni di conduzione, leggi di Ohm, re-sistenze in serie e in parallelo, i principi di Kirchhoff, reostato, energia elettrica, potenza elettrica, effetto Joule; la conduzione elettrica nelle soluzioni elettrolitiche, elettrolisi, dissociazione elettroli-tica, la neutralizzazione degli ioni nell’elettrolisi, generatori di f.e.m. (la pila di Volta). Campo magnetico Campo magnetico, campo magnetico uniforme, campo magnetico terrestre, linee di forza - Il vettore induzione magnetica Campo magnetico della corrente
Esperienza di Oersted, campo magnetico generato da un filo rettilineo (legge di Biot-Savart), o da un solenoide percorsi da corrente, interazione tra due fili rettilinei percorsi da corrente, flusso del cam-po di induzione magnetica, la circuitazione del campo magnetico, il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme, la forza magnetica sulle cariche in movimento (la forza di Lorentz). Campo magnetico nei materiali Sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche, il momento magnetico degli atomi. La polarizzazione dei materiali. Induzione elettromagnetica La corrente indotta – Esperienze di Faraday - Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz
Il campo elettromagnetico Le equazioni di Maxwell – Le onde elettromagnetiche – Proprietà delle onde elettromagnetiche-
La relatività dello spazio e del tempo Il principio di relatività – Le trasformazioni di Lorentz – La dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – La massa relativistica.

39
2) Metodi: (Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno e integrazione, ecc.)
Ho sviluppato i vari argomenti previsti dal programma ministeriale, soffermandomi, soprattutto, sui concetti, per far assimilare in maniera vera e profonda i vari argomenti trattati. In ogni lezione, prima di dare delle definizioni rigorose, sono sempre partita da esempi, da un’osservazione diretta della realtà utilizzando un metodo intuitivo - dinamico che coinvolgesse gli alunni e li facesse par-tecipare attivamente al dialogo educativo. Gli allievi sono anche stati guidati ed indirizzati ad un utile confronto di idee. Essi, per potersi esprimere in modo chiaro, rigoroso e sintetico, devono avere i concetti ben chiari. Per tale motivo, quando è stato necessario, alcuni argomenti sono stati ripresi, analizzati a fondo e approfonditi anche attraverso quesiti e problemi.
Gli alunni con frequenza hanno conferito su argomenti specifici, sui quali intessevano ampie discussioni con il coinvolgimento dell’intera classe. Per la maggioranza della classe gli argomenti trattati hanno suscitato un cosi vivo interesse che le discussioni scaturite hanno mostrato la maturità della classe e la sua buona recettività. 3) Mezzi: (Strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc. ) Libro di testo, materiale di laboratorio
4) Criteri e strumenti di valutazione adottati: (Prove scritte, verifiche orali, prove strutturate, prove grafiche, prove pratiche, ….)
Al termine di ciascun segmento didattico sono state effettuate delle verifiche orali e scritte. Nel valutare gli alunni si è tenuto conto della partecipazione all’attività didattica, dell’impegno profuso, del grado di apprendimento, delle abilità e competenze acquisite, dell’uso corretto del linguaggio scientifico, delle capacità espressive e comunicative.
Sono stati sempre considerati anche il livello di preparazione iniziale, lo sviluppo delle capacità logiche ed espositive, avvenuto durante l’anno e la maturità conseguita con l’impegno e lo studio assiduo. Gli alunni che mostravano ancora carenze e lacune nella preparazione sono stati oggetto di particolare cura e la verifica della loro assimilazione è stata più continua. A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie:
Torre Annunziata, 07/05/2018
Firma del docente
Felicia Wilma Fenda
Trattazione sintetica di argomenti
Quesiti a risposta singola x
Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Sviluppo di progetti

40
RELAZIONE FINALE DI SCIENZE
CLASSE 5^E - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
DOCENTE: MARINO AMALIA
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
CONOSCENZE: La classe evidenzia una discreta diversificazione nelle conoscenze, nel complesso dimostra: -di saper distinguere le più importanti classi di composti organici e le loro principali reazioni, -di saper individuare il ruolo delle biomolecole nei processi vitali e le loro connessioni; -di comprendere l’importanza dei processi metabolici, -di riconoscere il carattere dinamico delle conoscenze scientifiche ( Ogm,clonazione,cellule staminali,ecc.)in relazione al progredire delle metodologie e delle tecniche di indagine -di analizzare i modelli interpretativi nell’ambito delle Scienze della Terra, le manifestazioni della dinamica terrestre ed il loro legame di interdipendenza. COMPETENZE : La maggior parte degli alunni è in grado di cogliere gli aspetti fondamentali della disciplina ed organizzare le risposte in modo pertinente ed organico. Quasi tutti, inoltre, si esprimono con chiarezza e proprietà di linguaggio. CAPACITA’: Buona parte della classe è in grado di analizzare e sintetizzare gli argomenti in modo essenziale e semplice. Alcuni evidenziano coesione e coerenza delle argomentazioni, un linguaggio fluido ed originale e capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche.

41
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per:
Unità didattiche e/o moduli e/o percorsi formativi
ed eventuali approfondimenti Periodo/ore
Ibridazione del carbonio. Alcani, cicloalcani, concetto di saturazione. No-menclatura. Reazioni
Settembre
Alcheni, alchini, concetto di insaturazione. Isomeria strutturale, geometri-ca, conformazionale.
Ottobre
Benzene. Teoria della risonanza. Ottobre
Gruppi funzionali. Alcoli, fenoli ed eteri. Aldeidi e chetoni. Ottobre
Acidi carbossilici, esteri, ammine e ammidi. Novembre
Carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici. Dic. - Genn.
Respirazione cellulare e fotosintesi.
Febbraio
Metodi di analisi del DNA Cellule staminali. Clonazione e OGM Struttura interna della Terra Tettonica a zolle e deriva dei continenti
Aprile Maggio
Maggio
Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico 78 ore
2) Metodi: La metodologia didattica ha inteso favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abi-lità espressive , di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi degli allievi, uti-lizzando la lezione frontale. Questa è stata intesa non solo come discorso riguardante i vari argomenti trattati, ma anche come occasione per ampliare e presentare i conte-nuti in modo organizzato e funzionale, evidenziando le correlazioni logiche tra i di-versi argomenti e stimolando discussioni e confronto di opinioni diverse tra gli alun-ni. 3) Mezzi: Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, la consultazione di riviste specializ-zate di seria divulgazione scientifica, e sussidi audiovisivi (in particolare presentazio-ne in power point ) che hanno consentito di illustrare strutture e fenomeni particolar-mente complessi.

42
4) Spazi:
Gli spazi utilizzati sono stati prevalentemente l’aula che ospita la classe e l’ aula mul-timediale 5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: Per accertare le conoscenze del percorso modulare, sono state realizzate verifiche sia di tipo formativo alla fine di ogni unità didattica, sia di tipo sommativo alla fine di ogni modulo. Come esempi di prove oggettive, sono stati somministrati prevalentemente questio-nari o test a risposta singola. I criteri utilizzati hanno valutato: conoscenza dei conte-nuti, abilità di comprensione e di rielaborazione, utilizzo del linguaggio specifico del-la disciplina, interpretazione di grafici e tabelle. Hanno concorso alla valutazione an-che l’interesse, l’impegno e la partecipazione all’attività didattica, nonché la frequen-za alle lezioni ed il comportamento corretto e responsabile nei confronti degli altri. 6) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle
prove e delle verifiche effettuate secondo le seguenti tipologie: Trattazione sintetica di argomenti
Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla Problemi a soluzione rapida Torre Annunziata 07/05/2018 Firma del docente (Amalia Marino)
X
X

43
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE PROF.SSA IDA BUONOCUNTO
DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
a.s. 2017/2018 Classe V E
Presentazione sintetica
La classe V E dell’indirizzo scientifico è stata assegnata, per quanto riguarda l’insegnamento del Disegno e della storia dell’arte, alla prof.ssa Ida Buonocunto per il cor-rente anno scolastico.
Gli alunni sono stati coinvolti in un processo formativo finalizzato alla promozione di una consapevolezza del valore dell’arte come forma di comunicazione, come esperienza estetica, come patrimonio culturale e civile. Sono stati forniti loro gli strumenti per una for-mazione storico-artistica di base, nella convinzione che questo sia un fondamentale valore di cittadinanza.
La classe, piuttosto eterogenea in relazione al profitto, ha manifestato sin dall’inizio dell’anno scolastico, disponibilità ad arricchire le proprie conoscenze e le proprie abilità cri-tico-espositive. Pur conservando, nel corso dell’anno scolastico, un comportamento viva-ce, gli alunni, con le loro specificità, hanno raggiunto dei risultati soddisfacenti, alcuni di essi considerevoli.
In relazione alla programmazione gli allievi hanno raggiunto le seguenti mete cognitive così articolate:
Conoscenze riguardanti gli elementi essenziali dei fenomeni artistici analizzati e dell’opera degli artisti proposti;
Conoscenze relative ai contesti storici e socio-culturali in cui si collocano le forme d’arte analizzate;
Competenze linguistico-espressive (individuazione delle caratteristiche stilisti-che e formali di un’opera d’arte);
Capacità di muoversi con sensibilità e consapevolezza nell’ ambito dei beni culturali, partendo dalla realtà territoriale prossima.
I contenuti, prevalentemente di storia dell’arte, sono stati organizzati tenendo conto della interdisciplinarietà. Partendo dal fenomeno artistico, si è proceduto con l’analisi e la lettura di alcune opere degli artisti proposti, lette in relazione al loro poetica pittorica o scul-torea. Sono state svolte anche attività di approfondimento.

44
PROGRAMMA
Il Romanticismo
Caratteri generali – La poetica romantica nella pittura John Constable – “Studio di nuvole a cirro”, “Il carro del fieno” William Turner – “Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi”
– “Tramonto” Théodor Géricault – “La zattera di Medusa” Eugène Delacroix – “La Libertà che guida il popolo” Francesco Hayez – “Il bacio” – “Ritratto di Alessandro Manzoni
Il Realismo Caratteri generali
Il fenomeno dei Macchiaioli Aspetti generali della poetica del movimento: “La macchia in opposizione alla Forma” Giovanni Fattori – “La rotonda di Palmieri”, “Bovi al carro”
L’Impressionismo La poetica della luce e la cultura dell’attimo – Caratteri generali del movimento La fotografia Édouard Manet – “Colazione sull’erba”, “Olympia”: confronto con “La Venere di Urbino” di Tiziano Claude Monet – “Impressione: sole nascente”, “La Cattedrale di Rouen: il porta-le (al sole)” con approfondimenti, “Lo stagno delle ninfee”
Tendenze postimpressioniste Il Divisionismo - George Seurat – “Un dimanche après-midi à l’Ile de la Grande Jatte Vincent van Gogh – “I mangiatori di patate”, “Notte stellata”, “Cipressi”, “Campo di grano con volo di corvi”, “I girasoli”, “La chiesa di Auvers”
L’Art Nouveau Caratteri generali
Gustav Klimt – “Nudo disteso verso destra”, “Giuditta I”, “Giuditta II”, “Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”, “Danae”
I Fauves
Henri Matisse – “Donna con cappello”, “La gitana”, “La stanza rossa”, “La dan-za”
L’Espressionismo

45
Caratteri generali – Il gruppo Die Brucke
Edvard Munch – “La fanciulla malata”, “Notte a Saint-Cloud”, “Sera nel corso Karl Johann”, “L’urlo” con relativi approfondimenti, “Pubertà”
Le Avanguardie storiche
Il Cubismo
Caratteri generali – Il Cubismo analitico ed il Cubismo sintetico Pablo Picasso – “Poveri in riva al mare”, “Famiglia di saltimbanchi”, “Les de-moiselles d’Avignon” con approfondimenti, “Guernica” con approfondimenti
La stagione del Futurismo
Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista Umberto Boccioni – “La città che sale”, “Stati d’animo”, “Forme uniche della continuità nello spazio” Giacomo Balla – “Dinamismo di un cane al guinzaglio”
Il Dada
Caratteri generali Marcel Duchamp – “La Gioconda con i baffi”
Il Surrealismo
Caratteri generali Salvador Dalì – “Sogno causato dal volo di un’ape”, “Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia”
L’Astrattismo
Caratteri generali Piet Mondrian – Il tema dei Mulini e il tema dell’albero – “Il mulino Winkel al so-le”, “L’albero rosso”
La Metafisica
Caratteri generali De Chirico – “Le Muse inquietanti”
L’Architettura razionalista e l’architettura organica

46
Metodi e procedimenti adottati I movimenti artistici proposti, quasi sempre, sono stati presentati tracciando un affre-
sco del clima storico, politico, sociale e culturale dell’epoca, per dare la possibilità agli stu-denti di cogliere la interdisciplinarietà dell’argomento oggetto di studio, facendo così acco-stare la Storia dell’Arte alle altre discipline. SI è quindi partiti dal movimento per giungere alla personalità e alla poetica dell’artista, privilegiando la lettura di alcune sue opere attra-verso l’analisi formale, stilistica ed interpretativa dell’opera stessa. A volte sono state ac-costate e comparate opere dello stesso artista, di artisti della stessa epoca o di altre epo-che o di generi artistici differenti, sempre attraverso un approccio sistematico.
Per alcuni argomenti gli approfondimenti hanno definito il metodo attraverso letture iconologiche ed esempi concreti e buone pratiche di cura del Patrimonio.
Si è privilegiato il momento del confronto utilizzando la lezione frontale e la discussio-ne di gruppo per abituare gli studenti a comunicare il proprio punto di vista attraverso la lettura e l’interpretazione delle opere d’arte studiate. Infatti le verifiche, oltre che a vederli impegnati in discussioni orali, li ha visti impegnati in esercitazioni scritte di analisi e lettura di un testo iconografico. Nel corso dell’ultimo trimestre si è dato spazio al percorso CLIL così come da programma-zione condivisa, sviluppando un’attività di approfondimento il cui tema è “The Cubism: Pa-blo Picasso and his masterpiece Guernica. Mezzi
I manuali utilizzati sono stati Cricco, Di Teodoro – Itinerario nell’arte – Zanichelli e Ire-ne Baldriga – Dentro l’arte – Electa Scuola-Mondadori Education.
Sono stati utilizzati, inoltre, materiali audiovisivi, articoli di giornali e monografie tema-tiche per le attività di approfondimento, LIM. Spazi
Aula e visite guidate Criteri e strumenti di valutazione adottati CRITERI
Alla base della valutazione complessiva il riferimento è sempre stato l’alunno inteso come persona, con la sua individualità da considerare nella dinamica dello sviluppo della sua personalità, delle sue capacità, dell’impegno mostrato.
Gli elementi che hanno concorso alla formazione del voto sono stati: i livelli di parten-za, le conoscenze e competenze raggiunte, l’evoluzione dei processi di apprendimento, il metodo.
VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E DELLE ESERCITAZIONI SCRITTE Il voto è stato attribuito sulla base dei seguenti parametri:
- conoscenze: conoscenza specifica degli argomenti - capacità critico-espressiva (proprietà lessicale e chiarezza espositiva) - capacità critica e di sintesi (capacità di valutazione delle informazioni e di interpre-
tazione dei dati, di rielaborazione dei contenuti e di confronto) La griglia utilizzata è quella adottata dal Dipartimento.

47
Storia dell’arte Nulla
Gravemente
insufficiente Insufficiente Sufficiente Discreta Buona Ottima Voto
CONOSCENZA E
COMPLETEZZA DEI
CONTENUTI
1 2 2.5 3 3.5 4 5
PROPRIETA’ E
CHIAREZZA
ESPRESSIVA. USO
DEL LINGUAGGIO
SPECIFICO
0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
CAPACITA’CRITICA,
DI SINTESI E DI
APPROFONDIMENTO
0.5 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5
TOTALE
Torre Annunziata,07/Maggio/2018 Firma della Docente
Ida Buonocunto

48
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Prof.ssa Mastellone Tania
Materia: Ed. Fisica Classe: VE - a.s. 2017/18
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti obbiettivi in termini di:
CONOSCENZE: Conoscenze e pratica delle attività sportive. Informazioni fondamentali sulla Tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.
COMPETENZE: Padronanza del proprio corpo, ottenuta attraverso la ricerca di nuovi equilibri e sulla rielaborazione degli schemi motori precedentemente acquisiti. Conso-lidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso la pratica delle attività sportive
CAPACITÀ: Velocità e forza (tonicità muscolare generale). Mobilità articolare - Equilibrio – Destrezza – Agilità Miglioramento delle qualità fisiche di base ( respirazione, circolazione ).
. 1) Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione ( con riferimento ad un’eventuale durata o ca-
lendarizzazione quadrimestrale, trimestrale, bimestrale mensile o altro ) esposti per:
UNITÀ DIDATTICHE E/O MODULI E/O PERCORSI FORMATIVI ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI
PERIODO ORE
1) Modulo: miglioramento delle qualità fisiche. Sett-Ott a) Unità didattica: miglioramento della resistenza, velocità, tonicità muscolare, mobilità articolare.
b) Unità didattica: miglioramento delle funzioni cardio-respiratorie.
2) Modulo: affinamento delle funzioni neuro-muscolari. Ott-Nov-Dic a) Unità didattica: presa di coscienza ed elaborazione delle informazioni spazia-li temporali e corporee
b) Unità didattica; controllo del movimento.
c) Unità didattica: affinamento delle funzioni di equilibrio e coordinamento
3) Modulo: acquisizione delle capacità operative e sportive. Dic-Gen-Feb a) Unità didattica: avviamento alla pratica sportiva e orientamento delle attitu-dini personali
b) Unità didattica: pratica di sport individuale
Mar-Apr-Mag c) Unità individuale: pratica di sport di squadra
Pallavolo: palleggi, bagher, schiacciata, muro battute. Pallacanestro: presa, ricezione, passaggio, palleggio e tiro.
d) Unità didattica : abitudine alla pratica motoria e sportiva assunzione di ruoli di responsabilità.
Gli argomenti teorici sono stati: corpo umano, alimentazione, dieta dello sporti-vo, pronto soccorso, i principali paramorfismi dell’età scolare.
Le droghe: educazione e prevenzione.
Ore effettive svolte dal docente nell’intero anno scolastico

49
2) Metodi: (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, soste-
gno e integrazione)
3) Mezzi: (strumenti, materiali didattici, testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o
multimediali)
4) Spazi: (laboratori, biblioteca, stage, viaggi e visite guidate, mostre)
5) Criteri e strumenti di valutazione adottati: (prove scritte, verifiche orali, prove strutturate, pro-
ve grafiche, prove pratiche)
6) La valutazione è stata fatta attraverso l’osservazione dei ragazzi durante tutta l’attività, in mo-
do da constatare i progressi compiuti al termine di ogni ciclo di lavoro e si è tenuto conto
dell’impegno profuso durante le ore di lezione.
7) A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle veri-
fiche effettuate secondo le seguenti tipologie:
Trattazione sintetica di argomenti X Quesiti a risposta singola Quesiti a risposta multipla Problemi a soluzione rapida Sviluppo di progetti
Torre Annunziata, 07/05/2018
Firma del docente Tania Mastellone

50
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI ITALIANO – II° BIENNIO e ULTIMO ANNO
(in quindicesimi)
Allievo/a…………………………………..………………..classe…………….……data………..………
Competenze/Conoscenze Descrittori Punteggio Livello della prestazione
A Competenza testuale
a) rispetto delle consegne b) uso del registro complessivo adeguato al tipo di testo c) coerenza e coesione nella struttura del discorso d) scansione del testo in capoversi e paragrafi con even-
tuali titolazioni e) ordine nell’impaginazione e nell’aspetto grafico (cal-
ligrafia) f) comprensione del testo
1
1,5 2,5 3 4
Gravemente insufficiente Insufficiente
Sufficiente Buono Ottimo/Eccellente
B
Competenza grammaticale
a) padronanza delle strutture morfosintattiche e della
loro flessibilità e varietà b) correttezza ortografica c) uso consapevole della punteggiatura in relazione al
tipo di testo
0,5 1 2
2,5 3
Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo/Eccellente
C
Competenza lessicale-semantica
a) ampiezza del repertorio lessicale b) appropriatezza semantica e coerenza specifica del
registro lessicale c) padronanza dei linguaggi settoriali
0,5 1 2
2,5 3
Gravemente insufficiente Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo/Eccellente
D
Competenza ideativa / Conoscenze
a) scelta di argomenti pertinenti b) organizzazione degli argomenti intorno a un’idea di
fondo c) ricchezza e precisione di informazioni e dati d) rielaborazione della informazioni e presenza di com-
menti e valutazioni personali
1,5 2,5 3,5 4 5
Gravemente insufficiente Insufficiente
Sufficiente Buono Ottimo/Eccellente
TOTALE /15
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

51
ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ANALISI DEL TESTO– TRIENNIO ( in quindicesimi )
ALUNNO __________________________________ CLASSE _______ DATA ____/___/______
INDICATORI DESCRITTORI
CORRETTEZZA - correttezza ortografica - correttezza morfologica e sintattica - correttezza nell’uso della punteggia-
tura - proprietà e ricchezza lessicale
1 1,5 2 2,5 3
COMPRENSIONE - precisione nelle risposte alle do-mande
- individuazione dei concetti chiave - individuazione delle informazioni
accessorie - correttezza nelle citazioni testuali
1 1,5 2 2,5 3
ANALISI E INTERPRETA-ZIONE
- correttezza e precisione dell’analisi - riconoscimento degli elementi pro-
pri di un testo specifico (narrativo, poetico, teatrale, informativo, …)
- rielaborazione delle informazioni
1 1,5 2 2,5 3
CONTESTUALIZZAZIONE - confronto con testi dello stesso tipo - riferimenti precisi al co-testo (con-fronto tra opere dello stesso autore) - riferimenti corretti al contesto sto-
rico e letterario
1 1,5 2 2,5 3
COMPETENZA IDEATIVA - presenza di considerazioni personali
- efficacia delle valutazioni e dei commenti
- originalità degli spunti critici
1 1,5 2 2,5 3
TOTALE
LEGENDA DEL PUNTEGGIO: 1: insufficiente; 1,5: mediocre; 2:sufficiente; 2,5: discreto/ buono; 3: ot-timo/eccellente.
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA
Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

52
TABELLA DI VALUTAZIONE: MATEMATICA E FISICA
CONOSCENZE definizioni, formule, re-
gole, teoremi
COMPETENZE organizzazione dei contenuti, uso
della terminologia e della simbologia
CAPACITA’/ABILITA’ di rielaborazione, di applicazio-
ne, di deduzione
VOTO (V)
Rifiuta la verifica, conse-gna in bianco gli elabora-ti
2
Mancanza di conoscenze basilari
Non è in grado di organizzare i con-tenuti, uso improprio della termino-logia e simbologia
Non riesce ad applicare le cono-scenze e commette gravi errori
2<v≤3
Conoscenza degli ele-menti essenziali molto frammentaria e lacunosa
Organizza i contenuti in modo disor-ganico, uso improprio della termino-logia e simbologia
Applicazione incerta, errori (di calcolo e/ o concettuali) nell’esecuzione di compiti sem-plici
3<v≤4
Conoscenza parziale e/o superficiale degli ele-menti essenziali
Mostra incertezze nella gestione delle procedure risolutive. Uso impreciso della terminologia e simbologia
Applica le conoscenze acquisite in modo ripetitivo, errori (di calcolo e/o di applicazione delle regole) nell’esecuzione di com-piti semplici
4<v≤5
Conoscenze essenziali, ma confuse
È in grado di individuare le giuste procedure, ma in maniera imprecisa e meccanica. Uso confuso della termi-nologia e simbologia
Applica le conoscenze acquisite in modo generico con omissione di alcuni passaggi essenziali
5<v<6
Conoscenza degli ele-menti essenziali
Organizza i contenuti in modo so-stanzialmente corretto. Utilizza in modo appropriato la terminologia e simbologia
Applica correttamente le cono-scenze acquisite ed esegue compiti semplici senza commet-tere errori concettuali
6
Complete Organizza i contenuti in modo coe-rente. Utilizza in modo appropriato e sicuro la terminologia e simbologia
Applica correttamente i proce-dimenti. Rielabora i contenuti.
6<v≤7
Complete e approfondite
Organizza i contenuti in modo logico e coerente, individua la strategia riso-lutiva idonea. Padroneggia la simbo-logia e la terminologia
Rielabora in modo autonomo le conoscenze, esegue compiti complessi
7<v≤8
Complete, sicure ed ap-profondite
Contestualizza le conoscenze e le or-ganizza in modo logico e coerente, individua l’efficacia della strategia risolutiva. Padroneggia la simbologia e la terminologia
Rielabora autonomamente le conoscenze, deduce e esegue compiti complessi
8<v≤9
Complete, sicure, amplia-te e personalizzate
Evidenzia padronanza e disinvoltura nell’individuare la strategia risolutiva più efficace e nell’applicarla in modo rapido, ma chiaro, logico e coerente. Possiede un linguaggio appropriato, fluido e rigoroso
Rielaborazione dei contenuti pienamente autonoma, persona-le e critica; assoluta padronanza nell’effettuare collegamenti sia in ambito disciplinare che pluri-disciplinare
9<v≤10
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

53
PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 5Esc
“MADE IN (SOUTH) ITALY”
In ottemperanza al D.L 107/15, anche il nostro liceo è stato chiamato ad attivare, nel secon-do biennio e nell’ultimo anno di studi, percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per i quali sono previ-ste 200 ore che sono state ripartite in 60 ore al terzo anno, 70 al quarto e 70 al quinto. Con il pre-supposto in base al quale le attività previste dall’alternanza scuola-lavoro sono finalizzate a far capi-re ai giovani che è necessario possedere capacità trasversali e relazionali, nonché competenze che vanno accresciute nel tempo attraverso la specializzazione e l’aggiornamento permanente, si è stu-diato un percorso in collaborazione con l’associazione Slow Food Vesuvio, da sempre attiva nella tutela del nostro territorio e nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari.
Pertanto, il progetto intende migliorare la coscienza civica e ambientale degli alunni attra-verso un ritorno alle origini del territorio per attuare una produzione responsabile di prodotti agrico-li ed enogastronomici tipici del Paniere Vesuviano, avvicinando loro al mondo dell’agrisociale-bio e all’etica dell’alimentazione.
Mediante visite ad aziende e realtà produttive del territorio, di elevato standard qualitativo certificato e riconosciuto sulla base di indicatori nazionali e internazionali, e privilegiando esperien-ze di creatività e di imprenditoria giovanile, gli alunni hanno potuto comprendere quanto la ricerca applicata alla filiera agroalimentare sia importante per far emergere le specificità e le eccellenze che il nostro territorio offre.
Il progetto, inoltre, si propone di far conoscere agli studenti le tecnologie e i media mag-giormente utilizzati dalle realtà imprenditoriali prese in esame, indagando, così, anche il campo dell’innovazione e del digitale per comunicare e promuovere l’eccellenza agroalimentare del Made in Italy nel mondo. Lo scopo è quello di formare e implementare competenze nell’utilizzo della lin-gua e nella capacità di raccontare il territorio e l’identità culturale, al fine di promuovere la cono-scenza dei prodotti identitari del territorio vesuviano e campano.
Prendendo spunto dalla cronaca, agli studenti è stato proposto di compiere un viaggio di co-noscenza ed esperienza dal titolo “Dal peggio alle eccellenze della Campania”: conoscere il peggio significava capire le ragioni e i fatti che hanno portato parti della Campania ad essere drammatica-mente note in tutto il mondo come Terra dei Fuochi, e ripartire da questa consapevolezza per un viaggio di scoperta delle eccellenze ambientali e gastronomiche della Campania.
L I C E O S T A T A L E
“Pitagora - B. Croce” Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Linguistico
Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo – Musicale - Scienze Applicate
SCUOLA CAPOFILA AMBITO 21 E DEI LICEI SPORTIVI DELLA CAMPANIA Cod. mecc. NAPS930006 - C. F. 82007550633 Via Tagliamonte, 13 - 80058 Torre Annunziata (NA) - Tel. 08119970011 - Fax 08119716182
www.liceopitagoracroce.gov.it - [email protected] pec: - [email protected]

54
Gli studenti hanno prima di tutto approfondito il tema della legalità nella nostra regione, attra-verso due incontri in due differenti contesti di realtà :
A Torre Annunziata, in un incontro pubblico a Torre Annunziata per parlare di legalità con il presidente del Tribunale dei Minori di Napoli e per conoscere un’esperienza di resistenza alla illegalità intrapresa da Torrefazione Campana, azienda storica di Torre Annunziata;
A Giugliano in Campania, durante la visita ad un fondo sequestrato alla criminalità in locali-tà San Giuseppiello dove l’Università di Napoli, in collaborazione con aziende specializzate, sta realizzando un progetto sperimentale pilota di eco-bonifica di un campo agricolo grave-mente danneggiato da sversamenti di rifiuti tossici.
In entrambi i casi, sono stati trattati i temi della legalità e dell’impresa, della ricerca per
l’innovazione del prodotto, della ricerca applicata nella sperimentazione della eco-bonifica del fon-do sequestrato alla camorra nel giuglianese. In particolare, si è prestata attenzione agli incontri con le aziende e gli esperti, affinché agli studenti fosse chiaramente rappresentata la varietà dei profili professionali e l’ampiezza delle conoscenze necessarie per affrontare la complessità del mondo con-temporaneo.
La classe ha poi avviato un percorso di indagine, censimento e critica delle opportunità econo-miche e sociali del territorio vesuviano, al fine di elaborare una proposta di promozione turistica sostenibile della città. In ciascuna classe sono state svolte le seguenti attività:
Laboratorio Dalla Terra dei Fuochi alla Campania di qualità
Osservazione e studio sulle criticità ambientali della Campania Studio scientifico delle peculiarità del suolo vesuviano Riscoperta dei possibili percorsi di valorizzazione dell’agricoltura di qualità della Campania
Focus di approfondimento sulle criticità sociali ed ambientali del comune di Torre Annun-ziata
Laboratorio delle idee e dei linguaggi
Bene UNESCO: significato e valore per la città Il locale nel mondo globale – il globale nel locale Slow Food: buono, pulito e giusto . E basta? Tecniche di vendita: a km0, al dettaglio, di prossimità, grande distribuzione, e-commerce Linguaggio specialistico: il vocabolario del giornalista eno-gastronomico
Laboratorio Del Fare:
Progettazione di una guida per valorizzare le risorse economiche, culturali e paesaggistiche del Comune di Torre Annunziata. Selezione dei materiali pubblicati dal comune o da altri enti: pro-loco, Comune di Torre An-nunziata, Guide Touring Club Italia, guide Slow Food, guide dell’Espresso. Lavori di gruppo per progettare un itinerario di valorizzazione turistica e culturale della cit-tà. Sopralluoghi ai siti, studio e selezione delle immagini Riflessione sui linguaggi della comunicazione: giornali, brochures e riviste specializzate
Il Fare Progettazione di un Itinerario turistico per un gruppo di visitatori provenienti dal Senegal: Percorso di accoglienza turistica per un gruppo di visitatori senegalesi, con l’obiettivo di

55
riuscire a cogliere peculiarità e punti di forza turistici, culturali e gastronomici del nostro ter-ritorio.
Le discipline coinvolte nel progetto sono state, oltre a quelle caratterizzanti dell’indirizzo, quelle che contribuiscono alla costruzione del percorso indicato negli aspetti scientifici e storico-culturali. Infatti, le competenze linguistiche dell’italiano e della lingua straniera hanno facilitato gli alunni nella presentazione e promozione dei prodotti dell’area vesuviana, sia nella fase orale che in quella scritta, sul mercato italiano e, soprattutto, estero. Invece, lo studio delle coordinate storico-culturali, nonché quello della storia letteraria e della produzione filosofica dei paesi europei, hanno dato agli alunni una visione diacronica delle problematiche dello sviluppo socio-economico nel me-ridione e in particolare nell’hinterland napoletano. Infine i contenuti di chimica, botanica e biologia hanno loro consentito una maggiore conoscenza dei prodotti e maggiore consapevolezza delle po-tenzialità culturali e produttive del nostro territorio.
A partire da questo anno scolastico, gli alunni hanno potuto implementare anche le proprie co-noscenze sul mondo del lavoro ed alle norme che lo regolamentano grazie all’intervento di docenti di Diritto ed Economia che, a partire dal proprio ambito disciplinare ed in collaborazione con il consiglio di classe, hanno svolto, seppure in maniera occasionale e talvolta discontinua, il proprio compito con risultati discreti.
Sulla base di quanto espresso, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi e competenze:
Obiettivi Formativi:
a) Conoscere le esperienze di successo dell’imprenditoria italiana: dall’inizio del secolo scorso ai nostri giorni;
b) Conoscere i ruoli e le modalità organizzative del lavoro mediante visite ad aziende e luoghi di lavoro;
c) Conoscere le biografie e i casi di successi aziendali; d) Conoscere i marchi italiani di successo internazionale nel mondo; e) Conoscere il valore aggiunto di una efficace comunicazione multimediale; f) Approfondire la conoscenza del patrimonio paesaggistico e archeologico del territorio.
Competenze di Base:
a) competenza digitale; b) imparare ad imparare; c) competenze sociali e civiche; d) spirito d’iniziativa e imprenditorialità; e) consapevolezza del proprio contesto culturale.
Competenze di Indirizzo:
a) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
b) Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali.

56
c) Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
d) Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole disci-pline.
e) Riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; utilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline.