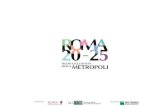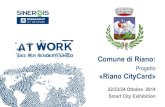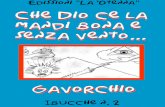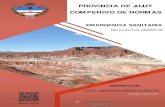Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Roma GLI … 1/GR_1_33-131_Maccagno.pdf ·...
Transcript of Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Roma GLI … 1/GR_1_33-131_Maccagno.pdf ·...
-
A.M. MACCAGNO
Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Roma
GLI ELEFANTI FOSSILI DI RIANO (ROMA)
Il lavoro consiste nello studio di cospicui resti elefantini riferibili ad E. antiquus FALC. e CAUTL. provenienti dalla formazione tufitico-diatomitica di Riano (Roma), attribuita al Mindel-Riss. Essi consistono di uno scheletro, di un grande cranio, di una difesa e di un molare. Per confronto è stato associato lo studio di alcuni pezzi inediti delle collezioni romane.
Particolare sviluppo è stato dato all'esame comparativo dei cinque crani rappresentati in questo materiale, che ha portato a interessanti risultati secondo i seguenti punti di vista:
1°) Sviluppo ontogenetico - Ricostruzione dello sviluppo ontogenetico del cranio di E. antiquus FALC. e CAUTL., attraverso la individuazione dei meccanismi di sviluppo del cranio nel suo insieme e delle singole ossa.
2°) Posizione sistematica - Attribuzione di tutti gli esemplari ad E. antiquus FALC. e CAUTL. e discussione dei rapporti filetici di questa specie.
3°) Stadio mutazionale - Separazione di due stadi mutazionali: il primo, a cui apparten-gono gli elefanti di Riano, corrispondente ad E. antiquus FALC. e CAUTL., forma tipica; il se-condo, a cui appartengono i crani di Via dell'Impero e del Museo di Paleontologia dell'Univer-sità, corrispondente ad E. antiquus italicus OSBORN, forma più evoluta.
Sono risultati particolarmente dimostrativi: per lo studio dei crani le sagome rappresen-tative delle sezioni-tipo (Osborn, 1942) e i diagrammi dei rapporti biometrici (figg. 9 e 11); per le difese la curva di proiezione grafica (Trevisan, 1942); per i molari le curve di varia-zione della larghezza delle lamelle (Adam, 1960); per la colonna vertebrale le curve di variazione dei rapporti percentuali dei corpi vertebrali; per l'architettura dei piedi il riferimento agli schemi strutturali proposti da Trevisan (1948).
Il presente lavoro è stato eseguito sotto gli auspici e con i mezzi del Comitato per la Geografia, Geologia e Mineralogia del C.N.R. e della Wenner Gren Foundation.
INTRODUZIONE
Nel quadro degli studi geopaleontologici del Quaternario dei dintorni di Roma, condotti sotto la direzione del Prof. Accordi dell'Istituto di Geo-logia e Paleontologia dell'Università di Roma, ho portato a termine la descrizione di interessanti resti di elefanti fossili, recentemente trovati, riferibili a E. antiquus FALC. e CAUTL.
una, inferiore, sotto al tufo litoide e una, superiore, intercalata tra questo e i > prima descritti da cui provengono i resti elefantini, oggetto di questo lavoro.
Essi provengono da livelli quasi corrispondenti di varie località, molto vicine tra loro, del territorio del Comune di Riano (Roma) e si trovano nella for-mazione tufitico-diatomitica, che corrisponde ai termini più elevati della serie in questa località. La formazione in parola è costituita di tufi strati-ficati incoerenti, di colore vario, da giallo a grigio scuro, con intercalazioni di strati di pomici e di episodi diatomitici di tipo lacustre e palustre, a volte molto rilevanti; essa qui è immediatamente sovrastante al tufo litoide > che ricopre in bancate di forte spessore tutta la regione circostante, formando le colline tabulari caratteri-stiche della zona. Verso Nord la serie è più compli-cata e compaiono due formazioni di tufo pisolitico,
Per considerazioni stratigrafiche e geomorfolo-giche e per dati paleontologici in genere e paleo-botanici in particolare, gli AA. riferiscono concor-demente la formazione che potremo chiamare ad E. antiquus al grande interglaciale Mindel-Riss (Blanc ed altri, 1955; Follieri, 1958 l e 2, 1960; Accordi-Maccagno, 1962). Devo alla squisita cor-tesia del Prof. U. V entriglia, che ha in corso lo studio vulcanologico della zona, la maggior parte di queste notizie.
I resti elefantini, oggetto di questo studio, con-fermano l'attendibilità del riferimento cronologico, infatti la presenza di rappresentanti di E. antiquus non ancora differenziati in italicus o appena allo tmzw della differenziazione, fa pensare ad un livello non molto elevato del Grande Interglaciale.
Questi interessanti resti paleontologici, che sono venuti ad arricchire la collezione di vertebrati
33
-
fossili del Pleistocene romano del nostro Museo, sono frutto di scavi eseguiti in più riprese in occasione delle numerose escursioni effettuate dal personale e da studenti del nostro Istituto. For-tunate campagne di scavo hanno portato a Impor-tanti ritrovamenti in diverse località:
1°) .
zo) (( IL CROCIFISSO >) (Km. 5 sulla via Rianese verso la via Tiberina. Quota 80 m. sulla scarpata a destra della strada venendo da Riano).
In questa località è stato trovato uno scheletro quasi completo di elefante giovane (20-25 anni); il cranio porta le due zanne (alquanto deformate e piuttosto piccole per l'età) e i penultimi molari in uso. La presenza del fossile ci è stata preannunciata da alcuni frammenti di una vertebra che affioravano sulla parete di taglio della strada; uno scavo, p re-ordinato allo scopo e sufficientemente ampio, ha permesso il recupero di questo bellissimo esemplare.
La fragilità delle ossa, dovuta all'età abbastanza
34
giovanile ed al tipo di fossilizzazione molto poco resistente, usuale nei terreni diatomitici, ha reso le operazioni di estrazione molto delicate. Nelle melme diatomeifere infatti i resti di organismi sono in-globati molto rapidamente e quindi sono molto imperfettamente fossilizzati per mancanza di cir-colazione di acque che apportino sostanze mine-ralizzanti.
Il fossile, anche dopo il restauro, si presenta infatti con le superfici delle ossa intatte ma molto fragili; il cranio è deformato per la pressione degli strati diatomitici soprastanti. Il terreno diatomeifero che inglobava il fossile appartiene alla formazione tufitico-diatomitica già descritta per la precedente località; l'elefante giaceva in uno strato di deposito stagnale più puro, ma sempre molto ricco di mate-riali vulcanici, varvato, che misura pochi metri di spessore globale; ad esso sottostanno, nell'ordine, un tufo terroso grigio scuro e un livello a pomici. In questa località manca sotto alla formazione di > il tufo litoide > e la formazione stessa poggia direttamente sulle argille sabbiose, marine, che da un esame della fauna risultano probabilmente calabriane.
Della scoperta di questo esemplare e delle ope-razioni di scavo, è già stata data una precedente notizia (Maxia, 1959). Desidero ringraziare qui il Prof. C. Maxia, che mi incaricò a suo tempo della direzione dello scavo e dello studio del fossile, la Dott. S. Zanfrà, e i numerosi studenti che parteci-parono attivamente ai lavori di scavo e di recupero, in modo particolare: Veronese, Merucci, Mazzini, D' Addario, Durante e Bomba.
Ringrazio vivamente per l'aiuto ricevuto il Preside della Fac. di Scienze prof. S. Visco ed il Gen. E. Palandri.
3°) LocALITA' . Al Km. 4,800 della via Rianese, sul versante sinistro della strada ve-nendo da Riano, quasi incontro quindi a >, in un campo costeggiante la strada, da un piccolo scasso sono affiorati frammenti di una zanna di Elephas, non recuperabile, e un molare che gia-ceva su di uno strato tufaceo cinerino, a scorie nere, passante in basso a livelli più diatomitici.
Il molare è conservato nel Municipio di Riano e devo alla cortesia del Sindaco del luogo di averlo potuto studiare a mio agio.
4°) VALLE DI PIANAPERINA (Riano). In una cava di diatomite, in uno strato di tufo terroso nerastro intercalato ai livelli diatomitici della formazione
-
suddetta, è stata recuperata una bella difesa di E. antiquus FALC. e CAUTL.
La località è posta a Est della via Rianese alle spalle della cava di farina fossile di Valle dell'In-ferno, da cui è separata da uno sprone di tufo >).
Nel Museo di Paleontologia dell'Università s1 trovano, da antica data, due crani interessanti, per quanto incompleti, riferibili a E. antiquus italicus OSBORN; il primo (n° 170) di circa 6 anni di età, il secondo (n° 25) di circa 30 anni.
Nel Museo delle Origini dell'Università di Roma infine, è conservato un bellissimo cranio anch'esso riferibile a E. antiquus italicus OSB. di 30-35 anni di età.
Tutti questi esemplari, a mia conoscenza, non erano mai stati illustrati. Mi è sembrato utile quindi descriverli insieme con i nuovi reperti di Riano, in modo da poterli utilizzare per un proficuo con-fronto insieme con gli altri crani, riferiti a E. anti-quus, descritti nella letteratura, tra cui i più im-portanti sono: i due crani di Pignataro Interamna (De Lorenzo, 1926; De Lorenzo e D'Erasmo 1927; Osborn, 1931 e 1942; D'Erasmo e Monchar-mont, 1955), il cranio, molto frammentario, di Vi-terbo (Trevisan, 1948) e un altro bell'esemplare proveniente, come quello del Museo delle Origini, dagli scavi di Via dell'Impero di Roma (De Angelis D'Ossat, 1936); non mi è stato possibile finora esa-minare direttamente questo ultimo esemplare, che deve essere ancora conservato nei Musei del Cam-pidoglio e che spero di poter esaminare in futuro.
Dato che i cinque crani che ho avuto diretta-mente in esame appartengono ad individui di età diversa, è stato possibile ricostruire attraverso il loro studio le successive fasi dello sviluppo onta-genetico del cranio di E. antiquus.
Inoltre, per merito dell'abbondanza del materiale, ho potuto precisare la definizione della specie attra-
verso lo studio dei singoli caratteri, istituendo il confronto diretto con E. meridionalis NESTI, esem-plare dell'Aquila (Maccagno, 1962) e con un bel cranio di Loxodonta africana (BLUM.) del Museo Civico di Zoologia di Roma, che ho avuto a dispo-sizione per la cortesia del Dott. Tamino.
Posso inoltre confermare ancora una volta la legit-timità della separazione di E. antiquus da E. nama-dicus FALC. e CAUTL. e a maggior ragione da E. rechi DIETRICH (Arambourg, 1942).
N ello stabilire la posizione sistematica è risul-tata evidente l'opportunità di separare gli esemplari di Riano ed alcuni esemplari romani (due mandi-bole di Roma, più avanti descritte: > e n° 7 Mus. Pal. e probabilmente il citato cranio descritto da De Angelis D'Ossat, 1936) come meno differenziati, riferibili cioè ad uno stadio muta-zionale corrispondente ad E. antiquus FALC. e CAUTL., tipico, mentre gli altri crani romani (
-
miche in lamelle a contorno irregolare che, unita-mente a una scarsa microfauna ( microforaminiferi e ostracodi) hanno subito un evidente trasporto.
Nella microfauna l'associazione delle forme presenti indicherebbe come età originaria il Pleisto-cene inf. ma, come si è detto, essa è certamente di deposito secondario.
Tale tipo di formazioni dunari-lacustri si tro-vano a Roma intercalate a differenti livelli nei tufi; il materiale che ancora ingloba in parte il piccolo cranio assomiglia in modo particolare a depositi similari osservati nel Fosso S. AGNESE a NE di Roma (vicino alla Batteria Nomentana) dove essi sono superiori al >.
N° 25 Mus. PAL. UNiv. RoMA - Il frammento di cranio fa parte di vecchie collezioni e non porta altre indicazioni che ; non si possono fare supposizioni per precisarne la provenienza.
VIA DELL'IMPERO - MusEo DELLE ORIGINI (nu-mero 1303 bis) - È questo un bellissimo cranio che il detto Museo ha avuto in dono dal Mus. Pigorini nel 1938 e porta l'indicazione dal luogo di provenienza indicato nell'etichetta originale: ; oggi però si ritiene (gentile informazione orale del prof. U. Ventri-glia) che una p2.rte di questa form2.zione com-prenda vari livelli anche sottostanti al tufo litoide.
-
CAP. I
CRANI
-
Premascellari
Mascellari e
Pala tini
Nasali
Coane nasali esterne
Diametro respiratorio:
lunghezza (bordo sup. coane est.-bordo sup. coane int.)
angolo tra l'asse l'asse baticefalico l'alto)
38
respiratorio e (aperto verso
DESCRIZIONE OSTEOLOGICA
N° 170 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 1; fig. 1 nel testo Tav. l; Tav. Il, 1-2
VENTAGLIO: non ancora sviluppato.
ALVEOLI delle DIFESE: molto pic-coli, divergenti di 56°; paralleli al piano di masticazione; fanno un an-golo di 650 con l'asse baticefalico (di 400 con il profilo della fronte).
PROCESSI ALVEOLARI dei MO-LARI poco sviluppati, leggermente divergenti verso il basso, subparalleli in senso longitudinale.
PALATO (lunghezza 16 cm., lar-ghezza ant. 6 cm., post. 7 cm.) a volta poco pronunciata, con una cresta mediana sagittale nella metà post. Il bordo alveolare post. descrive con la base del cranio un angolo di 153° e con il bordo alveolare laterale un angolo di 1350. Sul lato esterno dell'alveolo è accennata una cresta obliqua per gli attacchi muscolari.
COANE NASALI EST. molto in basso (al livello delle orbite), non troppo grandi, rotondeggianti, mst-stono su di una verticale che cade sulla metà del molare.
Fortemente inclinato in avanti sul piano alveolare dei molari:
330
72° ca.
VENTAGLIO: molto sviluppato, la lunghezza è quasi uguale al diametro distale. Lo sviluppo in lunghezza del VENTAGLIO è pari al 64,7% di tutta la faccia.
ALVEOLI delle DIFESE: poco di-vergenti: 31 o; delimitano un angolo di 1270 con il piano di masticazione; di 280 con l'asse baticefalico; di 174° con la linea della fronte. Nella regione prossimale è profonda la depressione per gli attacchi muscolari. Processi frontali alquanto depressi.
PROCESSI ALVEOLARI dei MO-LARI molto sviluppati, alquanto di-vergenti verso il basso e convergenti in avanti moderatamente.
P ALATO (lunghezza cm. 24, lar-ghezza ant. 7 cm., post. 9 cm.) a volta poco pronunciata, con spina mediana e bordo post. dei palatini ad arco profondo. Il bordo alveolare post. fa con la base del cranio un angolo di 1480, con il bordo alveolare laterale un angolo di 1210. Manca sul lato dell'alveolo la cresta obliqua.
NASALI larghi, ad angolo di con-vergenza dei lati piccolo, con estre-mità non ancora ossificata.
Comincia l'arretramento delle COA-NE che si trovano con il bordo inf. sotto al bordo superiore delle orbite per 1 /3 della altezza delle coane stesse; rotondeggianti, diametro mas-simo trasverso ad 1 /5 dell'altezza del bordo inf. ; insistono su di una ver-ticale che cade dietro alla superficie di masticazione.
Rialzato sul piano alveolare dei molari: 450
35 cm.
58° ca.
-
DEI CINQUE CRANI
NO 25 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 2
VENTAGLIO: manca; ne testimonia l'esistenza e lo sviluppo in larghezza solo una piccola porzione residua (lungh. 18 cm., largh. 18 cm.) in corrispondenza del bordo anteriore del processo zigomatico del mx.
ALVEOLI delle DIFESE: diver-gono di 54°; delimitano un angolo di 1200 con il piano di masticazione; di 400 ( ?) con l'asse baticefalico ; di 1 540 con la linea della fronte.
PROCESSI ALVEOLARI dei MO-LARI non troppo sviluppati, molto leggermente divergenti verso il basso e ben convergenti in avanti.
PALATO corto (lunghezza 17,5 cm., larghezza ant. 5,7 cm., post. 10,5 cm.), a volta poco pronunciata. Il bordo post. degli alveoli dei molari descrive con la base del cranio un angolo di 1460. Sul lato esterno dell'alveolo la cresta obliqua è poco distinta.
Manca tutta la porzione del cranio ant. per una buona profondità.
Le FOSSE NASALI internamente sono ovali, rotondeggianti agli angoli, con diametro trasverso poco maggiore dell'altezza; insistono su di una ver-ticale che cade avanti ai molari.
Rialzato sul piano alveolare dei molari: 46°
27 +cm.
59° ca.
ESAMINATI
«Via dell'Impero» Tav. VI
VENTAGLIO: fratturato; è conser-vata solo una breve porzione.
ALVEOLI delle DIFESE: a sezione rotonda, divergono di 540; delimitano un angolo di 930 con il piano di masti-cazione; di 1 so con l'asse ba ti cefalico; di 1680 con la linea della fronte.
PROCESSI ALVEOLARI dei MO-LARI ben sviluppati, fortemente con-vergenti in avanti e alquanto diver-genti verso il basso.
PALATO corto (lunghezza 24 cm., larghezza ant. 4,7 cm., post. 12,8 cm.), a volta ben pronunciata. Il bordo post. degli aheoli dei molari descrive con la base del cranio un angolo di 120o e un angolo uguale con il bordo laterale degli alveoli. Sul lato esterno dell'alveolo è ben pronunciata la cresta obliqua.
NASALI ben sviluppati ad angolo largo, appuntiti, ad andamento quasi verticale.
COANE arretrate fino al livello delle apofisi postorbitali; ovali, allungate trasversalmente, diametro trasverso massimo nel terzo inferiore dell'al-tezza; insistono su di una verticale che cade nel terzo ant. dei molari.
Rialzato sul piano alveolare dei molari: 530
47 cm.
580 ca.
« Pian dell'Olmo>> Tav. III e Tav. IV
VENTAGLIO: incompleto, conservato per circa i 2/3; è lungo quasi come la massima larghezza distale, la sua lunghezza è pari al 66,6% della lunghezza di tutta la faccia.
ALVEOLI delle DIFESE: divergo-no circa di 400; delimitano un an-golo di 1220 con il piano di mastica-zione; di 310 con l'asse baticefalico; di 195° con la linea della fronte. Molto approfondita la depressione prossimale per gli attacchi dei mu-scoli della proboscide. Processo fron-tale alquanto depresso.
PROCESSI ALVEOLARI dei MO-LAR I mancanti di buona parte del loro lato post., lentamente convergenti in avanti.
P ALATO abbastanza lungo (lunghezza 27 cm., larghezza ant. 6 cm., post. 13 cm.). Il bordo post. degli alveoli dei molari ricostruito idealmente de-scriverebbe con la base del cranio un angolo di 140°-150°. La cresta è poco accentuata.
NASALI incompleti, ad angolo largo, di forma appuntita e molto corti, non si estendono in fuori.
COANE molto arretrate, il bordo inferiore è a livello del bordo post. dell'apofisi postorbitale; ovali, a bordo inf. quasi rettilineo, ad angoli infe-riori rotondeggianti e diametro tra-sverso molto allungato, con valore massimo in corrispondenza del bordo inferiore. La verticale abbassata dalle coane insiste sulla metà dei molari.
L'angolo con il piano alveolare dei molari è molto ampio, 710. l/asse respiratorio si avvicina all'asse baticefalico.
42 cm.
400 ca.
39
-
Fronte
Cavità orbitarie
Pari e tali (cupola cranica)
40
N° 170 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 1; fig. 1 nel testo
Non è conservata; dai rapporti di-mensionali, dalla posizione delle fosse nasali, dallo sviluppo dei lobi ant. degli emisferi cerebrali (lobi fron-tali) e dal forte sviluppo della diploe dei parietali (molto sviluppata in rap-porto all'età) si deduce che era molto estesa in altezza, con ampia parteci-pazione dei parietali, grande sviluppo ai lati in alto delle bozze parietali e conseguente differenza tra il diametro trasverso inferiore e quello superiore. Tutta la fronte era in posizione arre-trata rispetto alla regione mascellare (fig. 1 a).
Laterali alle fosse nasali ; non sono conservate; se ne individua la posi-zione dalla presenza del foro lacero e dalla radice ant. del processo zigo-matico del mascellare. Insistono sulla verticale che cade dietro agli alveoli dei molari.
Ampiamente sviluppati, costituiscono parte della fronte, la metà superiore delle fosse temporali e un'ampia por-zione della regione occipitale. Nello esemplare è conservato solo l'angolo laterale postero-inferiore del parietale sinistro; l'andamento di questa por-zione e i sottostanti sovra- ed esocci-pitali indicano una volta del cranio rotondeggiante, in posizione arretrata rispetto al cranio viscerale, a bozze parietali molto oblique dall'alto dietro in basso avanti, a limiti non distinti indietro. L'allargamento del diametro trasverso del vertice, già evidente, non è ancora tale da far ruotare frontalmente la parte posteriore della fossa temporale come vedremo avve-nire negli esemplari più adulti; il contorno del cranio però già si pre-senta svasato verso l'alto. In rapporto all'alto grado evolutivo raggiunto, l'esemplare, nonostante l'età giova-nile, presenta un forte sviluppo della diploe dei parietali.
> Tav. I; Tav. II, 1-2
LA FRONTE, benché sia iniziato lo spostamento verso l'alto delle coane nasali est., è però ancora abbastanza estesa in altezza in rapporto all'età, principalmente per il piccolo svi-luppo del toro sovrafrontale. È costi-tuita dal frontale piuttosto ridotto e per buona parte in alto dai parietali ; si estende di profilo sulla stessa linea dei premascellari; è ampia e pianeg-giante inferiormente, concava nella parte superiore, alla quale sovrasta un TORO ben distinto, ma non molto sviluppato (in rapporto probabilmente al sesso) a carico dei parietali. Ai lati la fronte si prolunga in due angoli rilevati e sfuggenti indietro che pro-seguono in due creste delimitanti il margine superiore delle fosse tem-porali; anche ai lati della regione mediana due creste rilevate la divi-dono dalle fosse temporali. La fronte è ancora in posizione poste-riore rispetto alla regione mascellare e fortemente sfuggente indietro anche a prescindere dalla deformazione su-bita dal cranio.
Si trovano per 1 /3 dell'altezza sopra al livello del bordo inf. delle coane n. est.; molto deformate, grandi, ovali, allungate secondo il piano fron-tale; bordo inf. ispessito e reflesso in fuori dove termina a punta; apofisi postorbitali relativamente corte (cen-timetri 6,5) flesse in avanti.
Il cranio in questa regione è tanto deformato che la cupola cranica ap-pare accartocciata e contorta (la pla-sticità delle ossa è in parte dovuta all'età giovanile, in parte alla pres-sione orientata degli strati diatomei-feri in cui si è trovato l'esemplare). I limiti dei parietali non sono rico-noscibili; certamente questi formano la parte superiore della fronte e il toro soprafrontale che è nettamente di-stinto seppure non molto sviluppato (in rapporto al sesso ?) ; il diametro trasverso della regione è invece molto grande in conseguenza del grande sviluppo laterale dei parietali; non sembra che dovesse essere molto avanzata la ipsicefalia, nè la batice-falia della regione, infatti la cupola del cranio è ancora in posizione post. al cranio viscerale, sebbene meno di come lo sia nel cranio piccolo prece-dente. Dato lo schiacciamento subito non è constatabile il grado di brachicefalia raggiunto. Viste di fronte, le bozze parietali sono depresse e largamente, ma non profondamente, separate in senso sagittale. La parete posteriore delle fosse temporali è rivolta al-quanto in avanti e in conseguenza le fosse stesse guardano un po' frontal-mente.
-
N° 25 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 2
Non conservate, sembra si trovassero sotto al livello delle coane n.est.
-
Faccia occipitale
Forarne occipitale
Cavità cerebrale
Fosse temporali
42
N° 170 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 1; fig. 1 nel testo
Ampia, a contorno semicircolare, ad arco un po' depresso in alto (fig. 1 b); la sua altezza è dovuta allo stato di pneumatizzazione dei parietali che è molto elevato nonostante l'età infan-tile dell'esemplare. Il sovraoccipitale si arrotonda sulla nuca raccordandosi ai parietali in alto. Non è conservata la regione mediana. Gli esoccipitali delimitano il f.m. e ai suoi lati for-mano due bozze distinte a contorno reniforme, sporgenti sul piano occi-pitale, appiattite posteriormente; esse confinano con gli squamosi, che con angoli arrotondati formano ·i limiti laterali della faccia occipitale. Mancano i condili. I processi articolari per la mandibola sporgono in basso, diretti orizzontalmente in fuori. Il diametro trasverso degli esoccipitali è elevato in rapporto al diametro della faccia occipitale.
È conservata solo la metà inf. Diametro trasverso maggiore della altezza ( ?) .
È visibile il basioccipitale che forma il bordo inf. del f.m.; questo è un arco perfetto, che ha dato la misura del diametro trasverso del foro. Il basioccipitale forma l'inizio del pavi-mento della cavità cerebrale, che è diretto dal dietro in avanti, parallela-mente al piano alveolare dei molari. Dalla faccia anteriore, per la man-canza di gran parte della regione frontale e mascellare, sono visibili dall'esterno le pareti che limitano la cavità cerebrale che era molto grande; in particolare sono ben sviluppati i lobi frontali; essi si presentano piut-tosto deformati e non accessibili dall'interno della cavità.
La regione è ben conservata. Gli squamosi costituiscono la parete infe-riore delle FOSSE TEMPORALI, che sono poco profonde, in posizione arretrata, con asse obliquo verso l'alto e indietro. Sono quasi inesi-stenti le creste che dividono la por-z!one anteriore delle fosse dalla poste-nore.
> Tav. I; Tav. II, 1-2
L'esemplare è molto deformato in questa regione. La fossa ligamentare doveva essere ampia e profonda; la linea del cranio è svasata verso l'alto ma non sembra che la volta cranica dovesse essere molto elevata. Gli esoc-cipitali circoscrivono il f.m. sporgendo molto indietro ed in basso dal bordo sup. del forarne, si continuano late-ralmente con due ampie superfici piano-convesse, che si inftettono ai lati dove gli esoccipitali confinano con gli squamosi. Questi ultimi deli-mitano con un angolo pronunciato i limiti inferiori laterali della faccia posteriore. L'estensione trasversale de-gli esoccipitali è propmzionalmente ridotta. Ai lati del f.m. gli esoccipi-tali portano i condili, grandi, sub-triangolari, ad assi longitudinali con-vergenti in basso.
Molto ampio, poco pm alto che largo. Il f.m. è diretto obliquamente dal dietro in alto all'avanti in basso, in piccola misura.
La CAVITÀ CEREBRALE non è ac-cessibile e il pavimento all'inizio della cavità cerebrale è diretto obliqua-mente in alto dal fuori in dentro.
La regione è deformata su entrambi i lati. Gli squamosi concorrono larga-mente alla formazione delle FOSSE TEMPORALI che sono molto ampie in senso antera-posteriore, oblique verso l'alto e indietro, ma non molto estese in alto; esse sono in posizione arretrata rispetto al diametro antero-posteriore del cranio. Sono ben evi-denti le creste che dividono la por-zione anteriore delle fosse dalla poste-riore. Le pareti post. sono ruotate in senso frontale; i limiti sup. delle fosse sono segnati da una cresta rialzata.
-
N° 25 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 2
Il frammento di cranio conserva il f.m.; gli esoccipitali sono larghi e fortemente inclinati verso l'alto in avanti; essi portano due grandi condili arrotondati, con gli assi della super-ficie articolare poco convergenti in basso. I processi articolari mandibolari, molto sviluppati, sono diretti orizzontalmente in fuori. L'estensiom trasversale degli esoccipitali in rapporto al diametro trasverso del cranio è ridotta an-cora di più.
Grande, più largo che alto.
La CAVITÀ CEREBRALE è acces-sibile dal f.m.; essa è piuttosto ampia, lung~ 25 cm., larga 22 cm. nel punto massimo.
Il frllmmento di cranio è privo quasi completamente della regione tempo-rale. Sono conservati a destra: il processo articolare trasverso e il pro-cesso zigomatico del temporale. Il pro-cesso articolare per la mandibola è molto robusto e ben esteso in fuori.
-
Faccia ventrale
Base del cranio (basioccipitale, basisfenoide, tiro-panici, squamosi, palatini, ma-scellari)
Arcata zigomatica
44
N° 170 Mus. Pal. Univ. Tab. V, 1; fig. 1 nel testo
I lati post. degli squamosi sono estesi in fuori ed ampiamente arrotondati, le docce postglenoidee larghe ma non profonde, i processi trasversi per la articolazione della mandibola molto robusti. Medialmente le bullae tym-panicae, ben sviluppate, si spingono fino ai processi pterigoidei dell'alisfe-noide. Il diametro trasverso dei timpanici (cm. 8) è pari al 114% di quello dei processi articolari trasversi (cm. 7). Ben visibili i fori della base del cranio, in particolare i canali alisfenoidei ed i carotidei interni.
Il basioccipitale è arcuato all'estre-mità post. dove costituisce il bordo inf. del f.m. e il pavimento iniziale della cavità cerebrale, anteriormente si estende diritto ed obliquo verso il basso, come il basisfenoide. l timpanici, come s'è già detto, sono ben sviluppati ed occupano un'ampia superficie avanti e lateralmente al basioccipitale; medialmente e dietro ai processi articolari trasversi degli squamosi, le loro estremità anteriori (processi pte.rigoidei del timpani co) si addossano al bordo posteriore dei processi pterigoidei dell'alisfenoide. All'altezza del processo articolare tras-verso si aprono le coane nasali interne (c.n.int.) con asse longitudinale leg-germente inclinato verso il basso avanti. Esse sono delimitate inferior-mente dalla volta palatina che s'in-curva ad arco in avanti ed è ispessita da una cresta mediana sagittale. Sotto al palato sporgono in basso, diver-gendo leggermente tra loro, i ptocessi alveolari dei molari. Avanti ad essi si estendono per breve tratto i mascellari con l'alveolo delle piccole difese; essi si allargano lateralmente fino ai processi zigomatici dei mascellari, che sono molto appiattiti.
Manca completamente. Restano le radici del processo zigomatico dello squamoso e del processo zigomatico del mx. a sinistra; dalla loro posizione reciproca si deduce che l'osso zigo-matico era molto lungo e diretto quasi orizzontalmente dal dietro in avanti. Poichè la regione intermedia del cranio (veduta ventrale) è molto lunga, l'arcata zigomatica doveva es-sere anch'essa lunga e quindi relati-vamente stretta, specialmente in avan-ti; subtriangolare.
« Il Crocifisso» Tav. l; Tav. Il, 1-2
In basso gli squamosi formano gli angoli inferiori della faccia occipi-tale, ben sviluppati. Anteriormente si aprono le docce postglenoidee ampie e allargate verso l'interno. Lo sviluppo trasversale dei timpanici, che sono male individua-bili, rispetto a quello dei processi articolari trasversi è dell'SO%. Non sono individuabili i fori della base del cranio.
La regione occipitale ventralmente è ben sviluppata. Il basioccipitale ben arcuato sotto al f.m., si estende diritto e non molto inclinato in basso e avanti; il basisfenoide avanti ad esso prosegue con lo stesso andamento fino alla volta sup. delle c.n.int. (lungh. 25,5 cm.). l timpanici sono ancora ben sviluppati e si trovano avanti e lateralmente al basioccipitale, medialmente e dietro ai processi arti-colari trasversi; i processi pterigoidei dei timpanici si addossano in basso al bordo posteriore dei processi pteri-goidei dell'alisfenoide, per 2/5 della lunghezza di questi. All'altezza dei processi articolari tras-versi si aprono le c.n.int. piuttosto basse e larghe, il cui asse longitu-dinale è obliquo in basso e in avanti. Esse sono delimitate inferiormente dalle ossa palatine, a pavimento ispes-sito posteriormente (per la forma-zione di seni interni) e portano infe-riormente una pronunciata cresta lon-gitudinale mediana. Sotto al palato sporgono in basso i mascellari con i processi alveolari dei molari lenta-mente convergenti in avanti e pochis-simo divergenti in fuori. Avanti ad essi i mascellari e lateralmente i pmx. si allargano a formare l'ampio ven-taglio tra gli alveoli divergenti delle difese. Il bordo ant. è festonato.
Le arcate sono conservate entrambe, ma alquanto deformate. I processi zigomatici dei mx. sono ben svilup-pati in larghezza e formano con i mx. i grandi fori infraorbitali per il pas-saggio della branca del trigemino, che innerva tutta la proboscide. Gli ossi zigomatici che vi si articolano in avanti, si restringono subito dopo e divengono molto sottili e depressi; indietro si raccordano con una lunga sinostosi ai processi zigomatici dei temporali. La direzione dell'arcata, in posizione fisiologica, di profilo, è suborizzontale, appena declive in avanti. Ventral-mente, a parte la deformazione subita, le arcate zigomatiche sono ovoidali con diametro massimo spostato nel terzo post. con apici largamente ot-tusi.
-
N° 25 Mus. Pal. Univ. Tav. V, 2
Il diametro trasverso dei timpanici è pari al 54% di quello dei processi articolari trasversi dei temporali.
La regione occipitale ventralmente è ancora ben sviluppata. Il basioccipi-tale è incurvato, in grado minore del cranio precedente, sotto al f.m., e poi si estende stretto e diritto verso il basso, proseguito in avanti dal basisfenoide fino alla volta sup. delle c.n.int. (lunghezza 23 cm.). I timpanici sono conservati solo in lembi marginali, il che ha permesso tuttavia di misurarne il diametro trasverso; sembra che i loro processi ant. non arrivino più al bordo post. dei processi pterigoidei dell'alisfe. ncide. Un po' avanti ai processi arti-colari trasversi si aprivano le c.n.int. di cui sono conservate solo le pareti post.-inferiori; sembra che esse siano alte e strette, e che formino con la base del cranio un angolo di 1580. Mancano i palatini. I processi palatini del mx., molto ispessiti (cm. 9), sono rotti posteriormente e lasciano vedere la diploe ricca di ampi seni. Sotto al palato sporgono brevemente i mx. con i processi alveolari dei mo-lari larghi, divergenti in fuori e ben convergenti in avanti. Avanti ad essi i mx. con l'ampia partecipazione laterale dei pmx. si dovevano allargare a formare il ven-taglio tra gli alveoli delle difese, che sono nettamente divergenti, ma si interrompono invece subito per frat-tura.
Le arcate non sono conservate. Il lato destro porta il processo zigoma-tico del temporale a cui è sottesa l'estremità post. dello zigomatico, molto alta, ma sottile, per quasi un terzo della lungh. dell'arco zigoma-tico. Anteriormente è visibile solo la radice del processo zigomatico del mascellare. In posizione fisiologica, l'arcata, rico-struita idealmente, scende in avanti con pendio molto ripido: l'estremità post. dista dal piano alveolare più del doppio dell'estremità ant. Ventralmente l'arcata aveva forma ovoide con lato interno medialmente rientrante così che era larga e corta; il massimo diametro trasverso si do-veva trovare piuttosto indietro.
« Via dell'Impero >> Tav. VI
Le docce postglenoidee sono ben svi-luppate, anche in senso antero-post. Il diametro tr:ocsverso dei timpanici è pari al 73,9% di quello dei processi articolari trasversi.
Benché la regione occipitale dal lato ventrale sia ancora abbastanza svi-luppata in lunghezza per l'estensione degli squamosi, essa risulta però ap-piattita sul piano occipitale, in modo particolare a carico degli esoccipitali. Il b~sioccipitale non è molto arcuato nella sua parte post. dove appare largo e appiattito, s'incurva invece in avanti al contatto con il basisfenoide che è quindi diretto bruscamente in basso (elevata baticefalia). Tutta que-sta regione appare larga e corta. I timpanici sono molto ridotti e man-cano della parete superficiale per cui sono visibili i loro numerosi seni. I loro processi ant. sono molto abbre-viati e si spingono per tratto molto breve lungo il bordo post. dei processi pterigoidei dell'alisfenoide (circa per 1 /4 della lungh. di questi ultimi). Avanti ai processi articolari trasversi, ben sviluppati, si aprono le c.n.int. il cui asse longitudinale è quasi verti-cale. Esse sono grandi e strette anche inferiormente. I palatini, che ne costi-tuiscono la porzione post. del pavi-mento, sono reflessi in fuori, larghi e non presentano cresta sagittale me-diana nel loro lato inf. La volta del palato è larga e bene arcuata. Sotto di essa sporgono i processi alveolari dei molari, che sono stretti, rapida-mente convergenti in avanti e diver-genti in fuori; essi sono alti, perché nel loro interno e quasi affiorante portano il M 3 • Avanti al palato il cranio è rotto, mancano quindi il ventaglio e gli alveoli delle difese. Le arcate mancano completamente. La posizione delle superfici di frat-tura dei processi zigomatici, del tem-porale e del mascellare, indica la direzione dell'arcata zigomatica (vista di profilo in posizione fisiologica) come molto obliqua verso il basso avanti: l'estremità post. dista in al-tezza dal piano alveolare più del doppio dell'ant. Ventralmente, dato il relativamente breve processo articolare trasverso, l'arcata zigomatica non doveva essere molto ampia.
-
CRANIO
Misure m cm.
1 Lunghez~a: margine distale premascellari (nel piano sagittale) - sommità cramo
2 Distanza bordo ventr. foramen magnum - margine distale premascellare
3 Estremo post. condilo sinistro - punto medio inf. distale dell'alveolo difesa
4 Bordo distale premascellari - bordo anteriore coane interne
5 Bordo ventrale f.m. - bordo ant. coane interne
6 Bordo distale premascellari - punto prossimale ventrale alveolo difesa
7 Bordo ventrale f.m. - punto prossimale ventrale alveolo difesa
8 Bordo distale premascellari - punto all'altezza del limite anteriore dei molari
9 Bordo ventrale f.m. - punto all'altezza del limite ant. dei molari
10 Bordo ventrale f.m. - punto mediano volta coane nasali interne.
11 Bordo distale premascellari - punto mediano bordo inf. coane nasali esterne
12 Bordo distale premascellari - punto massima concavità frontale sul piano sagittale.
13 Margine distale alveolo difesa - estremità ant. nasali
14 Sommità del cramo - estremità sup. nasali .
15 Sommità del cramo - bordo inf. coane esterne
16 Bordo ventrale f.m. - punto massima concavità frontale sul piano sagittale .
17 Bordo di.stale premascellari - limite ant. depressione mediana del vertice del cranw
18 Larghezza tra le due bozze parietali .
1 9 Larghezza a livello degli squamosi .
20 Larghezza tra i bordi esterni degli alveoli dei molari
21 Distanza tra i margini esterni dei condili occipitali
22 Larghezza a livello dei fori infraorbitali
23 Distanza tra i lati esterni delle estremità distali degli alveoli delle difese
24 Distanza tra i lati interni delle difese all'uscita degli alveoli
25 Distanza tra gli apici delle apofisi postorbitali del frontale
26 Distanza minima tra i margini dorsali delle fosse temporali
27 Distanza minima tra i margini sup. delle fosse temporali
E. meridionalis NESTI
154
113
91
79
35
49,7
64,3
61
53
22,8
85
113
100
54
66
54,5
131
90
91
-23
52
54
9
82
44
47
no 170 Mus. Pal. Univ.
Roma Cr. Infantile
(52+)
41,6
-22,4
22,7
--
5
33,7
17,1
-
---
--
-
(54)
(41 ,8)
(14)
--
11,7
(7,7)
---
(*) Per comodità di confronto, specialmente a1 fini delle considerazioni ontogenetiche, nelle tabelle biometriche non è st~
46
-
TAB. l
E. antiquus FALC. e CAUTL. (*)
lP.I. 2°» Pigna- « Via dell'Impero » Pigna-
no 25 Mus. taro Interamna taro Interamna
-
-··- ----
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4&
49
so 51
CRANIO
Misure m cm.
Larghezza tra le arcate zigomatiche (all'altezza dei processi articolari trasversi)
Vertice cranio-margine inf. condili occipitali
Vertice cranio-linea alveolare
Vertice cranio-superficie di masticazione dei molari
Distanza vertice del cramo - margine sup. f.m.
Distanza vertice del cramo - bordo sup. delle orbite
Asse piano respiratorio: bordo su p. coane esterne - bordo su p. coane interne .
Bordo ventrale f.m. - punto medio bordo sup. coane esterne
Massima profondità fossa temporale (presa trasversalmente alla metà della arcata zigomatica)
Distanza centro meato uditivo esterno - bozza parietale
Distanza centro meato uditivo esterno - apice apofisi postorbitale
Distanza apofisi postorbitale - processo zigomatico del mascellare
Condili
Diametro processo articolare trasverso delle mandibole .
Diametro bulla tympanica (n° 42/n° 41 X 100)
Coane nasali interne: altezza
Coane nasali interne: diametro trasverso massimo
Coane nasali esterne : diametro trasverso
Coane nasali esterne: altezza massima
Foramen magnum (diametro trasverso x altezza)
Foro infraorbitale
Diametri orbite (dorso ventrale-trasverso) .
Distanza apofisi postorbitale - arcata zigomatica .
Fossa glenoidea posteriore al processo articolare trasverso
52 Lunghezze prese nella faccia ventrale:
Estremità distale premascellari - estremo post. occipitale .
Punto mediano avanti ai molari - estremo post. esoccipitali
Distanza punto posteriore occipitale - lato anteriore processo trasverso
Processo trasverso - punto posteriore mediano palatini .
Punto posteriore mediano palatini - estremità ant. alveoli molari
53 Dislivello tra processo zigomatico del mascellare e processo zigomatico dello
54
55
56
48
squamoso
Rapporto tra vertice cramo - superficie masticazione molari f ghezza piano respiratorio
l un-
Rapporto tra la distanza apofisi postorbitali e la distanza mmtma tra i margini dorsali delle fosse temporali
Rapporto tra lunghezza e altezza della regione sfenoidale - palatino-ma-scellare (Fig. 9)
E. meridionalis NESTI 1
c Aquila»
68
65-75
90
100
62
74,4
57,5
6&,5
22
59
41,5
11,5
33,5 ~
12-13 ~ 37,3%
14-15
10
55
14,7
8,& x 11
9,5 x4
24-16
11,5
173,9%
186%
-------
7
&
no 170 Mus. Pal. Univ.
Roma Cr. Infantile
(40,4)
(44,4)
(220)
17,9
~ 114% 12
8
7
8
4,6 x (4)
6,2
45
40
20
6,5
18,5
4,5
165%
-
segue TAB. l
E. antiquus FALC. e CAUTL.
• Via dell'Impero • «P.I. 1° • Pigna-
• P.I. 2° • Pigna- taro Interamna «Viterbo» taro Interamna « li Crocifisso » no 25 Mns. (Roma) De Lorenzo «Pian dell'Olmo>>
D'Erasmo-Mon- (Riano) Pal. Univ. Mus. delle e D'Erasmo Trevisan
charmont, 1955·
l (Roma) Origini. 1926 e 27; 1948
(Riano) Univ. Roma
Osborn 1931
l 62 68 67 - -
l - 88
46 (49) - 58 - - 55 l - 68 (57+) 67 - - 85 - 76 (+61) 79,4 99,9 - 91,5 39 (36) - 49 - - 51 - - - (34,5) - - 64,5 - (35) (33) 47 - - 42 - (43) 35,2+ 53,5 - - 57 - 16,5 (21+) - - - 28 37 (31) - 40 - - 50 29 28 - - - - 38,5 9 - - - - - 9,5
- 14,5 x 11 13,5 x 8 - - - 13,5 x 9,2 - 12,5
~ 14,7
~ 11,5+ ~ (13) - - 20
} - 10 80% 8,5 57% 8,5 (65%) - - 7 35% - 12 (16) 12 - - 15 - 11 (7) 10 - - 10 - 36 - 21 - - 56 - 12,5 11 8 - - 17 - 9,3 x 10 10 x 9,5 9,1 x8 - - 10,6 x 12 - - - - - - 6,7 x 5,5 - 11 x 18 - - - - 9x4,5 - - - - - - 16,5 x 16 - 13x 8 Ds 15 x8 - - - 38x 7
15 X 7 Sn
- 103 - - - - 105 - 62 60 62 - - 63 - 26 22 30 - - 21 - 26 27,8 2 - - 13 - 25 18,5 31 - - 28
- 2-3 17 7,5 - - 3-4
- - - - - - 217,8%
- - - - - - 96%
- 122% 112% 96% - - 80%
49
-
a Fig. l b
FIG. 1 - n° 170 Mus. Pal. Univ. Roma. Disegno schematico delle ossa del cranio con le suture visibili. a) profilo; b) faccia occipitale. Si nota lo sviluppo degli esoccipitali rispetto a quello degli squamosi.
Eo. esoccipitali; f.l.n. fossa ligamentum nuchae; Fr. frontale; m.u.est. meato uditivo esterno; Mx. mascellari; Pa. parietali; p. As. ali pterigoidee dell'alisfenoide; So. sovraoccipitale; Sq. squamosi.
- Number 170 Paleontological Museum University of Rome. Scheme drawing of the skull bones with the su tures apparent. a) profile; b) occipital face. Observe the development of the exoccipitals in comparison with that of the squamosals. Eo. exoccipitals; f.l.n.fossa ligamentum nuchae; Fr. frontal; m.u.est. external auditive meatus; Mx. maxillary; Pa. parietal;
p. As. pterigoid wings; So. supraoccipital; Sq. squamosal.
Fig. 2
FIG. 2-
-
Cavità cerebrale ed encefalo
(Tav. III, 2a, 2b; figg. 3 e 4 nel testo)
Nel cranio adulto di in rapporto al fatto che la battcefalia non è molto avanzata per un individuo della sua età (50 anni circa).
È stato possibile ricavare un calco sufficiente-mente attenclibile della cavità endocranica; esso riproduce naturalmente il cervello ancora avvolto nelle meningi, ciò nonostante è possibile trarne qualche informazione utile.
DIMENSIONI IN CM. TAB. 2
Diametro massimo antera-posteriore 29,5
Lunghezza emisferi cerebrali (lobi 19 temporali cm. 11)
Lunghezza regione cerebellare 10
Diametro massimo traverso (ai lobi 32,5 temporali)
Larghezza lobi frontali nella porzione 19,5 post. (avanti alla scissura di Silvio)
Larghezza regione cerebellare (metà 26 sinistra 13 cm.)
Altezza massima dorso-ventrale 21,5
Il modello dell'encefalo di
-
ranza anulare. Nel margine posteriore di questa lateralmente dovrebbe trovarsi l'uscita del nervo facciale, che negli elefanti è enormemente svilup-pato perchè il suo ramo mascellare innerva tutta la proboscide; però nel nostro caso non è conservata traccia di questa radice.
A contatto dei lati mediali dei lobi temporali invece, come s'è già detto, sporgono le radici del trigemino; esse sembrano meno divaricate di quanto lo siano nel calco dell'es. di E. meridionalis di Senèze (Dechaseaux, 1958 in Piveteau VI, 2, pag. 293, :fig. 4) il che è in rapporto al maggior grado di accorciamento e curvatura del cervello di >, il che è giusto dato che questo ultimo è meno differenziato.
Singolare è invece il confronto con i calchi del-l' encefalo degli elefanti viventi effettuato dallo stesso autore. In Loxodonta africana il cervello risulta più accentrato ed arcuato che nell'elefante indiano. Il fatto può essere messo in relazione con la maggiore spinta in avanti subita dal cervello del primo a causa della maggiore inclinazione del piano occipitale (fig. 10). Su E. antiquus Io stesso angolo > è minore di quello dell'elefante indiano e anche di E. meridionalis
c e
d f
Frc. 3 - Modelli artificiali della cavità cerebrale che mostrano il progressivo incurvarsi dell'asse longitudinale del cervello e la tendenza dei lobi frontali a ricoprire i bulbi olfattivi. Si nota una buona corrispondenza tra l'encefalo di (da Osborn); e) E. indicus L. (da Osborn); f) Loxodonta africana (BLUM.) (da O~born). - Intracranial b~ain casts that sho~ the pr?gressive ~endin~ of_ the longitudinal axis of the brain and the tendency of the frontal lob1 to cover the olfattlve bulb1. There 1s a sat1sfymg correspondence between the brain of " Pian del-l'Olmo :· (c) and that ?f" P_. I. 1° " (
-
Il v
c v h
p.a.
Fig. 4
FIG. 4 - Modelli artificiali della cavità cerebrale di: a) E. meridionalis NESTI, Senèze (da Dechaseaux in Piveteau VI, 2, fig. 4); b) E. antiquus FALC. e CAUTL. >) la flessione più accentuata dei lobi frontali che ricoprono, seppure di stretta misura, i bulbi olfattivi (bo), l'aumento relativo del diametro trasverso in conispondenza dei centri motori situati avanti alla scissura di Silvio e la contrazione dei diametri in senso antero-posteriore; tutti questi caratteri testimoniano il grado di evoluzione maggiore del cervello di E. antiquus rispetto a E. meridionalis. Sono individuabili nel calco dell'encefalo di
-
lari e dei palatini e delle ossa della base del cranio rispetto al loro accrescimento in lunghezza, con conseguente abbreviazione del palato e della re-gione fronto-sfenoidale (cirtocefalia). Questa abbre-viazione va accentuandosi durante tutto lo sviluppo, a ritmo molto accelerato dall'età infantile alla gio-vanile, più lento dalla gioventù all'età matura.
C'è una notevole differenza nella velocità di dimi-nuzione degli angoli sopraddetti tra i crani di Riano e quelli romani; questi ultimi infatti hanno un grado di cirtocefalia molto più avanzato propor-zionalmente all'età individuale; il fatto è reso ancora più evidente dal valore dell'angolo che è in rapporto alla direzione della tangente alla fronte, la quale nei crani romani è avvicinata alla verticale. I crani di Riano risultano più prognati, cioè ad uno stadio evolutivo più arretrato, inoltre vi si nota una minore divergenza degli alveoli delle difese che nei crani più evoluti romani; di conse-guenza il bordo distale del ventaglio è negli esem-plari di Riano piuttosto stretto: nel cranio di Pian dell'Olmo si può calcolare di 80 cm., molto infe-riore alla misura di cm. 98 dell'elefante di Vi-terbo e anche del cranio di Pignataro Interamna, nel quale questa misura è stata calcolata (85,7-90 cm.).
MASCELLARI (mx.) e PALATINI - Con l'età au-menta la baticefalia e di conseguenza diminuisce l'angolo >.
L'ispessimento della diploe, specialmente sul lato post. dei mascellari, concorre all'aumento della cirtocefalia.
Il palato, costituito dai processi palatini dei mx. e dai palatini, si presenta lungo con molari pochis-simo convergenti in avanti nei crani di Riano e nel cranio infantile romano, corto con molari forte-mente convergenti negli altri esemplari romani.
Una condizione intermedia a questo riguardo presentano (Osborn, 1931, pag. 10, fig. 8; 1942, pag. 1244, fig. 1101) e l'esemplare di Viterbo (Trevisan, 1948, tav. IV, fig. l) che hanno palato abbastanza lungo e molari lentamente con-vergenti.
Se osserviamo lo stato dei molari nei diversi esemplari, vediamo che hanno palato molto corto e molari molto convergenti quegli esemplari che portano un solo molare in funzione (come è il caso degli es. di Via dell'Impero e del n° 25 Mus. Pal. Univ.), mentre hanno palato più lungo e molari
54
meno convergenti gli esemplari che portano in funzione contemporaneamente due molari (nel no-stro caso residui di M 1 e M 2 ed M 2
e M 3 e ); sembra ragionevole dedurre che questo carattere non dipenda tanto dallo stadio evolutivo, quanto dallo stato dei molari e quindi dall'età, almeno per la maggior parte.
In relazione allo stadio di crescita dei molari è anche il valore dell'altezza dei loro alveoli, che infatti sono più alti quando il molare è all'inizio dell'uso.
La cresta obliqua sulla parete laterale del processo dei molari è molto sviluppata in alcuni esemplari, quasi inesistente in altri, come nel cranio de > e in quello del n° 25 Mus. Pal. Univ.; si può pensare che ciò sia dovuto a differenze ses-suali.
NASALI - La forma della loro estremità distale è ottusa, con lati convergenti ad angolo acuto, nei crani di e ; appuntita, con lati convergenti ad angolo molto più grande, nei crani di >.
Dall'esame della sez. A. di Osborn (fig. 5) si ricava che l'ampiezza dell'angolo secondo il quale convergono i lati dei nasali cresce con l'età, mentre la punta da ottusa diviene appuntita.
Nei crani più evoluti (>) o è spostata in avanti sulla metà dei molari (
-
l (·-·---------·-·---·-·r·-·-·-·-·-·-·-·---. ...,_ \ +-' .) •• l .. ----·· .. ._ .. ""----.. --- --- ... .._...
SEZ.B
-·-·---· (. ,_.·.·. ~ -·-··· "' ........... _..... ,.-. ····-·-·-·-···
-·-·-·-·-·)
---·-·-
SEZ. A
Fig. 5
P.I. 20 Il Crocifisso Via dell'Impero Pian dell'Olmo
FIG. 5 - In basso: Diagramma delle sagome del contorno dei nasali (Sez. A di Osborn). I bordi laterali delle ossa nasali confluiscono al centro secondo un angolo che diviene più ampio dall'esemplare più giovane al più vecchio,
mentre la estremità dei nasali diviene più appuntita. In alto: Sezione trasversale della fronte o ìntertemporale (Sez. B di Osborn), molto ampia, uniformemente convessa
nei giovani; pianoconvessa, con rilievi ai lati, nei più vecchi. Gli esemplari sono ordinati secondo l'età dei singoli individui.
- Below: Diagram of the outline of the nasals (section A of Osborn). The latera! edges of the nasals tend toward the center following an angle that gets wider the older the specimen is, while the extremity of the nasals become
more pointed. Above: Vertical transverse frontals, intertemporal (section B of Osborn), very wide, uniformly convex in the young
specimens, piano-convex, with prominences at the sides in the older ones. The specimens are placed in the figures according with their ages.
55
-
molari (conseguenza dell'aumento della ipsicefalia già discusso), mentre per l'aumento in altezza delle ossa an t. della base del cranio (etmoide e sfenoide) l'estremità post. dell'asse e l'apertura nasale interna volgono verso il basso.
FRONTE - Come s'è ripetutamente notato, con l'età la fronte tende a ridursi proporzionalmente in altezza per lo sviluppo verso l'alto delle ossa sottostanti; a ciò si aggiunge, specie nel maschio, la riduzione dovuta allo sviluppo in avanti del toro.
Dall'esame della Sez. B di Osborn (fig. 5) si nota, con l'aumentare dell'età, la progressiva esten-sione trasversale della fronte ed in particolare l'aumento dello spazio intertemporale a cui si ag-giunge una variazione morfologica, poichè si passa da una fronte uniformemente convessa nell'età più giovanile, ad una fronte la cui linea di sezione, ancora convessa al centro, presenta un'inflessione ai lati che risale appena all'estremità laterale nel giovane adulto, fino a raggiungere nell'età matura una fronte la cui linea di sezione è pianeggiante nel mezzo con forti rilievi alle estremità laterali.
In rapporto a E. meridionalis e al vecchio in-diano, E. antiquus ha fronte molto più estesa nella regione intertemporale.
Alla luce di queste osservazioni i due es. di Riano, confrontati con gli esemplari romani, posseggono fronte ancora sfuggente indietro, proporzionalmente bassa, con diametri trasversi meno diseguali e bozze parietali meno prominenti e meno nettamente sepa-rate. Mentre i crani romani hanno fronte raddriz-zata, cupola parietale molto elevata sopra al dia-metro trasverso massimo, depressione mediana che supera le bozze parietali, più accentuate (fig. 11 ).
La regione frontale del cranio di Viterbo (Tre-visan, 1948, pag. 12, fig. 3) per la posizione avan-zata, la direzione vicina alla verticale, la cupola parietale alta sopra il diametro trasverso massimo e per le bozze parietali accentuate ed ampiamente divise, si avvicina agli esemplari romani.
I due esemplari di Pignataro Interamna per i rapporti diametrali, la direzione della fronte e l'alta cupola parietale con le due bozze parietali profondamente divise, sono vicini ai crani romani e all'elefante di Viterbo. Manca però nei due esem-plari campani, o è molto ridotto, il toro soprafron-tale; probabilmente ciò è in rapporto a differenze sessuali.
56
CAviTA' ORBITARIA - La pos1z10ne delle orbite rispetto al meato uditivo esterno (m.u.est.) e alla arcata zigomatica resta praticamente invariata nei vari stadi di sviluppo se si considerano le posizioni relative in senso antera-posteriore e dorso-ventrale; rispetto all'apertura nasale esterna e ai processi mascellari dei molari, si sposta invece con l'età; infatti l'apertura nasale si sposta in alto rispetto alle orbite, mentre i processi mascellari dei molari, data l'accelerazione dell'aumento in altezza rispetto a quello della lunghezza, tendono ad arretrare; in conseguenza le cavità orbitarie, che sono situate dietro ai molari nel cranio infantile, passano gra-dualmente avanti a questi dai crani più giovani al più maturo; ciò è comune a tutti gli elefanti.
PARIETALI - In tutti i cram m esame i parietali hanno ampio sviluppo e formano la cupola cranica, la porzione superiore della fronte, la regione della cresta occipitale, la porzione superiore e posteriore delle fosse temporali.
Dal cranio infantile a quello dei giovani e allo adulto, si segue il contrarsi della fronte con ridu-zione della porzione ant. dei parietali che si spo-stano verso l'alto; causa di questo spostamento è il risalire dell'apertura nasale est. conseguente al raddrizzamento dell'asse respiratorio e il sollevarsi di tutta la volta cranica in conseguenza della forte pneumatizzazione. Per l'aumento dell'altezza del cranio, senza un adeguato aumento della lunghezza, specie nella regione mascellare, la posizione della volta cranica relativamente alla faccia cambia, si sposta in avanti e viene a trovarsi, nei più vecchi, sulla stessa verticale degli alveoli dei molari (fig. 9).
Se osserviamo i nostri esemplari, vediamo che si possono fare delle distinzioni anche per questo carattere: negli esemplari di Riano l'aumento della ipsicefalia e della cirtocefalia con la conseguente baticefalia ora descritte, hanno un ritmo più lento e raggiungono uno stadio meno avanzato anche nel cranio adulto, in confronto a quanto avviene nei crani degli esemplari romani; infatti il cranio di
-
concorso dei parietali in alto lateralmente e degli squamosi ai lati in basso.
Nei giovani si distinguono bene le suture rela-tive (fig. l h). II sovraoccipitale negli elefanti non è pneumatizzato, quindi si estende verso l'alto con una squama sottile e si approfondisce a formare la fossa ligamentum nuchae (con lamina sagittale esoccipitale); immediatamente sotto questa lamina, molto vicino alla superficie, si trova il lobo cere-bellare (Osman Hill ed altri, 1953). L'obliquità in avanti del sovraoccipitale esercita, come s'è visto, una pressione sul cervello e sollecita il suo ripiegarsi secondo l'asse antero-posteriore.
Gli esoccipitali sono ispessiti e sporgono sul piano occipitale nei crani più giovani; divengono piatti e meno distinti con il progredire dell'età. Tutta la regione posteriore del cranio diminuisce in lunghezza e si estende in larghezza con l'età, concorrendo, con l'abbreviazione della regione tim-panica-temporale e delle essa della base del cranio e con l'estensione trasversale degli squamosi e del piano occipitale, a dare al cranio un'accentuata brachicefalia (fig. 8).
In rapporto all'aumento dei diametri trasversali della faccia occipitale, il diametro trasverso degli esoccipitali aumenta più lentamente; quindi con l'età diminuisce in proporzione la loro estensione super-ficiale trasversa e in conseguenza il massimo dia-metro trasverso della faccia occrpitale si sposta verso l'alto; questo aumento relativo in senso trasver-sale della parte alta della faccia occipitale rispetto alla parte bassa è meno accentuato nei crani di Riano (>).
FORAME OCCIPITALE (f.m.) - Il foro occipitale, orientato quasi verticalmente nel cranio infantile, diviene obliquo dall'alto dietro al basso avanti in seguito alla posizione rialzata assunta dal cranio rispetto alla linea del dorso, posizione che dipende dall'angolo che il settore cervicale della colonna vertebrale fa con il settore toracico.
In E. antiquus, come vedremo, questo angolo era piuttosto piccolo, quindi l'animale doveva portare la testa abbastanza alta come del resto è proprio degli elefanti di foresta: E. meridionalis, E. indicus e, tra gli africani, Loxodonta africana cyclotis (Grassé, 1955, XVII, 1°, fig. 748).
FossA TEMPORALE - Dal cranio infantile a quello dell'adulto maturo, assistiamo ad un avanzamento
delle fosse temporali in senso antera-posteriore che porta il loro asse vicino alla verticale (aumento della baticefalia ), inoltre le pareti posteriori delle fosse stesse ruotano in avanti in modo che nello adulto sono orientate obliquamente in senso fron-tale specie con la loro parte superiore. Questo ultimo carattere, che tanto contribuisce a dare il suo aspetto caratteristico al cranio di E. antiquus rispetto a quello di E. meridionalis e degli altri Mammontinae, sembra legato ad un meccanismo di adattamento ambientale: infatti lo presentano in grado più o meno accentuato gli elefanti indiani e, tra gli africani, specialmente L. africana cyclotis (MATSCHIE), che sono elefanti ad habitat forestale e di clima oceanico.
I processi articolari trasversi degli squamosi sono robusti, estesi in fuori, e sporgono inferior-mente con una linea su borizzontale netta sotto al limite inferiore della faccia occipitale.
FACCIA VENTRALE - I temporali inferiormente portano le bullae tympanicae che, essendo a pareti sottili, sono raramente conservate e quasi sempre deformate; sono ben sviluppate nel cranio infan-tile, se ne possono individuare solo l'esistenza e la posizione negli altri.
Dato che i processi articolari trasversi del tem-porale aumentano di larghezza in misura e velo-cità diverse dei timpanici, abbiamo con l'età un variare delle proporzioni relative; infatti l'area occupata dai timpanici nel cranio adulto è molto ridotta rispetto all'estensione della regione artico-lare; una conseguenza di questo fatto è lo sviluppo di un lungo meato uditivo secondario (m.u. secon-dario) che serve ad assicurare la comunicazione con l'esterno.
BASE DEL CRANIO - L'accrescimento dei diametri trasversi dei temporali, occipitali e parietali e delle ossa della base del cranio, porta ad un notevole grado di brachicefalia, che è anch'essa conseguenza della diversa misura e velocità dell'accrescimento trasversale di queste ossa rispetto a quello longi-tudinale (antera-posteriore) (fig. 8).
La brachicefalia della regione post. del cranio, per quanto avanzata, è però meno accentuata di quella riscontrata nell'esemplare di E. meridionalis dell'Aquila.
Basioccipitale e basisfenoide si piegano progres-sivamente in basso in avanti, contribuendo all'ap-
57
-
profondirsi in senso verticale della regione post. del cranio, mentre la regione ant. piega in basso, arretrando ; cambia così l'orientamento delle coane nasali int. che tendono a disporsi ad angolo quasi retto con la base del cranio, rendendo sinuoso l'asse respiratorio che contemporaneamente si alza sul piano di masticazione. Il grado raggiunto da questi spostamenti è indice del grado di baticefalia, ipsicefalia e cirtocefalia raggiunto dal cranio (figu-re 6, 7, 9, 11).
Negli esemplari di Riano, in rapporto alla minore differenziazione, le c.n.int. sono dirette obliqua-mente in avanti rispetto alla base del cranio; l'asse respiratorio è relativamente basso sul piano di masti-cazione e la regione mediana è ancora abbastanza estesa in senso antero-post.; nei crani romani più evoluti, baticefalia, ipsicefalia e cirtocefalia sono più progredite, le c.n.int. sono orientate quasi verticalmente, l'asse respiratorio è diretto decisa-mente in alto e la regione mediana di tutto il cranio ha subito un forte accorciamento.
Nel settore mascellare l'aumento in altezza e la pneumatizzazione delle ossa palatine e dei processi palatini dei mascellari e la conseguente relativa abbreviazione, danno il grado di cirtocefalia del cranio e progrediscono con il crescere dell'indi-viduo.
In linea generale i molari tendono ad essere più convergenti e il palato più allargato posterior-mente negli esemplari più evoluti, ma la realizza-zione di questa tendenza è mascherata dal fatto
(spiegazione della fig. 6)
che la lunghezza del palato dipende anche dalla estensione della superficie masticatoria dei molari funzionanti.
La lunghezza degli alveoli delle difese, la loro divergenza, l'ampiezza del ventaglio che li unisce (pmx. e mx.) e l'approfondimento in basso di tutta la regione premascellare, progrediscono con l'età; tra questi caratteri, la divergenza delle difese e l'approfondimento in basso della regione prema-scellare sono meno pronunciati nei crani di Riano.
ARCATA ZIGOMATICA In rapporto al lieve grado di flessione, all'aumento in altezza e all'ac-corciamento relativo subiti dalle regioni mediana e mascellare, le arcate zigomatiche si presentano nei crani di Riano quasi orizzontali, a sezione subovale allargata posteriormente, con ossa zigomatiche larghe ma sottili di spessore; in questi crani il grado di baticefalia e di cirtocefalia è meno elevato. Le arcate zigomatiche sono invece forte-mente oblique in basso avanti, con ossa zigomatiche gracili nei crani romani (eccettuato il piccolo) che sono più baticefali e cirtocefali.
È da notare però che anche l'età,' seppure in grado minore, incide sulla direzione delle arcate zigomatiche; infatti nel cranio più vecchio di Riano esse sono un po' più oblique in basso avanti in confronto a come si presentano nel cranio più gwvane.
FIG. 6 - Sezione sagittale mediana del cranio (Sez. C di Osborn, modificata: è stata prolungata la sezion~ C fino a dare il profilo completo del cranio nel piano longitudinale mediano; ispirata a Osborn, 1942, II, fig. 1025). E possibile seguire il progressivo accorciamento (cirtocefalia), innalzamento (ipsicefalia) e approfondimento (baticefalia) del cranio dall'individuo infantile ai giovani, fino all'adulto di piena maturità. Contemporaneamente si ha progressivo aumento dell'inclinazione in avanti del piano occipitale, diminuzione in altezza della fronte (che s'incurva di profilo in una con-cavità longitudinale sempre più stretta) e aumento del toro soprafrontale. Le coane nasali est. sono spinte progressi-vamente in alto in conseguenza dell'aumento della cirtocefalia dei mascellari e dei palatini. Il ritmo di questi mecca-nismi di sviluppo, come è messo in evidenza dai diagrammi delle sagome, è più lento nei crani di Riano ( e
-
~ : :
' . \ . ' l \. ,' '. ~
--------------- n° 170 Mus. Pal. Univ. ------- P. I. 20
11 Crocifisso n° 25 Mus. Pal. Univ. Via dell'Impero Pian dell'Olmo
Fig. 6
59
-
CONCLUSIONI E CONFRONTI
L'esame dei dati biometrici e dei caratteri mor-fologici, come risultano dalla descrizione analitica degli esemplari esaminati e dallo studio delle sezioni orientate, rilevate dai crani stessi secondo il modo proposto da Osborn, ci permette di trarre delle conclusioni, che possiamo ritenere abbastanza atten-dibili, dato che si è potuto disporre di materiale insolitamente abbondante per elefanti fossili della stessa specie.
Cercherò di riassumere l'essenziale dei risultati conseguiti, considerando successivamente i diversi punti di vista:
1°) La ricostruzione dello sviluppo ontogene-tico del cranio di E. antiquus FALC. e CAUTL. come risulta con buona approssimazione dalle modifi-cazioni che intervengono nei singoli caratteri du-rante il progredire dell'età.
2o) L'attribuzione sistematica a E. antiquus FALC. e CAUTL.
3o) L'identificazione delle differenze muta-zionali nell'ambito di questa entità sistematica tra i rappresentanti della popolazione elefantina della
(spiegazione della fig. 7)
formazione tufaceo-diatomitica a N di Roma nei pressi di Riano (E. antiquus FALC. e CAUTL.) e quelli provenienti dai tufi e dalle ghiaie alluvionali di vari punti della città di Roma, da Pignataro Interamna e da Viterbo (E. antiquus italicus OSBORN).
Lasciando per un momento da parte la discus-sione sulla attribuzione sistematica e sul valore dei due stadi mutazionali, che verranno riprese più tardi, seguiamo le modifiche che intervengono nel cranio con lo sviluppo dell'individuo.
Sviluppo ontogenetico (da 6 anni a più di 50)
Il cranio elefantino in genere è alto e corto e tende a progredire sempre più in questo senso con l'avanzare dell'età; è noto che lo sviluppo dell'individuo si protrae fino alla piena maturità che corrisponde all'entrata in uso dell'ultimo mo-lare, cioè a 50 anni circa.
Il meccanismo che presiede a questo processo è dovuto:
a) alla IPSICEFALIA: allungamento dell'asse bati-cefalico (distanza vertice cranio - piano di masti-cazione) (fig. 7). Nel presente studio il termine è
FIG. 7 - Sezione sagittale laterale, passante per il punto più alto del bordo sup. delle c.n. est. e per il condilo destro (Sez. D di Osborn, modificata: anche questa sezione di Osborn è stata completata fino a rappresentare il profilo com-pleto dei crani nel piano sagittale laterale indicato). Gli esemplari sono ordinati secondo l'età dei singoli individui. Questo diagramma mette in evidenza, oltre all'aumento della cirtocefalia (particolarmente a carico dei mascellari e pala-tini) e della baticefalia (tendenza alla direzione verticale dell'asse ), la conseguente diminuzione dell'angolo , che raggiunge quasi il valore del retto («Via dell'Impero>>). Con il progredire di questi meccanismi evolutivi si passa dal cranio più lungo (in senso ant.-post.), più basso, più prognato, con piano sovraoccipitale proiettato indietro dell'età infantile al cranio relativa-mente più corto (cirtocefalo) e meno prognato dell'età adulta. La verticale abbassata dall'estremità distale dei nasali insiste sulla porzione posteriore dei molari nel cranio infantile e nei più giovani, si sposta in avanti con il progredire dell'età fino a che il grado di baticefalia raggiunto dal cranio è tale ch'essa cade avanti ai molari (>). Le sagome dei due esemplari di Riano ( e
-
.~·-·-·-·-· /.~ '·,
/" ' (,--------, \. ,/, ',
,' ' ,,'' . '\
,, ' ---·-·-·- .. ,'' . ,.,.-·-· ..................... / x·..- '· : /\ ' ,' / . \ ! .. ./ \ : \ \ \ \ \ : \
. ./
! ,, /' \ : l l \ \ 1. l \ i i l \ \~! ''· '·~·." \
SEZ.D
no 170 Mus. Pal Un1v P.l. 2° Il Crocifisso no 25 Mus. Pal. Un1v Via dell'Impero Pian dell'Olmo
·"·
Fig. 7
i j
\ . \ . \
' . \ • \ .
' \ .
\
61
-
stato esteso ad indicare l'aumento proporzionale di altezza anche di singole regioni del cranio.
b) alla BATICEFALIA: allungamento e rotazione dell'asse stesso dall'alto in basso e dall'avanti indietro con perno nella regione mediana del cranio ( otica-olfattoria ), mentre in conseguenza si approfondisce la norma facciale e si sollevano e inclinano in avanti la cupola parietale e la fronte. Il grado di baticefalia raggiunge livelli notevolissimi nell'adulto dei più evoluti rappresentanti della specie (figg. 6, 7, 9, 11 ).
c) alla BRACHICEFALIA: accorciamento relativo della regione occipitale, che non raggiunge però il grado accentuato presentato da altre specie (figu-
re 8 e 9).
d) alla CIRTOCEFALIA: accorciamento della re-gione mascellare, palatina e fronto-sfenoidale in relazione all'altezza, con esclusione dei processi alveolari delle difese; lo sviluppo in questo senso può raggiungere un grado molto spinto (figg. 7 e 9).
In altre parole, in seguito all'accelerazione della crescita dell'altezza rispetto alla lunghezza dei pmx., mx. e palatini, che è conseguenza dell'in-tensa pneumatizzazione di queste ossa, progressiva con l'età la distanza
-
0\ ~
------------- no 170 Mus. Pal. Univ. ------- P. I. 20 -··-··- Il Crocifisso
Via dell'Impero -·-o~._, Pian dell'Olmo
.,_ -~· '-- ........ ......_ ______ ...,.... . .,.-
. / /""" . ' • \
• \ .
\
:t ....... ,.. ., . '·-... l . . ·-·- '. ·----, ., / ' \ ' , ,. /' . \' \ ----- t' r· i • \ •
,' 'J \ l , . l • ,' . \ . \ . , \ . , / l ., . . . ' . , l , . ,'
: . l J l, ,' .-· , l t· .. ·-·-. . \ \ '·-·-·-r·-· /
.. . . . / \ \ ./, •, l •
. '• / ,. . . '·,. \-·-·-·~·~·--· / - ....... ·"'-. ..... ./ . ·, '•, . - . .. .. -· .
'· ' .,.. . ..... """'"-" ·~ -. '• . -- ~ -· '· . ..-, ..... . ...... ___ _ -....... _~:--SEZ. E
Fig. 8
Frc. 8 - Sezione occipitale orizzontale (Sez. E di Osborn). Gli esemplari sono ordinati secondo l'età dei singoli individui. Questa figura mette in evidenza il progressivo aumento dei diametri trasversi in rapporto a quelli longitudinali sagittali della regione occipitale (brachicefalia), l'approfondirsi della fossa ligamentare della nuca e l'aumento dello sviluppo trasversale degli squamosi rispetto agli esoccipitali, dal cranio infantile all'adulto di
piena maturità. Anche in questo diagramma si nota una minore velocità nello sviluppo di questa tendenza nei due crani di Riano.
- Horizontal occipital section (Section E of Osborn). The specimens are placed according to their ages. This figure shows the progressive growth of the transverse diameters in comparison with the sagittal longitudinal ones of the occipital region (br·achycephaly), the deepening of f.l.n. and the growing of the transverse development of the squamosals in comparison with the exoccipitals from child skull to the skull of an adult of a complete
maturity. In this diagram too is noticeable a slower speed in the development of these tenden
-
VARIAZIONE DEI RAPPORTI ANGOLARI E DELLE MISURE DI LUNGHEZZA NELLE DIVERSE REGIONI DEL CRANIO DI
(Variation of the angular ratios and of the length measures in the different regions of the skull of E. antiquus, from the infantile age to the complete maturity and with respect to the different mutational stage).
B B
CD
A B
Fig. 9
1) n° 170 Mus. Pal. Univ. Roma, cranio infantile; 2) > (Riano), 20-25 anni di età; 3) > (Riano), SO anni circa di età.
1) Number 170 Paleontological Museum University of Rome, infantile skull; 2) " Il Crocifisso " (Riano), 20-25 years; 3) "Via dell'Impero " (Roma), 30-35 years; 4) Number 25 Paleontological Museum University of Rome 30 years; 5) " Pian dell'Olmo " (Riano), about 50 years. '
64
-
E. antiquus, DALL'ETÀ INFANTILE ALLA PIENA MATURITÀ E IN RELAZIONE AL DIFFERENTE STADIO MUTAZIONALE.
A 8 B
Gli esemplari sono isorientati rispetto alla linea alveolare dei molari. L'angolo EAB dà lf! misura del prognatismo e diminuisce con l'età dell'individuo. La proiezione (B) di A (bordo inf. c.n.est.) sull'onzzontale si sposta progressivamente in avanti con l'età, in relazione all'avanzamento del cranio neurale e all'arretramento relativo dei molari. Il rapporto AB /CD indica il grado di cirtocefalia della regione sfenoidale-mascellare-premascellare-palatina e aumenta complessivamente con l'età; il valore relativo degli angoli ADC e CDB o, il che è lo stesso, il rapporto AC /CB dà le misure separate della cirtocefalia rispettivamente delle regioni premascellare-palatina e mascellare; questo rapporto diminuisce molto rapidamente dall'infanzia alla gioventù, per aumentare di nuovo dalla gioventù all'età matura. L'angolo ABD infine dà il grado di progresso della baticefalia nelle regioni anteriore e mediana del cranio, diminuendo con l'aumentare dell'età. Tenuto conto di queste modificazioni dovute allo sviluppo ontogenetico, vediamo che i due crani di Riano (2 e 5), relativamente alla loro età e in rapporto agli esemplari romani (1, 3, 4), più evoluti, sono più prognati, meno accen-tuatamente cirtocefali nella regione palatino-mascellare, molto meno baticefali e hanno molari meno arretrati rispetto alla verticale abbassata dalle c.n.est. Alla base delle singole figure sono indicate le misure dell'altezza della regione mascellare-palatina (AB) e le proiezioni delle lunghezze (diametri antera-posteriori) delle singole regioni del cranio; queste diminuiscono rispetto alle prime in rapporto all'età, ma in misura maggiore e con ritmo più veloce nei crani più evoluti (cfr. 2 con 3 e 4). Anche i rapporti tra le lunghezze dei segmenti tagliati sull'orizzontale dalle proiezioni di punti anatomici determinati (E.: confluenza delle linee alveolari dei molari; A: bordo inf. c. n. est.; D: bordo inf. m.u.est.; bordo su p. del f.m.; punto estremo dell'occipite) variano con l'età e con lo stadio evolutivo della specie; in modo particolare è da notare l'abbreviazione della regione occipitale (brachicefalia), molto più pronunciata nel giovane adulto di > (5).
These specimens have the same orientation of the alveolar line of the molars. The angle EAB gives the measurement of the amount of prognatism and becomes smaller the older the animai is. The projection (B) of A (inferior edge of the external nasa! choanae) upon the horizontal moves gradually forwards with the age, according to the moving forward of the neural skull and the relative hacking of the molars. The ratio AB /CD shows the amo un t of cyttocephaly of the maxillary-premaxillary-palatine region an d gradually increases with the age; the relative value of the angles ADC and CDB or, what is the same, the ratio AC /CB gives the separate measures of the cyrtocephaly respectively of the premaxillary-palatine region an d of the maxillary region: this ratio quickly diminishes from the infantile to the young age, to grow again from the young to the mature age. The angle ABD, at last, gives the degree of growing of the bathycephaly in the fore and median region of the skull and it gets smaller with the age. Taking notice of these modifications that are due to the ontogenetic development, we see that the two skulls of Riano (number 2 and 5) relatively to their age and in comparison with the roman more evoluteci specimens (1, 3, 4), are more prognate, their cyrtocephaly is less accentuateci in the palatine-maxillary region, are much less batycephalic and have less backed molars with respect to the vertical line drawn from the external nasa! choanae. At the bottom of each figure are shown the measurements of the height of the maxillary-palatine region (AB) and the projections of the length (antero-posterior diameters) of the single regions of the skull; these get smaller in com-parison with the former ones according to the age, but in a greater measure and with a quicker rate in the more evolved skulls (compare n. 2 with n. 3 and 4). Also the ratios between the lengths of the segments taken on the horizontal line of the projections of determined anatomie points (E = confluence of the alveolar lines of the molars; A = inferi or edge of the external nasa! choanae; D = inferior edge of the e.u.m.; the superior edge of f.m.; the extreme point of the occiput) vary according to the age and with the evolution degree of the species); particularly must be noticed the shortening of the occipital region (brachycephaly) much more accentuateci in the young adult of Via dell'Impero (number 3) than in the skull of advanced age of Pian dell'Olmo (number 5).
65
-
con diametro trasverso molto prevalente e spostato in alto.
Questa variazione nelle proporzioni della super-ficie sup. e inf. della faccia occipitale deriva dalla forte diminuzione trasversale degli esoccipitali rela-tivamente agli squamosi e ai parietali, i quali for-mano le superfici laterali sup. della faccia stessa.
L'estendersi in larghezza degli squamosi e spe-cialmente dei loro processi articolari trasversi e il mancato corrispondente allungamento in senso an-tera-posteriore, causa la brachicefalia del cranio degli elefanti in genere; nel cranio di E. antiquus, mentre l'allargamento suddetto è sensibilissimo, la diminuzione dell'allungamento degli squamosi è meno sensibile, quindi il cranio pur essendo brachicefalo non lo è in grado estremo.
Una sensibile modificazione di rapporti dimen-sionali si ha con l'avanzare dell'età tra il diametro trasverso dei processi articolari degli squamosi e quello della bulla tympanica (v. tab. l, pag. 48); infatti quest'ultima si accresce in modo minimo in larghezza, mentre il primo aumenta moltissimo dai giovani agli adulti di piena maturità; di conse-guenza il timpanico viene a trovarsi lontano dal-l'esterno e la comunicazione con questo deve essere assicurata da un lungo meato uditivo secondario.
Se studiamo il cranio nella faccia ventrale, oltre alla brachicefalia e ai rapporti dimensionali mutati tra timpanici e processi articolari trasversi dei temporali, si può apprezzare l'aumento progressivo della baticefalia; infatti l'apertura delle c.n.int., che nei giovani è diretta obliquamente verso il basso in avanti e delimita un ampio angolo con la base del cranio, nell'adulto diviene quasi verticale men-tre l'angolo corrispondente diminuisce fortemente; nello stesso tempo i processi alveolari dei molari si approfondiscono verso l'asse baticefalico.
Il toro soprafrontale, inesistente nei primi anni di vita, si individualizza già dalla prima gioventù (; ), diviene più pesante e reflesso medialmente negli adulti. La fronte, convessa nel giovane, diviene piana, fiancheggiata da due rilievi laterali nell'adulto: sez. B (fig. 5).
I nasali, larghi e a lati convergenti in un angolo relativamente stretto nei giovani, divengono ap-puntiti ad angolo convergente più ampio negli adulti: sez. A (fig. 5); nelle c.n.est. con l'età il diametro trasverso si allunga moltissimo rispetto all'altezza e si sposta in basso.
Il foramen magnum, diretto praticamente secondo la verticale nei crani infantili, diviene obliquo verso l'alto indietro nei giovani e negli adulti; questo
66
diverso portamento è in relazione alla posizione della testa rispetto alla linea del dorso; infatti il cranic, solidalmente con la regione cervicale della colonna vertebrale, ndl' età adulta forma con la regione toracica un angolo minore rispetto a quello che formava con la stessa nell'età giovanile. Il valore di questo angolo varia anche tra le varie razze di adulti della stessa specie; sembra minore per le forme adattate alla vita forestale (v. Grassé, 1955, XVII, 1°, pag. 731 ).
Posizione sistematica
Ultimata la ricostruzione dello sviluppo ontoge-netico attraverso le modificazioni morfologiche dovute all'età, possiamo stabilire la posizione siste-matica dei nostri esemplari.
Dalle precedenti descrizioni e dai confronti effet-tuati risulta chiaramente l'attribuzione dei cinque crani studiati a E. antiquus FALC. e CAUTL. Tutti presentano, infatti, nella misura propria alla hro età, i caratteri distintivi della specie che qui nas-sumo per quel che riguarda il cranio :
1°) Baticefalia e cirtocefalia abbastanza ele-vate: Sez. C e D di Osborn (figg. 6, 7, 9, 11);
a) valore medio dell'angolo tra piano occi-pitale e base del cranio (128° in
-
/ l
l
' \ \
, ~
/
\ \
\ \ \
,... .
---- C r. C. N EST l. Valdarno Aquila
-· -· Pian dell'Olmo no 6704 Mus. Zoologico Roma
Fig. 10
Fra. 10 - Valore dell'angolo tra E. meridionalis NESTI (> e ), E. antiquus FALC. f CAUTL. (
-
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL DIFFERENTE GRADO DI BATICEFALIA E CIRTOCEFALIA DI
~=============:-~--~~ A B
CD
A B A B
Fig. 11
I crani sono isorientati rispetto alla linea alveolare dei molari. Negli esemplari di Riano meno evoluti, la linea tangente al profilo della fronte e agli alveoli delle difese e quella tan-gente al bordo post. degli alveoli dei molari (presa al posto della base del cranio) formano angoli minori con l'orizzon-tale e sono per nulla o pochissimo convergenti in avanti; le stesse linee sono molto meno inclinate sull'orizzontale e rapidamente convergenti in avanti negli esemplari romani più evoluti.
68
-
E. antiquus FALC. E CAUTL. (ESEMPLARI DI RIANO) E DI E. antiquus itaficus OSB. (ESEMPLARI ROMANI)
A
A B
®
B
1) ), Riano; 2) « Pian dell'Olmo >), Riano; 3) n° 170 Mus. Pal. Univ. Roma; 4)
-
occipita!i sporgenti indietro a metà altezza ctrca. Cupola cranica elevata, ma non altissima, molto
ampia in senso antera-posteriore, pianeggiante in sommità, più o meno declive in avanti; bozze pa-rietali molto estese, prevalentemente in senso tras-versale, meno in altezza, separate da una doccia mediana larga ma non profonda.
Fronte costituita dal frontale sensibilmente ri-dotto in senso antera-posteriore, con ampia parte-cipazione dei parietali e coronata da un pesante toro reflesso in avanti, più o meno sviluppato secondo il sesso e l'età.
La fronte, diretta in alto e indietro nei meno evoluti, tende a raddrizzarsi seguendo la rotazione in avanti dell'asse baticefalico (figg. 6, 7, 11); di pro-filo è molto corta, piano-concava in basso, convessa in alto. In sezione trasversa (fig. 5), nei giovani è convessa con due depressioni laterali, negli adulti progressivamente diventa piana e le due depres-sioni laterali, meno accentuate, sono fiancheggiate sul lato esterno da due rilievi.
Fosse temporali ampie, specialmente in alto, con limiti netti, non bordati da creste rialzate eccetto che in corrispondenza della fronte. Estremità su-periore dell'asse progressivamente volgente in avan-ti; le pareti posteriori in alto si reflettono fino ad assumere un orientamento obliquamente frontale.
Nasali corti e larghi, a lati convergenti in un angolo ampio (fig. 5).
Coane nasali esterne non estese eccessivamente in larghezza, ad angoli arrotondati ai lati e dia-metro massimo più alto del bordo inferiore.
Orbite. La loro posizione nell'adulto è molto in basso rispetto alle coane nasali est.; con l'età si trovano sempre più in avanti rispetto ai molari in conseguenza dell'accorciamento della regione mascellare e del suo approfondimento che produce il progressivo arretramento dei molari stessi.
Mascellari molto sviluppati in altezza e pro· gressivamente diminuiti in lunghezza, con asse vol-gente progressivamente in basso (baticefalia) (fi-gure 6, 7, 11).
Premascellari progressivamente divergenti, quasi in linea con la fronte, tendono ad approfondirsi se-guendo il movimento dei mascellari; i due alveoli delle difese sono uniti da un ampio ventaglio con bordo festonato. Le zanne presentano la curva di E. antiquus (figg. 16 e 17).
Foramen magnum grande, con apertura diretta indietro e in alto. A questo proposito, ora che si conosce la colonna vertebrale, sarebbe da variare un poco l'orientamento dato da Osborn al cranio
70
di ; infatti, se si articola il cranio sull'a-tlante, tenuto conto dell'angolo che la regione cer-vicale della colonna vertebrale fa con la toracica, si vede che il cranio deve essere appoggiato un po' indietro, in modo che i condili si vengano a trovare un po' sotto all'occipite.
Questa posizione sembra sia propria degli ele-fanti di foresta in confronto a quelli di prateria.
CONFRONTI
Confronto con E. namadicus FALC. e CAUTL. e E. recki DIETRICH.
Dall'esarr.e di tutto ciò che abbiamo considerato finora risulta confermata la sostanziale differenza del cranio di E. antiquus da quello di E. namadicus FALC. e CAUTL. del Quaternario dell'India (De Lorenzo e D'Erasmo, 1932; Arambourg, 1942).
In quest'ultimo infatti il rapporto tra la faccia e la regione fronto-parietale è differente, poichè questa è molto ridotta e il vertice del cranio for-temente depresso, esteso trasversalmente e sormon-tato da un toro a forma di berretto frigio, pesante e uniforme, di aspetto molto tipico; gli alveoli delle difese sono più divergenti e la faccia è più larga; dì profilo il cranio di E. namadicus appare molto più ipsicefalo e baticefalo e il piano occi-pitale è proiettato più in avanti.
La somiglianza che si può trovare a pnma vista tra il cranio più vecchio di Riano (
-
dalla forma tipica; infatti in quest'ultimo l' ar-chitettura del cranio è molto diversa per il grande sviluppo, sia in altezza che in larghezza, della regione fronto-parieto-occipitale rispetto alla fac-cia; il toro soprafrontale è molto più accentua-tamente festonato, la ipsicefalia, baticefalia e cir-tocefalia sono di un grado inferiore sebbene già più elevato che negli esemplari di Riano.
E. antiquus risulta ancora più decisamente se-parato da E. recki DIETRICH: infatti i carat-teri dei crani di Riano come di quello di Via dell'Im-pero permettono di confermare le conclusioni che Arambourg ( 1942) ha potuto trarre dallo studio del cranio di questa specie proveniente dall'Orno; quest'ultimo infatti è fortemente cirtocefalo, bati-cefalo e ipsicefalo, ha profilo occipitale verticale ed è caratterizzato da bozze parietali fortemente proiettate in avanti verso l'alto e da una profonda fossa ligamentare della nuca che separa per tutta l'altezza della faccia posteriore le due bozze occl-pitali, molto accentuate. Il profilo concavo della fronte, il livello estremament