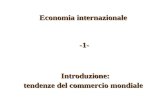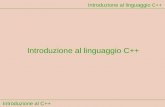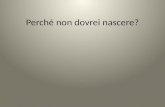Economia internazionale -1- Introduzione: -1- Introduzione: tendenze del commercio mondiale.
Introduzione
description
Transcript of Introduzione

Il 20 febbraio 1909 esce sul giornale «Figaro» di Parigi il Manifesto del futurismo. È il primo di una serie di manifesti con cui Filippo Tommaso Marinetti e i seguaci del movimento animano le cronache letterarie, artistiche e le piazze del periodo precedente la Grande Guerra in Italia, estendendo poi la loro influenza anche negli altri paesi europei. Il manifesto presenta con tono spavaldo la poetica del movimento: azione, ribellione, amore del pericolo fino alla temerità, militarismo, patriottismo, esaltazione della macchina e della velocità come simbolo di potenza e del mondo moderno, aggressività da cui deriva l’idea della guerra come purificazione del mondo, “le belle idee per cui si muore” e il disprezzo della donna nel senso della proclamazione della virilità temendo nell’emancipazione della donna la preponderanza del sentimentalismo sulla bellicosità. Nel Manifesto tecnico della letteratura futurista del 1912, Marinetti oppone all’ideale di ordine, armonia e eleganza il disordine delle “parole in libertà”: l’espressione sottratta ai vincoli della sintassi e liberata dall’impaccio della punteggiatura, l’abolizione dell’aggettivo affinché “il sostantivo nudo conservi il suo colore essenziale” e dell’avverbio “una fastidiosa unità di tono”. Marinetti impiega i segni matematici, le onomatopee, i caratteri tipografici diversi anche nelle dimensioni nella stessa pagina affinché il racconto sia la trascrizione sensoriale e non verbale della realtà.Il Futurismo tende per sua natura a occuparsi di politica: italianismo, modernità e mito di potenza ne caratterizzano l’atteggiamento. Il Risorgimento viene percepito come rivoluzione italiana incompiuta e si prefiggono di riprenderla e portarla al termine. La guerra in Libia e lo scoppio della prima guerra mondiale portano i futuristi a un impegno intenso e attivo, tramite dimostrazioni interventiste e all’arruolamento al fronte. Anticlericalismo, antisocialismo, antipacifismo sono le loro parole d’ordine. La guerra pare la realizzazione dell’ideale di vita moderna ed eroica, il rituale di rigenerazione purificatrice per preparare la nascita dell’italiano nuovo.
Nell’immediato dopoguerra i futuristi rivendicano il loro ruolo di profeti della nuova Italia e vogliono ispirare e guidare la nazione verso il compimento della “rivoluzione italiana” per forgiare un italiano virile, geniale, coraggioso.
L’11 febbraio 1918 il periodico “L’Italia Futurista” pubblica il Manifesto del Partito Futurista italiano, scritto da Marinetti: sono presenti i motivi del nazionalismo modernista, dell’italianismo, della pedagogia futurista, riforme istituzionali e sociali, minor toni bellicistici e antisocialisti e un aumento di quelli anticlericali.
Si crea una simbiosi tra arditismo e futurismo, poi tra arditofuturismo e fiumanesimo durante l’impresa di Gabriele D’Annunzio a Fiume (settembre 1919-dicembre 1920).

Si costituiscono dei fasci futuristi in varie città d’Italia. L’amore per l’azione, corroborato dall’esperienza della guerra, fa sì che il futurismo attragga a sé l’arditismo. L’arditofuturismo trasferisce lo stile della guerra alla lotta politica.
La politica dell’arringare la piazza, il rifiuto delle ideologie e della politica dei discorsi e la violenza contro gli avversari, diventano lo stile politico del fascismo. Marinetti partecipa alla riunione del marzo 1919 durante la quale Mussolini fonda i fasci di combattimento e i futuristi aderiscono alla costituzione dei primi fasci.
Futuristi, arditi e fascisti si trovano insieme nell’assalto alle sedi dell’ “Avanti!”, nello sbeffeggiare il nemico, nel compiere i riti di purificazione bruciando la stampa e le bandiere nemiche.
I due movimenti, anche se a volte vivono in simbiosi nelle stesse persone e Marinetti faccia parte della Commissione esecutiva dei fasci di combattimento, rimangono autonomi. Dal 1920, quando il fascismo comincia ad assumere un carattere reazionario e monarchico, i futuristi si allontanano dai fasci di combattimento e gli arditi dai futuristi.
I futuristi continuano a predicare una rivoluzione italiana e salutano l’impresa fiumana del soldato-poeta Gabriele D’Annunzio (occupazione della città di Fiume, settembre 1919-dicembre 1920), come il preludio di una mobilitazione di tutte le forze vive alla conquista del potere. Ma come nei confronti del fascismo, anche rispetto all’impresa fiumana l’entusiasmo rivoluzionario del futurismo si scontra col realismo politico: maestri nel campo della propaganda ideale vengono visti con fastidio per il loro continuo ribellismo. Marinetti e i futuristi, durante il regime fascista, accettano di indossare la camicia nera continuando ad avere comportamenti da ribelli, ma solo all’interno del mondo dell' arte. La loro ribellione non è più destinata a innescare la rivoluzione futurista e a creare un italiano nuovo, campi ormai riservati al regime totalitario fascista.Nel clima del “richiamo all’ordine”, il futurismo mantiene le sue caratteristiche di movimento d’avanguardia. Negli anni del regime i futuristi fanno da tramite fra l’Italia e i più recenti sviluppi dell’arte europea. La caratteristica del futurismo negli anni venti è l’interesse verso tutti i campi della produzione artistica, compresa la musica, la fotografia, il cinema, la moda, l’arredamento e le costruzioni di padiglioni effimeri. Nel 1929 viene pubblicato il Manifesto dell’aeropittura, dove si esalta nuovamente il mito della macchina: questa volta l’aeroplano.