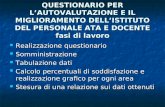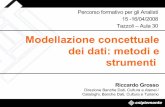IL QUESTIONARIO · 2017-11-28 · 2) Redazione del questionario 3) Verifica del questionario. La...
Transcript of IL QUESTIONARIO · 2017-11-28 · 2) Redazione del questionario 3) Verifica del questionario. La...

IL QUESTIONARIO
Prof.ssa Maria Carella

Fase in cui si predispone il piano di rilevazione
Si procede alla:
1. DEFINIZIONE DELLE UNITÀ DI RILEVAZIONE
2. SCELTA DELLE TECNICHE DI RILEVAZIONE DELLE UNITÀ STATISTICHE
3. SCELTA DELLE MODALITÀ DI REPERIMENTO DEI DATI
FASE 1 PROGRAMMAZIONE

Le modalità di rilevazione: le tecniche di indagine
Rilevazioni dirette
a) Rilevazioni tramite intervistatore
• intervista faccia a faccia
libera con questionario
• intervista telefonica
b) Rilevazione autocompilata
• con questionari postali
Rilevazioni indirette
Il rilevatore misura gli eventi a livello di atti
a) Esame dei documenti
atti di nascita, statistiche ufficiali e non.
b) Metodo del sopralluogo
si osserva nel luogo oggetto di indagine comportamento delle unità di interesse

Le rilevazioni dirette: Tipi di indagini
INDAGINI OCCASIONALI
Si tratta di indagini effettuate per ottenere stime riferite a caratteristiche possedute dalla popolazione in un determinato periodo o in un dato istante di tempo
(esempi: distribuzione del fatturato realizzato nell’arco di un anno, distribuzione della popolazione per classi di età ad una certa data).
INDAGINI PERIODICHE O RICORRENTI
Si tratta di indagini che vengono ripetute in momenti programmati nel tempo.

Le rilevazioni dirette: Tipi di indagini
• SONDAGGI DI OPINIONE: indagini condotte su argomenti di attualità o di pubblico interesse
• STUDI PANEL: interviste ripetute su uno stesso gruppo di soggetti su un ampio arco temporale
• STUDI DI TREND: interviste condotte su uno stesso tema nel corso del tempo
Le indagini svolte su un periodo molto lungo sono dette LONGITUDINALI

Le rilevazioni dirette: Tipi di indagini
Indagini longitudinali senza rotazione: sono indagini predisposte con lo scopo di seguire un particolare gruppo di unità nel tempo in modo da creare un record longitudinale per ogni unità osservata. Obiettivo: studiare le modificazioni intervenute nel collettivo durante il tempo. IMPORTANTE: è possibile produrre stime riferite alla sola popolazione di partenza dal momento che, senza disporre di ingressi di nuove unità, non si possono analizzare gli eventuali mutamenti nella struttura del collettivo di riferimento.

Le rilevazioni dirette: Tipi di indagini
Indagini longitudinali con rotazione: indagini disegnate per seguire un particolare gruppo di unità per un periodo di tempo, introducendo nuove unità nel campione con cadenze specifiche. In questo modo si tiene conto che nel tempo il collettivo di interesse si modifica con l’ingresso di nuove unità (es.: nascite o immigrazioni)
Mediante questo schema di indagine è quindi possibile produrre sia stime longitudinali, riferite alle variazioni nette intervenute e alle transizioni di stato, sia stime trasversali riferite alle popolazioni aggiornate ad ogni occasione di rilevazione.

Esempi indagini longitudinali
Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro, Istat: prevede un piano di campionamento a rotazione, per cui ogni famiglia fa parte del campione per due rilevazioni consecutive, poi esce per due indagini per poi rientrare nel campione per le ultime due.
• Cadenza trimestrale.
Indagine longitudinale sugli sbocchi professionali dei laureati, Istat:
condotta su coorti di laureati seguiti per 5 anni, con una prima rilevazione tre anni dopo la laurea e una seconda due anni dopo, per mezzo di un questionario postale.

Rilevazioni tramite intervistatore: L’intervista faccia a faccia
• libera :
focalizzata (quando l’intervistatore riesce ad ottenere risposte esplicite a domande precise)
biografica (quando l’intervistatore chiede l’opinione all’intervistato su determinate questioni sollecitando la sua esperienza di vita)

Rilevazioni tramite intervistatore
L’intervista faccia a faccia
• con questionario
l’intervista viene condotta da un rilevatore che legge le domande e le opzioni di risposta nell’esatto ordine e con lo stesso linguaggio adottati nel questionario.
L’intervistatore può anche utilizzare un questionario elettronico gestito da un PC Sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).

Vantaggi e limiti Intervista faccia a faccia
VANTAGGI Si identifica il rispondente
Maggiore possibilità di convincere il rispondente a collaborare
Possibilità di istruire il rispondente sul significato delle domande e sul modo corretto di fornire le risposte
Viene rispettato l’ordine delle domande
DIFETTI • Costosa da
implementare
• Necessita di una organizzazione capillare sul territorio
• Maggiori rischi di condizionamento

Rilevazioni tramite intervistatore
Intervista telefonica
Intervista condotta al telefono da un intervistatore che legge le domande e le opzioni di risposta nell’esatto ordine e con lo stesso linguaggio adottati nel questionario riportandovi quindi le risposte così come sono fornite dal rispondente.

Vantaggi e limiti
Intervista telefonica VANTAGGI
• Costi minori
• Tempestività nella raccolta dati
• Non richiede organizzazione sul territorio
• Maggiore controllo dei rilevatori
• Bassi rischi di condizionamento
• Maggiore possibilità di porre quesiti delicati
DIFETTI • Impossibile contattare
famiglie senza telefono
• Il rispondente non è identificato con certezza
• Limitazioni nell’aiuto fornito ai rispondenti

Rilevazione autocompilata
Questionario postale autocompilato
Il rispondente riceve il questionario a mezzo posta e provvede a compilarlo e a rispedirlo o eventualmente a riconsegnarlo ad un addetto che lo ritira a domicilio.

Vantaggi e limiti Questionario postale autocompilato
VANTAGGI
• Bassi costi di realizzazione
• Minore organizzazione
• Più impersonale (adatta per quesiti delicati)
• Rispondente si sente più garantito da anonimato
DIFETTI • Tempi lunghi di raccolta
• Basso livello di risposte
• Impossibilità di identificare con certezza il rispondente
• Minore capacità di ottenere la partecipazione all’indagine
• Impossibile aiutare i rispondenti nella comprensione delle domande e nella compilazione del questionario

Il questionario: definizione
Il questionario è lo strumento designato a raccogliere le informazioni sulle variabili qualitative e quantitative oggetto di indagine.
IMPORTANTE Il questionario deve essere uno strumento standardizzato
Ciò significa che domande e formulazione devono essere identiche per tutti i rispondenti in modo che le informazioni raccolte siano confrontabili fra loro.

La costruzione del questionario
La progettazione di un questionario è un’operazione complessa e difficile: si basa su una precisa metodologia non si può improvvisare.
TRE FASI:
1) Progettazione concettuale
2) Redazione del questionario
3) Verifica del questionario

La costruzione del questionario La fase preliminare
1) Fase della progettazione concettuale
Devono essere specificati e definiti:
• la popolazione di riferimento
• aree (argomenti) e ambiti da indagare
• le caratteristiche di interesse del fenomeno da studiare
• le finalità conoscitive
• la tecnica di rilevazione
ATTENZIONE: Occorre precisare in maniera chiara il concetto connesso al tema sul quale si vuole indagare (esempio: per un’ indagine sul tempo libero, occorre indicare precisamente cosa si intende per tempo libero)

La fase della stesura del questionario
2) Fase Redazione del questionario
scelta del tipo di domande
contenuto
forma
formulazione dei quesiti
ordine delle domande

La scelta delle domande: contenuto
In base al contenuto (argomento)
3 categorie domande che riguardano :
1. Caratteristiche socio-demografiche
2. Atteggiamenti
3. Comportamenti

La scelta delle domande: sostanza 1. Le Domande relative alle proprietà socio-demografiche:
si riferiscono alle caratteristiche permanenti o temporanee dell’individuo (genere, età, luogo di nascita, titolo di studio professione, stato civile)
vengono riportate in tutte le inchieste e seguono delle formulazioni standard.
2. Le Domande relative agli atteggiamenti (area dei pensieri)
riguardano opinioni, motivazioni, sentimenti, giudizi, valori
sono le più difficili da formulare e le risposte sono influenzate dal modo in cui sono poste le domande.
3. Le Domande relative ai comportamenti (area delle azioni)
rilevano ciò che il soggetto dice di fare o di aver fatto.
un aspetto più facile da indagare rispetto agli altri: i comportamenti sono inequivoci e osservabili

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI INDIVIDUALI
1. Sesso: Maschio 1|__| Femmina 2|__|
2. Data di nascita: giorno |__|__| mese |__|__| anno 19|__|__|
3. Paese di nascita:__________________________________________________________ |__|__|__|
3.1. Luogo di nascita:
- Villaggio (nome della città più vicina) __________________________________ 1|__|
- Piccola città (specificare): ____________________________________________ 2|__|
- Grande città (specificare): ____________________________________________ 3|__|
3.2. Dove ha trascorso la maggior parte del tempo dalla nascita fino ai 14 anni?
- Villaggio (nome della città più vicina) ______________________________________ 1|__|
- Piccola città (specificare): ________________________________________________ 2|__|
- Grande città (specificare): ________________________________________________ 3|__|
4. Cittadinanza/e attuale/i : ____________________________________________________ |__|__|__|
____________________________________________________ |__|__|__|
4.1. Lei ha intenzione di acquisire la cittadinanza italiana in futuro?
- Sono già italiano 1|__|
- Sì 2|__|
- No 3|__|
- Non so 4|__|
5. Attuale conoscenza dell’italiano:
Molto
4
Abbastanza
3
Poco
2
Per niente
1
- Comprende l’italiano |__| |__| |__| |__|
- Parla l’italiano |__| |__| |__| |__|
- Legge l’italiano |__| |__| |__| |__|
- Scrive l’italiano |__| |__| |__| |__|

La scelta delle domande: forma
In base alla forma:
1. Domande aperte o a risposta libera
- sono quelle in cui si lascia piena libertà all’intervistato nella formulazione della risposta;
- si rivolgono di solito ad un campione ridotto.
2. Domande strutturate o a risposte chiuse
-offrono la possibilità di scegliere tra risposte prefissate, quindi la risposta sarà standard.
- sono le sole che si possono utilizzare con campioni di grandi dimensioni.

La scelta delle domande: forma
Esempio D. Aperta
Cosa ne pensa dell’aborto?
Secondo lei quali sono i problemi più gravi nel nostro paese?
Esempio D.Chiusa
Qual è il suo stato civile?
Celibe/nubile 1
Coniugato/a 2
Vedovo/a 3
Separato/a 4
Divorziato/a 5

La scelta delle domande: forma
In base alla forma:
Domande a Risposta Mista: prevedono delle alternative fisse di risposte predefinite dal ricercatore ed una riposta aperta. A volte si lascia aperta la risposta con la voce Altro da specificare
Domande Multiresponse o Con Più di Una Risposta l’intervistato deve indicare, nel caso di risposte strutturate, una o più risposte fra le varie alternative proposte, o formulare una o più risposte di domande a risposta aperta.

La scelta delle domande: forma
D. a Risposta Mista
Qual è la trasmissione televisiva che segue maggiormente?
telegiornali 1
film 2
fiction 3
documentari 4
Altro specificare_______
D. Multiresponse
Quali trasmissioni televisive segue?
(sono previste più risposte)
telegiornali 1
film 2
fiction 3
documentari 4

La scelta delle domande: forma Domande Gerarchizzate: domande strutturate
con opzioni di risposta che devono essere ordinate secondo una scala di preferenze.
Esempio: Indichi in ordine di preferenza con numeri da 1 (più preferito) a 4 (meno preferito) il suo gradimento fra i seguenti programmi televisivi:
- telegiornali
- film
- fiction
- documentari

LE DOMANDE APERTE
VANTAGGI a) Concedono maggiore libertà di espressione
e spontaneità
b) Utili quando il ricercatore non è in grado di preventivare le possibili risposte
c) Utili per affrontare problemi complessi o delicati

LE DOMANDE APERTE SVANTAGGI
a. Possono essere troppo vaghe e dunque non comprese dall’intervistato.
b. Creano problemi di codifica, perché le risposte possono essere generiche o imprecise
c. La qualità delle risposte dipende dal livello culturale dell’intervistato
d. Penalizzano individui non avvezzi ad esprimersi in forma scritta o a concettualizzare.
e. Sono più impegnative, provocano un’alta percentuale di rifiuto

LE DOMANDE CHIUSE
VANTAGGI a. Sono standardizzate e consentono comparazioni b. Facilmente codificabili c. Le risposte multiple aiutano nella comprensione
della domanda stessa d. Sui dati sensibili risultano più adeguate per avere
risposte veritiere (es. reddito suddiviso in intervalli)
e. Possono sollecitare la memoria nel caso di ricordi, eventi o definizioni
f. L’intervistato è agevolato nella risposta.

LE DOMANDE CHIUSE
SVANTAGGI a. L’intervistato può rispondere a caso b. Rischio di influenzare la risposta con le
alternative proposte non considerando tutte le altre possibili alternative di risposta non previste
c. Se la lista delle risposte è molto lunga, l’ordine delle risposte può influenzare gli intervistati

La formulazione delle domande
La formulazione delle domande è importantissima perché può influenzare
fortemente la risposta
Criteri suggeriti relativi a:
linguaggio
sintassi
contenuto

La formulazione delle domande
1. Il livello linguistico delle domande
- semplice (le domande devono essere formulate con un linguaggio elementare);
- conciso (le domande non devono essere lunghe)
- appropriato (è preferibile non utilizzare parole complicate né tantomeno espressioni gergali)

La formulazione delle domande
2. La sintassi: le domande non devono essere
sintatticamente complesse (Domande doppie: quelle che includono due o più domande in una) Es. Lei è favorevole all’aborto e al divorzio?
Es. Si ritiene soddisfatto delle mansioni svolte e della posizione occupata nel suo attuale lavoro?
ambigue o imprecise (domande in cui i termini hanno significato non definito) Esempio: «Il suo è un lavoro stabile?»

La formulazione delle domande
le domande non devono essere
astratte (domande che possono dare facilmente luogo a risposte generiche o normative)
tendenziose o viziate (domande che orientano l’intervistato verso una possibile risposta) Esempio: «Lei non fuma, vero?»

Le insidie da domande
Le domande delicate/imbarazzanti possono riguardare argomenti che sono psicologicamente difficili da indagare
a) Quali sono gli argomenti?
• Reddito personale
• Orientamento e comportamenti sessuali
• Comportamenti illegali (es. uso di droghe non legali, evasione fiscale)
• Comportamenti moralmente inaccettabili
• Comportamenti socialmente stigmatizzati (es. forte consumo di alcolici)

Le insidie da domande delicate
b) Quali risultati producono?
Le risposte a queste domande possono essere difformi da ciò che è ritenuto socialmente accettabile
In realtà esse tendono a suscitare risposte normative cioè socialmente accettabili: si parla di “desiderabilità sociale”

Le insidie da domande delicate
c) Come formulare le domande? I possibili rimedi
Le domande devono porre bene in luce che il consenso alla norma non è scontato
Si deve considerare normale e diffuso anche il comportamento negativo
Esempio: indagine sulla propensione a frodare il fisco: Domanda sbagliata :”Secondo lei è giusto frodare il fisco?” Domanda corretta: ”Molti cittadini ritengono giustificabile chi froda il fisco, lei condivide?”
si possono porre le domande in forma indiretta Esempio: il reddito può essere stimato a partire da particolari consumi: quante vacanze, quante automobili, ecc.)

Le insidie da domande delicate
d) Accorgimenti
Queste domande devono essere poste alla fine del questionario per evitare che l’intervistato abbia reazioni negative e si rifiuti di proseguire.
Vanno alternate le domande difficili con quelle di informazione e di opinione

Le insidie da Acquiescenza e Response set
Acquiescenza si riferisce alla tendenza degli intervistati a scegliere risposte affermative piuttosto che negative Response set si riferisce alla tendenza degli intervistati a scegliere la stessa risposta per una batteria di domande che presentano lo stesso tipo di alternativa (uniformità delle risposte)
Rimedio Le domande devono essere formulate non tenendo vicine quelle che abbiano tra di loro un nesso logico o alternando la tipologia delle risposte

Tipologie di domande tecniche
LE DOMANDE FILTRO permettono di saltare uno o più quesiti successivi se sono verificate alcune condizioni (individuano i percorsi di compilazione ).
Sono utili:
1. per selezionare sottoinsiemi di intervistati, aventi caratteristiche in comune, e per indirizzarli verso alcune sezioni del questionario. (es: occupati o non occupati)
2. per guadagnare tempo e quindi per evitare di porre quesiti dettagliati quando è inutile (es. Lei dedica parte del suo tempo alla lettura? Se la risposta è sì l’intervista prosegue altrimenti si conclude)

28. Ha mai lavorato nel suo paese d’origine?
- Sì 1|__|
- No 2|__| [vai alla dom.28.2]
28.1. Qual è stata l’ultima attività lavorativa svolta nel paese di origine? _____________________
______________________________________________________________________________
28.2. Quale era la sua condizione professionale nel paese di origine prima della partenza? - Occupato 1|__|
- Disoccupato/in cerca di nuova occupazione 2|__|
- In cerca di prima occupazione 3|__|
- Studente/studentessa 4|__|
- Casalinga 5|__|
- Altro (specificare): ____________________________________________________
29. Attualmente lei svolge un’attività lavorativa? - Sì 1|__| [vai alla dom.29.2]
- No 2|__|
29.1. Ha effettuato ore di lavoro negli ultimi sette giorni?
- Sì 1|__|
- No 2|__| [vai alla dom.30]
29.2. Quale lavoro svolge? (se l’intervistato svolge più lavori, indicare nella prima riga quello che lo impiega
per il maggior numero di ore e così via, in ordine decrescente)
- Primo ___________________________________________________________________
- Secondo ___________________________________________________________________
- Terzo ___________________________________________________________________

Domande Condizionate • Si definisce DOMANDA CONDIZONATA un
quesito la cui risposta è condizionata dalla risposta data alla domanda precedente
DOMANDA FILTRO
Es. “Ha mai avuto un aborto?” e poi
“ Quanti anni aveva quando ha avuto il suo primo aborto?”
DOMANDA
CONDIZIONATA

Tipologie di domande tecniche
Domande con tecnica a imbuto sono quesiti collegati per cui si formulano prima domande generali e poi domande più specifiche
Utili per: - dare tempo al rispondente di focalizzare l’attenzione sul tema proposto - aiutare la memoria - registrare opinioni non meditate
Domande a imbuto rovesciato: si antepongono le
domande specifiche a quelle più generali.
-Utili quando si desidera raccogliere opinioni meditate su un determinato argomento.

Tipologie di domande tecniche
Domande di controllo: servono per attestare l’attendibilità delle risposte date
Esempio: “quali di questi settimanali legge abitualmente?” Segue un elenco e se l’intervistato sceglie settimanali mai esistiti è evidente che l’intervista non è attendibile

Tipologie di domande tecniche
Le batterie di domande sono domande che essendo tutte formulate nello stesso modo vengono presentate all’intervistato in un unico blocco
Tipo di formulazione: stessa domanda introduttiva e stesse alternative di risposta, varia solo l’oggetto al quale si riferiscono. Obiettivi:
• risparmiare spazio sul questionario e tempo dell’intervista,
• facilitare la comprensione del meccanismo di risposta
Svantaggi:
Rischio che le riposte siano date a caso e che siano meccanicamente tutte uguali tra di loro.

L’abitazione dispone di:
Sì No
- Una cucina o angolo cottura
1|__| 2|__|
- Stanza bagno e doccia 1|__| 2|__|
- W.C. 1|__| 2|__|
- Illuminazione elettrica 1|__| 2|__|
- Acqua corrente 1|__| 2|__|
- Acqua potabile 1|__| 2|__|
- Giardino, balcone o terrazza
1|__| 2|__|
- Impianto di riscaldamento fisso
1|__| 2|__|

Molto 5
Abba-stanza
4
Poco 3
Per Nient
e 2
Non so 1
- È bene che una donna abbia figli prima dei 25 anni |__| |__| |__| |__| |__|
- Le decisioni importanti devono essere prese da marito e moglie insieme |__| |__| |__| |__| |__|
- Il ricorso alla contraccezione all’interno della coppia è utile |__| |__| |__| |__| |__|
- Per avere figli occorrono adeguati mezzi economici |__| |__| |__| |__| |__|
- In una famiglia l’uomo lavora e la donna sta a casa e si occupa dei figli |__| |__| |__| |__| |__|
- I figli devono professare la stessa religione dei genitori |__| |__| |__| |__| |__|
- I figli devono adottare le abitudini del paese in cui vivono |__| |__| |__| |__| |__|
Esprima il suo grado d’accordo sulle seguenti affermazioni:

L’ordine Delle Domande REGOLE BASE
1. Presentare per prime le domande dalle risposte semplici
2. Seguire un ordine logico nella presentazione delle domande
3. Porre domande aperte o delicate nell’ultima parte del questionario
4. Separare le coppie di domande con funzione di controllo
5. Variare lunghezza e tipologia di domanda

Le Modalita’ Di Risposta
E’ NECESSARIO:
• Prevedere tutte le possibili risposte;
• indicare come l’intervistato deve comportarsi per rispondere alla domanda correttamente
• Sesso: maschio femmina X
• Sesso: maschio femmina X
• Sesso: maschio 1 femmina 2

Disposizione delle categorie di risposta
Bisogna fare in modo che l’intervistato non si confonda quindi le risposte vanno disposte:
-In colonna “Con quale frequenza leggi i giornali?” Sempre
Di tanto in tanto
Quasi mai
Mai
-Incasellate o a griglia Nome Età Sesso
Maschio Femmina
Laura 22 X

Le Modalità Di Risposta
• PER LE DOMANDE APERTE è necessario predisporre uno spazio bianco sufficiente in cui l’intervistato possa riportare una risposta completa.
• PER LE DOMANDE CHIUSE esistono diverse alternative a seconda che la variabile sia:
- nominale
- ordinale
- cardinale

Variabili e modalità
Ogni domanda individua una variabile statistica
Le caratteristiche riferite all’unità di analisi
Proprietà Ogni proprietà può manifestarsi in diversi modi:
questi sono definiti stati della proprietà
Proprietà Stati della proprietà
Età 1,2,3,4,5…. Anni
Sesso Maschio, Femmina
Orientamento religioso
Ateo, buddista, musulmano, cattolico, etc…

Le variabili nominali Le variabili nominali (caratteri qualitativi) sono quelle che si
presentano con modalità:
- non numeriche (espressioni verbali)
- discrete, cioè finite e delimitate
- non ordinabili
Esempi: orientamento religioso, professione, nazionalità
In questo caso la procedura di operativizzazione è la classificazione
Alle modalità viene assegnato un valore=numero che non ha alcun significato numerico
Le variabili dicotomiche sono quelle che presentano due sole modalità esempio: Sesso: maschio / femmina

Le variabili ordinali Le variabili ordinali (caratteri qualitativi) sono quelle che si
presentano con modalità:
- non numeriche (espressioni verbali)
- discrete
- ordinabili.
Esempio: titolo di studio, gerarchia militare, ceto sociale
In questo caso la procedura di operativizzazione è l’ordinamento, che tiene conto dell’ordinabilità degli stati della proprietà.
Alle modalità viene assegnato un valore=numero che ha un significato solo ordinale

Le variabili cardinali Le variabili cardinali (caratteri quantitativi) sono quelle che si presentano con modalità :
- numeriche
- ordinabili
- discrete o continue
Esempio: età, reddito
In questo caso la procedura di operativizzazione è il conteggio (se v. discrete) o la misurazione (se v. continua)

Dalla realtà alla matrice dei dati
Tipo di variabile Stato della proprietà Procedura di
operativizzazione
Nominale Discreti non ordinabili (orientamento religioso)
Classificazione
Ordinale Discreti ordinabili
(titolo di studio) Ordinamento
Cardinale Discreti enumerabili
(n. di figli) Conteggio
Cardinale Continui (altezza, peso) Misurazione
•Fonte: P. Corbetta, La ricerca sociale vol.II p39

Le Modalità Di Risposta
• PER LE DOMANDE CHIUSE se la variabile è:
- nominale: modalità di risposte non numeriche
- ordinale: modalità di risposte non numeriche ordinate per rango • es. favorevole/indifferente/sfavorevole
- cardinale: modalità di risposte numeriche discrete o ordinate con eguali intervalli • es. età, peso

Variabili Nominali • In generale il numero delle modalità per variabili nominali
è definito ed è ben noto
-Le variabili più facili da misurare sono quelle in cui le modalità sono di numero limitato e distinte concettualmente
(es. sesso: risposte possibili maschio-femmina)
• In alcuni casi possono essere presenti moltissime modalità:
1) si riportano sul questionario SOLO quelle più frequenti e si prevede una modalità “altro” per garantire l’esaustività della risposta.
Per es. “Che programmi vedi in tv?”:
telegiornali varietà film X altro

Variabili Nominali
2) si fornisce all’intervistato una scheda allegata al questionario in cui rintracciare un eventuale codice da inserire nelle risposte
(es. “In quale provincia della Puglia risiedi?” Nella scheda ci sarà un codice identificativo di ogni città da riportare nel questionario)
01 Bari 03 Lecce 05 Foggia
02 Brindisi 04 Taranto 06 Bat

Variabili Ordinali • Nella maggior parte dei casi i questionari
prevedono molte domande di opinione o di atteggiamento in cui le risposte sono di tipo ordinale.
• Le categorie per una scala ordinale sono spesso soggettive e definite dal ricercatore esempi: scale di risposta
Molto d’accordo/ d’accordo /indifferente/ in disaccordo/ assolutamente in disaccordo/ non in grado di rispondere
Spesso/qualche volta/ quasi mai

Le variabili ad intervalli
• Variabili continue (come l’età) consentono un elevato numero di possibili modalità di risposta, troppo elevato per una domanda chiusa.
• L’intervistatore si accontenterà di conoscere solo il gruppo di categorie entro il quale si colloca l’intervistato
• es. Che età hai? da 0-25 da 25-50 da 50-75 X 75 e oltre

Verifica del questionario: il pretest
La fase finale di costruzione del questionario si realizza con la verifica dello stesso tramite pretest.
Per collaudare il questionario lo si distribuisce ad un campione di persone molto più piccolo rispetto a quello di cui ci si servirà per la ricerca (indagine pilota): – AVVERTENZA: è necessario che il campione sia
rappresentativo di tutti gli strati del collettivo statistico oggetto di rilevazione

IL PRETEST La verifica del questionario tramite pretest è importante
perché fa emergere domande poco chiare e quindi aiuta a correggere le imperfezioni
Il campione per un pretest è di solito costituito da pubblico ad hoc: possono essere per esempio impiegati dell’istituto c/o cui si lavora o “testimoni privilegiati” (es. mediatori culturali)
A livello grafico nel questionario usato come pretest si lasciano margini più ampi (spazi per scrittura) per incoraggiare commenti da parte dei rispondenti.
Il ricercatore non deve obbligatoriamente accettare tutti i consigli degli intervistati anche se tali interventi spesso si rivelano utili.