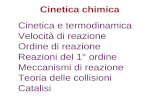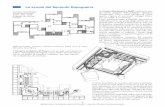Il primo dopoguerra in Europa: Ira rivoluzione e reazione · Il primo dopoguerra in Europa: Ira...
Transcript of Il primo dopoguerra in Europa: Ira rivoluzione e reazione · Il primo dopoguerra in Europa: Ira...
Il primo dopoguerra in Europa: Ira rivoluzione e reazione
Nonostante la spiccata tendenza del dibattito politico-storiografico italiano a concentrarsi in maniera assorbente, di volta in volta, attorno a singoli momenti e problemi considerati di particolare attualità (dopo gli anni venti e Weimar, gli anni trenta), il primo dopoguerra continua ad attirare l’attenzione degli studiosi e del pubblico. Lo dimostra il convegno promosso lo scorso anno dall’Istituto socialista di studi storici, di cui con rara tempestività sono stati pubblicati gli A tti lo confermano diverse iniziative editoriali volte a proporre al lettore italiano opere variamente significative di autori stranieri, apparse nella prima metà degli anni settanta: dopo quelle di Albert S. Lindemann e Pierre Broué, è ora la volta de La rivoluzione nell’Europa centrale 1918-1919 di Francis L. Carsten1 2.Del convegno di Perugia si è molto parlato, a suo tempo, sulla stampa periodica e quotidiana. E non a caso: l’attualità dei problemi affrontati veniva infatti caricata di precise implicazioni politiche dal fatto stesso che fossero gli storici del- l’«area socialista», ora raccolti attorno ad un punto di riferimento istituzionale, a misurarvisi. L ’interesse dell’iniziativa, in altre parole, era destinato a travalicare l’ambito degli « addetti ai lavori » non solo e non tanto per la chiara volontà che questa evidenziava di mettere in discussione le interpretazioni elaborate attorno a questo nodo cruciale della storia del movimento operaio internazionale e dell’intera età contemporanea dalla storiografia di indirizzo marxista (e segnatamente dagli storici comunisti), quanto dal contesto politico in cui si inseriva e dal suo ruolo nel quadro di un’operazione di vasto raggio intesa a « ricostruire » l’immagine e la fisionomia del Partito socialista italiano.La lettura dei due volumi degli Atti (sebbene la comprensione dell’effettivo andamento dei lavori sia resa difficoltosa dall’opinabile collocazione dei contributi: vari interventi precedono il testo di relazioni alle quali pure si riferiscono) conferma indubbiamente questo segno complessivo della manifestazione, anche se non possono essere trascurate le differenze esistenti nell’impostazione e negli orientamenti dei singoli relatori. Si tratta di un dato che induce ad alcune riflessioni, le quali peraltro non possono prescindere da un esame dei problemi affrontati e delle
1 Rivoluzione e reazione in Europa 1917-1924. Convegno storico internazionale - Perugia 1978, Roma, Mondo operaio - Edizioni Avanti!, 1978, 2 voli., pp. XXI-328-332.2 Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 358. Cfr. anche A.s. lindemann, Socialismo europeo e bolscevismo (1919-1921), introduzione all’edizione italiana di S. Bechi, Bologna, Il Mulino, 1977 (ediz. originale 1974) e Pierre broué, Rivoluzione in Germania 1917-1923, Torino, Einaudi, 1977 (edizione originale 1971).
94 Tommaso Detti
proposte interpretative che ne scaturiscono. I punti sui quali vorrei soffermarmi, che mi paiono corrispondere ai più rilevanti quesiti posti dal convegno sul piano storiografico, sono essenzialmente due: quello generale delle prospettive della rivoluzione e della democrazia in Europa e quello particolare del primo dopoguerra in Italia.Con ciò non intendo certo sminuire l’autonomo rilievo delle tre relazioni specificamente dedicate a problemi di storia della Russia sovietica3; è innegabile tuttavia — e Gaetano Arfé l’ha ricordato nelle sue conclusioni — che il centro dell’interesse del convegno per la Rivoluzione d’ottobre e per le stesse vicende interne del primo stato socialista risieda nel rapporto fra questo e l’Europa, riguardi l’influenza esercitata dalla Russia sovietica sugli sviluppi della storia europea del primo dopoguerra. Analogamente, se per la soluzione di tale nodo è di particolare importanza la questione della consapevolezza che le diverse componenti del movimento operaio internazionale ebbero del carattere della crisi del capitalismo, la stessa acuta relazione di Massimo L. Salvadori, con la sua analisi comparativa delle posizioni di :Kautsky e di Lenin, dà l’impressione di rimanere a sé stante rispetto al nucleo centrale del convegno a causa del taglio tutto interno alla storia delle idee che la contraddistingue4.Le linee generali di una interpretazione della crisi del dopoguerra contrapposta a una « vulgata leninista » che avrebbe « inciso profondamente sulla ricerca storica » 5 sono esposte da Franco Gaeta nella sua introduzione al convegno. I termini di questa « vulgata » vengono così richiamati: la disfatta della socialdemocrazia europea dipese dal mancato accoglimento del « modello » russo, la rivoluzione sovietica era l’unica possibile in quanto fu la sola a risultare vittoriosa, dal fallimento della rivoluzione in Europa discesero il « carattere specifico » della costruzione del socialismo in un paese solo nonché « la lunga e grave degenerazione dello stalinismo ». Secondo Gaeta, invece, « il fatto che movimenti reazionari abbiano finito per travolgere tutte le rivoluzioni tranne una non significa che essa sola, quella vittoriosa, sia esistita; a parte l’osservazione che l’unica rivoluzione vittoriosa fu essa stessa, obiettivamente, per le modalità in cui si verificò e per la confisca dello spirito rivoluzionario che essa volle operare, uno degli elementi che cospirarono alla liquidazione delle altre » 6. E ancora: « La costituzione del Comintern nel marzo 1919, in qualunque prospettiva la si voglia considerare e a qualunque finalità si ritenga che essa dovesse rispondere, venne obiettivamente a rappresentare (allora e nei decenni successivi) un fattore di complicazione e di ritardo nello sviluppo complessivo del movimento operaio internazionale, non tanto rompendone l’unità che già gli avvenimenti successivi alla presa bolscevica del potere aveva infranta, quanto perpetuando istituzionalmente una divisione il cui peso venne soltanto in parte e tardivamente avvertito » 7.Queste affermazioni meritano di essere discusse in maniera il più possibile puntuale. « Vulgata leninista » a parte (ma che gli esiti del primo dopoguerra in Europa non abbiano inciso sui successivi sviluppi della storia sovietica resta a mio avviso
3 G. petracchi, La diplomazia leninista: origini e presupposti della politica estera sovietica (1917-1924); R. risa liti, Rapporti fra Chiesa (ortodossa russa) e Stato sovietico: 1917-1924; c.G. de m ic h e lis , La storiografia sovietica sul periodo leniniano (1917-1921).4 massimo L. salvadori, Kautsky e Lenin nella crisi del primo dopoguerra. Considerazioni analoghe valgono per la relazione (quasi un libro) di Leonardo rapone, Trockij e le difficili lezioni dell'Ottobre.3 Rivoluzione e reazione, cit., voi. I, p. XIV.6 Ibid.7 Ibid., p. XVI.
Il primo dopoguerra in Europa 95
tutto da dimostrare), non credo che occorra un elenco di citazioni per sostenere che alla storiografìa marxista europea — e a quella italiana in particolare — non possa essere legittimamente attribuita una negazione della possibilità di prospettive diverse da quella russa, che tenessero conto delle specifiche condizioni dei diversi paesi. Con tutto ciò, affermare tale possibilità evidentemente non basta, ed è necessario cercar di chiarire le ragioni del fallimento al quale andarono incontro sia F« ipotesi leninista», sia quella democratico-parlamentare, sia anche quella (non riducibile alla prima né alla seconda) che potremmo definire «consiliare».Che 1’esistenza stessa dell’Ottobre sovietico condizionasse oggettivamente la storia delPintero occidente europeo, è ovvio: l’influenza che, anche soltanto in forma di mito, la prima rivoluzione socialista vittoriosa esercitò sulle masse lavoratrici dei vari paesi molto prima che il nuovo internazionalismo trovasse il sostegno attivo di forze organizzate operanti in collegamento con il gruppo dirigente bolscevico, fu enorme; e forse maggiore fu la paura che lo spettro del comuniSmo, alfine incarnatosi dopo settant’anni, suscitò nelle classi dominanti. Ciò non autorizza tuttavia a fondare un giudizio storicamente corretto intorno alla rottura del 1917 sul rimpianto per le possibili alternative che anch’essa (ma certo non soltanto essa) contribuì a vanificare. Ebbene, a me pare invece che proprio su questo punto decisivo il convegno non abbia sgombrato fino in fondo il terreno da ogni possibile equivoco, aprendo così la strada a interpretazioni non meno parziali e mistificanti di quelle alle quali si è inteso contrapporsi, e ad esse perfettamente simmetriche. Perciò appare tanto più opportuno il richiamo di Gastone Manacorda, il quale in uno dei suoi interventi ha ammonito che un’ottica europea e di breve periodo rischia di pregiudicare una corretta valutazione del « posto della rivoluzione russa nella storia», definendo il quale Edward H. Carr già aveva insistito sull’influenza del 1917 sullo sviluppo del «movimento per la liberazione dei cosiddetti popoli arretrati » dell’Asia e dell’Africa8.Quanto alla nascita e al ruolo della III Internazionale, le osservazioni di Gaeta debbono esser messe in rapporto con la tendenza (emersa molto chiaramente al convegno) ad operare una decisa retrodatazione della problematica del « socialismo in un paese solo», cui si collega una forte sottolineatura del peso esercitato dalle esigenze dello stato sovietico sulla politica del Komintern, considerata in ultima analisi, sin dall’inizio, subalterna e strumentale. Di qui ad attribuire all’Internazic- nale comunista e al gruppo dirigente bolscevico la responsabilità del fallimento di originali soluzioni rivoluzionarie in Europa, il passo è breve ma non per questo meno pericoloso. Indipendentemente dalla raccomandabilità sul piano storiografico di una riproposizione del metodo della « caccia alle responsabilità », infatti, una lettura in tale chiave della crisi del dopoguerra contrasterebbe con una serie di dati di fatto, scontrandosi per giunta, in alcuni casi, con elementari criteri di rispetto della cronologia.Per l’Austria tedesca e (ciò che più conta) per quella Germania che venne comunemente e non senza fondamento identificata come il luogo privilegiato e determinante di soluzione della crisi, ciò emerge con molta chiarezza dalla relazione nella quale Carsten ha sintetizzato i risultati della sua ricerca, risalente al 1972 e or ora tradotta in italiano. Sulla base di una ricostruzione minuziosa condotta mese per mese, regione per regione, quest’opera dimostra che sia in Germania, sia in Austria, i giuochi erano virtualmente conclusi prima che gli effetti della fonda- *
* Cfr. e .h . carr, 1917. Illusioni e realtà della rivoluzione russa, Torino, Einaudi, 1970, pp. 11- 47 e spec. 42 sgg.
96 Tommaso Detti
zione del Komintern si facessero in qualche modo avvertire. Carsten — che oltre tutto ridimensiona la capacità di incidenza dei ristretti gruppi di estrema sinistra esistenti nei due paesi, a proposito dei quali il suo giudizio è tutt’altro che tenero —• documenta infatti le pressioni esercitate sui comunisti austriaci dalTUngheria di Béla Kun, ma afferma che «per tutto il 1918-19 non esiste praticamente alcuna prova di un intervento diretto da parte di Mosca nella stessa direzione » 9 né in Germania, né in Austria.Ora, se è sicuramente superfluo insistere sulle ragioni oggettive che rendevano irrealizzabile in Germania un’esperienza rivoluzionaria meccanicamente ricalcata sul modello russo, la debolezza dell’estrema sinistra basterebbe a dimostrare che le cause prime della sconfitta della rivoluzione tedesca risiedono altrove. Non si dimentichi, inoltre, che la politica effettivamente svolta dal Komintern fino al II Congresso dell’estate 1920 non fu affatto volta alla creazione di partiti rivoluzionari mediante la scissione della socialdemocrazia, ma al contrario puntò sui consigli degli operai e dei soldati come strumento di ricomposizione sociale e politica e di direzione del processo rivoluzionario. Che poi anche in questo vi fosse un errore di calcolo dovuto alla sottovalutazione della forza e della vitalità dei partiti e dei sindacati guidati dai socialdemocratici, è un’altra questione. È comunque un fatto incontrovertibile che la politica di scissione del Komintern sopraggiunse quando la grande partita ingaggiatasi al termine del conflitto era ormai chiusa.È noto come tale non fosse la convinzione del gruppo dirigente del comuniSmo internazionale, ma questo dato non può che confermare quanto sia semplicistico parlare per questi anni di una subordinazione del movimento rivoluzionario internazionale agli interessi dello stato sovietico. Certo, il ruolo del partito russo nel Komintern fu preminente; certo, i dirigenti bolscevichi si posero anche in quella sede l’obiettivo prioritario della sopravvivenza della Russia socialista; ma occorre non dimenticare che tale obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto, a loro giudizio, unicamente attraverso il successo della rivoluzione in Europa e che pertanto non vi fu in questa fase alcuna contraddizione tra le prospettive del movimento rivoluzionario e quelle dello stato sovietico. Si tratta di questioni non irrilevanti, a chiarire le quali avrebbe potuto utilmente contribuire al convegno di Perugia una relazione specificamente dedicata ai primi anni di vita dell’Internazionale comunista.Se dunque, come Carsten ritiene, nella Germania (e nell’Austria) del 1918-19 una rivoluzione vi fu, quali ne furono le caratteristiche, e quali le cause della sua sconfitta? «Rivoluzione politica e costituzionale», quella tedesca del 1918-19 raggiunse secondo questo studioso obiettivi di grande rilievo in quanto « travolse un possente impero » e « ottenne l’introduzione del sistema parlamentare e del suffragio universale»; ma la «democratizzazione» così avviata rimase incompiuta, e come tale facilmente reversibile: la burocrazia imperiale e la vecchia casta militare restarono al loro posto e anzi si rafforzarono, « il vecchio sistema sociale sopravvisse ». Se a ciò si aggiunge — per accennare a un problema che non trova posto nella trattazione di Carsten — che anche le leve del potere economico rimasero sostanzialmente intatte nelle stesse mani, appare con ogni evidenza quanto e quanto presto risultassero compromesse le reali possibilità di sviluppo di una « rivoluzione democratica ».Il repentino esaurirsi del movimento rivoluzionario in Germania è attribuito da Carsten a cause molteplici, che vanno dall’assenza di un movimento contadino
f .l . carsten, La rivoluzione nell’Europa centrale, cit., p. 335.
Il primo dopoguerra in Europa 97
disposto ad unirsi a quello degli operai e dei soldati alla robustezza delle forze della conservazione, dalla tattica « disperatamente inadeguata » dei due partiti socialdemocratici a quella « putschista » dei comunisti, alla mancanza di una direzione centralizzata del movimento consiliare. Carsten non lo afferma esplicitamente, ma la sua simpatia per il programma di integrazione tra democrazia parlamentare e democrazia consiliare accarezzato in Baviera da Kurt Eisner lascia intendere che qui risiedeva a suo avviso la possibilità di uno sviluppo originale del movimento rivoluzionario Tedesco. Tra le molte cause che l’imperialismo, la sorda ostilità dei dirigenti della Spd e dei sindacati nei confronti dei consigli, la loro alleanza con le forze più retrive della società tedesca per restaurare l’ordine e bloccare il cammino della rivoluzione ebbero un peso determinante, e vengono poste da questo studioso nel dovuto rilievo.L’attenzione portata alla situazione del movimento operaio e ai suoi rapporti interni non impedisce comunque a Carsten di concludere in maniera del tutto pertinente che sarebbe una « grossolana semplificazione » far discendere il fallimento della rivoluzione del 1918 dalla spaccatura esistente nel movimento operaio tedesco, o dall’« ultraradicalismo » dei comunisti, o ancora dal « tradimento » di Ebert e Noske: tutti elementi in diversa misura presenti e capaci di incidere sulla situazione della Germania nel 1918-19, ma ai quali non è possibile riferirsi in maniera unilaterale ed esclusiva se si vogliono cogliere tutti i molteplici e diversi aspetti di un problema storico che è molto più complesso. A conclusioni non diversamente articolate ed equilibrate sembrano autorizzare nel loro insieme anche i contributi su rivoluzione e reazione in Ungheria, Bulgaria, Jugoslavia, Romania e Polonia, presentati a Perugia rispettivamente da Leo Valiani, Armando Pitassio, Giuseppe Pirjevec, Francesco Guida e Luigi Di Lembo: i quali rivestono un interesse affatto particolare anche perché riguardanti paesi le cui vicende erano sinora pressoché sconosciute al pubblico italiano, nonostante si tratti di studi di valore diseguale e basati talora solo su fonti edite — come quelli di Pitassio e Pirjevec — o prevalentemente su fonti diplomatiche italiane — come quello di Guida.Quella che allora si consumò nel movimento operaio internazionale fu in realtà una tragedia di immani proporzioni, le cui conseguenze possono essere verificate nella storia di ambedue i suoi tronconi su un arco di tempo che oltrepassa abbondantemente i limiti cronologici del convegno di Perugia. Le sue premesse risalgono al 4 agosto 1914 e la frattura portata dalla « grande guerra » nel movimento operaio internazionale, sancita dalla Rivoluzione d’ottobre, venne poi approfondita dagli eventi del primo dopoguerra fino a divenire irreversibile. In questo quadro, rilevare che il perpetuarsi della divisione del movimento operaio sul piano istituzionale rappresentò un « fattore di complicazione e di ritardo », o attribuirne ogni responsabilità allTnternazionale comunista, significa a mio avviso porsi in un’ottica riduttiva rispetto alla drammaticità e alla complessità di un problema che non è soltanto storiografico, ma presenta risvolti di stringente attualità.Dell’Italia — prescindendo da una relazione « ad effetto » di Piero Melograni10 — si è occupato al Convegno di Perugia Roberto Vivarelli. La sua relazione copre
10 pierò melograni, Lenin e la prospettiva rivoluzionaria in Italia, il quale pretende che il Komintern operasse per scongiurare una rivoluzione nella penisola ed accentua unilateralmente l’origine internazionale della scissione di Livorno. Tali affermazioni, fondate a detta dello stesso Melograni su una lettura « prudente » ma « maliziosa » di alcuni documenti, sono state efficacemente confutate dagli interventi di Manacorda e di Carlo Vallami. Quest’ultimo ha precisato che i bolscevichi « non temevano la rivoluzione quanto la sconfìtta della rivoluzione » ed ha invitato a non sottovalutare « le ragioni proprie e specifiche del socialismo italiano » che concorsero a determinare la nascita del PCd’I. C’è solo da aggiungere che le letture « maliziose » dei testi, per quanto prudentemente condotte, possono portare molto lontano.
98 Tommaso Detti
l’intero periodo 1918-22 ed affronta di conseguenza numerosi problemi di rilievo, ma mi sembra particolarmente interessante soprattutto per due diversi motivi: da un lato, forse anche a causa del suo carattere sintetico, essa ripropone in forma più recisa e, direi, porta alle estreme conseguenze l’interpretazione generale a mio avviso già discutibile avanzata dall’autore nel primo volume della sua opera sul dopoguerra u; dall’altro, essa presenta ipotesi nuove ed originali, ma tali da suscitare notevoli perplessità, su una importante e troppo trascurata questione, quella relativa alla natura del massimalismo.Come già era noto, quella per cui nell’Italia del primo dopoguerra sarebbe esistita una « situazione rivoluzionaria » è considerata « una ipotesi del tutto astratta » da Vivarelli, il quale ritiene invece che l’esito vittorioso del conflitto avesse aperto la strada a concrete « prospettive di rinnovamento » in senso democratico. Alla base di questa interpretazione sta un giudizio secondo il quale « la guerra dell’Intesa aprì la strada alla democrazia e la sua vittoria segnò, con il riconoscimento dei diritti politici delle masse popolari in tutto il mondo occidentale, la conclusione positiva della partita che si era aperta in Francia nel 1789 » n. Ciò presuppone evidentemente una valutazione quanto meno assai differenziata delle due parti in lotta, e infatti Vivarelli scrive: « Nel generale quadro europeo, l’Intesa ben rappresentava quella linea di sviluppo, risalente al costituzionalismo inglese e alla Rivoluzione francese, nella quale si incarnava la tradizione liberale e democratica; mentre gli Imperi centrali, perpetuando residui non trascurabili di ancien régime, rappresentavano tutto ciò che a questa linea continuava ad opporsi » 11 12 13.Anche a non voler insistere sul vistoso elemento di contraddizione rappresentato in questo quadro dalla presenza nell’Intesa della Russia zarista (che Vivarelli risolve troppo facilmente con una boutade sulla complessità e l’ironia della storia), tale interpretazione si presta a mio avviso ad alcuni rilievi di fondo. Che la celebre definizione leniniana della guerra imperialista, elaborata nel vivo della lotta politica, non possa essere accolta meccanicamente negli stessi termini a distanza di sessant’anni, come osserva Vivarelli, è sin troppo chiaro 14; ma una negazione del carattere imperialistico del conflitto, a più riprese e ancora recentemente confermato da studi autorevoli, necessiterebbe di essere argomentata in modo più ampio e approfondito di quanto egli non faccia. In mancanza di ciò, resta l’impressione che una lettura come quella di Vivarelli sia resa possibile da considerazioni che prescindono dal momento dell’economia, per privilegiare aspetti politico-istituzionali. Non a caso, nel richiamare la tesi di Lenin sulla guerra come « conflitto tra opposti imperialismi », egli aggiunge: « Cioè tra forze politiche sostanzialmente equivalenti » I5, mostrando dell’imperialismo una concezione profondamente distorta in quanto non distingue la sostanza dalla forma.Altrettanto problematica mi sembra l’affermazione secondo la quale la vittoria dell’Intesa avrebbe segnato « la conclusione positiva della partita che si era aperta in Francia nel 1789 ». È ben vero, infatti, che dopo il crollo dell’impero russo le potenze dell’Intesa erano tutte rette da regimi di tipo liberaldemocratico; ma in Italia lo stato liberale era in preda a una crisi acutissima che sarebbe sfociata nel
11 Roberto vivarelli, Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (1918-1922). I, Dalla fine della guerra all’impresa di Fiume, Napoli, Istituto italiano per gli studi storici, 1967.12 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 204.13 Ibid., p. 203.14 Per l’Italia, ad es., cfr. quanto scrive g. rochat, L ’Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di interpretazione e prospettive di ricerca, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 73-74.15 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 202.
Il primo dopoguerra in Europa 99
fascismo e i nuovi regimi democratici sorti sulle rovine degli Imperi centrali, come si è accennato, erano gravissimamente minati nelle loro ancor fresche fonda- menta 14 * 16. Se dunque, come scrive Vivarelli prevenendo una facile obiezione, « la storia d’Europa non finisce a Versailles », per poter considerare l’esito della « grande guerra » come un trionfo della democrazia non basta secondo me arrivare a Locamo: è necessario spostare lo sguardo sul secondo dopoguerra, con il risultato però di vedere nel fascismo e nel nazismo nient’altro che una parentesi, al più un fattore di ritardo destinato fatalmente ad essere superato nel cammino della democrazia. Né ad avallare una interpretazione « intesista » della guerra può essere addotto, per usare una espressione di Alberto Caracciolo, « l’ingresso delle masse sulla scena europea » 17. Fu un fenomeno grandioso, che suggellò la fine di molte organizzazioni statali postulando ovunque un nuovo tipo di rapporto tra stato e masse popolari, ma che non necessariamente avrebbe dato luogo a regimi democratici, benché di questi costituisse la premessa. Una dimensione di massa, com’è noto, contraddistingue infatti gli stessi regimi reazionari del XX secolo.Anche in Italia, del resto, all’apertura di non trascurabili spazi di rinnovamento in senso democratico fecero riscontro all’indomani del conflitto eventi e processi a dir poco contraddittori rispetto a tale prospettiva. Se pure l’involuzione privatistica e autoritaria dello stato sulla quale sin dal 1965 aveva opportunamente insistito Giuliano Procacci18 non costituì, come nota Vivarelli, una peculiarità dell’Italia, né nacque con la guerra, numerosi studi stanno ormai a confermare che gli anni del conflitto portarono in tale processo una sensibilissima accentuazione, ponendosi davvero come un importante momento di svolta nella storia nazionale. Né il crollo di alcuni grandi gruppi economici e finanziari può far parlare a mio parere di « forti ridimensionamenti del potere economico » 19 avvenuti nel dopoguerra. È vero infatti che solo il fascismo consentirà al padronato di consolidare e dispiegare compiutamente la propria politica, ma sbaglieremmo se considerassimo il primo come una forza sopraggiunta per suo conto in soccorso del secondo: la crisi dello stato liberale fu anche il frutto del distacco di un potere economico che continuava a godere di ottima salute da una classe dirigente politica gravemente indebolita, e lo stesso avvento del fascismo corrispose a precise scelte compiute dal padronato industriale e agrario.Non diversamente l’impresa di Fiume, se non riuscì ad « agire sulla politica interna operandovi una svolta reazionaria » 20 nell’immediato, introdusse però nell’esercito il cancro della sedizione e portò un fiero colpo all’autorità dello stato — fatto che lo stesso Vivarelli aveva già posto nella dovuta evidenza —, con gravi conseguenze per il futuro. Venendo infine al punto sul quale con maggior forza Vivarelli fa leva per sostenere la sua tesi, le stesse elezioni del 1919 e le pur importanti modificazioni del parlamento ad esse legate non possono esser lette in chiave di « occasione storica » perduta se non trascurando una serie di fattori che di fatto intralciavano una soluzione democratica della crisi ed attribuendone il fallimento, come appunto fa Vivarelli, al mancato concorso di una non meglio precisata « volontà degli
14 Cfr. anche Gian Enrico rusconi, La crisi di Weimar. Crisi di sistema e sconfìtta operaia,Torino, Einaudi, 1977, con il concetto (in sé significativo) ivi sviluppato di « democrazia contrattata ».17 Cfr. Alberto Caracciolo, L ’ingresso delle masse sulla scena europea, in aa.w ., Il trauma dell’intervento: 1914-1919, Firenze, Vallecchi, 1968, pp. 7-26.11 Cfr. giuliano procacci, Appunti in tema di crisi dello stato liberale e di origini del fascismo, in « Studi storici », 1965, pp. 221-237.19 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 211.29 Ibid., p. 208.
100 Tommaso Detti
uomini » 21. Egli ammette che gli anni della guerra avevano segnato « l’apice dell’impotenza parlamentare», considera a ragione «del tutto astratta» la formula di una alleanza tra popolari e socialisti, ma contraddice tutto ciò allorché sostiene che il Psi « avrebbe dovuto patrocinare una politica di riforme » 22 alleandosi con la « parte più avanzata delle superstiti forze costituzionali » rappresentata da Nitti e Giolitti.Il fatto è che l’imponente crescita del movimento socialista, in rapporto alla quale Vivarelli motiva la propria valutazione non ingiustificatamente negativa del ruolo dei socialisti nel parlamento e nel paese, altro non era che il frutto della politica di intransigente opposizione portata avanti nel periodo bellico. Conseguenza di quella politica fu anche un grave isolamento del movimento operaio, che certo i socialisti non seppero in alcun modo limitare ma che tuttavia non può essere attribuito unicamente alle loro carenze soggettive, né impugnato per liquidare il significato, il valore e i risultati delle scelte operate dal Psi nel 1914-15. Che gli enormi consensi raccolti da questo partito nel dopoguerra fossero il frutto della corrispondenza tra gli orientamenti dei massimalisti e quelli della base socialista è oltre tutto provato dal timore evidenziato dai riformisti a contrapporvisi. Non si è dunque tanto in presenza di una contraddizione tra le parole « rivoluzionarie » dei socialisti e i fatti che «spesso erano invece <riformisti> », quanto piuttosto dall’incapacità che fu comune a rivoluzionari e a riformisti di dar vita a una politica coerente con i rispettivi presupposti. Ma soprattutto — non lo si sottolineerà mai abbastanza — non è possibile valutare l’operato dei socialisti astraendo dai suoi molteplici condizionamenti oggettivi e dagli ostacoli che anche presso altre forze politiche (e più in generale nella società italiana del tempo) si frapponevano alla realizzazione di una politica democratica.Tutto ciò rinvia comunque al problema rappresentato dal fenomeno massimalista, che Vivarelli pone « al centro di ogni non superficiale riflessione sugli anni che segnano in Italia la crisi dello stato liberale » e collega strettamente alla questione dell’avvento del fascismo23. Del massimalismo — cui viene ricondotta 1’« atipicità » deUTtalia rispetto alla rivoluzione russa — Vivarelli rileva la mancanza di contenuti «in termini politici», per proporne una definizione in negativo come «rifiutodi ogni riformismo» e, più in generale, espressione di uno «stato d’animo».
!
Prescindendo dall’affermazione secondo la quale forme di massimalismo sarebbero riscontrabili da questo punto di vista anche presso altre forze politiche (frutto dell’accoglimento di una accezione estensiva del termine, che rischia di far smarrire la specificità storica di un fenomeno che ha contorni ben definiti), non c’è dubbio che questa impostazione consenta di coglierne alcuni tratti essenziali. « Credenze di base » e « valori assoluti », messianismo popolare, utopia e mito sono in effetti altrettante componenti del massimalismo, ed è merito di Vivarelli averne tenuto conto. Suscita però non poche perplessità la rigida separazione da lui introdotta tra forme politiche e « prepolit’che » del massimalismo, che lo induce a far sua l’interpretazione del populismo russo avanzata da Gerschenkron « non tanto o non soltanto come un capitolo nella storia del socialismo, quanto invece come un capitolo nella storia delle ideologie che si sviluppano nelle condizioni di arretratezza » 24.
21 Ibid., p. 213.22 Ibid., p. 215.22 Benché sla questo un nodo centrale del dibattito storiografico, cui Vivarelli porta con la sua relazione un nuovo contributo, non potrò soffermarmici per non dilatare oltre misura l’ampiezza di questa nota. La citazione è a p. 233.24 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 227.
Il primo dopoguerra in Europa 101
La questione introduce al nucleo della proposta interpretativa di Vivarelli, per cui il massimalismo sarebbe fondamentalmente espressione di un’Italia rurale rimasta immobile dall’unità al primo dopoguerra. Questa « faccia » del massimalismo, cui soprattutto vengono attribuite le caratteristiche « prepolitiche » sopra richiamate, dev’essere tenuta ben distinta secondo lui da una minoritaria componente urbana, che dette al massimalismo i suoi quadri dirigenti e in cui sopravvivevano spiccate influenze della tradizione mazziniana.Ora, a me pare che le due « facce » non possano essere così drasticamente isolate. Fin dal 1894-95, ad esempio (il problema non riguarda solo le tendenze intransigenti sul cui tronco si innesterà il massimalismo, ma anche la speculare componente riformista), i quadri piccolo-borghesi e « popolari » del socialismo italiano avevano instaurato un rapporto non effìmero con delimitati ma importanti settori del mondo rurale, e le rispettive culture erano rimaste variamente influenzate da questo incontro. Non è poi vero che i principali dirigenti (cui Vivarelli si riferisce; per i « minori » il problema è diverso e richiederebbe ricerche approfondite) muovevano solitamente dai centri urbani, dove si trovavano le maggiori organizzazioni politiche e sindacali, i giornali ecc., per recarsi quotidianamente tra i contadini? Più in generale, il tipo di rapporto tra città e campagna esistente nell’Italia del centro- nord, grazie anche all’introduzione di rapporti capitalistici di produzione nelle campagne proprio nelle regioni in cui non a caso i socialisti avrebbero trovato le loro più solide basi di massa — un fenomeno, tra l’altro, che ridimensiona l’affermazione di Vivarelli sull’immobilità del mondo rurale segnatamente per il problema che ci interessa —, non consente esso stesso di operare distinzioni così nette.Si tratta evidentemente di questioni assai complesse, cui non è possibile dare qui risposte esaurienti e documentate, ma che debbono essere richiamate come contributo ad una seria discussione. Maurizio Degl’Innocenti, ad esempio, ha mostrato come nel 1911-12 la vittoria degli intransigenti nel Psi si fondasse sul consenso non soltanto delle organizzazioni delle zone bracciantili, ma anche di quelle delle zone urbane e industriali23. Occorre allora domandarsi se una interpretazione del massimalismo come fenomeno in primo luogo rurale non debba esser verificata concentrandosi sulle modificazioni geografiche e sociali della base socialista maturate negli anni della guerra. Ciò che oltre tutto, ferma restando la necessità di non trascurarne le più profonde radici, introduce a una corretta valutazione del massimalismo come fenomeno dell’epoca della guerra e della rivoluzione. Chi scrive ha avuto occasione di rilevare nella geografia degli iscritti al Psi nel primo dopoguerra i primi segni di una significativa espansione verso il Mezzogiorno 25 26; si tratta però di un dato che non modifica nell’immediato le caratteristiche generali della dislocazione del partito e che per giunta non è confermato dalle cifre delle elezioni del 1919. Se pure l’accentuarsi del carattere rurale del movimento socialista sembra un fatto reale, il mutare della sua composizione sociale dev’essere dunque riscontrato attraverso indagini settoriali e differenziate, ma sempre all’interno di una distribuzione geografica che nel complesso ricalca quella tradizionale 27.Ed ecco che — quasi a confermare la validità di un assunto metodologico fonda
25 Cfr. Maurizio degl’innocenti, La guerra libica, la crisi del riformismo e la vittoria degli intransigenti, in « Studi storici », 1972, pp. 499 sgg. e id., Il socialismo italiano e la guerra di Libia, Roma, Editori Riuniti, 1976, cap. X.26 Cfr. tommaso detti, Serrati e la formazione del Partito comunista italiano. Storia della frazione terzinternazionalista 1921-1924, Roma, Editori Riuniti, 1972, p. XXIX.21 Su questi problemi si vedano anche il cap. I e le appendici di Renzo Martinelli, Il Partito comunista d’Italia 1921-1926. Politica e organizzazione, Roma, Editori Riuniti, 1977.
102 Tommaso Detti
mentale — la questione del massimalismo torna a presentarsi in quest’ambito inestricabilmente connessa con quella del riformismo. In che misura differivano le basi geografiche e sociali delle due correnti? Non è facile, allo stato attuale delle conoscenze, dare a questo interrogativo una risposta soddisfacente, ma credo si possa ipotizzare che alcune innegabili differenze debbano in ogni caso collocarsi nell’ambito della constatazione del permanere in linea generale di marcate analogie. Per questo, fermo restando che nel dopoguerra si è certo in presenza di una crisi nel rapporto tra il riformismo e la sua base, non sembra sostenibile che tale crisi fosse già giunta alle estreme conseguenze, come autorizza a ritenere un esame degli orientamenti dei sindacati e delle stesse elezioni del 1924. Vi è da domandarsi, in altri termini, se l’affermazione di Vivarelli secondo cui la « base rurale » socialista era nel dopoguerra ormai « saldamente conquistata dal massimalismo » 28 non corrisponda a una inaccettabile semplificazione che non trova riscontro nella realtà. Né si vede come possa essere fondatamente sostenuto che « i presupposti del riformismo » fossero « in aperto contrasto con i presupposti di quella cultura popolare che permeava generalmente le masse rurali e specialmente quel bracciantato, il quale costituiva il nucleo più robusto del movimento contadino organizzato ed era l’asse portante di quella base » 29. In tal caso, l’intera storia del socialismo riformista sarebbe percorsa da tale contraddizione, in quanto — come studi autorevoli hanno dimostrato senza trovare confutazioni sul piano della ricerca — le sue basi erano e rimanevano in gran parte rurali.A sostegno delle sue tesi, Vivarelli adduce alcune elaborazioni dei dati congressuali del Psi nel dopoguerra, che dimostrano come la base del massimalismo fosse « ormai saldamente radicata nelle campagne ». Riprendiamo ed integriamo questi dati: nel 1918 il voto massimalista proveniva per il 30,5 per cento dai capoluoghi di provincia, che davano al partito il 29 per cento dei suoi iscritti, e tali percentuali risultano al congresso del 1919 modificate rispettivamente in 20 e 19 per cento. Se si considera che nel 1918 la mozione Modigliani trasse dai capoluoghi il 22 per cento dei suoi voti, quella Tiraboschi il 10 per cento e le due mozioni insieme il 15 per cento30, si può constatare una effettiva inversione di tendenza: al congresso del 1919, infatti, la mozione Lazzari (sulla quale confluirono i riformisti) ottenne nei capoluoghi il 26 per cento dei suoi voti. Al congresso di Milano nel 1921, poi, dove la percentuale dei capoluoghi sul totale degli iscritti rappresentati è del 14,5 per cento, questo quadro appare confermato nelle sue linee generali: le mozioni massimaliste di Baratono e Lazzari vi ottennero il 13,5 per cento dei voti, quella «centrista1» di Alessandri il 17,5 per cento, quella riformista il 18 per cento31.Ammesso e non concesso che il criterio prescelto da Vivarelli per distinguere le zone rurali da quelle urbane possa considerarsi valido e che le sole cifre relative al partito siano sufficienti per definire fenomeni come il massimalismo e il riformismo, possiamo dunque constatare che tra il 1918 e il 1919 il carattere « rurale » del primo si accentua, quello del secondo si attenua. Secondo questi dati, però,
u Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 230.25 lbid., p. 228.30 Sulla mozione Tiraboschi confluirono infatti non pochi voti riformisti, come quelli delle sezioni del Ferrarese rappresentate da Bussi e Zirardini e quelli delle sezioni della provincia di Rovigo.31 I dati relativi al congresso di Milano sono tratti da direzione del p s i , Resoconto stenografico del XVIII Congresso del Psi (Milano, 10-15 ottobre 1921), Roma, 1922, pp. 346-394. Le cifre nel testo sono state intenzionalmente arrotondate, non potendosi render conto in questa sede di alcune inesattezze di questi dati e delle loro discrepanze con altre fonti, che peraltro non modificano in misura apprezzabile il quadro sopra delineato.
Il primo dopoguerra in Europa 103
nessuna delle tendenze socialiste può considerarsi « urbana » in misura superiore al 30 per cento, con la conseguenza che l’identificazione di un carattere in gran parte « rurale » del massimalismo non è tale da consentire fondate distinzioni su questo piano tra esso e il riformismo, che presenta analoghe caratteristiche.A maggior ragione appaiono dunque pertinenti le osservazioni contenute nell’intervento svolto a Perugia da Zeffiro Ciuffoletti, mentre non si può che restare stupiti di fronte alla replica di Vivarelli, secondo la quale « dopo il Congresso di Bologna del 1919 il termine <riformista) non ha più alcun significato concreto » 31 32. Il fatto che a Bologna i riformisti non presentassero una loro mozione (o che a Livorno questa assumesse il nome di « concentrazionista ») non consente infatti di ipotizzare, se non sul terreno di un formalismo esasperato e non giustificabile sul piano storiografico, la scomparsa di una tendenza che possedeva strumenti organizzativi e caratteri ideali ben definiti, e che per giunta nel 1922 avrebbe dato vita ad un partito politico.Quelle sin qui sommariamente svolte non sono che alcune delle tante osservazioni che la relazione di Vivarelli ha il merito di stimolare. Esse configurano 1’esistenza di ampi margini di discussione anche sul piano del metodo, ma non hanno né ambiscono ad avere che il carattere di un primo contributo allo sviluppo del dibattito intorno a questo nodo cruciale della storia dell’Italia contemporanea. Il taglio necessariamente sintetico della relazione, non può far dimenticare che essa è il frutto di un lavoro pluriennale, rinviando così una verifica più approfondita alla attesa pubblicazione del secondo volume dell’opera di Vivarelli sul primo dopoguerra.Si è detto all’inizio del significato politico complessivo del convegno di Perugia. Nelle sue conclusioni, Arfé ha negato energicamente che si sia trattato di « una operazione politica di segno moderato», pur aggiungendo di ritenere «assai probabile che da alcune parti possa esser fatto il tentativo di presentare questa nostra iniziativa in termini di polemica anticomunista » 33. Ora, che tali non fossero gli intenti di studiosi come lo stesso Arfé o Gaeta, non si ha alcuna difficoltà a crederlo; il problema però è un altro: è se questa ed altre analoghe iniziative possono prestarsi o meno ad un uso anticomunista, e prima ancora se contengono già in sé o meno elementi di moderatismo derivanti dal modo in cui le interpretazioni scaturite dalla ricerca storica vi vengono affrontate quanto ai contenuti e ai metodi.Nel merito delle principali questioni affrontate dal convegno, Arfé ha ricordato come proposito degli organizzatori fosse quello di « sottoporre a verifica critica, senza schemi precostituiti in osservanza a pregiudiziali di parte, l’ipotesi sulla quale sorse la III Internazionale, alla quale essa ispirò le rigidissime direttive impartite alle correnti e alle frazioni del movimento comunista europeo e mondiale che la sua autorità riconoscevano » 34. Un’ipotesi, che a suo giudizio non ha trovato da parte degli storici comunisti una verifica critica non soltanto nei paesi socialisti, ma anche in Italia. Quanto alla storia del movimento operaio italiano, Arfé considera « pressoché conclusa » una fase degli studi pesantemente condizionata dalle ipoteche politiche e ideologiche dello stalinismo e dà atto agli storici comunisti di aver contribuito al suo superamento, ma nell’indicare il compito che sta oggi di fronte alla storiografia scrive: « Si tratta di sbarazzare il terreno del giudizio secondo il quale [...] è col 1921 che comincia per il movimento operaio italiano il passaggio, per usare una espressione classica, della preistoria alla storia » 35.
31 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 276.33 Ibid., p. 319.34 Ibid., p. 31433 Ibid., p. 318.
104 Tommaso Detti
A me pare che in tutto ciò debbano essere ravvisate alcune inesattezze e una contraddizione di fondo. A Perugia, come anche al più recente convegno dell’Istituto socialista di studi storici su Camillo Prampolini e il socialismo riformista in Italia, l’elaborazione di nuove ipotesi interpretative e la rivendicazione di una « storiografia critica » contrapposta a una « storiografia ideologica » poggiano in Arfé su una valutazione non immotivamente severa di una fase degli studi della storia del movimento operaio italiano e internazionale sulla quale gravavano pesanti condizionamenti ideologico-politici, che però ne costituisce l’esclusivo punto di riferimento34 * 36. Ma è proprio questo, oggi, il problema? È possibile riallacciarsi direttamente alla situazione degli anni cinquanta senza falsare in qualche modo i termini reali dell’odierno dibattito storiografico, senza correre il rischio di ribaltare le certezze di allora, di ripetere in forme diverse antichi errori? In realtà, solo trascurando i risultati di un intero quindicennio di studi e discussioni condotti con pieno spirito critico, che ha visto la storiografia sul movimento operaio italiano e internazionale compiere non piccoli progressi sul piano delle conoscenze e del metodo, grazie anche al contributo della storiografia marxista, è possibile a mio avviso affermare che è mancata da parte degli storici comunisti italiani una verifica critica sulla storia del Komintern e del Pei.Tutto ciò sa bene Gaetano Arfé, il quale non a caso ammonisce che non si tratta di « rovesciare vecchi giudizi e pregiudizi » o di « sostenere pregiudizialmente, programmaticamente » chi « avesse ragione » o « avesse torto », e pone il giusto obiettivo di « arrivare a una visione non politicamente ma storiograficamente unitaria del movimento operaio socialista dell’intera Europa » 37 E tuttavia, è proprio dalla mancanza di un ampio confronto sul piano storiografico, da questo « scarto » tra anni cinquanta e anni settanta, che possono riprendere fiato posizioni moderate ed anticomuniste fondate sulla riproposizione di schemi precostituiti sul terreno del giudizio storiografico.Al termine di un’ampia e approfondita riflessione sul primo dopoguerra europeo, Salvadori ha scritto in un suo saggio del 1972 che, «anziché parlare di <crisi rivoluzionaria degli anni 1919-1920 >, dovremmo piuttosto parlare di crisi sociale e politica con elementi di rivoluzione e controrivoluzione nel quadro della vittoria delle forze imperialistiche » 38. Si tratta di una conclusione la cui validità mi sembra confermata, come ho cercato di mostrare, anche da taluni dei contributi del convegno di Perugia. Parrebbe quindi sufficientemente chiaro che dalla critica dell’analisi leniniana sulle prospettive della rivoluzione in Europa nel primo dopoguerra non può scaturire se non entro limiti ben precisi l’affermazione della possibilità di una « rivoluzione democratica » che sarebbe stata affossata dalla nascita e dalla politica del Komintern. Che, insomma, ad una « occasione perduta » non può sostituirsi un’altra «occasione perduta®, che un giudizio storicamente motivato sulla tragedia del movimento operaio nel primo dopoguerra non può certo formularsi in termini di caccia alle responsabilità.Eppure, proprio grazie al tipo di impostazione del dibattito sopra richiamata, accanto a contributi polemici ma equilibrati sono suonati al convegno di Perugia
34 Per la relazione al convegno prampoliniano, di cui sono peraltro imminenti gli Atti, cfr.gaetano arfé, La storiografia del movimento socialista in Italia, in « Mondoperaio », 1978, n. 11,pp. 59-66.37 Rivoluzione e reazione, cit., voi. II, p. 318.33 massimo L. salvadori, Rivoluzione e conservazione nella crisi del 1919-1920, in aa.vv., Problemi di storia dell’Internazionale comunista (1919-1939), a cura di A. Agosti, Torino, Fondazione L. Einaudi, 1974, p. 56.
Il primo dopoguerra In Europa 105
accenti di schematismo dettati da pregiudiziali ideologiche e politiche, si sono affacciati persino tratti di integralismo. Non può stupire allora che vi sia stato chi, rendendo conto dei risultati del convegno, ha creduto bene di sollecitare e banalizzare il senso della relazione di Salvadori, avanzando retorici interrogativi su chi, tra Lenin e Kautsky, avesse ragione. Queste le sue perentorie conclusioni: « I termini del dibattito di ieri non sono stati ancora superati da quello di oggi. Esso potrà dirsi storicamente chiuso solo quando chi scopre oggi il terreno del < revisionismo socialista >, vecchio e nuovo, e lo contrabbanda come propria originale < evoluzione >, avrà pagato, fino in fondo, il suo debito di fronte al tribunale della storia » 39. Ogni commento è superfluo; ma è certo che, sinché si rimarrà su questo piano, lasciarsi alle spalle « i termini del dibattito di ieri » e farli oggetto di indagine scientifica sarà tutt’altro che facile. Non è molto diverso il procedimento seguito da un altro cronista nel presentare la già citata relazione di Arfé al recente convegno prampoliniano. Questi può valersi infatti dell’insistenza del relatore sugli anni cinquanta (che peraltro hanno portato a risultati non irrilevanti e meritevoli di maggiore attenzione) per contrapporre alla « capacità della cultura socialista d’impostare anche una operazione di recupero storico con spirito critico, aperto, rispettoso senza riserve dell’autonomia del momento scientifico nei confronti del politico » a una « storiografia comunista » che si vorrebbe non altrettanto rispettosa di tale autonomia e impegnata « a fare da braccio culturale della politica togliattiana, con effetti fortemente mistificanti nei confronti del socialismo italiano prima del ’21 » 40.Non è dunque irreale il pericolo del riemergere di una concezione (magari più sottilmente) ancillare della storia, di un arretramento anziché di un progresso del dibattito storiografico. L ’esigenza di ripercorrere criticamente e autocriticamente tutte le tappe di tale dibattito è un’esigenza reale, una riflessione sulla storia della storiografia del movimento operaio italiano e internazionale appare indispensabile per lo sviluppo di questi studi. Ma attardarsi a polemizzare contro lo stalinismo degli anni quaranta e cinquanta al di fuori di un contesto più ampio, che introduca a una discussione spassionata e proficua sullo stato attuale e sulle prospettive degli studi, serve ormai soltanto a sfondare porte aperte da tempo. Il terreno privilegiato di un confronto fecondo, proprio di quella « cultura non più strumentalizzata a fini di propaganda » 41 che giustamente gli storici dell’« area socialista » rivendicano, non può essere che quello delle più significative e durature acquisizioni della ricerca scientifica.
TOMMASO DETTI
59 M. baccianini, Leninismo e socialdemocrazia nel primo dopoguerra, in « Mondoperaio », 1978, n. 4, p. 123.40 p. amato, L ’eredità del socialismo riformista, in « Mondoperaio », 1978, n. 11, p. 139.
Rivoluzione e reazione, cit., voi. I, p. IX.41