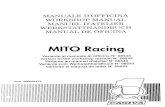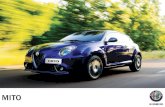Il mito dell’acqua - Paulo Borges | Filosofia · Web viewIl mito dell’acqua Ciascuno degli...
Click here to load reader
Transcript of Il mito dell’acqua - Paulo Borges | Filosofia · Web viewIl mito dell’acqua Ciascuno degli...

Il mito dell’acqua
Ciascuno degli elementi materiali che ha ispirato le filosofie tradizionali e le
cosmologie antiche: l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra, porta in sé, intimamente radicate,
delle immagini. Si tratta di immagini della materia, immagini dirette della materia.
Immagini spesso bellissime, belle di una bellezza interna.
Qualsiasi immagine sostanziale per fiorire, deve riempirsi di ornamenti,
soccombere all’esuberanza della bellezza formale. Noi siamo soliti coltivare l’immagine
formale, l’immagine chiara. Dietro le immagini formali, cangianti e vane, se ne
nascondono, però, altre di una profondità tale da apparire eccezionali, quelle originarie
ed eterne della materia.
L’immagine più mobile, più metamorfosante, conserva, sempre, una densità, un
cuore, un nucleo di germinazione immaginativa: l’invariabilità della materia. Colta nella
prospettiva della profondità, la materia è l’origine di qualsiasi slancio immaginativo, è il
principio di ogni forma. Per questo dobbiamo eliminare i suffissi della bellezza formale,
scoprire le immagini che si celano dietro le immagini che si mostrano, raggiungere la
fonte stessa del potere immaginante, la sorgente che è sorgente: la materia stessa.
Fatte queste debite premesse vediamo come l’acqua1, elemento femminile,
persistente e mutevole, evochi forze umane nascoste, semplici, semplificanti. Sotto le
immagini superficiali dell’acqua ne appaiono altre più profonde e tenaci, è come se
all’immaginazione delle forme facesse eco quella della sostanza, una sostanza
vivificante, strutturante.
L’immaginazione materiale dell’acqua è una specie particolare di
immaginazione. La sostanza acqua, porta iscritto in sé un tipo di destino, un destino
importante. Essa scorre sempre, sempre cade, in un movimento rotondo e fluido che
dona mutevolezza e pienezza all’essere, che lo trasforma incessantemente. E’ un
danzare voluttuoso tra nascita e morte.
Colui che si vota all’acqua è preso nella vertigine. Egli muore ogni istante,
qualcosa della sua essenza inesorabilmente sprofonda nel ventre materno per rinascere.
E’ in questo scorrere che si compie il destino dell’acqua e dell’essere; l’acqua e l’essere,
1 Cfr., in proposito, G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, trad. it., Como, 1992.
1

fluendo, si trasformano e, trasformandosi, fluiscono. L’acqua è veramente l’elemento
transeunte, l’emblema della metamorfosi ontologica.
Essa ci fa comprendere in modo simpatetico e doloroso uno dei caratteri
dell’eraclitismo, il mobilismo, il perenne fluire2. Non un fluire caotico ma uno scorrere
verso gli opposti, un tendere ai contrari. Niente rimane e perdura qual è inizialmente,
ciò che è freddo si riscalda e ciò che è caldo si raffredda, l’umido si asciuga e il secco si
inumidisce, in un processo infinito che contrappone ad ogni cosa il suo opposto. E’ la
legge enantiodromica del divenire. In essa i contrari non si eliminano, né si conciliano,
sono indissolubilmente legati, dipendono gli uni dagli altri, stanno in una tensione
continua, in una guerra che genera armonia.
L’essere umano vive questo principio eracliteo perché ha in sé, iscritto nel
profondo, il destino dell’acqua che scorre. Questa immaginazione aperta, la percezione
di qualcosa che continua, qualcosa di incompleto, che bisogna completare, un’acqua
viva. In uno specchio naturale3, in un’immagine riflessa più reale del reale perché più
pura, l’uomo vede la sua vera identità: la catena ininterrotta di morti e rinascite, il suo
incessante fluire. Il riflesso, infatti, nella sua vaghezza, nel suo correggere la realtà, nel
suo eliminarne le sbavature, le imperfezioni, le conferisce solennità, idealità platonica.
E’ come se sistematicamente la idealizzasse.
Una volta richiamata l’attenzione sull’immagine sostanziale dell’acqua,
sull’azione metamorfosante che esercita sull’essenza dell’essere, possiamo
abbandonarci alle immagini formali dei suoi contrari: la vita e la morte. Le immagini
che incontreremo ci parleranno del suo essere a un tempo vivificante e mortifera, del
suo essere acqua che nutre, sostiene, culla, al pari di una madre tenera e premurosa ma
che, altresì, uccide, colei che accompagna nell’ultimo viaggio, quello nel regno dei
morti dal quale si fa ritorno sempre rafforzati e arricchiti nella propria essenza.
L’acqua viva, portatrice di vita, contiene in sé in potenza i germi di qualsiasi
manifestazione. E’ la fons et origo di tutte le possibili esistenze. Essa precede le forme e
2 “Tutto scorre. Il fiume in cui entrano è lo stesso, ma sempre altre sono le acque che” vengono loro incontro, Eraclito (Diels-Kranz), fr. 12. Nel Cratilo di Platone si trova scritto: “Eraclito afferma, […] che tutto scorre e nulla permane e, paragonando gli enti alla corrente di un fiume, sostiene che non ci si può immergere due volte nello stesso fiume”, Platone, Cratilo, 402 a.3 E’ curioso come gli specchi di vetro, o meglio, la geometricità della forma e la fissità del materiale di cui sono fatti, diano un’immagine statica dell’oggetto. Torneranno ad essere vivi e naturali quando potranno essere paragonati a un’acqua tranquilla nel suo scorrere. Cfr. G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, op. cit., pp. 35-37.
2

fa da supporto ad ogni creazione4. E’ l’acqua che genera il mondo. Un’acqua
immensamente espansa, eterna, inesauribile. Un’acqua nutriente, l’alimento tiepido e
fecondo che la terra prepara nel suo ventre oscuro. Un’acqua semplice o composta.
Vale la pena di soffermarsi, seppure brevemente, sul significato di immagine
sostanziale semplice e composta5 per meglio comprendere i principi della causa
materiale.
Qualsiasi immaginazione formale per essere vitale, per avere vigore e forza, per
riuscire ad evocare energie primigenie, deve racchiudere, nel suo intimo,
un’immaginazione materiale. L’immaginazione materiale, l’immaginazione dei quattro
elementi, normalmente ne privilegia uno. Il suo elemento prediletto impregna tutto,
diventa l’unica sostanza di un mondo. Ama, però, anche giocare con loro, le piace
combinarli insieme. Un aspetto di tali combinazioni colpisce immediatamente, esse
uniscono sempre due elementi, mai tre. Un’unione ternaria di sostanze non è pensabile,
si tratterebbe di un’immagine artificiosa, figlia delle idee non della materia.
Le immagini vere, le immagini ardenti, palpitanti di vita, sono, sempre, unitarie
o binarie. Partecipano della monotonia di una sostanza o della giocosa combinazione di
due elementi.
Ritorniamo, adesso, alle immagini di acqua semplice, di acqua gravida di vita, e
vediamo quali sono i suoi attributi.
Da sempre l’acqua rappresenta per l’uomo uno dei maggiori e costanti simboli
materni, della madre e del suo latte, della creatura-cibo che lo ha nutrito con la sua
stessa sostanza6.
Le acque naturali, le acque dei fiumi, dei laghi, dei mari, assumono sembianze
lattiginose, diventano metafore lattee. L’acqua si maternizza, diviene nutriente e densa,
abbondante e salvifica, il latte di Madre natura.
Si tratta dell’attuazione del principio fondamentale dell’immaginazione
materiale che mette alla base di ogni immagine formale uno degli elementi primitivi.
Per l’immaginazione tutto ciò che scorre è acqua. Il colore, la consistenza, poco
importano, si traducono solo in un aggettivo. Il latte materno, la bevanda felice, fluisce.
Fluendo partecipa della natura dell’acqua, diventa acqua e l’acqua, latte.
4 Cfr. M. Eliade, Immagini e simboli, trad. it., Milano, 1981, p. 135.5 Cfr. G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, op. cit., pp. 113-116.6 Cfr. op. cit., pp. 137-157.
3

In tutte le tradizioni antiche le immagini acquatiche semplici sono associate alla
vita, alla nascita del cosmo. Pensiamo al mito cosmogonico indù di cui si trova traccia
nei Rig-Veda7, al terribile combattimento tra la divinità ctonia Vrtra e quella solare
Indra. Il serpente primordiale che imprigiona le acque nelle viscere della montagna,
impedendo al mondo di essere e di durare e il dio generoso armato di vajra8 che lo
folgora, liberandole, generando, così, il creato.
Nella cultura greca uno dei racconti più antichi delle origini, al quale allude
anche Omero nell’Iliade9, un racconto diffuso soprattutto tra le genti della costa, narra
di Oceano e Teti. Oceano, dio delle acque, principio generante maschile, raffigurato
come un fiume di grande portata che scaturisce da sé e a sé ritorna, fluendo in un circolo
ininterrotto, e Teti, divinità acquatica, rappresentante il principio fecondante femminile.
Dalla loro sacra unione tutto ha origine, gli dei e il mondo.
Ci occupiamo, ora, di alcuni miscugli, di alcune mescolanze di elementi in cui
l’acqua ha un ruolo preponderante. Esamineremo in successione l’unione dell’acqua con
il suo contrario, il fuoco, dell’acqua con la terra, dell’acqua con l’aria.
Per quanto riguarda la combinazione dell’acqua e del fuoco, di un elemento
passivo femminile con uno attivo maschile, una delle immagini formali più ricorrenti è
quella della pioggia. Una pioggia di luce, una pioggia d’oro, una pioggia vivicante e
fecondante. Essa veicola forze spirituali, permette agli influssi celesti di discendere sulla
terra.
Non è un caso che la luce e la pioggia siano associate al sole10, ciò è
perfettamente conforme alla natura dei fenomeni fisici corrispondenti. Il sole è
realmente la sorgente diretta di luce del nostro mondo e colui che, facendo evaporare le
acque, le aspira verso l’alto, nelle regioni superiori dell’atmosfera, da cui ridiscendono
sotto forma di pioggia. Va sottolineato come questa azione sia esercitata dal calore del
sole. Appaiono, così, i due termini complementari in cui, solitamente, si polarizza
l’elemento igneo: la luce e il calore. Questa spiegazione ci aiuta a comprendere meglio
come mai esistano, nelle diverse epoche storiche, immagini simboliche uguali del sole
e dell’acqua.
7 Cfr. Rig-Veda, I, 32.8 Arma simile al fulmine, affilata e con molte punte, solitamente di ferro o d’oro, che quando viene lanciata sibila.9 Cfr. Omero, Iliade, 14, 246.10 Cfr. R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, trad.it., Milano, 1997, pp. 313-316.
4

Spesso, in tempi e luoghi diversissimi, e in Occidente fino al Medioevo, il sole è
stato raffigurato con raggi rettilinei e ondulati, un sole raggiante e fiammeggiante. La
linea retta rappresenta la luce, quella ondulata il calore. La linea ondulata è, però,
ovunque il simbolo dell’acqua. Se pensiamo a quanto abbiamo detto non c’è alcuna
contraddizione. La pioggia procede dal sole. Essa è un effetto del suo calore, per questo
la sua raffigurazione può confondersi con quella del calore stesso. Allo stesso modo la
duplice radiazione del sole di luce e calore può essere vista come luce e pioggia.
Numerosi sono i racconti mitologici che parlano della pioggia di stelle, della
pioggia di luce, della pioggia d’oro. Nella cultura classica, in quella greca, uno dei più
conosciuti è quello di Danae11, figlia di Acrisio, re di Argo, e Euridice, che il padre fa
rinchiudere in una torre di bronzo a causa di una profezia: uno dei figli di Danae gli darà
la morte. Zeus, invaghitosi di lei e deciso a non lasciarsela scappare, penetra nella torre
sotto forma di pioggia d’oro. Dalla loro unione nasce Perseo, l’eroe che compirà la
predizione. A Larissa, durante una gara di piastrella a cui prenderà parte, sbaglierà mira,
uccidendo proprio Acrisio.
Gli abitanti dell’isola di Rodi raccontano che qualcosa di simile è accaduto alla
nascita di Atena. Al balzar fuori della dea dalla testa del padre, egli fa cadere una
pioggia d’oro12.
L’unione fra l’acqua e la terra, fra due elementi passivi femminili, fra le sostanze
che più rappresentano la materializzazione, il divenire delle forme, è un connubio
speciale. E lo è per due ordini di motivi. In primo luogo esso implica un processo
ulteriore di sessualizzazione di uno degli elementi13. Quando materie tendenzialmente
femminili, come l’acqua e la terra, si mescolano, una di esse deve leggermente
mascolinizzarsi per dominare l’altra. Solo così la combinazione risulta solida e duratura,
solo così crea immagini reali e vive.
In secondo luogo questo miscuglio rende, nell’intimo, lo schema della causa
materiale14. Acqua e terra insieme producono un impasto. L’impasto fornisce
un’esperienza primaria della materia. Libera la mente dal problema delle forme. In esso
la forma viene cancellata, dissolta, esclusa per poi rinascere. Nell’impasto l’azione 11 Cfr. A. M. Carassiti, Dizionario di mitologia classica, Roma, 2001, p. 70 e pp. 244-245 e K. Kerényi, Gli dei della Grecia, trad. it., Milano, 1998, p. 112.12 Cfr. Pindaro, Le Olimpiche, 7, 34.13 Cfr. G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, op. cit., pp. 115-116.14 Cfr. op. cit., pp. 125-135.
5

dell’acqua è evidente. Essa tempera gli elementi e quando è davvero penetrata nella
terra, quando ha divorato la terra, quando ha portato alla terra il principio stesso della
fecondità calma, lenta, sicura, solamente allora l’esperienza del legamento ha inizio e la
forma comincia a emergere dalla vegetazione sognante dell’amorfo. L’acqua,
nell’impasto, è vissuta nella sua ambivalenza attiva, nel suo ruolo emolliente e
agglomerante, nel suo essere potenza dissolvente ed aggregante.
Una delle immagini formali più antiche e potenti di questa unione che ricorre in
quasi tutte le tradizioni, è quella dell’uomo. Un uomo fatto d’argilla. Una sostanza che
contiene, o dovrebbe contenere, in giuste proporzioni, acqua e terra e che il poeta e
romanziere polacco, Milosz, fa derivare dal connubio di lacrime e terra. Egli scrive: “La
mancanza di dolore […] rende l’uomo asciutto, povero, maledetto. Troppe lacrime,
privo di coraggio […] di presa […] un’altra sventura”15.
Della combinazione di acqua e aria, di un elemento femminile passivo con uno
maschile attivo, stranamente, Bachelard non parla, nemmeno un accenno. Al potere
materializzante e fecondante dell’acqua si unisce quello spiritualizzante e trasfigurante
dell’aria.
La sostanza aria, volatile e eterea, solitamente, è associata al vento, al soffio16. E’
il messaggero alato fra il mondo celeste e quello terreno, l’icona sensibile della vita
invisibile. La mescolanza di acqua e aria è gravida di frutti. L’acqua della loro unione, è
fluida, leggera, trasparente, aerea. Essa nutre più l’anima che il corpo.
Un’immagine formale molto conosciuta di questa combinazione è quella
dell’Acquario, l’undicesimo segno dello Zodiaco17. Un uomo a figura intera con tratti da
vecchio saggio che porta sulle braccia o sulle spalle una o due anfore inclinate dalle
quali esce un fiotto d’acqua. Un’acqua lieve e limpida che riunisce in sé il carattere
instabile dell’aria e quello morbido dell’acqua. Un’acqua a metà tra gli spruzzi diffusi
dalle onde e l’oceano gassoso in cui ci bagniamo. Un cibo per l’anima, per i suoi taciti
bisogni.
Torniamo, ora, al carattere ambivalente dell’acqua, al suo partecipare sia della
vita che della morte. L’acqua, come ciascun elemento materiale, contiene in sé il germe
15 Citato in G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, op. cit., p. 133.16 Cfr. G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archetipologia generale, trad. it., Bari, 1991, p. 152 e pp. 175-176.17 Cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, vol. I, trad. it., Milano, 1994, pp. 10-11.
6

della distruzione. Si tratta, però, di una distruzione particolare: la dissoluzione delle
forme.
L’acqua porta lontano, trascina il nostro essere nell’indistinto, lo consegna
temporaneamente all’informe, lo disperde totalmente, per farlo rinascere rafforzato e
arricchito sotto nuove spoglie. L’acqua, infatti, nel suo essere datrice di vita non può
trascendere le condizioni della virtualità, della latenza. Tutto ciò che è forma si
manifesta al di sopra dell’acqua, emerge dall’acqua, staccandosi da essa. Non appena
una forma si è staccata, non appena cessa di essere virtuale, soggiace alla legge del
tempo, si corrompe e finisce per svuotarsi. Una forma da sola non può trasformarsi.
Trasformarsi è contrario alla sua natura.
Dietro ogni trasformazione c’è sempre un’immaginazione materiale, dietro al
gioco delle forme c’è sempre l’acqua. Solo attraverso di lei le immagini formali
tradizionali si rianimano, solamente lei può riportarle in vita, trasformandole.
Ogni acqua originariamente chiara è destinata ad oscurarsi, ad assorbire
materialmente le ombre, ad inghiottirle come uno sciroppo nero. E’ un’acqua in potenza
fonda e oscura, di una profondità insondabile. Un’acqua dormiente. Rapidamente le
voci si smorzano, passando dal mormorio al silenzio. E’ un’acqua che arricchendosi, si
appesantisce. Piena di riflessi e d’ombre diventa pesante. La più pesante di tutte le
acque. Un acqua di morte18.
L’immersione nell’acqua, tanto sul piano cosmologico che su quello
antropologico, equivale a una regressione momentanea nel pre-formale a cui fa seguito
una nuova creazione.
Da un punto di vista strutturale il diluvio, l’affondamento dei continenti e il
battesimo sono equivalenti, aboliscono le forme, le disintegrano, per poi ricostruirle. E’
il destino delle forme quello di dissolversi per riapparire. Se esse non fossero
periodicamente riassorbite dalle acque, da un’acqua che fa vivere nella morte, aldilà
della morte, si frantumerebbero.
Il diluvio19 distrugge quasi tutta l’umanità perché le forme sono oramai logore.
Atlantide20 sprofonda perché si corrompe, perché la forma si svuota della sua sostanza. 18 Cfr. G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, op. cit., pp. 61-87.19 Cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, vol. I, op. cit., pp. 385-386 e H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, trad. it., Milano, 1991, pp. 158-159.20 Cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, vol. I, op. cit., pp. 113-114 e H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, op. cit., pp.
7

Nel battesimo21 l’uomo vecchio muore, l’antica struttura si sgretola per permettere a
un’altra di emergere.
Come non provare, dopo queste poche pagine, un certo disdegno per le forme?
Le forme che sono abiti, linee concluse, quando la materia è feconda, innovatrice,
polivalente? Colui che si abbandona all’immaginazione materiale, intraprende un
viaggio senza fine. Una sostanza non sembrerà mai sufficientemente lavorata, poiché
non smette di generare. Le forme si concludono. La materia no. Essa è la madre dei
sogni indefiniti.
Cinzia Russo
55-56.21 Cfr. J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, vol. I, op. cit., pp. 139-141.
8

Bibliografia
AA. VV., Rig-Veda. Le strofe della sapienza, a cura di S. Sani, trad. it., Venezia, 2000.
G. Bachelard, Psicanalisi delle acque, purificazione, morte e rinascita, trad. it., Como,
1992.
H. Biedermann, Enciclopedia dei simboli, trad. it., Milano, 1991.
A. M. Carassiti, Dizionario di mitologia classica, Roma, 2001.
J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dizionario dei simboli. Miti, sogni, costumi, gesti, forme,
figure, colori, numeri, voll. I e II, trad. it., Milano, 1994.
G. Durand, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione
all’archetipologia generale, trad. it., Bari, 1991.
M. Eliade, Immagini e simboli, trad. it., Milano, 1981.
R. Guénon, Simboli della Scienza sacra, trad. it., Milano, 1997.
K. Kerényi, Gli dei della Grecia, trad. it., Milano, 1998.
Omero, Iliade, trad. it., Milano, 2001.
Pindaro, Le Olimpiche in Le Odi, vol. I, trad. it, Milano, 2000.
Platone, Tutti gli scritti, a cura di G. Reale, trad. it., Milano, 2001.
9