Il Core Curriculum del Fisioterapista - corsi.unibo.itcorsi.unibo.it/fisioterapia/Documents/Il Core...
Transcript of Il Core Curriculum del Fisioterapista - corsi.unibo.itcorsi.unibo.it/fisioterapia/Documents/Il Core...

1
Il Core Curriculum del Fisioterapista
Versione 2.0

2
SOMMARIO
Core Curriculum in fisioterapia……………………….……………… pag. 4
1. cosa è il Core Curriculum……………………………………… pag. 5 2. perché il Core Curriculum 3. a cosa serve il Core Curriculum 4. a chi è diretto il Core Curriculum 5. come è stato realizzato il Core Curriculum
Introduzione……………………………………………………………. pag. 6
1. la conoscenza (nel contesto delle professioni sanitarie) 2. le fonti
Materiali e metodi………………………………………………………. pag. 7
1. le tappe principali 2. partecipanti 3. metodi
Struttura del Core Curriculum………………………………………… pag. 9
1. come è fatto e come si legge Il Core Curriculum………………………………………………………. pag. 11 Indice analitico…………………………………………………………… pag. 75 Il glossario....…………………………………………………………….. pag. 77 Sviluppi futuri……………………………………………………………... pag. 80 Bibliografia ……………………………………………………………….. pag. 80

3
PREMESSA
Nessun Core Curriculum può essere considerato definitivo. Il primo Core pubblicato sul numero 1 del 2005 di “Scienza Riabilitativa” ha rappresentato un forte stimolo per tutti i professionisti impegnati nella formazione, che hanno quindi voluto dare il proprio contributo per migliorare uno strumento che vuole tendere a migliorare le basi delle conoscenze del Fisioterapista. Da qui la attuale revisione, fondata sulle attuali indicazioni ministeriali, che ha visto una crescente partecipazione e quindi una miglior condivisione di tutti gli aspetti e ambiti.

4
IL CORE CURRICULUM
“Quando arriva la conoscenza arriva anche la memoria” (Gustav Meyrink)
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”
(Dante Alighieri)
“Il Core Curriculum è il complesso di contenuti essenziali (conoscenze, competenze, abilità e comportamenti) che tutti i neo-laureati debbono avere
acquisito in modo completo e permanente per l’esercizio iniziale della professione” (Luciano Vettore)
IL CORE CURRICULUM DEL Fisioterapista
(da “TRADIZIONE E INNOVAZIONE NELLA FORMAZIONE UNIV ERSITARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE: Il Core Curriculum, dal Core Contents al Core Competence” P . Binetti – D. Valente)
Il progetto formativo del Fisioterapista ha come obiettivo quello di fornire allo studente conoscenze e capacità di base che gli consentano di accedere al mondo sanitario, permettendogli da un lato comportamenti professionali in grado di rispondere ai bisogni di salute, dall’altro di esercitare funzioni e responsabilità tipiche della sua attività. Il corpo delle conoscenze e delle competenze del Fisioterapista sono in continua evoluzione, trattandosi di una disciplina sanitaria relativamente giovane ed in pieno sviluppo. Determinante all’interno della crescita del settore è stata l’emanazione degli atti legislativi relativi al “Profilo professionale” (D.M. n° 741/94) e alla “Disciplina delle Professioni Sanitarie” (L.42/99 e L.251/2000), che hanno creato i presupposti per una profonda innovazione, estesa inevitabilmente al campo della formazione. Il Fisioterapista può ora esprimere le peculiarità e le specificità che gli derivano direttamente dal suo profilo, nel rispetto dei principi etici. In merito alla formazione, queste norme rappresentano importanti spartiacque, in quanto prima di esse tutto ciò che progressivamente veniva inserito nella formazione di base (programmi, ma spesso anche discipline o materie), tutto quello che la riempiva di contenuti, andava costruendo, delineando, definendo e profilando quello che poi sarebbe diventato e stato il futuro Fisioterapista. La direzione di questo processo “centrifugo” procedeva dalla disciplina, la materia, i contenuti, verso le competenze; era un po’ come inventarsi questa figura: un “puzzle” a cui collaborarono tutti coloro che in Italia si occupavano di formazione (e non solo). Questo è avvenuto inizialmente con corsi molto eterogenei, poi in maniera più definita, con le “Scuole per Terapisti della Riabilitazione” o con le “Scuole dirette a fini speciali”. Dal profilo professionale in poi emerge chiaramente “chi è il Fisioterapista” e “cosa fa”. Vengono definite, pertanto, le sue competenze. Tra l’altro, con la nascita dei Diplomi Universitari prima e con i Corsi di Laurea dopo, la formazione viene costruita in coerenza alle competenze professionali; compare per la prima volta, il termine “obiettivo ” nell’ordinamento del Diploma Universitario, a rappresentare la competenza specifica da raggiungere. Infatti, nel D.I. 2 aprile 2001 si riporta, in relazione agli obiettivi formativi qualificanti, il testo del profilo professionale. Il processo formativo da questo momento diventa “centripeto” e va dalle competenze verso i contenuti , verso le discipline, verso i programmi. Per questo motivo, prima di procedere alla definizione del “Core Curriculum” della

5
formazione del Fisioterapista, l’Associazione Italiana Fisioterapisti ha demandato ad alcuni esperti il compito importante di creare un “Core Competence”, inteso come il nucleo di competenze professionali che lo studente deve acquisire in modo completo e permanente al termine del triennio necessario a conseguire la Laurea in Fisioterapia, ai fini dell’esercizio iniziale della professione. La definizione delle competenze professionali, cui corrispondono gli obiettivi formativi qualificanti del Corso di Laurea, nasce dall’approfondita analisi del profilo e dalla sua declinazione in funzioni ed attività, in riferimento ai problemi prioritari di salute della popolazione, dai quali i professionisti sanitari non possono prescindere, tenendo conto anche dei principali problemi di qualità dei servizi sanitari in cui il Fisioterapista svolge la propria attività. Tale elencazione di competenze è corredata, inoltre, da un sistema di valutazione che permette la verifica del raggiungimento e definisce il livello minimo di performance accettabile. Successivamente all’elaborazione del “Core Competence”, è stato possibile mettere a punto il “Core Curriculum”, inteso come il corpo di conoscenze , contenuti e abilità che, opportunamente combinati, diventano strumenti ed elementi facilitatori del raggiungimento delle competenze. È necessario precisare che il “Core Curriculum” elaborato, così come le competenze professionali dalle quale deriva, non è indelebile, ma deve essere interpretato come un modello suscettibile di modifiche in relazione sia alla eventuale evoluzione normativa riferita alla professione, che alle trasformazioni relative alle esigenze di salute della popolazione, che ai rinnovamenti culturali. Il Core Curriculum è uno strumento che può essere utilizzato con diversi criteri, soprattutto perché nella sua costruzione è stata prevista la versatilità. Per definizione la natura del Core Curriculum è tale che debba essere comunque sottoposto ad una “revisione continua”, per cui questa versione sarà riveduta e corretta ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.
1. Cosa è il Core Curriculum
Il Core Curriculum è un progetto educativo proposto agli studenti dei corsi di laurea, all’interno dei quali gli obiettivi educativi specifici devono coincidere con le definizioni che si ritengono necessarie e sufficienti per fare di ogni studente un professionista capace di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della società. Tutto ciò che lo studente deve apprendere per raggiungere le conoscenze, le abilità e le competenze richieste deve essere contenuto nel Core Curriculum.
2. Perché il Core Curriculum
Poiché come abbiamo più volte richiamato nessun Core Curriculum è definitivo e avvertendo la necessità di creare una condivisione più ampia di quella che aveva portato alla versione del Core Curriculum pubblicata su “Scienza Riabilitativa” nel gennaio 2005 (raffigurata in copertina), si è provveduto a sollecitare tutti i docenti e i professionisti impegnati nella formazione del Fisioterapista per dare il proprio contributo, proponendo i possibili miglioramenti. C’era infine il desiderio di far nascere una discussione di carattere pedagogico a livello nazionale per: • uniformare a livello nazionale le conoscenze da acquisire da parte degli studenti pur mantenendo le specificità locali • facilitare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti in vista dell’applicazione del DM 270/2004, in un'ottica pedagogica in cui al centro del processo è “l'apprendimento degli studenti”

6
3. A cosa serve il Core Curriculum
Stante le motivazioni di cui al paragrafo 2, la revisione del Core Curriculum ha diverse implicazioni pratiche, tra cui: • rendere sempre più facile la trasferibilità degli studenti sia in territorio nazionale che internazionale • costruire le basi per una quantificazione funzionale dei contenuti in ore/crediti anche in funzione del “Diploma Supplement”. 4. A chi è diretto il Core Curriculum È rivolto a studenti, formatori (Coordinatori dei C.d.L., Tutor clinici e di tirocinio), professionisti e a tutte le Istituzioni coinvolte nella formazione e nella professione del Fisioterapista (Ministero, Università, Regioni, Aziende Sanitarie). 5.Come è stato realizzato il Core Curriculum Sono stati individuati 10 responsabili d'area, Coordinatori dei C.d.L. in Fisioterapia, disponibili ad essere referenti di un gruppo di docenti competenti nelle varie discipline contenute nell’ordinamento didattico. È stato predisposto un format dai referenti, che hanno utilizzato come modello di riferimento il Core Curriculum di Medicina e Chirurgia e la precedente versione del Core Curriculum dei C.d.L. in Fisioterapia presentato nella Conferenza Permanente dei C.d.L. delle Professioni Sanitarie nell’ottobre del 2003 a Catania. Per ottenere il massimo coinvolgimento di tutti i C.d.L in Fisioterapia è stato utilizzato e aggiornato un indirizzario che, attualmente, comprende 99 sedi formative sul territorio nazionale. I 10 responsabili hanno coinvolto: _ i Presidenti di tutti i Corsi di Laurea in Fisioterapia _ i Coordinatori di tutte le sedi formative dei C.d.L. in Fisioterapia _ i Docenti delle singole discipline presso i vari C.d.L. in Fisioterapia _ gli Studenti di alcuni corsi C.d.L. in Fisioterapia per verificare, modificare ed aggiornare i programmi svolti nelle singole realtà e confrontarli con il precedente Core Curriculum.
INTRODUZIONE
1. La Conoscenza
La conoscenza è la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti attraverso l'esperienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori). La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di informazioni connesse tra di loro, le quali, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori. Jean Jacques Guilbert, nella “Guida Pedagogica”, al capitolo degli obiettivi educativi riporta 2 aforismi del pedagogista Mager: 1. “Se non sapete con precisione dove volete andare….. rischiate di ritrovarti altrove (e di non accorgervene)”;

7
2. “Se aiutate il discente a definire i suoi obiettivi, in molti casi può capitare che non vi resti altro da fare …. che verificare se li ha raggiunti!” Un Core Curriculum è costruito di solide conoscenze scientifiche e di adeguate conoscenze didattiche: non deve mai perdere di vista che il fine è la formazione dello studente.
2. Le fonti
Le fonti utilizzate sono: - Guilbert J.J, “Guida pedagogica per il personale sanitario”, ED. Dal Sud, Modugno (BA), 2002 - Tomasi A, Gaddi A, L. Vettore. “Il Core Curriculum degli studi medici”, Medicina e Chirurgia. N° 16/2001. pag.566/575 - Core Curriculum Corso di Laurea in fisioterapia del 2003 Bertozzi L., Bielli S., Costi S., Pillastrini P. “Il Core Curriculum del Fisioterapista”. Scienza Riabilitativa, Vol. 7.1, Gennaio 2005, pag. 5-44 - CINAHL AN: 2009214965 oltre alle stesse fonti citate nel Core Competence ( vedi pag.17 )
MATERIALI E METODI
1. Le tappe principali
- dicembre 2006 - nella riunione promossa dall’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) a Bologna, ha convocato tutti i Coordinatori dei C.d.L. in Fisioterapia nazionali, sono stati individuati fra i presenti 10 responsabili d'area, disponibili ad essere referenti di un gruppo di docenti competenti in materia. È stato conseguentemente predisposto un format dai referenti/coordinatori, che ha utilizzato come modelli di riferimento il Core Curriculum di Medicina e Chirurgia e la precedente versione del Core Curriculum dei C.d.L. in Fisioterapia presentato nella Conferenza Permanente dei C.d.L. delle Professioni Sanitarie nell’ottobre del 2003 a Catania. - gennaio 2007 - creazione di una rete di esperti da parte di ogni responsabile con produzione di unità didattiche elementari (U.D.E., successivamente denominate “stringhe”) che identificano gli obiettivi didattici riferiti agli argomenti delle varie discipline. - febbraio 2007 - i Coordinatori hanno raccolto tutto il materiale prodotto dai Corsi di Laurea in Fisioterapia coordinati dai 10 responsabili d'area. - marzo 2007 - i file contenenti le “stringhe” proposte sono stati assemblati, assimilati, uniformati e rimodellati. Si è condiviso che ciascuna stringa/U.D.E. dovesse contenere il testo di un obiettivo di apprendimento/insegnamento e utilizzare un parametro temporale, di circa 2 ore ciascuna. Al fine di arrivare ad una “validazione” finale, è stato inviato il testo a tutti i Corsi di Laurea in Fisioterapia ed è stato chiesto loro di eseguire un’ultima valutazione. - aprile 2007 - sono state raccolte ed assemblate tutte le nuove revisioni. Il lavoro provvisorio (work in progress) è stato presentato il 20-21 aprile 2007 alla Conferenza Permanente dei C.d.L. delle Professioni Sanitarie ad Alghero. - aprile 2007 / luglio 2008 - i lavori del “Core Curriculum” sono sospesi in attesa dell’elaborazione del “Core Competence del tirocinio ” per essere presentato in un unico testo. - luglio 2008 - in una riunione promossa dall’A.I.FI. per la stesura del “Core Competence

8
del tirocinio” viene dato mandato al gruppo referente/coordinatore di divulgare il documento precedentemente elaborato e di proporne una versione per la sua eventuale presentazione e pubblicazione. - dicembre 2008 – inserimento degli Ambiti Europei; inclusa in una apposita colonna la tipologia dell’attività didattica proponibile (L= lezione frontale; P= lezione a piccoli gruppi; T= attività tutoriale (Terminologia ripresa dal core curriculum – 2003 ); le scienze fisioterapiche sono state incluse all’interno dell’ambito europeo denominato “trattamento della persona” ; inserite alcune stringhe relative al tirocinio (denominato “pratica professionale” ) tratte dal core competence del tirocinio. Rivista la scelta di attribuire ad ogni stringa / U.D.E. il parametro temporale di circa 2 ore ciascuna, lasciando ad ogni sede formativa la definizione del tempo dedicato.
2. Partecipanti
Suddivisione delle attività formative Responsabili Di base Montevecchi
Pagnoni ortopedica Ravagni neurologica Caruso cardio-resp Costi-Cortini età evolutiva Montanari
Professionalizzanti
geriatrica Padalino Medico chirurgiche Bielli Prevenzione Bedotti-Tonni Umane e psico-pedagogiche Padalino Interdisciplinari Spada
Caratterizzanti
Management sanitario Ferrari Altre Conoscenza linguistica e altre Costi Ogni responsabile ha collaborato con coordinatori delle attività professionalizzanti delle sedi regionali, coordinatori didattici, docenti e referenti Fisioterapisti dei G.I.S. (Gruppo di Interesse Specifico dell’A.I.Fi.), i Fisioterapisti dell’ Associazione Riabilitatori dell’Insufficienza Respiratoria (ArIR).
3. Metodi
Le attività formative sono state suddivise e distribuite ai rispettivi referenti, con istruzioni operative e tempi d’ esecuzione, delle seguenti aree: o Discipline di base o Discipline Professionalizzanti suddivise in 5 sottogruppi: _ area ortopedica _ area neurologica _ area cardio-respiratoria _ area dell’età evolutiva _ area geriatrica o Discipline medico-chirurgiche o Discipline della prevenzione o Discipline umane e psico-pedagogiche o Discipline interdisciplinari

9
o Discipline del management sanitario o Conoscenza Linguistica Successivamente i referenti hanno coinvolto per posta elettronica, i Presidenti, Coordinatori, Docenti, ed esperti fisioterapisti per programmare ed elaborare la revisione dei programmi per: _ trasformare i contenuti in unità didattiche elementari, _ aggiornare gli obiettivi, in riferimento alla nuova normativa nazionale e internazionale. Terminato il primo confronto, i coordinatori hanno assemblato e inoltrato a tutti i CL in Fisioterapia il lavoro svolto, composto da 782 stringhe. In un secondo tempo è stato richiesto di _ eliminare le ripetizioni dei contenuti Conseguentemente i coordinatori hanno inoltrato a tutti i Cl in Fisioterapia l’aggiornamento che vedeva le stringhe diminuire, da 782 a 680. In seguito è stato programmata una sessione di lavoro che ha utilizzato l’ultimo elaborato. La sessione di lavoro ha coinvolto 2 coordinatori del core curriculum, 1 Presidente di corso, 6 coordinatori di CL in fisioterapia e 6 studenti, con obiettivo di ascoltare il vissuto e i suggerimenti degli studenti per alleggerire ulteriormente il core curriculum. Inoltrato a tutti i Cl in Fisioterapia l’ ultima versione. Negli incontri successivi alla Conferenza tenuta ad Alghero, per l’elaborazione del Core Competence, si è convenuto di riprendere il core curriculum e ridurre ulteriormente le stringhe portandole a 600. Successivamente il confronto con esperti e referenti nazionali del Core Curriculum, del corso di laurea in medicina, ci ha portato di aggiornare la stesura inserendo gli Ambiti europei, il Tipo tipo di lezione, e alcune stringhe dell’ambito del tirocinio , che denomineremo “ pratica professionale”.
STRUTTURA DEL CORE CURRICULUM
1. come è fatto e come si legge
Il documento è caratterizzato da 10 colonne così denominate e descritte: 1. numero progressivo di stringhe; 2. numero progressivo di stringhe dell’ambito cultural e; 3. ambito culturale : raggruppa le unità didattiche elementari, corrisponde alle discipline 4. ambito culturale europeo è stata inserita, rispetto alla versione precedente, una colonna dedicata gli ambiti europei, utilizzando una tabella di riferimento per i contenuti (di base, propedeutici, clinici, ecc….); 5. tema generale : sono gli argomenti dell’ambito culturale suddivisi in grossi capitoli; 6. unità didattica elementare : definisce una conoscenza, una competenza un'abilità o un comportamento che lo studente deve essere in grado di eseguire come risultato del processo di apprendimento/insegnamento; è caratterizzata da un verbo che indica una azione osservabile, verificabile nel grado di performance, consentendone la valutazione oggettiva del grado di apprendimento – rispetto al testo precedente dove era presente un elenco di argomenti da apprendere (e da insegnare), ora sono rappresentati gli obiettivi educativi da apprendere; 7. livello di conoscenza : è detta superficiale quando lo studente può averne solo sentito parlare; generale quando lo studente deve sapere inquadrare l'argomento all'interno delle conoscenze complessive; particolareggiata quando lo studente deve conoscere

10
l'argomento in modo esauriente; 8. livello di competenza : è detta mnemonica quando lo studente deve ricordare quanto ha appreso, interpretativa quando lo studente deve applicare quanto ha appreso per interpretare dati o fenomeni, decisionale quando lo studente deve applicare quanto ha appreso per risolvere personalmente problemi e assumere decisioni autonome; 9. livello di abilità : è indicata come teorica quando lo studente deve aver visto eseguire la manovra, pratica quando deve eseguire almeno una volta sotto il controllo del docente, autonoma quando la deve eseguire in modo autonomo; 10. il tipo di lezione è stata inserita in una apposita colonna la tipologia dell’attività didattica proponibile (L= lezione frontale; P= lezione a piccoli gruppi; T= attività tutoriale. Terminologia ripresa dal core curriculum - 2003); Dal punto 5 al punto 9 sono le conoscenze richieste che tutti gli studenti devono raggiungere.

11
IL CORE CURRICULUM
N°
stringhe
N° a.c.
Ambito culturale
Ambito culturale europeo
Tema generale Unità didattica elementare Livello di Conoscenza
Livello di Competenza
Livello di Abilità
Tipo di lezione
1 1 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Propedeutica biochimica
Definire la reazione chimica (aspetti elementari di cinetica ed energetica), le reazioni di non ossidoriduzione, il numero di ossidazione, di ossidanti e riducenti, i potenziali normali e l'equazione di Nernst
Generale Mnemonica Non richiesto
L
2 2 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Propedeutica biochimica
Descrivere le soluzioni molecolari e ioniche: le proprietà e i modi di esprimere le concentrazioni e le proprietà colligative (la pressione osmotica e la sua legge); gli aspetti dell'equilibrio chimico e della sua legge (il significato della costante di equilibrio), le basi e gli acidi secondo Bronsted e Lowry e gli equilibri di dissociazione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
3 3 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Propedeutica biochimica
Descrivere la definizione di pH, la sua scala e le soluzioni tampone (tamponi del sangue); gli idrocarburi alifatici ed aromatici, i composti aromatici eterociclici e l'isomeria. Conoscere la struttura e le proprietà dei principali composti monofunzionali (alcoli, enoli, fenoli, ammine, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici) e di alcuni composti polifunzionali (polialcoli, ossiacidi, chetoacidi, poliesteri)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
4 4 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Propedeutica biochimica
Descrivere la struttura e le proprietà dei monosaccaridi (pentosi ed esosi), dei disaccaridi, dei polisaccaridi, dei grassi e olii. Descrivere la struttura e le proprietà di: lipidi di membrana, aminoacidi, legame peptidico, struttura primaria e secondaria delle proteine
Generale Mnemonica Non richiesto
L
5 5 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Propedeutica biochimica
Descrivere la struttura e le proprietà delle basi del DNA e dell’RNA, dei nucleosidi, dei nucleotidi e dei polinucleotidi
Generale Mnemonica Non richiesto L
6 6 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biochimica
Descrivere le generalità della struttura e della funzione delle proteine strutturali (collageno) e funzionali (emoglobina). Conoscere gli enzimi (struttura, funzione, meccanismo d'azione, ruolo nella regolazione metabolica), i coenzimi e le vitamine idrosolubili
Generale Mnemonica Non richiesto
L
7 7 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biochimica
Descrivere il metabolismo glucidico: la digestione dei glucidi, la glicolisi, la glicogenosintesi, la glicogenolisi e la glucogenesi. Conoscere i cicloacidi tricarbossilici, la catena respiratoria e la
Generale Mnemonica Non richiesto
L

12
fosforilazione ossidativa
8 8 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biochimica
Descrivere il metabolismo lipidico (la digestione lipidi), le lipoproteine plasmatiche e la ß-ossidazione degli acidi grassi, la lipolisi, la lipogenesi, il colesterolo, i fosfolipidi, i corpi chetonici
Generale Mnemonica Non richiesto
L
9 9 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biochimica
Illustrare il metabolismo degli aminoacidi e delle proteine: digestione delle proteine, sintesi proteica, ureogenesi
Generale Mnemonica Non richiesto L
10 10 Biochimica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biochimica
Descrivere i principali ormoni di regolazione metabolica (insulina, glucagone, catecolamine, ormoni tiroidei, glucocorticoidi); il metabolismo del tessuto muscolare
Generale Mnemonica Non richiesto L
11 1 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia
Descrivere il concetto di biologia come scienza sperimentale (l'oggetto, i metodi di studio e le branche della biologia) e i livelli di organizzazione (il protoplasma, le cellule, i tessuti, gli organi e gli apparati, gli organismi, le popolazioni)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
12 2 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia
Descrivere il concetto di differenziamento (la cellula come unità di struttura e di funzione della sostanza vivente) e le caratteristiche principali di eucarioti e procarioti
Generale Mnemonica Non richiesto
L
13 3 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia
Elencare le proprietà fisico-chimiche e lo stato di aggregazione della sostanza vivente, i composti inorganici (acqua e sali minerali) e organici (proteine, acidi nucleici, glucidi, lipidi)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
14 4 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia
Descrivere la cellula: generalità, membrana cellulare, permeabilità, reticolo endoplasmatico liscio e rugoso
Generale Mnemonica Non richiesto L
15 5 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia
Descrivere ribosomi, apparato del Golgi, lisosomi, esocitosi ed endocitosi, la struttura e la funzione dei mitocondri e del nucleo intercinetico (nucleolo)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
16 6 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia applicata Esporre le generalità della riproduzione: riproduzione ed eredità
Generale Mnemonica Non richiesto
L
17 7 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia applicata Descrivere la duplicazione del DNA, il ciclo cellulare e la mitosi
Generale Mnemonica Non richiesto
L
18 8 Biologia applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Biologia applicata Descrivere la fecondazione: gamete maschile e femminile
Generale Mnemonica Non richiesto
L

13
19 1 Istologia Morfologia umana
Embriologia
Descrivere le tappe principali dello sviluppo embrionale, l'origine e le caratteristiche generali dei tessuti epiteliale, connettivale, muscolare e nervoso e la formazione dei foglietti embrionali. Descrivere la derivazione embrionale e le caratteristiche morfologiche e funzionali dei diversi tipi di tessuti connettivali
Generale Mnemonica Non richiesto
L
20 2 Istologia Morfologia umana
Istologia
Descrivere le caratteristiche generali, le funzioni, la nutrizione e la classificazione degli epiteli di rivestimento e degli epiteli secernenti esocrini ed endocrini
Generale Mnemonica Non richiesto
L
21 3 Istologia Morfologia umana
Istologia
Descrivere le caratteristiche morfologiche, strutturali e funzionali del tessuto connettivo propriamente detto e del tessuto adiposo; l'organizzazione strutturale, le funzioni e la distribuzione del tessuto cartilagineo (cartilagine ialina elastica e fibrosa) e del pericondrio
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
22 4 Istologia Morfologia umana
Istologia
Descrivere i componenti e l'organizzazione strutturale macroscopica e microscopica del tessuto osseo compatto e spugnoso, di quello lamellare e non lamellare; la struttura e le funzioni del periostio, la nutrizione dell'osso e l'ossificazione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
23 5 Istologia Morfologia umana
Istologia
Descrivere la morfologia del sangue (plasma ed elementi figurati), le funzioni e la durata di vita di eritrociti, leucociti e piastrine, l’emopoiesi e la morfologia dei tessuti mieloide e linfoide
Generale Mnemonica Non richiesto
L
24 6 Istologia Morfologia umana Istologia
Descrivere la morfologia e la struttura delle fibrocellule scheletriche e l'organizzazione dei muscoli: endomisio, perimisio ed epimisio
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
25 7 Istologia Morfologia umana Istologia
Descrivere la morfologia, la struttura e la distribuzione delle fibrocellule muscolari lisce e delle fibrocellule miocardiche
Generale Mnemonica Non richiesto L
26 8 Istologia Morfologia umana
Istologia
Descrivere la struttura, la durata di vita e i tipi di neuroni e la loro distribuzione nel sistema nervoso centrale e periferico; la morfologia ed il significato funzionale di: nervo (tipi di fibre), guaina mielinica, struttura delle sinapsi, astrociti, oligodendrociti, ependima e microglia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
27 1 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Descrivere l'organizzazione generale del sistema nervoso centrale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
28 2 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Descrivere l'anatomia macroscopica e microscopica del midollo spinale, del tronco encefalico e del cervelletto
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L

14
29 3 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Descrivere l'anatomia macroscopica e microscopica degli emisferi cerebrali, della lamina quadrigemina, del diencefalo, del telencefalo e del sistema limbico
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
30 4 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Definire la morfologia delle vie motrici e delle vie della sensibilità generale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
31 5 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Illustrare la morfologia della retina, delle vie ottiche, delle vie acustiche, delle vie gustative ed olfattive
Generale Mnemonica Non richiesto
L
32 6 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Descrivere l'anatomia macroscopica e microscopica delle meningi e la vascolarizzazione cerebrale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
33 7 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso centrale
Descrivere la morfologia dei ventricoli cerebrali e della circolazione liquorale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
34 8 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso periferico
Descrivere la morfologia generale dei nervi spinali e dei plessi
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
35 9 Anatomia umana Morfologia umana
Sistema nervoso periferico
Descrivere la morfologia dei nervi encefalici e del sistema ortosimpatico e parasimpatico
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
36 10 Anatomia umana Morfologia umana
Apparati sensibilità specifica
Descrivere l'anatomia del bulbo oculare e degli organi accessori, dell'orecchio esterno, medio e interno
Generale Mnemonica Non richiesto
L
37 11 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Descrivere lo scheletro assiale: testa, colonna vertebrale, sterno, coste
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
38 12 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Descrivere lo scheletro appendicolare: estremità superiore, estremità inferiore
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
39 13 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Esporre la classificazione delle articolazioni (i tipi di articolazioni e i tipi di movimenti consentiti dalle articolazioni sinoviali) e le articolazioni sinoviali (temporo-mandibolare, scapolo-omerale, gomito, polso, anca, ginocchio)
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
40 14 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Definire la morfologia di tendini, aponeurosi e fasce Particolareggiata Interpretativa Non
richiesto L
41 15 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Descrivere l'anatomia dei muscoli del capo, del collo e del tronco
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
42 16 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Descrivere l'anatomia dei muscoli dell'arto superiore: della spalla, del braccio, dell'avambraccio e della mano
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
43 17 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato locomotore
Descrivere l'anatomia dei muscoli dell'arto inferiore: dell'anca, della coscia, della gamba, del piede
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
44 18 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato respiratorio
Esporre la morfologia del naso, delle cavità nasali e paranasali, l'anatomia macroscopica della laringe, della trachea e dei bronchi e la morfologia dell’apparato di fonazione
Generale Mnemonica Non richiesto L
45 19 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato respiratorio
Descrivere l'anatomia macro e microscopica del polmone
Generale Mnemonica Non richiesto
L

15
46 20 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato circolatorio
Illustrare la topografia della cavità toracica e l'anatomia esterna, la cavità, le valvole e il sistema di conduzione del cuore
Generale Mnemonica Non richiesto
L
47 21 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato circolatorio
Descrivere l'anatomia del circolo polmonare e del circolo sistemico, con particolare riferimento all'aorta, alle principali arterie e alla vene cave
Generale Mnemonica Non richiesto L
48 22 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato circolatorio
Descrivere l'anatomia del timo, della milza, dei linfonodi e del circolo linfatico
Generale Mnemonica Non richiesto L
49 23 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato digerente
Descrivere le generalità e la morfologia delle diverse porzioni dell'apparato digerente e la morfologia del peritoneo
Generale Mnemonica Non richiesto
L
50 24 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato digerente
Descrivere la circolazione splancnica (relativa alla milza), l'anatomia del fegato, della cistifellea e del pancreas
Generale Mnemonica Non richiesto
L
51 25 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato endocrino
Descrivere la morfologia dell'apparato endocrino e l'anatomia delle principali ghiandole endocrine ed il loro controllo ipotalamo-ipofisario
Generale Mnemonica Non richiesto
L
52 26 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato genitale
Descrivere la morfologia e l'anatomia degli organi e delle vie genitali maschili e femminili
Generale Mnemonica Non richiesto
L
53 27 Anatomia umana Morfologia umana
Apparato tegumentario
Descrivere l'anatomia macroscopica e microscopica della cute e degli annessi cutanei
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
54 28 Anatomia umana Morfologia umana Apparato urinario
Descrivere l'anatomia macro e microscopica del rene e della vescica urinaria
Generale Mnemonica Non richiesto L
55 29 Anatomia umana Morfologia umana Apparato urinario
Descrivere l'anatomia topografica della cavità pelvica
Generale Mnemonica Non richiesto L
56 1 Anatomia palpatoria
Morfologia umana
Ispezione manuale di superficie di capo e tronco
Individuare i punti di repere ossei, muscolari, vascolari e nervosi della regione del capo e del tronco
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
57 2 Anatomia palpatoria
Morfologia umana
Ispezione manuale di superficie dell'arto inferiore
Individuare i punti di repere ossei, muscolari, vascolari e nervosi dell'arto superiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
58 3 Anatomia palpatoria
Morfologia umana
Ispezione manuale di superficie dell'arto superiore
Individuare i punti di repere ossei, muscolari, vascolari e nervosi dell'arto inferiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
59 1 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato cardiocircolatorio
Descrivere l'attività elettrica (avviatore primario e secondario) e meccanica del cuore (ciclo cardiaco)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
60 2 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato cardiocircolatorio
Descrivere il significato delle onde di un tracciato elettrocardiografico fisiologico, la regolazione intrinseca dell'attività cardiaca (legge del cuore) e gli effetti della stimolazione vagale e simpatica sull'attività cardiaca
Generale Mnemonica Non richiesto L

16
61 3 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato cardiocircolatorio
Esporre i principi fondamentali dell'emodinamica, la funzione delle arteriole, la misura e i valori normali della pressione arteriosa e la sua regolazione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
62 4 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato cardiocircolatorio
Descrivere le funzioni dei capillari e dei vasi linfatici ed il controllo nervoso e umorale del circolo periferico
Generale Mnemonica Non richiesto
L
63 5 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato cardiocircolatorio
Illustrare la funzione delle vene e i fattori che determinano e modificano il ritorno venoso al cuore
Generale Mnemonica Non richiesto
L
64 6 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato digerente
Descrivere il sistema nervoso enterico e le funzioni motorie dell'apparato digerente e la loro regolazione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
65 7 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato digerente
Descrivere le funzioni secretorie, digestive e di assorbimento dell'apparato digerente
Generale Mnemonica Non richiesto L
66 8 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato renale
Descrivere i compartimenti idrici dell'organismo; Descrivere il processo di ultrafiltrazione nel glomerulo renale, la composizione dell'ultrafiltrato e la velocità di ultrafiltrazione
Generale Mnemonica Non richiesto L
67 9 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato renale
Descrivere i meccanismi di riassorbimento e di secrezione tubulari e i meccanismi di concentrazione e di diluizione dell'urina (assorbimento obbligatorio e facoltativo di acqua e ruolo dell'ormone antidiuretico)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
68 10 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato renale
Descrivere il meccanismo della minzione: struttura e innervazione della vescica e controllo della minzione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
69 11 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato respiratorio
Descrivere i movimenti respiratori ed il ruolo di muscoli principali ed accessori, i concetti di: spazio morto, ventilazione polmonare e ventilazione alveolare
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
70 12 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato respiratorio
Interpretare un tracciato spirografico, definendo e quantificando i principali volumi e capacità polmonari
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
71 13 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato respiratorio
Descrivere gli scambi gassosi nei polmoni: barriera aria-sangue, la composizione dell'aria atmosferica e del gas alveolare, la diffusione dell'ossigeno e dell'anidride carbonica nei polmoni
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L

17
72 14 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato respiratorio
Descrivere i meccanismi di trasporto dell'ossigeno nel sangue, descrivendo la curva di dissociazione dell'ossiemoglobina, e Descrivere le forme di trasporto dell'anidride carbonica nel sangue
Generale Mnemonica Non richiesto
L
73 15 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Apparato respiratorio
Descrivere i centri nervosi del respiro, i meccanismi di controllo chimico della ventilazione e i principali tipi di ipossia
Generale Mnemonica Non richiesto L
74 16 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Sistema endocrino
Descrivere i meccanismi di azione ormonale e i principali ormoni; gli ormoni tiroidei e la regolazione della loro secrezione
Generale Mnemonica Non richiesto L
75 17 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Sistema endocrino
Descrivere le funzioni di adenoipofisi e neuroipofisi: azione degli ormoni e regolazione della loro secrezione
Generale Mnemonica Non richiesto L
76 18 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Sistema endocrino
Descrivere la regolazione della secrezione degli ormoni ovarici (ciclo ovarico) e le azioni degli estrogeni e del progesterone (ciclo mestruale)
Generale Mnemonica Non richiesto
L
77 19 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Sistema endocrino
Descrivere la regolazione endocrina della glicemia: valori normali, meccanismi d'azione dell'insulina e degli ormoni iperglicemizzanti e regolazione della loro secrezione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
78 20 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Biofisica
Descrivere la composizione ionica del liquido extracellulare e intracellulare; Descrivere il potenziale di membrana a riposo e il potenziale di azione delle cellule nervose e muscolari, canali voltaggio-dipendenti, generazione e propagazione del potenziale d'azione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
79 21 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Biofisica
Definire la trasmissione sinaptica nelle sinapsi elettriche e in quelle chimiche: i principali neurotrasmettitori e recettori postsinaptici, i potenziali postsinaptici eccitatorio ed inibitorio, la nascita del potenziale d'azione sulla cellula postsinaptica
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
80 22 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Biofisica
Descrivere il funzionamento dei recettori sensoriali: canali ionici a porta meccanica e chimica, processo di trasduzione del segnale, fenomeni di adattamento, campi recettivi
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
81 23 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Biofisica
Descrivere la stimolazione elettrica dei tessuti eccitabili: l'uso di correnti continue e alternate, la soglia di stimolazione, la curva intensità-durata per determinare la soglia di efficacia della stimolazione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L

18
82 24 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Fisiologia muscolare
Descrivere la funzione del muscolo scheletrico: il meccanismo di trasmissione neuromuscolare, l'accoppiamento elettro-meccanico e il ruolo del calcio, il ciclo dei ponti actomiosinici
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
83 25 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Fisiologia muscolare
Definire il concetto di unità motoria, i tipi di unità motoria, la graduazione della contrazione muscolare
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
84 26 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Fisiologia muscolare
Descrivere la funzione del muscolo scheletrico: l'ultrastruttura della cellula muscolare
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
85 27 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia - Fisiologia muscolare
Descrivere il meccanismo della contrazione muscolare, la scossa semplice e il tetano muscolare, la contrazione isometrica ed isotonica, concentrica ed eccentrica, la relazione tra lunghezza e tensione, la graduazione della contrazione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
86 28 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Esporre l'organizzazione anatomo-funzionale del sistema nervoso centrale e periferico, l'organizzazione funzionale del midollo spinale, il concetto di vie afferenti ed efferenti rispetto al SNC
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
87 29 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere la sensibilità somatica generale: la funzione dei recettori sensoriali tattili, le vie della sensibilità tattile e propriocettiva, la somatotopia nella corteccia cerebrale
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
88 30 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere la definizione di dolore somatico e dolore viscerale (dolore riferito), i nocicettori e le vie della sensibilità dolorifica, i fenomeni di sensibilizzazione e iperalgesia, i meccanismi analgesici endogeni
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
89 31 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere: le funzioni motorie del midollo spinale e i tipi di riflessi spinali, i recettori sensoriali, circuito e significato funzionale del riflesso nocicettivo flessorio
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
90 32 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere: il fuso neuromuscolare (terminazioni sensitive primarie e secondarie, gamma-motoneuroni) e il circuito del riflesso miotatico ed il suo significato funzionale
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
91 33 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere: il tono muscolare e la sua regolazione, il riflesso miotatico inverso (organo tendineo di Golgi e circuito del riflesso)
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L

19
92 34 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere il controllo motorio da parte della corteccia cerebrale (aree corticali motorie e vie motrici somatiche piramidali ed extrapiramidali)
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
93 35 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Definire le funzioni motorie del tronco dell'encefalo: il ruolo dei nuclei tronco-encefalici nel controllo dei riflessi spinali, il fenomeno dello shock spinale, i meccanismi di mantenimento dell'equilibrio e della postura
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
94 36 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere il ruolo del cervelletto e dei nuclei della base nella regolazione del movimento e i principali effetti della loro lesione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
95 37 Fisiologia umana
Funzioni biologiche integrate degli organi e apparati umani
Neurofisiologia
Descrivere l'organizzazione anatomo-funzionale e le funzioni del sistema nervoso vegetativo (ortosimpatico, parasimpatico e sistema nervoso enterico), gli effetti orto e parasimpatici sui principali organi e apparati ed il loro significato funzionale
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
96 1 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Metodologica
Descrivere la fisica e le scienze biomediche e descrivere le grandezze fisiche, la definizione operativa, le relazioni tra grandezze, i sistemi di unità di misura, le grandezze scalari e vettoriali
Generale Mnemonica Non richiesto
L
97 2 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Il moto
Descrivere le definizioni di massa e peso; Descrivere il concetto di posizione, velocità, accelerazione lineare e angolare, inerzia e momento di inerzia, cinematica e cinetica di un punto (leggi del moto); Descrivere la teoria del Punto di Equilibrio e le leggi fondamentali della dinamica. Applicare i principi di dinamica traslazionale e rotazionale al corpo umano
Generale Mnemonica Non richiesto L
98 3 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Il moto
Descrivere i principi della meccanica Newtoniana, le leggi di forza, la scomposizione delle forze, l'equilibrio, il concetto di lavoro e potenza, il concetto di potenza e metabolismo
Generale Mnemonica Non richiesto
L
99 4 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Il moto
Descrivere l'energia cinetica e potenziale, la conservazione dell'energia meccanica
Generale Mnemonica Non richiesto
L
100 5 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Statica ed elasticità dei corpi
Descrivere la meccanica applicata ai sistemi biologici: forza muscolare, momento della forza, equilibri, il concetto di equilibrio stabile e instabile, i 3 tipi di leva meccanica e i principali esempi di applicazione nel corpo umano
Generale Mnemonica Non richiesto L
101 6 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Statica ed elasticità dei corpi
Descrivere i solidi, i liquidi e i gas, il concetto di tensione superficiale e la Legge di Laplace, il concetto di deformazione ed elasticità
Generale Mnemonica Non richiesto L

20
102 7 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Meccanica dei fluidi
Descrivere la fisica del sistema circolatorio: le applicazioni al circolo sanguigno e il lavoro e il rendimento del cuore; i liquidi ideali e teorema di Bernoulli, liquidi newtoniani e legge di Poiseuille. Descrivere la pressione osmotica e i fenomeni osmotici nel corpo umano
Generale Mnemonica Non richiesto
L
103 8 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Termologia e trasporto calore
Definire il meccanismo della propagazione e gli effetti biologici del calore e la termoregolazione, le soluzioni e le proprietà colligative, il concetto di quantità di calore, i principi della termodinamica
Generale Mnemonica Non richiesto L
104 9 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Elettricità e magnetismo
Descrivere le teorie e le strumentazioni dell'elettricità e del magnetismo e le radiazioni ionizzanti, l'elettroterapia con correnti continue e variabili
Generale Mnemonica Non richiesto
L
105 10 Fisica applicata
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Fisica moderna
Descrivere le caratteristiche delle principali energie fisiche utilizzate in ambito fisioterapico (calore, energia elettrica, radiazioni elettromagnetiche, meccanica) e Descrivere la possibilità di utilizzarle a scopo terapeutico in riabilitazione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
106 1
Radioprotezione
Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione Descrivere le radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e l'ambiente
Generale Mnemonica Non richiesto
L
107 2 Radioprotezione Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione
Descrivere le interazioni delle radiazioni ionizzanti con la materia e gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
Generale Mnemonica Non richiesto L
108 3 Radioprotezione Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione Descrivere le grandezze usate in radioprotezione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
109 4 Radioprotezione Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione
Descrivere i principi fondamentali della radioprotezione e la normativa vigente
Generale Mnemonica Non richiesto L
110 5 Radioprotezione Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione Illustrare i rischi da radiazione nella struttura ospedaliera
Generale Mnemonica Non richiesto
L
111 6 Radioprotezione Metodologie e tecniche diagnostiche
Radioprotezione Descrivere i fattori principali della radioprotezione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
112 1 Bioingegneria
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Bioingegneria
Descrivere la storia dell'analisi del cammino. Descrivere le tecniche di stereofotogrammetria digitale in Fisioterapia. Principi di funzionamento di base ed applicazioni. Descrivere la cinematica, la cinetica e i determinanti del cammino
Particolareggiata Mnemonica Teorica L
113 2 Bioingegneria
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Bioingegneria Descrivere gli Elettrogoniometri, le Celle di carico e le Pedane di forza
Particolareggiata Interpretativa Teorico-pratica
L

21
114 1 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Piani di movimento
Descrivere i piani del movimento (sagittale, frontale e trasversale), la posizione anatomica e la classificazione dei movimenti articolari con le relative eccezioni
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
P
115 2 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Meccanica del corpo esteso
Applicare le leggi di gravità al corpo umano (concetti di forza di gravità, baricentro, linea di gravità, base d'appoggio), utilizzare le tavole delle dimensioni somatiche lineari, delle dimensioni ponderali e delle distanze dei baricentri dai fulcri
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
P
116 3 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Meccanica del corpo esteso
Descrivere i sistemi di riferimento (mono, bi, tridimensionali) ed i vettori. Costruire il vettore delle forza muscolare in base all'anatomia del muscolo scegliendo il punto di applicazione, la direzione, il verso e il modulo e scomporlo nelle componenti rotazionali e assiali costruendo il rettangolo biomeccanico e utilizzando le principali formule trigonometriche
Particolareggiata Decisionale Teorica P
117 4 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Analisi della contrazione muscolare
Descrivere il principio di reciprocità muscolare e i principali fattori meccanici che influenzano l'intensità della tensione muscolare: tipo di contrazione (isotonica concentrica ed eccentrica, isometrica); orientamento delle fibre muscolari; rapporto tensione/lunghezza e tensione velocità
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
118 5 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Biomeccanica applicata al sistema locomotore
Descrivere le forze di attrito applicate al corpo umano: concetti di attrito radente statico e dinamico, attrito volvente, attrito e lubrificazione articolare. Descrivere i concetti di catena cinetica chiusa e aperta e i principali esempi applicati al corpo umano
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
P
119 6 Biomeccanica
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Biomeccanica applicata al sistema locomotore
Analizzare un gesto segmentario individuando le forze esterne ed interne, considerando i relativi momenti rispetto ad uno o più assi opportunamente scelti e tracciare un diagramma esplicativo
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
120 1 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Scienza del movimento
Descrivere le curve del rachide nel loro insieme, la vertebra tipo, gli elementi di connessione intervertebrale e le divisioni funzionali del rachide, la fisiologia del disco intervertebrale. Descrivere i movimenti del rachide nel suo insieme
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
121 2 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del rachide lombare nel suo insieme, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso, la statica del rachide lombare in posizione eretta
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P

22
122 3 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del rachide dorsale nel suo insieme, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso, Descrivere la fisiologia articolare delle articolazioni costo-vertebrali e sternocostali, le deformazioni del torace durante l’inspirazione e l'espirazione e le azioni dei muscoli della respirazione e le relazioni tra diaframma e muscoli addominali
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
123 4 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del rachide cervicale nel suo insieme e nel dettaglio dei suoi segmenti superiore ed inferiore, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso, l'equilibrio del capo sul rachide cervicale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
124 5 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare dell'articolazione temporo-mandibolare e l'azione dei muscoli agenti su di essa
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
125 6 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Saper descrivere la fisiologia articolare del cingolo scapolare nel suo insieme e delle relative articolazioni, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso, i fattori di coattazione articolare della gleno-omerale
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
126 7 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del complesso articolare del gomito e delle articolazioni radio-ulnari, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di essi, i fattori di coattazione articolare del gomito
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
127 8 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del polso, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
128 9 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare delle articolazioni delle dita lunghe e del pollice i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esse
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
129 10 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Scienza del movimento
Illustrare l'architettura e la posizione di funzione della mano nel suo insieme e la chinesiologia della prensione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
130 11 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere l'architettura e la fisiologia articolare della cintura pelvica e delle articolazioni sacro-iliache, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P

23
131 12 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare dell'articolazione coxo-femorale, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
132 13 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare del complesso articolare del ginocchio, i relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esso, i fattori di stabilità del ginocchio
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
P
133 14 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare della tibio-tarsica, relativi movimenti e i fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di essa, i fattori di stabilità della tibio-tarsica Conoscere l'architettura generale della volta plantare, la ripartizione generale dei carichi e delle deformazioni, l'adattamento della volta plantare al terreno
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
134 15 Chinesiologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiologia articolare
Descrivere la fisiologia articolare delle articolazioni del piede e delle dita, i relativi movimenti e fattori limitanti normali, l'azione dei muscoli agenti su di esse
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
135 16 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Illustrare i fondamenti della valutazione muscolare: posture della persona, fissazione, resistenze, le scale di grading muscolare internazionali
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
136 17 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Eseguire i test muscolari e le prove di estensibilità relativi ai muscoli del collo e del tronco
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
137 18 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Eseguire i test muscolari e le prove di estensibilità relativi ai muscoli dell'arto superiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
138 19 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Eseguire i test muscolari e le prove di estensibilità relativi ai muscoli dell'arto inferiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
139 20 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Eseguire i test muscolari relativi ai muscoli mimici e muscoli dell’occhio
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
140 21 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione muscolare
Eseguire i test muscolari relativi ai muscoli della deglutizione e delle respirazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
141 22 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione articolare
Illustrare le generalità sulla valutazione articolare: sensazioni finali normali e patologiche, strumenti, indicazioni e controindicazioni, affidabilità delle misurazioni goniometriche
Particolareggiata Interpretativa Teorica L
142 23 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione articolare
Eseguire i test articolari relativi al rachide e della temporo-mandibolare
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
143 24 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione articolare
Eseguire i test articolari relativi alle articolazioni dell'arto superiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
144 25 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione articolare
Eseguire i test articolari relativi alle articolazione dell'arto inferiore
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

24
145 26 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione articolare
Eseguire le misurazioni circonferenziali e di lunghezza relative agli arti superiori ed inferiori, le misurazioni cirtometriche relative ai diametri del torace e alle curve del rachide
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
146 27 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione posturale
Conoscere il concetto di postura e il corretto allineamento dei segmenti corporei sui diversi piani ed eseguire una valutazione della postura nelle diverse posizioni analizzando tutti i distretti articolari
Particolareggiata Decisionale Teorica L
147 28 Chinesiologia Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione chinesiologica
Conoscere la chinesiologia dei passaggi posturali ed eseguire la valutazione chinesiologica
Particolareggiata Decisionale Autonoma PT
148 1 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Epidemiologia
Acquisire conoscenze sul significato del concetto di salute e malattia: i principali fattori di rischio (genetici, ambientali, socio-economici, biologici, comportamentali), le cause e leggi di diffusione delle malattie e i principali agenti patogeni, il significato di infettività, patogeneticità, virulenza e tossigenicità; gli indicatori di salute e il ruolo del Fisioterapista nel promuovere i diritti del cittadino
Generale Mnemonica Non richiesto
L
149 2 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Epidemiologia Descrivere la storia naturale ed il profilo epidemiologico della malattia trasmissibile
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
150 3 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Epidemiologia
Descrivere la profilassi diretta e indiretta delle malattie infettive; le modalità di trasmissione delle infezioni ospedaliere; le modalità di tutela e promozione della salute
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
151 4 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Metodologia della prevenzione
Illustrare il significato di: prevenzione primaria (fattori di rischio per la salute), prevenzione secondaria (screening), prevenzione terziaria e riflettere sul contributo della professione in merito alle strategie di promozione della salute, educazione alla salute, educazione sanitaria, educazione terapeutica
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
152 5 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Educazione sanitaria
Descrivere i concetti di educazione sanitaria: obiettivi, protagonisti e destinatari degli interventi di educazione sanitaria
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
153 6 Igiene generale e applicata
Medicina e sanità pubblica
Educazione sanitaria
Descrivere gli strumenti di prevenzione nelle malattie cronico-degenerative mediante adeguate abilità di linguaggio e comunicazione. Dimostrare capacità di analisi dei danni alla salute, in riferimento a stili di vita errati, mediante valutazione dell'efficacia degli interventi di educazione sanitaria
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L

25
154 1 Medicina legale Medicina e sanità pubblica
Deontologia sanitaria
Sviluppare conoscenze e metodi per l'esercizio di competenze educative; acquisire le nozioni utili in merito ai rapporti con la persona: informazione, consenso all'atto sanitario; acquisire le conoscenze normative di base per un corretto esercizio dell'attività professionale in relazione a: stato di necessità, referto, omissione di soccorso, segreto professionale, esercizio abusivo della professione, documentazione in Fisioterapia
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
155 2 Medicina legale Medicina e sanità pubblica
Deontologia sanitaria
Descrivere il processo evolutivo della professione e della disciplina ica; acquisire i concetti di autonomia e responsabilità del Fisioterapista nell'esercizio della professione; descrivere le funzioni del Fisioterapista e i rapporti di interdipendenza con altre professioni; l'approfondimento dei riferimenti deontologici e legislativi a livello nazionale ed europeo
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto
L
156 3 Medicina legale Medicina e sanità pubblica
La responsabilità professionale
Agire come indicato dal codice deontologico, verso le persone, i colleghi e le organizzazioni sanitarie in cui si è inseriti. Conoscere quanto prevede il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L
157 4 Medicina legale Medicina e sanità pubblica
La responsabilità professionale
Conoscere la normativa in vigore in tema di: responsabilità, informazione, comunicazione, ascolto e consenso in ambito sanitario. La riservatezza e il trattamento dei dati sensibili (privacy); il segreto professionale e d'ufficio
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L
158 5 Medicina legale Medicina e sanità pubblica
La responsabilità professionale
Strutturare una base di conoscenze idonee allo sviluppo di una professionalità autonoma e responsabile coerente con le norme che regolano l'esercizio professionale
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L
159 1 Scienze umane Scienze umane
I sistemi dei valori
Riconoscere la differenza fra etica, bioetica e deontologia. Riconoscere la matrice filosofica della riflessione etica mirata al raggiungimento di ciò che è bene per l'uomo. Individuare e utilizzare i riferimenti bibliografici di base utili alla comprensione dei problemi etici da un punto di vista sanitario dal punto di vista filosofico, antropologico, sociologico e politico. Difendere la centralità dell'uomo e la sua unicità senza farsi influenzare solo da scelte politiche, economiche o culturali nelle scelte di cura
Particolareggiata Interpretativa Teorica L

26
160 2 Scienze umane Scienze umane
La riflessione bioetica
Confrontarsi in equipe per assumere decisioni sui risvolti professionali dei temi inerenti la bioetica con particolare riguardo alle implicazioni etiche dell'intervento " riabilitativo" nelle fasi estreme della vita: grave prematurità, fase terminale di malattia e stati vegetativi persistenti
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
161 3 Scienze umane Scienze umane
La riflessione bioetica
Riconoscere le diverse implicazioni etiche i differenti modi di comunicare con la persona in funzione di sentimenti, stati d'animo, principi culturali e religiosi. Rispettare il valore della corporeità umana (senso e significato del corpo, pudore, relazione con la disabilità e con la morte)
Generale Decisionale Autonoma P
162 4 Scienze umane Scienze umane
Etica professionale
Descrivere gli elementi della deontologia professionale che consentano allo studente di comprendere i principi ed i criteri cui ispirarsi nel suo operato nei confronti dell'utente, dei colleghi, dell'organizzazione e della comunità professionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
163 5 Scienze umane Scienze umane
Etica professionale
Individuare anche su basi storiche le differenze epistemologiche esistenti tra le medicine alternative o non convenzionali e la medicina basata su prove di efficacia ai fini di una corretta e non illusiva condotta professionale. Individuare gli aspetti etici della ricerca sperimentale clinica e di indirizzo nelle scelte professionali critiche dal punto di vista etico. Indicare cosa sono e la funzione dei Comitati Etici
Generale Decisionale Autonoma P
164 6 Scienze umane Scienze umane
Deontologia professionale
Descrivere i profili professionali delle professioni sanitarie con particolare riguardo a quella del Fisioterapista; il ruolo delle professioni, i codici deontologici gli ordini e i collegi. RiDescrivere la deontologia professionale quale fonte di orientamento nelle condotte professionali
Generale Interpretativa Teorica L
165 7 Scienze umane Scienze umane
La responsabilità professionale
Acquisire conoscenze integrate con elementi di diritto, legislazione sanitaria, etica e bioetica al fine di agire responsabilmente nell'interesse del malato. Conoscere le implicazioni giuridiche e legali della responsabilità professionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
166 8 Scienze umane Scienze umane
La responsabilità professionale
Agire la attività professionale del Fisioterapista in modo competente, aggiornato in grado di collaborare con gli altri professionisti facenti parte del team riabilitativo nel rispetto delle reciproche competenze
Particolareggiata Decisionale Autonoma P

27
167 1 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Legislazione e organizzazione
Descrivere l'evoluzione storica, i principi generali, il quadro legislativo di riferimento della medicina del lavoro
Generale Mnemonica Non richiesto
L
168 2 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Igiene del lavoro
Acquisire conoscenze di base in tema di prevenzione, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Generale Mnemonica Non richiesto L
169 3 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Igiene del lavoro
Descrivere i rischi occupazionali degli operatori sanitari: fattori di rischio allergologico, chimico, ergonomico, biologico, e approfondire il concetto di limite, di sicurezza negli ambiti di lavoro
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
170 4 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Malattie muscolo scheletriche e da agenti fisici
Idividuare e prevenire le patologie del rachide e arto superiore, dovute a fattori biomeccanici, movimentazione dei carichi e vibrazioni. Conoscere, saper individuare e prevenire i disturbi collegati all'uso di videoterminali: disturbi visivi e muscolo-scheletrici anche attraverso l'applicazione dei principi di ergonomia
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L
171 5 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Malattie muscolo scheletriche e da agenti fisici
Acquisire conoscenze sulla patologia da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti (definizione e caratteristiche fisiche) rischi per operatori e persone; gli effetti alla loro esposizione, le problematiche relative all'uso di radiazioni e le procedure da adottare per prevenire incidenti da esposizione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
172 6 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Malattie legate alla organizzazione del lavoro
Acquisire conoscenze sulla patologia da fattori relazionali: relazioni persona-lavoro, relazioni interpersonali, i turni di lavoro, lo stress, il mobbing
Generale Mnemonica Non richiesto
L
173 7 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Malattie da agenti chimici
Acquisire conoscenze sulle patologie da polveri: pneumoconiosi, asma allergica professionale, alveoliti allergiche estrinseche. Acquisire conoscenze sulle patologie della cute: dermatiti da contatto irritative e allergiche, altre malattie della cute di natura professionale. Acquisire conoscenze sulle malattie trasmesse per via ematica, aerea e cutanea: epatiti, HIV, Tbc, influenza, meningite, scabbia, carbonchio, verruche
Generale Mnemonica Non richiesto L
174 8 Medicina del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Cancerogeni professionali
Acquisire conoscenze sulle neoplasie da agenti fisici, chimici e biologici: tumori polmonari, mesoteliomi, tumori delle vie urinarie, degli organi emopoietici e tumori cutanei
Generale Mnemonica Non richiesto
L
175 1 Primo soccorso
Urgenza, emergenza e primo soccorso
Basic life support Prestare il primo soccorso alla persona Generale Interpretativa Autonoma T
176 2 Primo soccorso Urgenza, emergenza e primo soccorso
Basic life support Raccogliere gli elementi anamnestici essenziali in condizioni di emergenza
Generale Interpretativa Autonoma T

28
soccorso
177 3 Primo soccorso
Urgenza, emergenza e primo soccorso
Basic life support
Effettuare (su manichino) procedure di “basic life support” (BLS), spiegandone la tecnica e il razionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
178 4 Primo soccorso
Urgenza, emergenza e primo soccorso
Basic life support
Effettuare le procedure standard per la rilevazione dei parametri vitali in condizioni di emergenza
Generale Decisionale Autonoma T
179 1 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Le origini di psicologia e pedagogia
Descrivere le principali teorie della mente inserite nel loro contesto storico, sociale e culturale. Identificare e differenziare la diversa natura delle conoscenze professionali (sapere, saper essere e saper fare) e distinguere gli elementi di complessità ricompresi nel concetto di competenza
Generale Mnemonica Non richiesto
L
180 2 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane L'apprendimento
Esporre le principali strategie di apprendimento per le conoscenze relative a sapere, saper essere e saper fare e sapere cosa si intende per "apprendimento sul campo" e quanto per esso prevede la normativa alla base dei programmi di ECM
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
181 3 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane La comunicazione
Descrivere i modelli teorici di interpretazione della "comunicazione efficace" per agire con una comunicazione efficace nella relazione con gli utenti, i tutori, e il gruppo classe
Generale Mnemonica Non richiesto L
182 4 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane La comunicazione
Analizzare ed interpretare le modalità gestuali di cura alla luce della teoria generale della comunicazione
Generale Mnemonica Non richiesto L
183 5 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Il tutoring Descrivere ciò che implica la funzione tutoriale nelle professioni sanitarie
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L
184 6 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane Il tutoring
Agire nell'apprendimento sul campo e nell'affiancamento in qualità di discente e in qualità di formatore
Particolareggiata Decisionale Teorica P
185 7 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Professione d'aiuto
Descrivere cosa si intende per "relazione di aiuto". Descrivere la professione del Fisioterapista nell'ambito delle professioni che implicano l'instaurarsi di una relazione di aiuto
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
186 8 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Professione d'aiuto
Inferire le strategie per ridurre la dissonanza cognitiva e il disagio che essa comporta. Descrivere il "rischio di violenza" insito nelle relazioni d'aiuto. Descrivere il valore dell"altro" all'interno di una relazione di aiuto
Generale Decisionale Teorica L
187 9 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Lo stereotipo
Descrivere il rischio di disumanizzazione del malato nel processo di cura. Descrivere il rischio dello "stereotipo" nell'incontro con l'altro ed evitare il condizionamento sulla base degli stereotipi culturali nella relazione professionale
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L

29
188 10 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Il processo decisionale
Descrivere le principali teorie di interpretazione e conoscenza del processo decisionale
Generale Interpretativa Teorica L
189 11 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Il ragionamento clinico
Descrivere le basi epistemologiche del moderno ragionamento clinico da Murri a Popper
Generale Mnemonica Teorica L
190 12 Pedagogia generale e sociale
Scienze umane
Il processo decisionale in area clinica
Applicare le fasi del processo decisionale in area clinica. Conoscere l'importanza dei rituali nella relazione, il significato e il valore delle "buone prassi" e del "porre la persona al centro del processo riabilitativo"
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
191 1 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
Processi cognitivi
Descrivere le componenti dell'apprendimento: condizionamento operante, rinforzo, modellamento, programmi di rinforzo
Generale Mnemonica Non richiesto
L
192 2 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
Processi cognitivi
Descrivere le forme e i meccanismi del ragionamento: la formazione dei concetti, la soluzione dei problemi, la creatività e le fissità funzionali
Generale Mnemonica Non richiesto L
193 3 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
Processi cognitivi
Descrivere le teorie e i metodi di misurazione dell'intelligenza e delle abilità cognitive
Generale Mnemonica Non richiesto
L
194 4 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
Processi cognitivi e relazionali
Descrivere gli elementi costitutivi del processo di comunicazione e le funzioni della comunicazione verbale e non verbale
Generale Mnemonica Non richiesto L
195 5 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
La motivazione
Descrivere le principali teorie alla base della individuazione della gerarchia dei bisogni dell'uomo e le principali teorie di interpretazione del processo motivazionale alla base dell'agire umano
Generale Mnemonica Non richiesto
L
196 6 Psicologia generale
Scienze del comportamento umano
La motivazione
Sviluppare la consapevolezza dell'importanza di apprendimento e formazione continua in ambito professionale
Particolareggiata Decisionale Non richiesto
L
197 1 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Somatizzazione Descrivere i concetti di stile di vita, salute e malattia
Generale Mnemonica Non richiesto
L
198 2 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Somatizzazione
Descrivere l'equilibrio psicosomatico tra salute e malattia. Descrivere il concetto di stress, di conflitto psichico e i meccanismi di difesa adeguati e inadeguati
Generale Mnemonica Non richiesto
L
199 3 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Somatizzazione Descrivere le reazioni psicofisiologiche e il processo di somatizzazione
Generale Mnemonica Non richiesto L
200 4 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Somatizzazione Descrivere lo sviluppo e gli squilibri psicosomatici in età evolutiva
Generale Mnemonica Non richiesto
L
201 5 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Metodi
Descrivere i metodi di valutazione in psicologia clinica: il colloquio clinico in ambito sanitario
Generale Mnemonica Non richiesto
L
202 6 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Metodi
Descrivere il concetto di aggressività e alessitimia nella relazione diagnostica e terapeutica
Generale Mnemonica Non richiesto
L

30
203 7 Psicologia clinica
Scienze del comportamento umano
Metodi
Descrivere le metodologie di educazione alla relazione. Descrivere l'approccio terapeutico integrato, il concetto di rispetto per la persona e la collaborazione tra terapeuti
Generale Mnemonica Non richiesto
L
204 1 Lingua inglese Metodologia clinica
Inglese scientifico
Utilizzare le funzioni linguistiche con vocaboli scientifici di uso più frequente in modo da soddisfare i bisogni dei persone
Generale Interpretativa Autonoma T
205 2 Lingua inglese Metodologia clinica
Inglese scientifico
Utilizzare la lettura attraverso l’acquisizione delle tecniche di base per affrontare un testo scritto comprendendone il senso generale
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
206 3 Lingua inglese Metodologia clinica
Inglese scientifico Utilizzare skills per l'uso di motori di ricerca o banche dati in lingua inglese
Non specificato Non specificato
Autonoma T
207 4 Lingua inglese Metodologia clinica
Inglese scientifico
Utilizzare strumenti di traduzione simultanea per l'utilizzo degli idiomi informatici in lingue diverse dall'inglese
Non specificato Non specificato
Autonoma T
208 5 Lingua inglese Metodologia clinica
Inglese scientifico
Comprendere e discutere con capacità critica articoli di ricerca medica in lingua inglese
Particolareggiata Decisionale Pratica P
209 6 Lingua inglese Metodologia clinica Inglese scientifico
Scrivere in lingua inglese in modo grammaticalmente corretto report semplici di vario genere su argomenti biomedici
Generale Interpretativa Pratica P
210 1 Informatica generale
Metodologia clinica
Informatica generale
Descrivere il calcolatore. Descrivere il sistema operativo
Generale Mnemonica Non richiesto
L
211 2 Informatica generale
Metodologia clinica
Informatica
Descrivere i concetti generali dell'informatica, la codifica dell'informazione e gli strumenti informatici per la produttività individuale
Generale Mnemonica Non richiesto
L
212 3 Informatica generale
Metodologia clinica
Tecnologie di Internet
Descrivere le nozioni generali dei tipi di reti: Reti TCP/IP ed utilizzare Internet ed i protocolli applicativi di Internet: posta elettronica, http, World-wide web, il linguaggio html e l'accesso ai servizi di rete
Generale Mnemonica Non richiesto L
213 4 Informatica generale
Metodologia clinica
Informatica medica
Descrivere le applicazioni informatiche in medicina
Generale Mnemonica Non richiesto
L
214 5 Informatica generale
Metodologia clinica Laboratorio Utilizzare i fogli elettronici
(word) e power point Particolareggiata Decisionale Autonoma T
215 6 Informatica generale
Metodologia clinica
Laboratorio Utilizzare fogli di calcolo (excel)
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
216 7 Informatica generale
Metodologia clinica
Informatica applicata
Usare strumenti informatici per identificare, accedere, registrare dati della persona e per trattare documentazione specifica
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
217 1 Informatica applicata
Metodologia clinica Ausili informatici
Descrivere l’approccio Integrato dell’informatica per le disabilità neuromotorie e neurocognitive (Analisi dei bisogni; valutazione; disabilità potenziali e potenziabili finalizzato all’approccio sistemico; prestazione di lavoro; postura; gesto)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P

31
218 2 Informatica applicata
Metodologia clinica
Ausili informatici
Descrivere gli ausili elettronici ed informatici per la mobilità, la comunicazione, il controllo dell'ambiente a distanza, il gioco. Descrivere la Domotica: una casa intelligente
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
219 3 Informatica applicata
Metodologia clinica Ausili informatici
Descrivere e applicare programmi informatici per la riabilitazione cognitiva, comunicativa, della memoria, delle eminegligenze, delle aprassie, delle acinesie del parkinsoniano
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
220 4 Informatica applicata
Metodologia clinica
Ausili informatici
Descrivere le varie tipologie della realtà virtuale: tecnologiche e campi di applicazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
221 5 Informatica applicata
Metodologia clinica
Protesiologia adiuvata dall'informatica
Descrivere le diverse metodologie nella persona amputata nella fase pre-protesica e post-protesica; il concetto di ausilio come strumento per l'autonomia personale. l'utilizzo dell'infomatica per adiuvare il cammino in riferimento alla persona protesizzata (analisi dei vari pattern fisiologici/patologici)
Particolareggiata Decisionale Teorica P
222 6 Informatica applicata
Metodologia clinica
Protesiologia adiuvata dall'informatica
Descrivere gli ausili riabilitativi che si adattano alla situazione patologica invalidante della persona rispetto alle sue esigenze: le protesi elettroniche di arto inferiore e superiore, i metodi di controllo adiuvati all'informatica, il biofeedback sensoriale per soggetti amputati di arto inferiore, i concetti base sulla mano artificiale, gli ausili per la prensione e la loro correlazione alla rieducazione funzionale
Generale Mnemonica Teorica P
223 1 Riabilitazione generale
Medicina e sanità pubblica
Generalità
Descrivere il significato di "menomazione", "limitazione della abilità" e "restrizioni alla partecipazione" sul modello bio-psico-sociale secondo la classificazione internazionale di funzione, disabilità e salute (I.C.F.)
Generale Interpretativa Non richiesto
L
224 2 Riabilitazione generale
Medicina e sanità pubblica
Storia della riabilitazione
Attraverso la conoscenza del passato, acquisire consapevolezza del carattere storico, mutevole e problematico, dei paradigmi scientifici in uso. Sviluppare un atteggiamento critico equilibrato di fronte alla molteplicità delle proposte teoriche in campo
Generale Interpretativa Non richiesto
L
225 3 Riabilitazione generale
Medicina e sanità pubblica
Le risorse umane
Descrivere le radici storico-culturali della riabilitazione analizzando i principali modelli riabilitativi di riferimento e le principali teorie del movimento .Descrivere i ruoli e i compiti delle professioni della Riabilitazione
Generale Mnemonica Non richiesto
L
226 4 Riabilitazione generale
Medicina e sanità pubblica
Il target della riabilitazione
Formulare in team il progetto riabilitativo e il programma di Fisioterapia, identificando gli aspetti generali della
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto
L

32
aspetti generali della valutazione della persona
227 5 Riabilitazione generale
Medicina e sanità pubblica
Cause di disabilità
Identificare le principali cause di disabilità: traumi, malattie vascolari, infezioni, malattie croniche, malattie tossiche, malattie genetico-ereditarie, malattie osteo-articolari, malattie cardio-respiratorie, ustioni
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
228 1 Genetica medica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Malattie genetiche
Indicare i caratteri quantitativi e semiquantitativi e i concetti generali delle malattie ereditarie, congenite e genetiche
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
229 2 Genetica medica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Malattie genetiche
Indicare: la definizione, la costruzione e lo studio degli alberi genealogici con le relative problematiche, Indicare alberi genealogici dove segregano malattie autosomiche dominanti
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
230 3 Genetica medica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Malattie cromosomiche
Illustrare gli aspetti generali delle anomalie cromosomiche e aneuploidi dei cromosomi sessuali
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
231 4 Genetica medica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Genetica molecolare
Illustrare gli aspetti generali della classificazione delle mutazioni geniche
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
232 5 Genetica medica
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Genetica clinica Descrivere l'uso di banche dati in genetica medica
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
233 1 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Micologia
Conoscere i principali miceti di interesse sanitario, i loro caratteri biologici e i principi della diagnostica micologica
Generale Mnemonica Non richiesto L
234 2 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Batteriologia generale
Descrivere i caratteri biologici dei batteri, le interrelazioni ospite-cellula batterica, i farmaci antibatterici
Generale Mnemonica Non richiesto L
235 3 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Batteriologia generale
Descrivere la struttura, il metabolismo e la riproduzione della cellula batterica; Descrivere la formazione delle spore e il meccanismo di azione patogena dei batteri
Generale Mnemonica Non richiesto
L
236 4 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Batteriologia speciale
Descrivere i principali batteri di interesse sanitario e i principi generali per la diagnosi delle malattie causate da batteri
Generale Mnemonica Non richiesto L
237 5 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Protozoologia
Descrivere i principali protozoi di interesse sanitario; Descrivere i caratteri biologici e i metodi di identificazione dei principali protozoi di interesse sanitario
Generale Mnemonica Non richiesto
L
238 6 Microbiologia Etiologia e patogenesi delle malattie
Virologia generale
Descrivere i caratteri morfologico-strutturali dei virus: interazioni virus-cellula e virus-ospite e i principali virus di interesse sanitario
Generale Mnemonica Non richiesto
L
239 1 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Malattie genetiche Descrivere le principali aberrazioni cromosomiche e le malattie ereditarie
Generale Mnemonica Non richiesto
L
240 2 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Patologia del sangue
Descrivere la fisiopatologia delle anemie
Generale Mnemonica Non richiesto
L

33
241 3 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Immunologia
Descrivere il sistema immunitario e la sua funzione: la risposta immunitaria come causa di malattia
Generale Mnemonica Non richiesto
L
242 4 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Patologia cellulare
Descrivere i meccanismi della reazione e del riparo del danno cellulare e tissutale
Generale Mnemonica Non richiesto L
243 5 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Infiammazione acuta
Descrivere le caratteristiche, l'evoluzione del processo infiammatorio acuto
Generale Mnemonica Non richiesto L
244 6 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Infiammazione cronica
Descrivere le caratteristiche dell'evoluzione del processo infiammatorio cronico
Generale Mnemonica Non richiesto
L
245 7 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Agenti di danno Descrivere gli agenti fisici, chimici e biologici
Generale Mnemonica Non richiesto
L
246 8 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
247 9 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Malattie metaboliche
Descrivere l'eziopatogenesi e clinica del diabete mellito di tipo I e II; illustrare le complicanze acute e croniche del diabete mellito con particolare riguardo alle complicanze vascolari periferiche, al piede diabetico ed alle neuropatie di tipo motorio e vegetativo
Generale Mnemonica Non richiesto
L
248 10 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Fisiopatologia cardio-circolatoria
Descrivere i meccanismi fisiopatologici delle principali malattie vascolari e cardio-vascolari, e dell'edema
Generale Mnemonica Non richiesto
L
249 11 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Le neoplasie
Descrivere il meccanismo fisiopatologico della trasformazione neoplastica, la classificazione e le caratteristiche generali delle neoplasie benigne e maligne
Generale Mnemonica Non richiesto L
250 12 Patologia generale
Patologia sistematica integrata
Le neoplasie
Descrivere il meccanismo fisiopatologico della cancerogenesi e le basi genetiche delle neoplasie: oncogeni e antioncogeni
Generale Mnemonica Non richiesto L
251 1 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Carcinogenesi Descrivere i fattori di rischio oncogeno: dall'evidenza sperimentale a quella clinica
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
252 2 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Epidemiologia
Illustrare la dimensione del problema cancro e le tecniche diagnostiche convenzionali dei tumori
Superficiale Interpretativa Non richiesto L
253 3 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Diagnostica e prevenzione
Descrivere il significato dello screening dei tumori e possibilità preventive
Generale Interpretativa Non richiesto L
254 4 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Stadiazione Illustrare la stadiazione dei tumori: principi generali e sue applicazioni
Generale Interpretativa Non richiesto
L
255 5 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Terapia oncologica
Illustrare sommariamente i farmaci antiproliferativi, il trattamento ormonale e trattamenti integrati (adiuvanti, neoadiuvanti e palliativi) e le linee guida per la medicina del territorio per la gestione dei malati con leucemie e linfomi
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
256 6 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Riabilitazione
Illustrare i principi generali della riabilitazione in oncologia e illustrare casi specifici
Generale Interpretativa Non richiesto
L

34
257 7 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Cure palliative Fornire assistenza psicologica al persona e alla famiglia
Generale Interpretativa Non richiesto
L
258 8 Oncologia medica
Patologia sistematica integrata
Cure palliative
Realizzare modelli di assistenza al malato terminale: hospice e assistenza domiciliare, ruolo della famiglia, delle associazioni, dei medici di medicina generale; implicazioni organizzative, di programmazione sanitaria e di costo
Generale Interpretativa Non richiesto L
259 1 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Farmacocinetica generale
Descrivere i concetti generali della farmacologia (l'origine dei farmaci, gli aspetti generali del passaggio di essi attraverso le membrane biologiche), della distribuzione dei farmaci nell'organismo (il loro legame alle proteine plasmatiche, il metabolismo e l'eliminazione)
Superficiale Mnemonica Non richiesto
L
260 2 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Farmacocinetica generale
Descrivere le vie di somministrazione dei farmaci, le forme farmaceutiche, la loro conservazione, i principali fattori che modificano l’azione dei farmaci e l'interazione farmaco-recettore antagonismo e sinergismo
Generale Interpretativa Non richiesto L
261 3 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Principi di tossicologia
Descrivere gli aspetti generali delle interazioni, reazioni avverse e delle allergie ai farmaci gli aspetti generali della tossicità: acuta e cronica, test di mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi
Generale Interpretativa Non richiesto L
262 4 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Neuropsicofarmacologia
Esporre l'inquadramento generale dei farmaci che agiscono sul sistema nervoso autonomo, le qualità dei farmaci sedativo-ipnotici, antidepressivi, antimaniacali, antipsicotici, i farmaci per il trattamento del morbo di parkinson e di altre patologie neurovegetative,
Generale Interpretativa Non richiesto
L
263 5 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Neuropsicofarmacologia
Descrivere gli effetti dei farmaci per il trattamento di disturbi della muscolatura scheletrica e la tossina botulinica
Generale Interpretativa Non richiesto L
264 6 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Farmacologia cardiovascolare
Descrivere le qualità dei farmaci anti-ipertensivi e antianginosi, quelli anti-iperlipidemici e quelli inibitori dell’aggregazione piastrinica e le qualità dei farmaci trombolitici
Superficiale Interpretativa Non richiesto L
265 7 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Farmacologia dell'apparato respiratorio
Illustrare le qualità dei farmaci broncodilatatori ed altri farmaci per il trattamento dell’asma e della broncopneumopatia cronica ostruttiva
Generale Interpretativa Non richiesto L
266 8 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Farmacologia dell'infiammazione
Descrivere le qualità dei farmaci steroidei e anti-infiammatori non steroidei (fans) nelle patologie reumatologiche quali: artrite reumatoide, gotta e osteoporosi
Generale Decisionale Non richiesto L

35
267 9 Farmacologia
Medicina bio-molecolare e bio-tecnologica
Tossicologia
Descrivere le qualità dei farmaci anestetici locali e il loro uso nella pratica sportiva, i quadri di abuso di farmaci nella attività fisica, i disturbi e i sintomi del Doping, gli aspetti generali della dipendenza fisica e psichica da farmaci
Generale Decisionale Non richiesto L
268 1 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Disturbi di alimentazione
Descrivere la fisiopatologia della deglutizione e della motilità esofago-gastrica
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
269 2 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Disturbi di alimentazione
Descrivere la differenza tra patologie organiche e funzionali di interesse fisioterapico
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
270 3 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Disturbi di alimentazione
Illustrare le problematiche della persona con rigurgito, reflusso, disfagia, pirosi, anoressia, sarcofobia, polifagia, polidipsia
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
271 4 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Disturbi di alimentazione
Illustrare i concetti di obesità e magrezza, in Fisioterapia
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
272 5 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Clinica medica
Descrivere l'eziopatogenesi e la clinica dell'osteoporosi, e il deficit di Vitamina D; dell'osteomalacia e del Morbo di Paget
Generale Interpretativa Non richiesto L
273 6 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Nefrologia
Descrivere i principali meccanismi di danno renale e la loro possibile evoluzione fisiopatologia e clinica nel tempo, la semeiogenesi di base utile alla comprensione dei principali segni e sintomi di compromissione della funzione renale
Superficiale Mnemonica Non richiesto L
274 7 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Nefrologia
Descrivere i quadri clinici di patologia renale primitiva e secondaria acuti e cronici;dell’insufficienza renale cronica e le sue modalità evolutive
Generale Interpretativa Non richiesto L
275 8 Medicina interna Patologia sistematica integrata
Nefrologia
Descrivere le principali misure terapeutiche conservative della funzione renale, e i principi basilari della terapia sostitutiva renale (emodialisi, emofiltrazione e dialisi peritoneale)
Generale Interpretativa Non richiesto L
276 1 Malattie dell'apparato respiratorio
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Esporre le basi fisiopatologiche delle alterazioni funzionali respiratorie: funzione ventilatoria, meccanica ventilatoria, studio funzionale dei muscoli respiratori, distribuzione della ventilazione, distribuzione del flusso sanguigno e rapporto ventilazione/perfusione, diffusione dei gas, equilibrio e trasporto dell'O2 e della CO2, equilibrio acido-base, regolazione della ventilazione, funzione respiratoria durante il
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L

36
sonno
277 1
Malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere segni e sintomi comuni alle disfunzioni degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio e le relative interazioni delle principali patologie suscettibili di riabilitazione respiratoria e le relative indicazioni di trattamento: le malattie croniche delle vie aeree (Asma, BPCO, Bronchiectasie e Fibrosi cistica), le malattie dell'interstizio (fibrosi), le malattie restrittive del torace (Malattie neuromuscolari, Deformità della parete toracica)
Generale Interpretativa Non richiesto L
278 2
Malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere le alterazioni fisiopatologiche alla base dello scompenso cardiaco e le indicazioni di trattamento riabilitativo,le alterazioni fisiopatologiche e le complicanze correlate agli esiti di interventi chirurgici di trapianto cuore, cuore-polmone e le relative indicazioni di valutazione e trattamento pre e post-operatorio
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
279 3
Malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere come i diversi sistemi cardio-circolatorio, respiratorio e muscolare, si integrano in risposta all'esercizio fisico nel soggetto sano, nel soggetto affetto da patologia cardiocircolatoria, respiratoria e nel soggetto decondizionato
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
280 4
Malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere le alterazioni fisiopatologiche e le complicanze cardio-circolatorie e respiratorie correlate ai quadri di disabilità motoria complessa (Paralisi Cerebrali Infantili)
Generale Interpretativa Non richiesto L
281 5
Malattie dell'apparato respiratorio e cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere le caratteristiche, le indicazioni e le modalità di gestione delle strumentazioni complesse (incentivatori di flusso e di volume respiratorio) comunemente utilizzati nei programmi di Fisioterapia cardio-circolatoria e respiratoria, in ambienti ad elevata specializzazione
Generale Interpretativa Teorico L

37
282 1 Malattie dell'apparato cardiovascolare
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere la fisiopatologia della funzione cardiaca (cuore destro e sinistro); i test impiegati nella valutazione della funzionalità cardio-circolatoria e dell'attività elettrica cardiaca, integrando i dati ricavati con i segni clinici manifestati dalla persona (refertazione ECG, ecocardiogramma)
Generale Interpretativa Non richiesto L
283 1 Chirurgia generale
Etiologia e patogenesi delle malattie
Fisiopatologia ed esiti di interventi chirurgici negli apparati cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere le alterazioni fisiopatologiche e le complicanze correlate agli esiti di interventi chirurgici toraco-addominali (vie di accesso chirurgico, resezioni parenchimali, interventi demolitivi della parete toracica) e addominali alti e relative indicazioni di valutazione e trattamento pre e post-operatorio
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
284 2 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Chirurgia generale a implicazione fisioterapica
Descrivere le tipologie di neoplasie della mammella, i protocolli, la chirurgia plastica, riscostruttiva del seno, le indicazioni/controindicazioni al trattamento riabilitativo. Descrivere i criteri di trattamento conservativo e chirurgico dell'incontinenza fecale e stipsi.Descrivere segni e sintomi dell'insufficienza venosa profonda e superficiale arti inferiori
Generale Interpretativa Non richiesto L
285 3 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Chirurgia vascolare a implicazione fisioterapica
Descrivere la fisiopatologia dell'aneurisma dell'aorta addominale e le relative tecniche chirurgiche, la fisiopatologia delle arteriopatie obliteranti periferiche
Generale Interpretativa Non richiesto L
286 4 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Chirurgia plastica a implicazione fisioterapica
Descrivere il trattamento chirurgico delle ustioni con esiti cicatriziali
Superficiale Interpretativa Non richiesto L
287 5 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Chirurgia plastica a implicazione fisioterapica
Illustrare le finalità e gli scopi di alcune tecniche fisioterapiche massoterapiche e/o strumentali specifiche coadiuvanti l'intervento del chirurgo plastico
Generale Interpretativa Non richiesto LT
288 6 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Neurochirurgia a implicazione fisioterapica
Illustrare i comportamenti intracranici e la fisiopatologia dell 'ipertensione endocranica e dell'edema cerebrale
Generale Interpretativa Teorico Pratica
289 7 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Neurochirurgia a implicazione fisioterapica
Descrivere le caratteristiche dei traumi cranio encefalici e il relativo trattamento chirurgico: la fase acuta post-operatoria e la fase post acuta
Generale Interpretativa Non richiesto L
290 8 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Neurochirurgia a implicazione fisioterapica
Descrivere le caratteristiche dei traumi spinali e il relativo trattamento chirurgico
Generale Interpretativa Non richiesto L

38
291 9 Chirurgia generale
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Chirurgia maxillo facciale e odontostomatologica
Descrivere le patologie legate all’articolazione temporo-mandibolare: mala occlusione (anche derivanti dall'utilizzo di alcuni tipi di apparecchi ortodontici), lock, traumi, fratture e tumori
Generale Interpretativa Non richiesto L
292 1 Fisioterapia cardio-respiratoria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale clinica/strumentale della persona in fase acuta/cronica
Descrivere le modalità di documentazione della valutazione effettuata sulla persona (es: metodo SOAP)
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
293 2 Fisioterapia cardio-respiratoria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale clinica/strumentale della persona in fase acuta/cronica
Eseguire una valutazione della condizione soggettiva e oggettiva della persona affetta da problemi cardio-circolatori e/o respiratori (intervista e/o applicazione di altri strumenti per indagine sui sintomi non strettamente collegati alla disfunzione cardio - respiratoria e/o respiratoria;revisione, e interpretazione dei dati di interesse e non cardio - respiratori ed esame obiettivo)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
294 3 Fisioterapia cardio-respiratoria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale clinica/strumentale della persona in fase acuta/cronica
Eseguire una valutazione oggettiva della persona affetto da problemi cardio-circolatori e/o respiratori (revisione ed interpretazione delle indagini di laboratorio e strumentali, effettuazione ed interpretazione dei test di funzionalità cardio-polmonare)
Generale Interpretativa Pratica P
295 4 Fisioterapia cardio-respiratoria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale clinica/strumentale della persona in fase acuta/cronica
Descrivere le modalità di monitoraggio e valutazione dei dati in uso in ambienti ad elevata specializzazione (terapia intensiva, neonatologia, trapianti d'organo, disturbi del sonno)
Generale Mnemonica Non richiesto L
296 5 Fisioterapia cardio-respiratoria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale clinica/strumentale della persona in fase acuta/cronica
Eseguire una valutazione oggettiva della persona candidato/sottoposto a ventilazione meccanica e della persona candidato allo svezzamento dal ventilatore, finalizzata alla progettazione di un appropriato programma di gestione
Generale Interpretativa Teorica L

39
297 6 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Definizione ed elaborazione del programma di Fisioterapia
Individuare, anche in equipe multidisciplinare, i problemi della persona suscettibili di trattamento riabilitativo, valutare la loro entità e la modificabilità ponendoli in ordine di priorità, senza distinzione tra problemi di natura respiratoria e/o cardio-circolatoria (es: gestione delle vie aeree, ventilazione, ossigenazione, lavoro respiratorio, distress respiratorio acuto, malnutrizione, gestione della patologia cronica, decondizionamento muscolare generalizzato) e problemi di diversa natura (es: esiti di icuts acuto, ridotta funzionalità articolare conseguente ad intervento chirurgico)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
298 7 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Definizione ed elaborazione del programma di Fisioterapia
Progettare l'intervento riabilitativo individualizzato di competenza fisioterapica (modalità terapeutiche e tempi) rispetto agli obiettivi prefissati, basandosi sulle migliori evidenze scientifiche disponibili (Linee guida) e individuare, anche in equipe multidisciplinare, gli outcome adeguati per la misurazione dell'impairment, disability and participation adeguati a verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti
Particolareggiata Decisionale Autonoma
299 8 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Effettuazione autonoma dell'intervento terapeutico di rieducazione funzionale in fase acuta e/o cronica
Progettare ed applicare programmi di riespansione polmonare, scegliendo le tecniche appropriate sulla base della causa della riduzione volumetrica e scegliere e applicare esercizi respiratori appropriati alla ottimizzazione del problema della persona
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
300 9 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Effettuazione autonoma dell'intervento terapeutico di rieducazione funzionale in fase acuta e/o cronica
Scegliere ed applicare, sulla base dei rilievi clinici, le modalità appropriate di monitoraggio della persona in fase acuta e/o cronica, anche sottoposto a ventilazione meccanica, interpretando segni, sintomi e dati funzionali clinico-strumentali (manifestazioni di effetti desiderati o collaterali) rilevati durante le attività terapeutiche
Generale Interpretativa Pratica P

40
301 10 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Effettuazione autonoma dell'intervento terapeutico di rieducazione funzionale in fase acuta e/o cronica: proposta di utilizzo di protesi, ortesi e ausilii, addestramento all'utilizzo e verifica di efficacia
Proporre l'adozione di protesi, ortesi e ausilii (es: ventilatori meccanici non invasivi), e scegliere i presidi idonei alla rieducazione funzionale della persona, istruendo la persona e/o i caregivers all'utilizzo e gestione dei medesimi e alla verifica della loro efficacia attraverso il monitoraggio delle funzioni vitali (es: incentivatori e/o presidi di riespansione polmonare, presidi di disostruzione bronchiale, sorgenti di ossigeno e di strumenti atti al controllo delle funzioni vitali)
Generale Interpretativa Teorica P
302 11 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Effettuazione autonoma dell'intervento terapeutico di rieducazione funzionale in fase acuta e/o cronica
Elaborare una relazione finale o di raccordo con l'intervento di altri professionisti, che includa problemi ed obiettivi pregressi ed attuali, interventi effettuati ed in corso, misure di risultato e la descrizione di eventuali programmi da eseguire a domicilio con i relativi follow-up
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
303 12 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Effettuazione di interventi valutativi e terapeutici in aree di elevata specializzazione
Descrivere la gestione della persona portatore di via aeree artificiali (modalità di clearance, fonazione deglutizione riconoscimento e gestione di eventi critici) e del neonato
Generale Interpretativa Teorica P
304 13 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona Controllo di qualità
Verificare, anche in equipe multidisciplinare, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed applicare le procedure necessarie al miglioramento della qualità delle prestazioni
Generale Interpretativa Pratica P
305 14 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale
Progettare e condurre interventi educativi rivolti ad altri operatori sanitari mirati allo sviluppo di condotte preventive, alla esecuzione di manovre terapeutiche e alla gestione del danno/disabilità conseguente/i alla patologia cardio-respiratoria
Generale Interpretativa Teorica P
306 15 Fisioterapia cardio-respiratoria
Trattamento della persona
Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale
Collaborare alla conduzione di progetti di ricerca finalizzati alla definizione di Linee Guida e alla diffusione della migliore attività riabilitativa basata sulle evidenze scientifiche
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
307 1 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Semeiotica neurologica
Riconoscere i segni inerenti: la capacità di reclutamento muscolare, la sensibilità, i riflessi, il tono muscolare, la coordinazione, l'equilibrio e la marcia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L

41
308 2 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Semeiotica neurologica
Esaminare le funzioni motoria, sensitiva, cognitiva, viscerale, le A.D.L. e la qualità della vita
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
309 3 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Semeiotica neurologica
Descrivere gli strumenti di indagine diagnostica (elettroencefalogramma, elettromiografia, potenziali evocati, T.A.C. e risonanza magnetica) per la definizione del progetto riabilitativo e del programma fisioterapico
Generale Interpretativa Non richiesto L
310 4 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Descrivere e definire le sindromi: piramidale, del II° motoneurone, cerebellare, extrapiramidale, sensitiva, vestibolare
Generale Mnemonica Non richiesto L
331 5 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Neurolesione
Descrivere e valutare il fenomeno della spasticità differenziando i quadri e rispettive cause
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
311 6 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Descrivere le patologie dei nervi cranici di interesse fisioterapico, correlandole alle patologie del sistema nervoso centrale
Generale Mnemonica Non richiesto L
312 7 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere l’ictus ischemico ed emorragico e le vasculopatie croniche
Generale Mnemonica Non richiesto L
313 8 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere il morbo di Parkinson, i parkinsonismi, la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica
Generale Mnemonica Non richiesto L
314 9 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere le eredoatassie, le meningoencefaliti, le demenze e le complicanze neurologiche dell’AIDS
Generale Mnemonica Non richiesto L
315 10 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere le polineuropatie acute, subacute e croniche le miopatie, la miastenia e le mielopatie acute e croniche
Generale Mnemonica Non richiesto L
316 11 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere i comi, la morte cerebrale, le epilessie, le cefalee e i disturbi del sonno
Generale Mnemonica Non richiesto L
317 12 Neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Clinica neurologica
Definire e descrivere la sindrome da ipertensione endocranica e i tumori cerebrali
Generale Mnemonica Non richiesto L
318 1 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia
Illustrare i concetti generali, la definizione e i cenni storici della neuropsicologia
Generale Mnemonica Non richiesto P
319 2 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia
Definire il concetto di dominanza emisferica e lo sviluppo del linguaggio: i meccanismi della comunicazione verbale e gli apparati coinvolti nella produzione del linguaggio verbale
Generale Interpretativa Non richiesto L
320 3 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Le Afasie
Descrivere le varie classificazioni delle afasie, comprese le sindromi afasiche da disconnessione
Generale Interpretativa Non richiesto L

42
321 4 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Le Afasie
Descrivere la testistica per valutare l'afasia e per indirizzare la strategia rieducativa
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
322 5 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia
Descrivere la negligenza spaziale unilaterale nelle sue manifestazioni cliniche, i meccanismi della visione e i disturbi percettivi visivi, inquadrandone le ipotesi interpretative
Generale Interpretativa Non richiesto L
323 6 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Le Aprassie
Descrivere i disturbi nella realizzazione del gesto considerando progetto e programma di azione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
324 7 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia
Descrivere i modelli funzionali e il substrato organico della memoria e dell'attenzione ed inquadrarne i disturbi
Generale Interpretativa Non richiesto L
325 8 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia Inquadrare e descrivere le agnosie Generale Interpretativa Non richiesto L
326 9 Neuropsicologia Scienze del comportamento umano
Neuropsicologia
Descrivere la sindrome frontale, il deterioramento demenziale, gli esiti neuropsicologici di coma
Generale Interpretativa Non richiesto L
327 1 Medicina fisica riabilitativa in neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Neurolesione
Descrivere il modello riabilitativo dello stroke, della sclerosi multipla, del coma e stato vegetativo
Generale Interpretativa Teorica P
328 2 Medicina fisica riabilitativa in neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Neurolesione
Descrivere i modelli del controllo del movimento: modello riflesso, modello gerarchico, modelli cibernetici, modelli sistemici
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
329 3 Medicina fisica riabilitativa in neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Neurolesione
Descrivere le cause, il “momentum”, il substrato biologico, la monofocalità e plurifocalità, lo shock e la diaschisi
Generale Interpretativa Teorica L
330 4 Medicina fisica riabilitativa in neurologia
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Neurolesione
Definire i concetti di movimenti “normali”, menomazione primaria e componenti secondarie, menomazioni terziarie
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
332 5 Medicina fisica riabilitativa in neurologia
Trattamento della persona
Valutazione neurologica
Utilizzare i dati raccolti ed il ragionamento clinico per la definizione degli obiettivi del progetto riabilitativo della persona con lesioni del sistema nervoso
Particolareggiata Interpretativa Pratica L
333 1 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale neurologica
Raccogliere dati anamnestici di interesse terapeutico-riabilitativo in persone con lesioni del sistema nervoso
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
334 2 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale neurologica
Utilizzare le scale validate in neuro-riabilitazione per la raccolta di dati riabilitativi e la compilazione della cartella riabilitativa
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
335 3 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nel trauma cranio encefalico e coma
Descrivere generalità, inquadramento, etiopatogenesi, disturbi della coscienza, gli indici generali di gravità e i possibili danni associati nel trauma cranio encefalico e nel coma
Generale Interpretativa Teorica P

43
336 4 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nel trauma cranio encefalico e coma
Prevenire le complicanze (piaghe da decubito, retrazioni, paraosteoartropatie, tromboembolie) nel trauma cranio encefalico e nel coma
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
337 5 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nel trauma cranio encefalico e coma
Pianificare e realizzare il trattamento fisioterapico nel trauma cranio encefalico e nel coma in fase acuta
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
338 6 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nel trauma cranio encefalico e coma
Pianificare l'intervento fisioterapico in fase di recupero e degli esiti in riferimento alla valutazione dell'outcome
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
339 7 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nel trauma cranio encefalico e coma
Valutare i fattori ambientali, personali e i potenziali facilitatori o barriere/ostacoli al raggiungimento della migliore autonomia e qualità di vita nel trauma cranio encefalico e nel coma
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
340 8 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nello stroke
Descrivere indici generali di gravità e possibili danni associati nello stroke
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
341 9 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nello stroke
Pianificare e realizzare il trattamento fisioterapico dello stroke in fase acuta: prevenzione delle complicanze e dei danni secondari
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
342 10 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nello stroke
Pianificare l'intervento fisioterapico nella fase post acuta nello stroke: dall'educazione terapeutica all’autocura e autogestione ed il coinvolgimento dei caregivers
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
343 11 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nello stroke
Valutare il raggiungimento e il mantenimento del massimo livello di autonomia nella fase degli esiti dello stroke in riferimento alla valutazione degli outcome
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
344 12 Fisioterapia in neurologia
Trattamento del persona
Fisioterapia
Costruire un programma di rieducazione funzionale del gesto:pointing-reaching-grasping-release
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
345 13 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle mielolesioni
Descrivere indici generali di gravità e possibili danni associati nelle mielolesioni, in riferimento alla valutazione e classificazione A.S.I.A.
Particolareggiata Mnemonica Teorica P
346 14 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle mielolesioni
Pianificare e realizzare il trattamento fisioterapico delle mielolesioni in fase acuta: prevenzione delle complicanze e dei danni secondari in riferimento agli elementi significativi per il progetto riabilitativo: bilancio motorio, sensitivo, osteo - articolare, radiologico,e bilancio delle complicanze e del dolore
Particolareggiata Interpretativa Pratica P

44
347 15 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle mielolesioni
Pianificare l'intervento fisioterapico nella fase post acuta nelle mielolesioni: le strategie terapeutiche, la prevenzione delle complicanze (paraosteoartropatie, turbe tromboemboliche, infezioni urinarie)
Generale Interpretativa Teorica P
348 16 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle mielolesioni
Pianificare l'intervento fisioterapico negli esiti delle mielolesioni in riferimento all'outcome: dalla facilitazione neuromuscolare alla ripresa delle autonomie ed il reinserimento sociale tramite opportuni ausilii e adattamenti ambientali
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
349 17 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Descrivere gli indici di gravità e i meccanismi di recupero delle neurolesioni periferiche utilizzando un bilancio motorio, sensitivo, osteo - articolare, radiologico, delle complicanze e del dolore
Generale Mnemonica Teorica P
350 18 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Utilizzare dati provenienti da indagini strumentali (elettromiografia, elettroneuronografia, entità anatomopatologiche di neurolesione periferica) per la definizione del programma riabilitativo
Generale Interpretativa Pratica P
351 19 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Descrivere etiopatogenesi, segni e sintomi nelle lesioni dei nervi cranici con particolare riferimento alla paralisi del VII° nervo cranico
Generale Mnemonica Teorica P
352 20 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Descrivere etiopatogenesi, segni e sintomi della sindrome di Guillain-Barrè e delle neuropatie degenerative ereditarie (Charcot Marie-Tooth e Dejerine Sottas)
Generale Mnemonica Teorica P
353 21 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Riconoscere segni e sintomi nelle patologie dello stretto toracico e delle radicolopatie riferite al plesso brachiale
Generale Mnemonica Teorica P
354 22 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Riconoscere segni e sintomi nelle radicolopatie riferite al plesso lombare e sacrale
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
355 23 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle patologie del sistema nervoso periferico
Pianificare e realizzare il trattamento riabilitativo nelle lesioni del sistema nervoso periferico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
356 24 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle atassie
Valutare le diverse forme di atassia (sensitiva, cerebellare, vestibolare, frontale, eredo-atassia di
Generale Mnemonica Teorica P

45
Friedreich, di Pierre-Marie, di Strumpell-Lorrain, di Levy-Roussy)
357 25 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle atassie
Illustrare i principi del trattamento riabilitativo dell’atassia cerebellare e dell’atassia vestibolare in fase acuta e post acuta, con riferimento alle strategie di adattamento e di compensazione tramite opportuni ausilii
Generale Interpretativa Teorica P
358 26 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Tecniche in Fisioterapia
Descrivere le origini e l’evoluzione e le applicazioni delle principali metodiche di neuroriabilitazione (Concetto Brunnstrom e Vojta)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
359 27 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Tecniche in Fisioterapia
Descrivere le origini e l’evoluzione e le applicazioni delle principali metodiche di neuroriabilitazione (Concetto Bobath)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
360 28 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Tecniche in Fisioterapia
Descrivere le origini e l’evoluzione e le applicazioni delle principali metodiche di neuroriabilitazione (Concetto Propriocettive Neuromuscular Facilitation)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
361 29 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Tecniche in Fisioterapia
Descrivere le origini, l’evoluzione e le applicazioni delle principali metodiche di neuroriabilitazione (Esercizio Terapeutico Conoscitivo, Evocazione di componenti motorie assenti)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
362 30 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Tecniche in Fisioterapia
Descrivere le origini, l’evoluzione e le applicazioni delle principali metodiche di neuroriabilitazione (Affolter, Constraint Induced Movement Therapy)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
363 31 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Psicomotricità
Realizzare attività pratica su di sé con esperienze di attività psicomotoria e tecniche di rilassamento
Generale Interpretativa Autonoma P
364 32 Fisioterapia in neurologia
Trattamento della persona
Psicomotricità
Saper predisporre il setting terapeutico nella sala di psicomotricità per realizzare attività psicomotoria di gruppo
Generale Interpretativa Pratica P
365 33 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale neurologica
Valutare utilizzando sistemi appropriati l'integrità, le attività e le limitazioni strutturali e funzionali, con riferimento alla partecipazione alla vita sociale e sue restrizioni, in persone con lesioni del sistema nervoso
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
366 34 Fisioterapia in neurologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale neurologica
Valutare i fattori contestuali: ambiente e persone (potenziali facilitatori o barriere al raggiungimento dell’autonomia) in persone con lesioni del sistema nervoso
Particolareggiata Interpretativa Pratica P

46
367 1 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Generalità in ortopedia e traumatologia
Descrivere le generalità dell'esame clinico in ortopedia: indagine anamnestica, esame obiettivo, indagini strumentali. Descrivere le generalità sull'eziologia dei traumi: fratture, distorsioni, lussazioni, lesioni muscolari e tendinee
Generale Mnemonica Non richiesto L
368 2 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Affezioni dell'infanzia e dell'adolescenza
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la terapia delle affezioni dell'infanzia e dell'adolescenza: ginocchio valgo, piede piatto valgo, osteocondrosi, spondilosi e spondilolistesi, scoliosi e cifosi,
Generale Mnemonica Non richiesto L
369 3 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Alterazioni infiammatorie e tumorali
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la terapia delle alterazioni infiammatorie (osteomielite, artrite settica e tubercolosi osteoarticolare) e dei tumori ossei primitivi e delle affezioni ossee
Generale Mnemonica Non richiesto L
370 4 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Affezioni tendinee
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e lai terapia delle affezioni dei tendini e delle aponevrosi: tendinopatie, malattia di Dupuytren e dismetrie arti inferiori
Generale Mnemonica Non richiesto L
371 5 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Ernie discali e stenosi vertebrali
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la terapia delle lombalgie e lombo-sciatalgie da ernia discale e da stenosi vertebrale
Generale Mnemonica Non richiesto L
372 6 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Generalità sulle fratture
Descrivere l'eziopatogenesi, l'anatomia patologica, il quadro clinico, le complicanze delle fratture in generale e la fisiologia della osteogenesi riparativa delle fratture. Descrivere le generalità sulle terapie conservative e chirurgiche delle fratture: riduzione cruenta e incruenta, immobilizzazione, osteosintesi interna ed esterna arto superiore, dell'arto inferiore e del bacino e della colonna
Generale Mnemonica Non richiesto L
373 7 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Lussazioni e distorsioni
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia delle lussazioni (in particolare di spalla, gomito e anca) e delle distorsioni (in particolare di ginocchio e caviglia) e rachide cervicale
Generale Mnemonica Non richiesto L
374 8 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Lesioni tendinee e muscolari
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia delle lesioni tendinee e muscolari: in particolare dei tendini della mano, della cuffia dei rotatori e
Generale Mnemonica Non richiesto L

47
del tendine d'Achille
375 9 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica - materiali e metodi
Descrivere le generalità sugli interventi a cielo aperto (materiali, modalità di fissazione e influenze in Fisioterapia) e in artroscopia (diagnostica e terapeutica: vie d'accesso e influenze in Fisioterapia). Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso e le precauzioni per la riabilitazione correlate dell'intervento delle sostituzioni protesiche dell'anca, di osteotomia correttiva di femore, di osteosintesi interna ed esterna
Generale Mnemonica Non richiesto L
376 10 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso dell'intervento di sostituzione protesica del ginocchio, di osteotomia correttiva di tibia, di osteosintesi interna ed esterna per fratture di ginocchio e gamba, di ricostruzione dei legamenti
Generale Mnemonica Non richiesto L
377 11 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso dell'intervento di sostituzione protesica della caviglia, osteosintesi per fratture della caviglia e del piede, di tenoraffie del tendine d'Achille, di ricostruzione dei legamenti
Generale Mnemonica Non richiesto L
378 12 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso degli interventi di correzione delle dismetrie degli arti inferiori
Generale Mnemonica Non richiesto L
379 13 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso dell'intervento di sostituzione protesica della spalla, di osteosintesi per fratture di clavicola e omero, di acromion-plastica e di interventi sulla cuffia dei rotatori
Generale Mnemonica Non richiesto L
380 14 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso dell'intervento di sostituzione protesica del gomito, di osteosintesi per fratture di gomito e avambraccio
Generale Mnemonica Non richiesto L

48
381 15 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso dell'intervento di sostituzione protesica del polso, di artroplastica dell'articolazione trapezio-metacarpale, di osteosintesi per fratture di polso e di mano, di tenoraffie e tenolis
Generale Mnemonica Non richiesto L
382 16 Ortopedia e Traumatologia
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Chirurgia ortopedica e traumatologica
Descrivere le principali tecniche chirurgiche, le relative vie d'accesso degli interventi di osteosintesi per fratture di bacino, di stabilizzazione per fratture vertebrali e di risoluzione di ernie discali e stenosi vertebrali
Generale Mnemonica Non richiesto L
383 1 Fisiopatologia dell'apparato locomotore
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiopatologia delle articolazioni
Esporre le proprietà viscoelastoplastiche dei tessuti biologichi e la fisiopatologia delle retrazioni delle componenti viscoelastiche articolari e miofasciali
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
384 2 Fisiopatologia dell'apparato locomotore
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiopatologia muscolare
Descrivere le definizioni, la fisiopatologia e i principi di intervento riguardanti: la contrattura muscolare, lo spasmo muscolare, i trigger point, la miogelosi, le aderenze tra diversi tessuti
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
385 3 Fisiopatologia dell'apparato locomotore
Fisiopatologia dell'attività fisica e malattie dell'apparato locomotore
Fisiopatologia muscolare
Descrivere la definizione, la fisiopatologia e i principi di intervento riguardanti l'ipotrofia muscolare, il deficit di forza e di resistenza muscolare e i principi dell'allenamento della performance muscolare
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
386 1 Fisioterapia in ortopedia e traumatologia
Trattamento della persona
Fisioterapia
Costruire un programma di Fisioterapia per la prevenzione dell'osteoartrosi
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
387 2 Fisioterapia in ortopedia e traumatologia
Trattamento della persona
Fisioterapia
Descrivere e applicare le principali linee guida e protocolli nella rieducazione funzionale delle patologie ortopediche e traumatologiche del rachide
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
388 3 Fisioterapia in ortopedia e traumatologia
Trattamento della persona
Fisioterapia
Applicare le principali linee guida e protocolli nella rieducazione funzionale delle patologie ortopediche e traumatologiche dell'anca e del femore, del ginocchio e della gamba, della caviglia e del piede
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
389 4 Fisioterapia in ortopedia e traumatologia
Trattamento della persona
Fisioterapia
Applicare le principali linee guida e protocolli nella rieducazione funzionale delle patologie ortopediche e traumatologiche del cingolo scapolare e dell'omero, del gomito e dell'avambraccio, del polso e della mano
Particolareggiata Interpretativa Teorica P

49
390 1 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeurico
Descrivere le origini del massaggio, i presupposti teorici e basi neurofisiologiche, gli effetti meccanici d’azione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto P
391 2 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeurico
Descrivere le definizioni delle diverse tecniche di massaggio e i relativi effetti, indicazioni e controindicazioni assolute e relative, generali e specifiche di ogni tecnica e le zone di precauzione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
392 3 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeutico
Eseguire il trattamento del rachide lombare, posizionando la persona e applicando correttamente le manovre più adeguate
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
393 4 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeutico
Eseguire il trattamento del rachide cervicale posizionando la persona e applicando correttamente le manovre più adeguate
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
394 5 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeutico
Eseguire il trattamento degli arti inferiori, posizionando la persona e applicando correttamente le manovre più adeguate
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
395 6 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeutico
Eseguire il trattamento degli arti superiori posizionando la persona e applicando correttamente le manovre più adeguate
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
396 7 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio terapeutico
Descrivere la fisiopatologia delle cicatrizzazione cutanea e i principi generali di gestione degli esiti e pianificare la gestione degli esiti cicatriziali ed eseguire le manovre specifiche di trattamento delle cicatrici
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
397 8 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio connettivale reflessogeno
Elencare i principi generali delle diverse scuole di massaggio connettivale e la suddivisione dei dermatomeri
Generale Mnemonica Non richiesto P
398 9 Massoterapia Trattamento della persona
Massaggio connettivale reflessogeno
Eseguire la costruzione di base del massaggio connettivale secondo le diverse scuole e le varie costruzioni del dorso e degli arti
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
399 10 Massoterapia Trattamento della persona
Linfodrenaggio
Illustrare i fondamenti teorici del linfodrenaggio: linfa e circolazione linfatica, legge di Starling, generalità sull'esecuzione, effetti del linfodrenaggio, indicazioni e controindicazioni
Generale Mnemonica Non richiesto P
400 11 Massoterapia Trattamento della persona Linfodrenaggio
Eseguire le manovre di base del linfodrenaggio nel viso e nella parte anteriore del collo Eseguire le manovre di base del linfodrenaggio nell'arto superiore. Eseguire le manovre di base del linfodrenaggio nell'arto inferiore. Eseguire le manovre di base del linfodrenaggio nel tronco e nell'addome
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

50
401 1 Terapia fisica Trattamento della persona
Strumenti fisioterapici
Descrivere, attraverso la letteratura scientifica, effetti, indicazioni e controindicazioni di utilizzo delle principali energie fisiche utilizzate a scopo terapeutico (elettroterapia, fototerapia (UV), termoterapia, ultrasuonoterapia, laserterapia e magnetoterapia)
Particolareggiata Decisionale Non richiesto P
402 2 Terapia fisica Trattamento della persona
Metodologia fisioterapica
Leggere e interpretare la documentazione clinica, la diagnosi di patologia e la indicazione medica ai fini della somministrazione di energie fisiche a scopo terapeutico nell'ambito del programma fisioterapico
Particolareggiata Decisionale Pratica P
403 3 Terapia fisica Trattamento della persona
Trattamento fisioterapico
Applicare correttamente le più recenti apparecchiature di elettroterapia, fototerapia (UV), termoterapia, ultrasuonoterapia, laserterapia, magnetoterapia, elettroterapia analgesica (T.E.N.S.) elettroterapia funzionale
Particolareggiata Decisionale Pratica P
404 4 Terapia fisica Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione fisioterapica
Valutare in itinere e al termine del ciclo di trattamento il risultato terapeutico delle terapie fisiche applicate e riconoscere sulla persona eventuali effetti indesiderati/danni causati da un utilizzo ed applicazione incongrua
Particolareggiata Decisionale Pratica P
405 1 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Principi generali
Esporre le nozioni generali delle malattie reumatiche dell'apparato locomotore la classificazione delle principali malattie reumatiche ed i cenni generali sul loro trattamento farmacologico
Generale Mnemonica Non richiesto L
406 2 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Principi generali
Descrivere le principali procedure medico-diagnostiche: esami di laboratorio, indagini radiologiche, utilizzati nella valutazione delle patologie reumatiche
Generale Mnemonica Non richiesto L
407 3 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Principi generali
Differenziare le caratteristiche riparative dei tessuti molli nei vari stadi della flogosi e nelle condizioni post-traumatiche e post-chirurgiche
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
408 4 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Reumatismi acuti
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia del Reumatismo articolare acuto a localizzazione peri e para-articolare
Generale Interpretativa Non richiesto L
409 5 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Reumatismi cronici
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia Reumatismi infiammatori cronici dell'adulto e dell'Artrite reumatoide
Generale Interpretativa Non richiesto L

51
410 6 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Spondiloartriti
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia delle Spondiloartrite anchilosante dell'Artrite psoriasica, delle Artriti Reattive, del Morbo di Reiter, delle Enteroartriti
Generale Interpretativa Non richiesto L
411 7 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Connettiviti
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e cenni di terapia del Lupus eritematoso sistemico, della Sclerosi sistemica, della Dermatomiosite,della Connettivite mista, della Sindrome di Sjogren
Generale Interpretativa Non richiesto L
412 8 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Osteoartrosi
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la Fisioterapia nell'Osteoartrosi
Generale Interpretativa Non richiesto L
413 9 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Artriti da microcristalli
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la Fisioterapia Gotta e dell'Artrite da idrossiapatite
Generale Interpretativa Non richiesto L
414 10 Reumatologia Patologia sistematica integrata
Malattie dell'osso
Descrivere il quadro clinico, l'eziopatogenesi e la Fisioterapia dell'Osteoporosi e dell'Osteomalacia
Generale Interpretativa Non richiesto L
415 1 Medicina fisica riabilitativa in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione clinica in reumatologia
Descrivere ed eseguire la valutazione delle patologie reumatiche: anamnesi, esame obiettivo generale e distrettuale, valutazione clinica
Particolareggiata Interpretativa Teorico P
416 2 Medicina fisica riabilitativa in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione clinica in reumatologia
Riconoscere i comportamenti riferibili ai fattori psicosociali associati, che talora limitano il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi
Particolareggiata Interpretativa Teorico P
417 3 Medicina fisica riabilitativa in reumatologia
Trattamento della persona
indicazioni e controindicazioni in reumatologia
Identificare indicazioni, controindicazioni e modalità di applicazione di terapia fisica, terapia termale e terapie non convenzionali in reumatologia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
418 1 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Utilizzare le principali le scale di valutazione adottate in ambito reumatologico riguardanti: lo Stato psico-affettivo; la Qualità della vita Attività della vita quotidiana; la Disabilità funzionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
419 2 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Eseguire la valutazione differenziale del dolore reumatologico attraverso l'anamnesi e l'esame obiettivo ed utilizzando le opportune scale di misurazione. Eseguire le tecniche per l'approccio ai diversi tipi di dolore nelle diverse fasi e stadi delle malattie reumatiche
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
420 3 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione globale della persona con artrite reumatoide
Particolareggiata Decisionale Pratica P

52
421 4 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione globale della persona con spondililartropatie: spondilite anchilosante, artrite psoriasica e enteropatica
Particolareggiata Decisionale Pratica P
422 5 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione globale della persona con osteoartrosi, osteoporosi: primaria e secondaria
Particolareggiata Decisionale Pratica P
423 6 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione delle patologie legamentose e discali di interesse reumatologico del rachide cervicale, dorsale, lombare e sacrale e in generale per la valutazione funzionale della persona con lombalgia e lombosciatalgia
Particolareggiata Decisionale Pratica P
424 7 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione funzionale della persona con sclerodermia, lupus, fibromialgia, algodistrofia riflessa
Particolareggiata Decisionale Pratica P
425 8 Fisioterapia in reumatologia
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale in reumatologia
Esporre e applicare le procedure usate per la valutazione funzionale della persona con reumatismi extrarticolari e con patologie dei tendini e delle borse a livello dell'arto superiore e inferiore
Particolareggiata Decisionale Pratica P
426 9 Fisioterapia in reumatologia
Trattamento della persona
Trattamento fisioterapico in reumatologia
Descrivere i principi della relazione fisioterapista-persona nella gestione delle malattie reumatiche croniche, dell'educazione della persona con patologia reumatica, della sua autogestione e del coinvolgimento dei familiari
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
427 10 Fisioterapia in reumatologia
Trattamento della persona
Trattamento fisioterapico in reumatologia
Costruire un programma di economia gestuale e articolare e di prevenzione dei danni articolari nelle malattie reumatiche; utilizzo di ausili e/o di applicazioni di splint/ortesi nelle malattie reumatiche
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
428 11 Fisioterapia in reumatologia
Trattamento del persona
Trattamento fisioterapico in reumatologia
Costruire un programma di Fisioterapia in un gruppo in presenza di patologie reumatica e Descrivere i principi generali di prevenzione dell'osteoporosi
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
429 1 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire una valutazione funzionale differenziale della rigidità articolare e scegliere le tecniche di intervento più corrette
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
430 2 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire una valutazione funzionale differenziale l'ipotrofia muscolare, il deficit di forza e di resistenza muscolare
Particolareggiata Decisionale Autonoma P

53
431 3 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire la valutazione funzionale differenziale del dolore attraverso l'anamnesi e l'esame obiettivo ed utilizzando le opportune scale di misurazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
432 4 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire la valutazione delle alterazioni delle sensibilità da danno periferico utilizzando gli opportuni strumenti e scale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
433 5 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire la valutazione funzionale differenziale dei dismorfismi e delle deviazioni sui diversi piani
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
434 6 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire la valutazione funzionale differenziale dei compensi nella deambulazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
435 7 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione funzionale
Eseguire la valutazione funzionale differenziale dei compensi nella funzione prensile-manipolativa/non-manipolativa
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
436 8 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Trattamento della persona
Principi di trattamento
Eseguire le manovre di risoluzione della contrattura muscolare e di risoluzione delle aderenze cicatriziali
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
437 9 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Trattamento della persona
Principi di trattamento
Descrivere i principi dello stretching, del movimento passivo continuo e delle tecniche di inibizione neuromuscolare e di rilassamento generalizzato gli effetti, le indicazioni e controindicazioni e le modalità di applicazione dei diversi distretti
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
438 10 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Trattamento della persona
Fisioterapia
Eseguire le mobilizzazioni delle articolazioni periferiche dell'arto superiore, inferiore e del rachide
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
439 11 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Trattamento della persona Fisioterapia
Costruire un programma di Fisioterapia per il recupero dell'ipotrofia muscolare, il deficit di forza e di resistenza muscolare (allenamento)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
440 12 Fisioterapia nell'apparato locomotore
Trattamento della persona Fisioterapia
Costruire un programma di rieducazione funzionale del cammino comprensivo della ricostruzione della capacità di trasferimento del carico e la proposta degli ausili più opportuni
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
441 1 Ginecologia e ostetricia
Medicina della riproduzione e materno-infantile
La Gravidanza Descrivere i fenomeni gravidici locali e generali il monitoraggio longitudinale
Generale Mnemonica Non richiesto L
442 2 Ginecologia e ostetricia
Medicina della riproduzione e materno-infantile
La Gravidanza Descrivere motricità e sensorialità del feto
Generale Mnemonica Non richiesto L
443 3 Ginecologia e ostetricia
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Il Parto Descrivere i fenomeni dinamici e meccanici del parto
Generale Mnemonica Non richiesto L
444 4 Ginecologia e ostetricia
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Il Prolasso genitale e l'incontinenza urinaria
Descrivere l'etiopatogenesi, diagnosi e terapia del prolasso genitale e dell'incontinenza urinaria
Generale Mnemonica Non richiesto L

54
445 1 Fisioterapia in ginecologia e ostetricia
Trattamento della persona
Preparazione alla nascita
Descrivere i contenuti teorici e pratici dei corsi di preparazione alla nascita, compresa l'applicazione del training autogeno respiratorio
Particolareggiata Mnemonica Pratica P
446 2 Fisioterapia in ginecologia e ostetricia
Trattamento della persona
Preparazione alla nascita
Applicare il programma fisioterapico per la prevenzione della lombalgia e dell'incontinenza urinaria in gravidanza in seguito alle modificazioni dell'organismo materno
Particolareggiata Mnemonica Pratica P
447 1 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento della persona
Fisioterapia perineale
Descrivere eziologia e fisiopatologia dell’incontinenza uro-fecale su base neurologica e su base non neurologica, la classificazione delle incontinenze urinarie femminili con particolare riferimento alle situazioni del post-partum e menopausa
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
448 2 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento della persona
Fisioterapia perineale
Riconoscere il significato degli esami funzionali ai fini della definizione degli obiettivi di trattamento fisioterapico e della pianificazione del programma (urodinamica, test elettrofisiologici, defecografia, manometria ano-rettale)
Generale Decisionale Teorica P
449 3 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento della persona
Fisioterapia perineale
Leggere e interpretare la documentazione clinica, la diagnosi di patologia e la indicazione medica ai fini della somministrazione di energie fisiche a scopo terapeutico nell'ambito del programma fisioterapico
Particolareggiata Decisionale Teorica P
450 4 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento della persona
Fisioterapia perineale
Formulare una diagnosi funzionale fisioterapica/riabilitativa con l'identificazione di obiettivi di trattamento nel rispetto e integrazione con gli altri professionisti potenzialmente coinvolti nella presa in carico del soggetto incontinente (urologo, ostetrica) e spiegare come si effettua la valutazione dei risultati raggiunti anche tramite l'uso di adeguata testistica
Particolareggiata Decisionale Teorica P
451 5 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento del persona
Fisioterapia perineale
Descrivere i principi metodologici del trattamento fisioterapico della incontinenza urinaria e fecale non neurogene e di quelle neurogene
Generale Decisionale Teorica P
452 6 Fisioterapia nelle disabilità viscerali
Trattamento del persona
Fisioterapia perineale
Descrivere indicazioni e controindicazioni di utilizzo terapeutico di Biofeedback, F.E.S. e cinesiterapia del piano perineale
Generale Decisionale Teorica P
453 1 Pediatria generale e specialistica
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Prevenzione in pediatria
Descrivere la generalità degli screening neonatali e la loro applicazione
Generale Mnemonica Non richiesto L

55
454 2 Pediatria generale e specialistica
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Prevenzione in pediatria
Descrivere le principali malattie infettive e loro complicanze e la tipologia delle vaccinazioni e loro complicanze
Generale Mnemonica Non richiesto L
455 3 Pediatria generale e specialistica
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Neonatologia
Descrivere le principali complicanze del feto e del neonato: neurologiche, vascolari, cardio-respiratorie, muscolo-scheletriche, gastro-enteriche
Generale Interpretativa Non richiesto L
456 4 Pediatria generale e specialistica
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Malattie pediatriche
Descrivere etiopatogenesi, quadro clinico e terapia delle principali patologie pediatriche (emofilia, patologie dell'accrescimento, rachitismo carenziale)
Generale Mnemonica Non richiesto L
457 5 Pediatria generale e specialistica
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Fisiopatologia dell'apparato cardio-circolatorio e respiratorio
Descrivere le principali caratteristiche fisiopatologiche e di adattamento degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio del soggetto in età pediatrica, distinguendone le peculiarità rispetto al soggetto adulto
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
458 1 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Ontogenesi e Scale di sviluppo
Descrivere il significato dell'essere bambino, il suo sviluppo e la sua interpretazione nella storia: dal modello adultometrico, al modello statistico (principali scale di sviluppo: Gesell, Milani-Gidoni, Brazelton), al modello analitico
Generale Interpretativa Non richiesto P
459 2 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
La funzione
Descrivere il concetto di esigenza- funzione: motricità fetale, sviluppo delle funzioni per la sopravvivenza e per la vita di relazione
Generale Mnemonica Non richiesto P
460 3 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
La sopravvivenza, l'alimentazione, la difesa
Descrivere lo sviluppo delle competenze antigravitarie: riflessi, organizzatori di funzioni, traccianti,raddrizzamento e difesa (afferramento, paracaduti, equilibrio)
Particolareggiata Decisionale Non richiesto P
461 4 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
La postura
Descrivere lo sviluppo della postura seduta in rapporto allo sviluppo della manipolazione
Particolareggiata Decisionale Non richiesto P
462 5 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Lo spostamento orizzontale
Descrivere lo sviluppo delle capacità motorie per lo spostamento orizzontale, i passaggi posturali e il cammino
Particolareggiata Decisionale Non richiesto P
463 6 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Generalità
Elencare gli elementi che caratterizzano lo sviluppo dei sistemi: muscolo-scheletrico, cardio-polmonare, neurologico centrale e periferico, nella fascia 0-14 anni
Generale Mnemonica Non richiesto P
464 7 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Descrivere lo sviluppo psico-affettivo del bambino nei primi anni di vita: integrazione e interazione fra sviluppo cognitivo, motorio e relazionale
Generale Mnemonica Non richiesto P

56
465 8 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Descrivere la costruzione e lo sviluppo dell'identità: mondo esterno- mondo interno
Generale Mnemonica Non richiesto P
466 9 Sviluppo motorio
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Descrivere gli aspetti psicologici della comunicazione e dell'ascolto, linguaggio verbale e non - verbale. Il significato del gioco nella vita di relazione
Generale Mnemonica Non richiesto P
467 1 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrale infantile
Descrivere la definizione di paralisi cerebrale infantile: dal concetto di lesione al concetto di paralisi
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
468 2 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrale infantile
Descrivere la classificazione delle paralisi cerebrale infantili secondo diversi autori (Milani-Comparetti, Bobath, Bottos, Ferrari)
Generale Mnemonica Non richiesto L
469 3 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrali infantili
Riconoscere le diverse forme di paralisi cerebrale infantile: tetraplegia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
470 4 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrali infantili
Riconoscere le diverse forme di paralisi cerebrale infantile: diplegia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
471 5 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrali infantili
Riconoscere le diverse forme di paralisi cerebrale infantile: emiplegia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
472 6 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrali infantili
Riconoscere le diverse forme di paralisi cerebrale infantile: atassia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
473 7 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrali infantili
Riconoscere le diverse forme di paralisi cerebrale infantile: discinesia
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
474 8 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrale infantile
Descrivere l'analisi del movimento attraverso l'interpretazione del modulo, dello schema e della rappresentazione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
475 9 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrale infantile
Descrivere l'analisi percettiva dalle sensazioni, alle percezioni, al vissuto
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
476 10 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Paralisi cerebrale infantile
Descrivere l'aspetto intenzionale del movimento attraverso l'analisi di azione, scopo e motivazione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
477 11 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Disprassia
Descrivere gli elementi connotativi e le indicazioni terapeutiche della disprassia, dei disturbi di attenzione e della dislessia
Generale Mnemonica Non richiesto L
478 12 Neuropsichiatria infantile
Malattie neurologiche e degli organi di senso
Epilessia Riconoscere le principali forme di epilessia e il loro trattamento
Generale Mnemonica Non richiesto L

57
479 13 Neuropsichiatria infantile
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Disturbi dello sviluppo cognitivo
Descrivere i principi generali di classificazione, diagnosi e terapia del ritardo mentale e i disordini dello sviluppo cognitivo nelle diverse patologie pediatriche in Fisioterapia
Generale Mnemonica Non richiesto L
480 14 Neuropsichiatria infantile
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Distrofia muscolare
Descrivere la semeiotica e la prognosi della distrofia muscolare progressiva, delle miopatie congenite e atrofie muscolari spinali
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
481 15 Neuropsichiatria infantile
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Disordini pervasivi dello sviluppo
Descrivere gli elementi identificativi delle principali sindromi dismetaboliche, disgenetiche e malformative
Generale Interpretativa Non richiesto L
482 16 Neuropsichiatria infantile
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Spina bifida
Descrivere la clinica, il livello di lesione e le complicanze malformative della spina bifida
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
483 1 Medicina fisica riabilitativa in pediatria
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Nascita prematura ed intervento abilitativo
Riconoscere le problematiche cliniche più importanti del neonato prematuro: asfissia, patologia neurologica, patologia respiratoria
Generale Interpretativa Teorica L
484 2 Medicina fisica riabilitativa in pediatria
Medicina della riproduzione e materno-infantile
Nascita prematura ed intervento abilitativo
Descrivere l'esame neurologico e neuroevolutivo del neonato e i principi fondamentali dell'osservazione valutazione del bambino prematuro: l'approccio comportamentale e i General Movements (GM's Prechtl)
Particolareggiata Interpretativa Pratica L
485 3 Medicina fisica riabilitativa in pediatria
Progetto riabilitativo
Approccio integrato
Conoscere l' approccio olistico, il processo evolutivo, il concetto di abilitazione-riabilitazione, la centralità della famiglia.
Particolareggiata Interpretativa Pratica L
486 1 Fisioterapia in pediatria
Valutazione fisioterapica in ambito pediatrico
Fisioterapia in pediatria
Descrivere l'iter fisioterapico in ambito pediatrico: raccolta dati (valutazione e misurazione), elaborazione e condivisione del programma (diagnosi fisioterapica funzionale, obiettivi a breve, medio e lungo termine, piano di trattamento), intervento diretto e indiretto (procedure e tecniche fisioterapiche, setting, ausili e ortesi, modifiche adattive ambientali)
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
487 2 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia in pediatria
Descrivere la specificità fisioterapica in ambito pediatrico: procedure e tecniche fisioterapiche (intervento diretto e indiretto), predisposizione del setting, ausili e ortesi, modifiche adattive ambientali
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
488 3 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino Infant massage
Descrivere ed applicare le manovre specifiche dell’ “Infant Massage"
Particolareggiata Interpretativa Pratica P

58
489 4 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Nascita prematura ed intervento abilitativo
Illustrare i principi generali di "care" del prematuro in Terapia Intensiva Neonatale: cura posturale, ausili, facilitazioni delle funzioni posturomotorie, sensoriali e alimentari nel neonato
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
490 5 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Nascita prematura ed intervento abilitativo
Descrivere le modalità di presa in carico abilitativa e fisioterapica del prematuro e della sua famiglia
Particolareggiata Mnemonica Teorica P
491 6 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nelle malattie reumatologiche
Esporre i principi fondamentali di valutazione e trattamento fisioterapico dell'artrite cronica giovanile
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
492 7 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere la metodologia di trattamento delle disabilità infantili con danno neurologico e saper impostare un programma fisioterapico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
493 8 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere le facilitazioni fisioterapiche per la modificazione del modulo motorio, dello schema e della rappresentazione nelle disabilità con danno neurologico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
494 9 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere le facilitazioni fisioterapiche per la raccolta di informazioni percettive, per la loro elaborazione e successiva rappresentazione nelle disabilità con danno neurologico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
495 10 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere la modalità di costruzione di una seduta terapeutica (setting terapeutico) nelle disabilità con danno neurologico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
496 11 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere gli elementi fondamentali e specifici del trattamento fisioterapico volto alla modificazione della postura seduta e all'utilizzo di ausili nelle disabilità con danno neurologico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
497 12 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia delle disabilità infantili con danno neurologico
Descrivere gli strumenti specifici volti a modificare il cammino (fisioterapia, ortesi, chirurgia e tossina botulinica), il trattamento fisioterapico post- chirurgico (chirurgia funzionale) nelle disabilità con danno neurologico
Generale Interpretativa Pratica P
498 13 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nelle Paralisi cerebrali infantili
Descrivere i criteri di osservazione del bambino con paralisi cerebrale infantile: trattamento prognostico
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
499 14 Fisioterapia in pediatria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisioterapia nelle malattie neuromuscolari
Descrivere i principi fondamentali di valutazione (individuazione degli obiettivi) e gli strumenti dell'intervento fisioterapico nelle malattie neuromuscolari, in particolare nelle distrofie
Particolareggiata Interpretativa Pratica P

59
muscolari
500 15 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nei dismorfismi
Descrivere ed applicare il trattamento fisioterapico delle lesioni ostetriche del plesso brachiale
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
501 16 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nei dismorfismi
Descrivere ed applicare il trattamento fisioterapico del torcicollo posturale e del torcicollo miogeno congenito
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
502 17 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nei dismorfismi
Elencare le varie tipologie di piede torto congenito ed applicare il trattamento fisioterapico ed ortesico
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
503 18 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nei dismorfismi
Elencare i principi del trattamento fisioterapico generale nei dismorfismi (pre-trattamento, trattamento chirurgico, ortesico, sblocco e mobilizzazione, correzione, rieducazione funzionale e posturale) ed applicare il trattamento fisioterapico del dismorfismo toracico (scoliosi)
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
504 19 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nella Spina Bifida
Descrivere il trattamento chirurgico della spina bifida ed applicare il trattamento fisioterapico ed ortesico
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
505 20 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nelle patologie cardiopolmonari
Descrivere ed applicare la Fisioterapia nelle patologie cardiopolmonari del bambino con disabilità complesse (di tipo chirurgico, fibrosi cistica, asma, immunodeficienze) e conoscerne il percorso assistenziale dall'ospedale al territorio (assistenza domiciliare del bambino ventilato artificialmente)
Particolareggiata Interpretativa Teorico /Pratica
P
506 21 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nella oncoematologia in pediatria
Illustrare l'inquadramento dei tumori infantili ed applicarne il trattamento fisioterapico: interventi preventivi, interventi funzionali, interventi supportivi o di cura e interventi palliativi
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
507 22 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Fisioterapia nelle disabilità infantili
Descrivere l'utilizzo di ortesi (tutori e corsetti) e ausili in Fisioterapia in età evolutiva
Particolareggiata Interpretativa Teorico/ Pratica
P
508 23 Fisioterapia in pediatria
Trattamento del bambino
Intervento centrato sulla famiglia
Descrivere la definizione di "intervento centrato sulla famiglia", i principi e le caratteristiche, le evidenze scientifiche, le modalità di applicazione e di verifica, nonchè gli elementi rilevanti delle famiglie multiculturali, del bambino "straniero" e della capacità di adattamento del bambino
Particolareggiata Interpretativa Teorica P

60
509 1 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Sociologia
Descrivere il cambiamento degli assetti demografici in Italia e in UE. Descrivere i mutamenti in atto relativamente alla organizzazione familiare, alle associazioni di volontariato, in riferimento all'anziano con disabilità. Interpretare in maniera non "medicalizzata" i sintomi e i disturbi legati fisiologicamente allo invecchiamento
Generale Interpretativa Non richiesto L
510 2 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Programmazione sanitaria
Identificare quali sono i " bisogni " della persona anziana. Definire i concetti di speranza di vita e speranza di vita senza disabilità per conciliare le risorse disponibili con il costante aumento di domanda assistenziale. Conoscere la rete socio-assistenziale rivolta agli anziani
Generale Interpretativa Non richiesto L
511 3 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Programmazione sanitaria
Descrivere l'assetto organizzativo generale e definire il ruolo del Fisioterapista in ciascuna delle strutture facenti parte della rete socio-assistenziale: Lungodegenza riabilitativa, Residenza Sanitaria Assistenziale, Assistenza Domiciliare Integrata, Centro Diurno. Descrivere il ruolo e le modalità operative della Unità di valutazione Geriatrica
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
512 4 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Medicina legale
Descrivere le implicazioni giuridiche della applicazione di contenzione fisica negli anziani a rischio di danno per sè e per gli altri
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
513 5 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Prevenzione
Informare e applicare i principi generali di condotte favorenti il mantenimento della salute nell'anziano (prevenzione primaria e secondaria)
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
514 6 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Prevenzione
Stilare, per quanto di competenza, un programma individualizzato di Fisioterapia di tipo preventivo delle cadute nell'anziano
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
515 7 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Medicina di comunità
Descrivere gli elementi per gestire un corretto rapporto con il "medico di famiglia", quale figura cardine nella assistenza globale dell'anziano. Descrivere le peculiarià assistenziali-cliniche dell'anziano con pluripatologia e/o disabilità sia che viva a domicilio che in struttura assistenziale
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L

61
516 8 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Metodologia clinica
Descrivere il concetto di " valutazione multidimensionale geriatrica" e applicare gli strumenti di valutazione di competenza, coinvologendo gli O.S.S. e familiari su adeguati e personalizzati interventi di riattivazione
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
517 9 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi geriatriche
Descrivere quali sono le più frequenti malattie croniche che si riscontrano nell'anziano, come esse interferiscono fra loro e come l'insieme di poli-patologie possono determinare una riduzione delle attività, riconoscerne i sintomi più evidenti
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
518 10 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi geriatriche
Descrivere come: depressione, isolamento, carenza affettiva ed economica, disturbi del sonno, deficit sensitivi e sensoriali collegati all'invecchiamento, possano intervenire sulle abilità e la motivazione dell'anziano
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
519 11 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi geriatriche
Esporre il problema delle cadute e delle fratture nell'anziano come emergente problema di salute; descrivere il ruolo di osteoporosi e sincope nel loro determinarsi e definire, per quanto di competenza, opportune misure preventive (mobilità, prevenzione ambientale)
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
520 12 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi geriatriche
Descrivere le implicazione rispetto alla autonomia nelle A.D.L. che rendono incongruo l'intervento fisioterapico riguardo: i problemi nutrizionali dell'anziano e dell'anziano allettato, i problemi legati alla incontinenza, la partecipazione in famiglia e nel tessuto sociale, i problemi legati al deterioramento mentale, alle demenze e al delirio
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
521 13 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi geriatriche
Descrivere ed indicare gli effetti patologici di allettamento e immobilizzazione (prevenzione delle piaghe da decubito) per prevenirli attraverso indicazioni a famigliari e O.S.S.
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
522 14 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Grandi sindromi cliniche
Descrivere le particolari implicazioni cliniche legate all'età geriatrica di: cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, ipertensione arteriosa, diabete mellito, insufficienza renale e malattie reumatiche
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L

62
523 15 Geriatria
Clinica medica, chirurgia e cure primarie
Terapia e farmacologia
Descrivere i principi generali della geragogia e incoraggiare i soggetti anziani a tutelare il proprio stato di salute attraverso un adeguato comportamento. Descrivere gli effetti collaterali che possono interferire con il trattamento fisioterapico dei più comuni farmaci utilizzati in caso di decadimento psicofisico e nella sedazione
Generale Decisionale Non richiesto L
524 1 Fisioterapia in geriatria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione fisioterapica
Valutare in modo personalizzato, gli aspetti sociali, psicologici, motivazionali che fanno da substrato alla individuazione degli obiettivi di trattamento fisioterapico. Pianificare il programma di Fisioterapia dell'anziano a domicilio, in RSA, struttura protetta, lungodegenza
Particolareggiata Decisionale Teorica P
525 2 Fisioterapia in geriatria
Metodologie e tecniche diagnostiche
Valutazione fisioterapica
Valutare attraverso adeguate scale di valutazione eventuali menomazioni multiple compresa la valutazione delle funzioni cognitive, la limitazione delle attività con particolare riferimento a quelle modificabili attraverso l'intervento fisioterapico, valutare la restrizione della partecipazione alla vita sociale con particolare riferimento alla individuazione degli obiettivi di progetto
Particolareggiata Decisionale Teorica P
526 3 Fisioterapia in geriatria
Trattamento della persona
Trattamento fisioterapico
Descrivere il programma fisioterapico e l'utilizzo di adeguati setting ambientali di riferimento delle principali patologie tipiche dell'età geriatrica
Particolareggiata Decisionale Teorica P
527 4 Fisioterapia in geriatria
Trattamento della persona
Trattamento fisioterapico
Descrivere ortesi e ausili con particolare riferimento alla sicurezza e alla facilità di gestione autonoma dell'anziano
Particolareggiata Decisionale Teorica P
528 1 Fisioterapia speciale
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisiopatologia clinica delle ustioni
Descrivere la definizione di ustione (cenni di epidemiologia) e la classificazione delle ustioni ai fini di una corretta diagnosi fisioterapica in base alla: profondità, sede, causa (termica, elettrica, chimica)
Generale Mnemonica Teorica P
529 2 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisiopatologia clinica delle ustioni
Descrivere la malattia da ustione nei suoi effetti locali e sistemici, i principi della metodologia di cura in fase di emergenza dopo grave ustione (idratazione, asepsi, terapia antidolorifica) e di una corretta pianificazione dell'intervento fisioterapico precoce e le manifestazioni cliniche della MOF ai fini di una
Particolareggiata Interpretativa Teorica P

63
corretta pianificazione dell'intervento fisioterapico
530 3 Fisioterapia speciale
Metodologie e tecniche diagnostiche
Fisiopatologia clinica delle ustioni
Descrivere la fisiopatologia della cicatrice da ustione (rigenerazione cutanea e guarigione), i cheloidi e le cicatrici ipertrofiche e retraenti
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
531 4 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Chirurgia nelle ustioni
Descrivere i trattamenti chirurgici: finalità delle principali tecniche operatorie in relazione alla pianificazione dell'intervento fisioterapico sin dalla fase acuta (escarectomia, escarotomia, dermo-abrasione, innesti); la metodologia della assistenza post-operatoria con le specifiche indicazioni e controindicazioni al trattamento fisioterapico
Generale Interpretativa Teorica P
532 5 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle ustioni
Effettuare la valutazione fisioterapica della persona ustionata durante la fase di copertura e riepitelizzazione delle aree ustionate, nella fase di rimodellamento delle cicatrici e nella fase di stabilizzazione: individuazione dei problemi prioritari (espiratorio, immobilizzazione, da lesioni associate)
Particolareggiata Decisionale Teorica P
533 6 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle ustioni
Analizzare e interpretare i dati raccolti, anamnestici e clinici, ai fini della collaborazione con l'equipe nella definizione degli obiettivi della presa in carico riabilitativa in fase acuta, in fase post-acuta e in fase tardiva; selezionare le priorità e individuare gli obiettivi del programma fisioterapico durante la fase di copertura e riepitelizzazione delle aree ustionate, nella fase di rimodellamento delle cicatrici e nella fase di stabilizzazione
Particolareggiata Decisionale Teorica P
534 7 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle ustioni
Descrivere indicazioni e controindicazioni all'intervento fisioterapico (tenere conto della possibile instabilità clinica nella esecuzione del trattamento in fase acuta) e saper applicare adeguati interventi di Fisioterapia respiratoria e interventi di controllo posturale anche mediante adeguate ortesi
Particolareggiata Decisionale Teorica P

64
535 8 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nelle ustioni
Descrivere ed effettuare il bendaggio elastocompessivo per lo scollamento e rimodellamento della cicatrice in fase post acuta
Particolareggiata Decisionale Teorica P
536 9 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Descrivere i principi e le caratteristiche generali dell'allenamento: basi fisiopatologiche ed aspetti pratici
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
537 10 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Raccogliere ed interpretare i dati, identificare problemi e pianificare programmi di Fisioterapia in ambito sportivo
Particolareggiata Interpretativa Autonoma P
538 11 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Descrivere e utilizzare le principali scale di valutazione dei problemi e sintomi, al fine di applicare le principali tecniche fisioterapiche in ambito sportivo (PNF, pliometria, massaggio terapeutico, tecniche di mobilizzazione articolare, muscolare e terapia manuale)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
539 12 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Descrivere ed applicare il corretto intervento di primo soccorso nello sportivo in relazione a traumi muscolari, articolari ed ossei
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
540 13 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Descrivere i principi basilari, le tecniche, le indicazioni e le controindicazioni, i materiali impiegati nel bendaggio funzionale
Generale Mnemonica Teorica P
541 14 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Fisioterapia nello sport
Descrivere e applicare le modalità per effettuare un corretto bendaggio funzionale alle principali articolazioni: polso, ginocchio e caviglia
Particolareggiata Interpretativa Pratica P
542 15 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere i concetti generali della Medicina Ortopedica Cyriax: principi, valutazione, cenni di trattamento
Generale Mnemonica Non richiesto P
543 16 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Eseguire il massaggio trasverso profondo conoscendo le relative indicazioni e controindicazioni
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
544 17 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere i principi generali del Concetto Maitland e le procedure per l'applicazione delle tecniche di oscillazione graduale
Generale Interpretativa Non richiesto P
545 18 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere i principi generali del Concetto Kaltenborn-Evjenth e le procedure per l'applicazione delle tecniche di gioco articolare traslatorio prolungato
Generale Interpretativa Non richiesto P
546 19 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Descrivere i principi generali del Concetto Mulligan e le procedure per l'applicazione delle tecniche di mobilizzazione con movimento
Generale Interpretativa Non richiesto P

65
547 20 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Descrivere i principi generali del Concetto Butler e le procedure per l'applicazione delle tecniche di mobilizzazione del Sistema Nervoso Periferico
Generale Interpretativa Non richiesto P
548 21 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Descrivere i principi generali del Metodo McKenzie e in particolare la valutazione e il trattamento per il distretto lombare e cervicale
Generale Interpretativa Non richiesto P
549 22 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Illustrare le modalità di scelta delle tecniche per i diversi distretti e le diverse strutture lese, i concetti generali della costruzione di una seduta di terapia manuale, di inizio e di progressione di un trattamento
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
550 23 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Eseguire le mobilizzazioni delle articolazioni periferiche dell'arto superiore, dell'arto inferiore e del rachide
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
551 24 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Esporre i principi generali del Metodo Mézières e il concetto di catena muscolare: la classificazione e le basi teoriche dell'allungamento muscolare
Generale mnemonica Non richiesto P
552 25 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Descrivere i principi generali della Rieducazione Posturale Globale e la descrizione delle principali posture utilizzate
Generale Mnemonica Non richiesto P
553 26 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere i principi generali della Terapia Manuale secondo Bienfait
Generale Mnemonica Non richiesto P
554 27 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere il significato funzionale dell'anatomia, dell'istologia, e della fisiopatologia del tessuto fasciale, la definizione, gli obiettivi, le indicazioni e le controindicazioni e le diverse modalità di applicazione dei pompages
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto P
555 28 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona
Terapia manuale
Eseguire i pompages del rachide cervicale, degli scaleni, dello sternocleidomastoideo, del trapezio superiore, del rachide lombare
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
556 29 Fisioterapia speciale
Trattamento della persona Terapia manuale
Descrivere la definizione generale di osteopatia e di chiropratica, cenni sulla loro storia e sulle differenze con la terapia manuale
Generale Mnemonica Non richiesto P
557 1 Terapia occupazionale
Medicina e sanità pubblica
Generalità in terapia occupazionale
Descrivere la definizione e i principi teorici della terapia occupazionale ed il profilo professionale del terapista occupazionale
Generale Mnemonica Non richiesto P

66
558 2 Terapia occupazionale
Medicina e sanità pubblica
Concetti di autonomia e indipendenza-valutazione
Descrivere i concetti di autonomia e indipendenza ed in particolare i concetti di "acquisizione di abilità", "limitazione funzionale" e "stato di dipendenza". Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di valutazione per l'identificazione del potenziale residuo della persona, per la verifica dell'autonomia (scala F.I.M.) e per la programmazione di obiettivi di recupero funzionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
559 3 Terapia occupazionale
Medicina e sanità pubblica
Intervento riabilitativo
Descrivere le modalità di intervento e di attuazione dei programmi riabilitativi in terapia occupazionale in riferimento alle principali disabilità
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
560 4 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Attività della vita quotidiana
Applicare le modalità operative che favoriscono le abilità negli spostamenti, le abilità manuali, l'autonomia nelle A.D.L.
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
561 5 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Attività della vita quotidiana
Applicare le modalità operative che favoriscono l'autonomia respiratoria nello svezzamento dalla cannula tracheostomica e l'autonomia nutrizionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
562 6 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili, ortesi e protesi
Descrivere la definizione di "ausilio", "ortesi" e "protesi". Descrivere le ortesi di riposo, le ortesi di correzione, le ortesi funzionali statiche e dinamiche
Generale Mnemonica Teorica P
563 7 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili, ortesi e protesi
Illustrare la normativa vigente in materia di ausili (nomenclatore tariffario e prescrizioni I.N.A.I.L.) e il ruolo del Fisioterapista e del terapista occupazionale nell'informare, orientare e consigliare la persona disabile nella scelta e nell'adattamento dell'ausilio. Acquisire conoscenze in materia di accessibilità degli edifici pubblici e privati (progettare la normalità), di controllo ambientale (ISO 24), di mobilità e adattamenti per la casa o per altri edifici (ISO 18) e Descrivere gli ausili per la cura della casa (ISO 15)
Particolareggiata Decisionale Autonoma P
564 8 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili
Descrivere gli ausili per la cura e la protezione personale (ISO 09) comprese qualità, caratteristiche, materiali e criteri per la prevenzione delle piaghe da decubito (ISO 0333) ed istruirne la persona ed i familiari all'uso
Particolareggiata Interpretativa Teorica P

67
565 9 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili
Descrivere gli ausili per la mobilità personale (ISO 12), le caratteristiche tecniche della carrozzina e dei sistemi di postura (criteri che consentono di scegliere e personalizzare la carrozzina) e saper addestrare all'uso della carrozzina l'accompagnatore e l'utente
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
566 10 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili
Descrivere gli ausili per lo sport, per le attività del tempo libero (ISO 30) ed istruire la persona ed i familiari all'uso. Descrivere gli ausili per comunicazione
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
567 11 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Ausili
Descrivere i possibili adattamenti delle autovetture per persone disabili o parzialmente abili e la normativa per l'ottenimento della "patente speciale"
Particolareggiata Interpretativa Teorica P
568 12 Terapia occupazionale
Trattamento della persona
Protesi
Descrivere materiali e componenti delle protesi per gli arti superiori e inferiori e per le protesi speciali (energia corporea, bioelettriche ed ibride, sperimentali)
Generale Mnemonica Teorica P
569 1 Statistica medica Metodologia clinica Statistica descrittiva
Descrivere gli indicatori di sintesi numerica delle unità statistiche quantitative con particolare riguardo alla distribuzione gaussiana: media, deviazione standard, effettiva
Generale Mnemonica Non richiesto
570 2 Statistica medica Metodologia clinica
Statistica descrittiva
Descrivere le componenti del grafico: grafici semplici e complessi, istogrammi a colonne e a torta, diagramma a scatola o boxplot
Generale Mnemonica Non richiesto L
571 3 Statistica medica Metodologia clinica
La probabilità Descrivere le funzioni di probabilità per misure e per categorie
Generale Mnemonica Non richiesto L
572 4 Statistica medica Metodologia clinica
Statistica inferenziale
Descrivere il campione statistico e le tecniche di campionamento con randomizzazione semplice, stratificata, a cluster, per immissione successiva, in modo sistematico
Generale Mnemonica Non richiesto L
573 5 Statistica medica Metodologia clinica
Statistica inferenziale
Descrivere il procedimento di stima, la differenza tra misura e stima, l'errore standard della misura media campionaria e della frequenza media campionaria., la standardizzazione della normale sull'errore standard, limiti di confidenza e loro utilità per la valutazione evidence based
Generale Mnemonica Non richiesto L
574 6 Statistica medica Metodologia clinica
Statistica inferenziale
Descrivere la standardizzazione della normale sull'errore standard, i limiti di confidenza e la loro utilità per la valutazione
Generale Mnemonica Non richiesto L

68
evidence based delle conoscenze
575 1 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Principi generali
Descrivere la storia dell'Evidence based Medicine e i principi dell'Evidence based Practice in Fisioterapia. Descrivere le fonti di ricerca (primarie, secondarie, terziarie), i diversi tipi di studio clinico e la gerarchia delle evidenze. Descrivere il processo di revisione di una rivista indicizzata
Generale Interpretativa Pratica P
576 2 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Principi generali
Riconoscere obiettivi e modalità principali della ricerca quantitativa e qualitativa, le caratteristiche psicometriche di un sistema di misura in Fisioterapia (validità, affidabilità, riproducibilità)
Generale Interpretativa Pratica P
577 3 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Principi generali Saper formulare un quesito clinico di ricerca
Particolareggiata Decisionale Pratica P
578 4 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Ricerca bibliografica
Descrivere ed applicare strategie di ricerca utilizzando parole chiave, termini liberi, thesaurus me.s.h.,operatori booleani
Particolareggiata Decisionale Pratica P
579 5 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Ricerca bibliografica Descrivere e utilizzare banche dati specialistiche in riabilitazione/fisioterapia
Particolareggiata Decisionale Pratica P
580 6 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Ricerca bibliografica Interpretare l'organizzazione di un articolo originale
Particolareggiata Decisionale Pratica P
581 7 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Concetti Specifici Metodologia ricerca
Descrivere elementi di epidemiologia clinica e i concetti di efficacia e efficienza in riabilitazione
Generale Interpretativa Pratica P
582 8 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Concetti Specifici Metodologia ricerca
Scegliere e valutare criticamente le misure di esito in riabilitazione. Conoscere i principi di audit clinico e le metodiche di lavoro di gruppo Delphi, focus group
Particolareggiata Decisionale Pratica P
583 9 Metodologia della ricerca
Metodologia clinica
Concetti Specifici Metodologia ricerca
Valutare criticamente uno studio scientifico rispetto ad una sua validità interna (applicando strumenti specifici) e ad una sua validità esterna (identificando gli elementi che determinano la trasferibilità dei risultati nella propria pratica clinica)
Particolareggiata Decisionale Pratica P
584 1
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Le organizzazioni complesse
Descrivere i più recenti modelli interpretativi relativi alle organizzazioni complesse con particolare riferimento alle organizzazioni sanitarie. Descrivere le problematiche specifiche delle organizzazioni sanitarie come uno degli ambiente dove si realizza il processo riabilitativo
Generale Mnemonica Non richiesto L

69
585 2
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
L'organizzazione del lavoro
Descrivere alcuni aspetti di sociologia del lavoro: divisione del lavoro, occupazione, professione, competenza
Generale Mnemonica Non richiesto L
586 3
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
La multietnicità
Descrivere la visione della salute della malattia del malato e della disabilità nelle principali culture contemporanee. Accettare la possibile dimensione multietnica della sanità futura
Generale Interpretativa Non richiesto L
587 4
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Il cambiamento organizzativo
Dare valore al cambiamento organizzativo per garantire la qualità e la appropriatezza delle prestazioni sanitarie e riconoscerne l'impatto sul concetto di competenza che ne deriva, in costante evoluzione
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
588 5
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
Il cambiamento organizzativo
Riconoscere i recenti cambiamenti nell'ambito delle professioni sanitarie in seguito alle più recenti normative, soprattutto per quello che riguarda il cambiamento organizzativo e i rapporti fra professioni. Riconoscere i rischi insiti in una eccessiva proliferazione delle professioni/occupazioni sanitarie
Particolareggiata Interpretativa Non richiesto L
589 6
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
La famiglia come risorsa
Inquadrare i problemi della famiglia in presenza di un persona gravemente disabile che necessita un importante carico assistenziale: importanza del caregiver. Fornire alla famiglia conoscenze e competenze perché diventi promotrice di integrazione del familiare con limitata partecipazione a causa di disabilità
Particolareggiata Decisionale Non richiesto L
590 7
Sociologia dei processi economici e del lavoro
Medicina e sanità pubblica
La percezione di salute
Analizzare dal punto di vista psicosociologico il mito della salute perfetta e della prestanza fisica come elemento aggravante nella percezione delle ridotte abilità e dei risultati ottenibili con l'intervento riabilitativo. Analizzare il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nella diffusione di comportamenti con impatto anche sanitario e della percezione del valore/disvalore della disabilità
Generale Interpretativa Non richiesto L
591 1 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Organizzazione sanitaria
Acquisire le conoscenze riguardo alle competenze statali e regionali, alle organizzazioni e alle variabili organizzative
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
592 2 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Organizzazione sanitaria
Descrivere e interpretare il processo di aziendalizzazione del S.S.N. Leggere l’organizzazione sanitaria:
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L

70
l’esempio dell’analisi sistemica
593 3 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Organizzazione sanitaria
Descrivere il sistema di distribuzione delle responsabilità organizzative per fornire le basi di comprensione delle funzioni decisionali di pianificazione e di gestione dell’erogazione delle prestazioni assistenziali
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
594 4 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Organizzazione sanitaria
Acquisire conoscenze riguardo alle organizzazioni e alle variabili organizzative in sanità
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
595 5 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Organizzazione sanitaria
Illustrare le principali indicazioni contenute nel Piano Sanitario Nazionale ed il Piano Sanitario Regionale
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
596 6 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Riabilitazione
Descrivere le principali indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali sulla riabilitazione
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
597 7 Organizzazione sanitaria
Medicina e sanità pubblica
Riabilitazione e qualità
Acquisire conoscenze relative al miglioramento continuo delle azioni organizzative per il sistema del controllo della qualità aziendale
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
598 1 Diritto amministrativo
Medicina e sanità pubblica
Elementi di diritto pubblico
Descrivere la gerarchia delle fonti e produzione legislativa, le fonti normative portanti del sistema legislativo, le competenze e le gerarchie degli organi politici e amministrativi; l'organizzazione della pubblica amministrazione, i principi dell'attività amministrativa, attività amministrativa servizi pubblici
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
599 2 Diritto amministrativo
Medicina e sanità pubblica
Elementi di diritto pubblico
Elencare le norme di competenza inerenti al diritto del lavoro, le tipologie contrattuali i diritti e doveri del lavoratore (rapporto di pubblico impiego)
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
600 3 Diritto amministrativo
Medicina e sanità pubblica
Elementi di diritto pubblico
Descrivere elementi di diritto sanitario: il diritto alla salute nella costituzione; l'organizzazione del S.S.N. dalla 833/78 al d. lgs. 229/99; la riforma dei sistemi sanitari nei paesi europei
Particolareggiata Mnemonica Non richiesto L
601 1 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Condotta professionale
Prendere in carico la persona secondo l'etica e la deontologia professionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
602 2 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Condotta professionale
Tutelare la professione e la sua immagine
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

71
603 3 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Condotta professionale
Assicurare il proprio intervento nei limiti del proprio ambito professionale e/o della propria esperienza/competenza
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
604 4 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Condotta professionale
Mantenere un rapporto trasparente fisioterapista-persona -altri soggetti coinvolti
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
605 5 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Rispetto individualità e autonomia della persona
Recepire i bisogni di salute associati alle diverse culture e società
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
606 6 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Rispetto individualità e autonomia della persona
Dimostrare un approccio centrato sul persona e sui care-givers, in modo da coinvolgerli nelle decisioni terapeutiche e responsabilizzarli
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
607 7 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Integrità professionale e impegno al benessere della Persona
Accettare la responsabilità delle proprie azioni e decisioni
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
608 8 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Integrità professionale e impegno al benessere della Persona
Mantenere autonomia nella pratica in modo da tutelare il giudizio professionale e da rispettare gli interessi dell'utente
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
609 9 pratica professionale
Scienze umane
Responsabilità professionale: Integrità professionale e impegno al benessere della Persona
Fornire servizi/prestazioni che oltre all'efficacia garantiscano un efficiente uso delle risorse
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
610 10 pratica professionale
Medicina e sanità pubblica
Responsabilità professionale: Integrità professionale e impegno al benessere della Persona
Adottare criteri di trasparenza nel tariffario
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
611 11 pratica professionale
Medicina e sanità pubblica
Prevenzione primaria
Individuare i bisogni di salute e di prevenzione della disabilità
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
612 12 pratica professionale
Medicina e sanità pubblica
Prevenzione primaria e secondaria
Promuovere le azioni necessarie al mantenimento della salute e al superamento della disabilità
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

72
613 13 pratica professionale
Medicina e sanità pubblica
Prevenzione terziaria
Prevenire ulteriori aggravamenti della disabilità
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
614 14 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Identificazione necessità di cura e riabilitazione
Identificare i bisogni della Persona e della collettività in riferimento alla sfera fisica, psicologica e sociale, suscettibili di recupero funzionale
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
615 15 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Raccolta dati ed esame della persona
Raccogliere i dati relativi all'anamnesi fisiologica e patologica del persona, a strutture, funzioni, attività, partecipazione e ai fattori personali ed ambientali
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
616 16 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Raccolta dati ed esame della persona
Effettuare l'esame (fisico) del persona utilizzando strumenti validati, ove esistenti, e l'osservazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
617 17 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Valutazione
Analizzare ed elaborare i dati raccolti per determinare le abilità, capacità funzionali ed outcome (risultati) potenziali, rispettando le scelte dell'utente e/o famiglia/care givers
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
618 18 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Diagnosi fisioterapica
Formulare la diagnosi fisioterapica basandosi sulla valutazione dei dati raccolti secondo il modello di classificazione ICF
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
619 19 pratica professionale
Trattamento della persona
Cura e riabilitazione: Prognosi fisioterapica
Formulare la prognosi fisioterapica basandosi sulla diagnosi fisioterapica
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
620 20 pratica professionale
Trattamento della persona
Definizione e pianificazione dell'intervento
Facilitare il coinvolgimento del persona per il processo di presa di decisione informato
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
621 21 pratica professionale
Trattamento della persona
Definizione e pianificazione dell'intervento
Definire i relativi obiettivi terapeutici e priorità di intervento
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
622 22 pratica professionale
Trattamento della persona
Definizione e pianificazione dell'intervento
Partecipare alla stesura del progetto riabilitativo
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
623 23 pratica professionale
Trattamento della persona
Definizione e pianificazione dell'intervento
Pianificare il programma di trattamento fisioterapico Particolareggiata Decisionale Autonoma T
624 24 pratica professionale
Trattamento della persona
Effettuazione dell'intervento
Realizzare l'intervento riabilitativo (secondo gli obiettivi del progetto) ed il programma fisioterapico
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
625 25 pratica professionale
Trattamento della persona
Effettuazione dell'intervento
Effettuare eventuali modifiche in itinere (secondo i cambiamenti, risposte e stato del persona)
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
626 26 pratica professionale
Metodologie e tecniche diagnostiche
Effettuazione dell'intervento
Attuare interventi mirati alla valutazione, adattamento e, se appropriati, confezionamento e addestramento all'uso di ausili per la persona e per l'ambiente
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
627 27 pratica professionale
Trattamento della persona Verifica del risultato
Verificare, in collaborazione con il resto del team, l'efficacia complessiva del progetto riabilitativo
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

73
628 28 pratica professionale
Trattamento della persona
Verifica del risultato Verificare l'efficacia dell'intervento fisioterapico
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
629 29 pratica professionale
Trattamento della persona
Consulenza Fornire consulenza tecnico specifica
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
630 30 pratica professionale
Trattamento della persona
Educazione terapeutica
Formulare il progetto di educazione terapeutica per la persona assistita/care givers
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
631 31 pratica professionale
Trattamento della persona
Educazione terapeutica
Effettuare attività di educazione e mantenimento del benessere nel singolo/gruppo attraverso interventi specifici
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
632 32 pratica professionale
Trattamento della persona
Educazione terapeutica
Verificare l'appropriatezza del progetto di educazione terapeutica
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
633 33 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management
Applicare il problem-solving per prendere decisioni
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
634 34 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management
Rispondere ai cambiamenti in maniera flessibile
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
635 35 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management
Gestire il proprio lavoro nell'ambito del servizio in cui si opera
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
636 36 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management
Gestire la privacy in ambito sanitario
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
637 37 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management Gestire il rischio clinico Particolareggiata Decisionale Autonoma T
638 38 pratica professionale
Trattamento della persona
Gestione e management
Operare in qualità Particolareggiata Decisionale Autonoma T
639 39 pratica professionale
Trattamento del persona
Formazione e autoformazione
Formulare programmi di formazione
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
640 40 pratica professionale
Scienze del comportamento umano
Formazione e autoformazione
Riflettere sulla propria pratica professionale con lo scopo di apprendere dall'esperienza
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
641 41 pratica professionale
Scienze umane
Evidence based practice
Formulare una domanda, a partire da un problema clinico specifico del tirocinio, strutturata in modo tale da poter facilmente rispondervi
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
642 42 pratica professionale
Scienze umane
Evidence based practice
Identificare, a seguito della tipologia della domanda, il disegno di studio più apprropriato per rispondervi
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
643 43 pratica professionale
Scienze umane
Evidence based practice
Reperire le evidenze disponibili attraverso la consultazione di appropriate banche dati generali e specialistiche e i principali motori di ricerca
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
644 44 pratica professionale
Scienze umane
Evidence based practice
Leggere e analizzare criticamente la letteratura scientifica corrente
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
645 45 pratica professionale
Scienze umane
Evidence based practice
Valutare l'opportunità di modificare la propria pratica clinica, considerando i valori/necessità del persona e la propria esperienza
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
646 46 pratica professionale
Scienze umane
Comunicazione/relazione con pazienti/care givers
Stabilire e mantenere un'efficace comunicazione con il persona e/o altre figure di riferimento
Particolareggiata Decisionale Autonoma T

74
647 47 pratica professionale
Scienze umane
Comunicazione/relazione con pazienti/care givers
Comunicare in modo efficace con modalità scritta con pazienti, care- givers, altri soggetti interessati
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
648 48 pratica professionale
Scienze umane
Comunicazione/relazione con pazienti/care givers
Instaurare e gestire una relazione d'aiuto con pazienti e care-givers
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
649 49 pratica professionale
Scienze umane
Comunicazione interprofessionale/collaborazione
Comunicare efficacemente con altri professionisti sanitari e altri rilevanti professionisti per assicurare un efficace ed effciente servizio all'utente
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
650 50 pratica professionale
Scienze umane
Comunicazione interprofessionale/collaborazione
Collaborare con i componenti del gruppo/team nella pianificazione, coordinamento e valutazione delle prestazioni del persona
Particolareggiata Decisionale Autonoma T
651 51 pratica professionale
Scienze umane
Negoziazione/gestione conflitto
Negoziare obiettivi e gestire conflitti Particolareggiata Decisionale Autonoma T

75
INDICE ANALITICO
Anatomia palpatoria................................................................................................................. pag. 15 Anatomia umana................................................................................................................... .. pag. 13 Biochimica ............................................................................................................................... pag. 11 Bioingenieria.............................................................................................................................. pag. 20 Biologia applicata...................................................................................................................... pag. 12 Biomeccanica........................................................................................................................... pag. 21 Chinesiologia............................................................................................................................. pag. 21 Chirurgia generale.................................................................................................................. .. pag. 37 Diritto amministrativo................................................................................................................ pag. 70 Farmacologia.......................................................................................................................... pag. 34 Fisica applicata...................................................................................................................... pag. 19 Fisiologia umana.................................................................................................................... pag. 15 Fisiopatologia dell’apparato locomotore.................................................................................. .. pag. 48 Fisioterapia cardio-respiratoria.................................................................................................. pag. 38 Fisioterapia nell’apparato locomotore....................................................................................... pag. 52 Fisioterapia delle disabilità viscerali.......................................................................................... pag. 54 Fisioterapia in geriatria.............................................................................................................. pag. 62 Fisioterapia in ginecologia e ostetricia...................................................................................... pag. 54 Fisioterapia in neurologia......................................................................................................... pag. 42 Fisioterapia in ortopedia e traumatologia.................................................................................. pag. 48 Fisioterapia in pediatria............................................................................................................ pag. 57 Fisioterapia in reumatologia..................................................................................................... pag. 51 Fisioterapia speciale................................................................................................................. pag. 62 Genetica medica...................................................................................................................... pag. 32 Geriatria.................................................................................................................................... pag. 60 Ginecologia e ostetricia............................................................................................................. pag. 53 Igiene generale e applicata....................................................................................................... pag. 24 Informatica applicata.................................................................................................................. pag. 30 Informatica generale ................................................................................................................. pag.30 Lingua inglese........................................................................................................................... pag. 30 Malattie dell’apparato respiratorio............................................................................................. pag. 35 Malattie dell’apparato e cardiovascolare.................................................................................. pag.36 Istologia.................................................................................................................................... pag. 13 Massoterapia............................................................................................................................. pag. 49 Medicina del lavoro.................................................................................................................... pag. 27 Medicina fisica riabilitativa in neurologia................................................................................... pag. 42 Medicina fisica in pediatria........................................................................................................ pag.57 Medicina fisica in reumatologia.................................................................................................. pag. 51 Medicina legale......................................................................................................................... pag. 25 Medicina interna....................................................................................................................... pag. 35 Metodologia della ricerca......................................................................................................... pag. 68 Microbiologia............................................................................................................................ pag.32 Neurologia................................................................................................................................. pag. 40 Neuropsichiatria infantile............................................................................................................ pag. 56 Neuropsicologia......................................................................................................................... pag. 41 Oncologia medica...................................................................................................................... pag. 33 Organizzazione sanitaria........................................................................................................... pag. 69 Ortopedia e traumatologia......................................................................................................... pag. 46 Patologia generale.................................................................................................................... pag. 32 Pedagogia generale e sociale................................................................................................... pag. 28 Pediatria generale e specialistica............................................................................................. pag. 54 Pratica professionale................................................................................................................ pag. 70 Primo soccorso......................................................................................................................... pag. 27 Psicologia generale.................................................................................................................. pag. 29 Psicologia generale psicopedagogia........................................................................................ pag. 29 Psicologia clinica....................................................................................................................... pag. 29 Radioprotezione........................................................................................................................ pag. 20

76
Reumatologia.............................................................................................................................. pag. 50 Riabilitazione generale............................................................................................................... pag. 31 Scienze umane.......................................................................................................................... pag. 25 Sociologia dei processi economici e del lavoro......................................................................... pag. 68 Statistica medica....................................................................................................................... pag. 67 Sviluppo motorio........................................................................................................................ pag. 55 Terapia fisica............................................................................................................................. pag. 50 Terapia occupazionale.............................................................................................................. pag. 65

77
GLOSSARIO
GLOSSARIO stringa Definizione
A.D.L. 520
the things we normally do in daily living including any daily activity we perform for self-care (such as feeding ourselves, bathing, dressing, grooming), work, homemaking, and leisure/ le cose che normalmente svolgiamo nella vita quotidiana, tra cui attività relative alla cura di sé,al lavoro ed al tempo libero. http://en.wikipedia.org/wiki/Activities_of_daily_living
A.S.I.A. 345 scala di valutazione (impairment scale) :American Spinal Injury Association
AFFIDABILITÀ’ 141, 576
È la misura della probabilità che l'assieme (od il componente) considerato non si guasti (ovvero non presenti deviazioni dal comportamento descritto nella specifica) in un determinato lasso di tempo. Termine inglese di riferimento: Reliability http://it.wikipedia.org/wiki/Affidabilit%C3%A0
ALESSITIMIA 202
"non avere le parole per le emozioni". Un insieme di deficit della competenza emotiva ed emozionale, palesato dall'incapacità di mentalizzare, percepire, riconoscere le emozion. www.benessere.com/psicologia/emozioni
AUDIT CLINICO 582
strategia del Governo Clinico, è un processo ciclico di miglioramento degli aspetti tecnico-professionali della qualità delle cure; si basa sulla revisione sistematica della documentazione clinica. http://www.ospfe.it/index.phtml?id=1012
AUSILI 301
prodotto, strumento,attrezzatura o sistema tecnologico di produzione specializzata o di comune commercio, utilizzato da una persona disabile per prevenire, compensare, alleviare o eliminare una menomazione, disabilità o handicap”. Standard internazionale ISO 9999, approvato nel 1998 come normaeuropea EN ISO 9999 definisce ausilio http://www.alihandicap.org/download/v_ausili.pdf
CAREGIVERS 301
“care” corrisponde a” prendersi cura di”, il famigliare o persona di riferimento che svolge un ruolo attivo, prende in carico la “persona” fornendo assistenza informale è definito caregiver. Dizionario medico inglese-italiano, italiano-inglese di Lucchesi Mario,Editore: Cortina RaffaelloCollana: Dizionari. Medicina,Pagine: 1467
CELLE DI CARICO 113 Modelli di dinamometro, trasduttore di pressione, torsiometro, manometro digitale www.dseurope.it
DIAGNOSI FUNZIONALE
450
ragionamento clinico che fornisce le indicazioni sulle quali basare e decidere il programma terapeutico-riabilitativo e le sue modalità di applicazione. “Dall’autonomia alla diagnosi funzionale e differenziale del fisioterapista” Ft. Oscar Casonato http://www.siriscuola.it/pubb_autonomia.htm
DISABILITÀ MOTORIA COMPLESSA
280
limitazione o perdita,conseguente ad una menomazione,della capacità di compiere un’attività nel modo e nell’ampiezza considerati normali per un essere umano. La disabilità complessa, prevede un incremento della dependence e richiede un approccio multidisciplinare. Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
DISSONANZA COGNITIVA
186
situazione di complessa elaborazione cognitiva in cui credenze, nozioni, opinioni elicitate contemporaneamente nel soggetto in relazione ad un tema si trovano a contrastare funzionalmente tra loro; concetto introdotto da Leon Festinger nel 1957 in psicologia sociale, e in ambito clinico da Milton Erickson. Esempi ne sono la "dissonanza per incoerenza logica", la dissonanza con le tendenze del comportamento passato, la dissonanza relativa all’ambiente con cui l’individuo si trova ad interagire (dissonanza per costumi culturali.

78
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissonanza_cognitiva F.E.S. 452 Functional Electrical Stimulation
FONTI DI RICERCA (PRIMARIE, SECONDARIE E TERZIARIE)
575
Fonti testuali primarie – prove scritte di prima mano create nello stesso periodo storico da qualcuno che era presente (diari, corrispondenza e giornali), prodotte contemporaneamente agli eventi descritti. Fonti testuali secondarie – testi storici scritti basati sulle prove di fonti primarie (libro di storia basato su ciò che è scritto in un diario o negli articoli di un giornale). Fonti testuali terziarie – testi basati su fonti primarie e secondarie (enciclopedie e trattati). http://it.wikipedia.org/wiki/Fonte_testuale
GENERAL MOVEMENTS
484 Movimenti che coinvolgono tutto il corpo e che. Hanno una durata che varia da pochi secondi a molti minuti www,medicina-chirurgia.uniss.it …
Me.S.H. 578
MeSH ( Medical searching headings ) is the National Library of Medicine's controlled vocabulary thesaurus. It consists of sets of terms naming descriptors in a hierarchical structure that permits searching at various levels of specificity. http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/mesh.html
MIOGELOSI 384
Indurimento di una parte del muscolo, doloroso irrigidimento della muscolatura. Con il termine miogelosi si intende una patologia, anche grave, del tessuto muscolare,dovuta a stress eccessivi od a sollecitazioni non fisiologiche www.dizi.it
MOBBING 172
comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, etc.) perpetrati da parte di superiori e/o colleghi nei confronti di un lavoratore, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso; http://it.wikipedia.org/wiki/Mobbing
MOF 529 multi organ failure – sindrome da �iabilita tor multiorgano
O.S.S. 516 Operatori Socio-Sanitari
ORTESI
301, 427, 486, 497, 502, 507, 527, 534, 562, 563
dispositivo esterno utilizzato al fine di modificare le caratteristiche strutturali o funzionali dell' apparato neuro-muscolo-scheletrico Organizzazione Internazionale degli Standard
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation
360 Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive
PEDANE DI FORZA
113
Strumenti per posturografia, utilizzate dai riabilitatori per valutare eventuali deficit del tronco, anche per misurare le forze. Costituite da un tappeto di sensori piezoelettrici o al quarzo sollecitati dall’appoggio www.neuroequilibrio.it/Atassia%20cervicale.pdf
PLIOMETRIA 538
"esercizio pliometrico" - esercizio in cui la contrazione concentrica (cioè la contrazione in cui il muscolo si accorcia, come quello dell'avambraccio che porta verso la spalla un manubrio, mentre ricordiamo che è eccentrica la contrazione contraria in cui il muscolo si allunga, per esempio quando l'avambraccio allontana il manubrio dalla spalla) viene preceduta da uno stiramento dello stesso muscolo contratto. http://www.albanesi.it/Arearossa/Articoli/013pliom.htm
RETTANGOLO BIOMECCANICO
116
Composto dalla diagonale che è il vettore originale,dal segmento sull’asse delle ordinate che è il braccio della potenza,dal segmento sull’asse delle ascisse che è la quota chinesiologicamente efficace. Neurofisiologia del movimento-M.Marchetti,P.Pillastrini-P.C edizione 1997-pp58
RIPRODUCIBILITÀ 576 Proprietà della misura – Le scale di misura in riabilitazione- D.Bonaiuti-Società editrice universo

79
RIVISTA INDICIZZATA
575 La rivista è inserita nell'indice mondiale delle pubblicazioni scientifiche e pubblicare un articolo su di essa ha un indice di rilevanza (impact factor) proporzionale a quello della rivista.
RSA 524 Residenza sanitaria assistenziale
SCALE DI GRADING MUSCOLARE
135 Riferito alla Medical Research Council Scale
SETTING TERAPEUTICO
364, 495
il setting terapeutico è la disposizione di uno stabile contenitore mentale, relazionale e materiale atto a consentire e favorire il processo terapeutico http://www.psicologiaesalute.it/Neopsiche/24%20articoli/01%20IlSetting.htm
SOAP 292
Subjective, Objective Assessment Plan The Soggettivo, Oggettivo, Analisi, Piano un metodo impiegato dai professionisti sanitari per documentare in modo ordinato e possibilmente completo la raccolta dati e le valutazioni effettuate sulla singola persona per arrivare al programma di trattamento e ed eventuali cambiamenti dell’intervento. Weed LL. Medical records that guide and teach. N Engl J Med. 1968;278:593-9, 652-7..
STEREOFOTO- GRAMMETRIA
112 Fotogrammetria che si esegue per mezzo di fotografie stereoscopiche http://www.ipertesto.net/s/stereofotogrammetria_84838.html#
T.E.N.S. 403 Transcutaneous electrical nerve stimulation
THESAURUS 578
vocabolario di linguaggio di indicizzazione controllato, "normalizzando" i termini con cui vengono espressi i concetti nel linguaggio naturale e fornendo una guida preziosa alla gerarchia disciplinare. http://biblio.ing.unibo.it/pdf/brochure_compendex_settembre2005.pdf
UV 401, 403 Raggi ultra-violetti

80
SVILUPPI FUTURI
Nessun Core Curriculum è definitivo, pertanto anche questo documento avrà aggiornamenti e revisioni ogni 2 anni, che lo rendano sempre più leggibile e fruibile, con parti sempre più omogenee fra di loro ed uniformi. A questo scopo sarà auspicabile trasformare le stringhe in un insieme di dati in formato access e quindi in una banca dati.
BIBLIOGRAFIA
o AA.VV. Linee Guida per la Formazione del Fisioterapista – Core Competence. Casa
Editrice Masson, Milano, 2003
o Binetti l, Valente D. Tradizione e innovazione nella formazione Universitaria delle
professioni sanitarie: Il Core curriculum, dal core contens al core competence. Società
editrice Universo, Roma, 2003
o Bertozzi L, Bielli S, Costi S, Pillastrini P. Il Core Curriculum del Fisioterapista. Scienza
Riabilitativa, Vol. 7.1, Gennaio 2005, pag. 5-44 - CINAHL AN: 2009214965
o Core Curriculum per i Corsi di Laurea Specialistica in Medicina
http://www.presidentimedicina.unibo.it/sito_new
o Description of Physical Therapy W.C.P.T. - Declarations of Principle and Position
Statements Approved at the 13 th General Meeting of WCPT June 1995
o Gaddi A, Vettore l, Tommasi A. Il Core curriculum degli studi medici: proposta
metodologica per una sua prima revisione. Med.Chir. 22: 846-9, 2003
o Guilbert JJ, “Guida pedagogica per il personale sanitario”, ED. Dal Sud, Modugno (BA),
2002
o http://www.wcpt.org/
o Tommasi A, Gaddi A, Vettore l. Core curriculum degli studi medici. Med.Chir. 16: 566-
74, 2001
o Vettore l, Gaddi A, Tommasi A. La revisione del Core curriculum. Med.Chir. 29: 1103-
05, 2005
o Vettore L, Scandellari C. Come identificare le competenze essenziali per conseguire la
laurea in medicina? Una proposta di metodo. Med.Chir. 15: 518-26, 2000







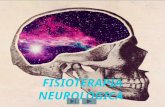



![Università degli studi di Catania - FISIOTERAPIA · Università degli studi di Catania - FISIOTERAPIA A.A. 2014-2015 CHIRURGIA - Q91 FISIOTERAPIA [Q81] Numero posti a concorso: 39](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5ae597ec7f8b9a29048c711d/universit-degli-studi-di-catania-degli-studi-di-catania-fisioterapia-aa-2014-2015.jpg)







