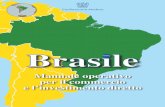Il "boom" economico
-
Upload
diego-deplano -
Category
Documents
-
view
482 -
download
0
description
Transcript of Il "boom" economico

Il boom economico
MANODOPERA A BASSO COSTO E PREZZI COMPETITIVI
I primi anni del dopoguerra per l’Italia furono caratterizzati da profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali. Il decollo economico ebbe luogo in un contesto in cui l’Italia apparteneva all’alleanza atlantica e la Dc aveva l’egemonia politica.
Il settore più interessato fu quello industriale, mentre quello agricolo era in costante calo. Se prima l’Italia era prevalentemente agricola, ora invece era forte della sua industrializzazione.
Sia le grandi imprese che le medie e piccole aziende si avvalsero di una vasta manodopera a basso costo, potendo indirizzare la produzione, ad un prezzo molto più basso e quindi competitivo, al mercato estero. La forza lavoro che garantì questa fase di grande sviluppo era prevalentemente emigrata dall’Italia meridionale.
Dopo la seconda metà degli anni 50 ci fu un’enorme migrazione di italiani del sud verso il nord.
IL DEGRADO DELL’AGRICOLTURA E LA SCOMPARSA DEI CONTADINI
L’agricoltura continuava a risentire di una distribuzione squilibrata della terra, problema che gli interventi di riforma agraria non riuscirono a colmare.
Non venne a crearsi una dinamica borghesia agraria ma piuttosto si rafforzarono le proprietà a conduzione familiare. Così andando le cose non vi era un ammodernamento delle tecniche e degli strumenti, poiché non se ne sentiva la necessità.
La Cassa del mezzogiorno erogava sovvenzioni pubbliche che si basavano su rapporti di favoritismi: i fondi erano distribuiti in cambio del favore politico; su questo intreccio si fondò il sistema di potere democristiano. Quest’agricoltura arretrata e protetta non era tuttavia in grado di assorbire l’offerta di manodopera proveniente dalle nuove generazioni, costrette quindi all’emigrazione. La “scomparsa dei contadini” fu un fenomeno che caratterizzò l’Italia centro-meridionale, comportando la scomparsa della mezzadria (che non poteva più sussistere in un contesto di internazionalizzazione dei mercati).
In definitiva, in Italia non si sviluppò quella media azienda agraria meccanizzata, anche a gestione familiare, che negli Stati Uniti e nel resto d’Europa garantiva la modernizzazione dell’agricoltura e la sua prosperità economica. L’Italia, necessariamente, divenne dipendente dall’estero per quanto riguarda l’importazione di materie prime. La questione meridionale andò aggravandosi sempre più, e con essa il divario tra nord (industriale) e sud (agricolo).
IL MIRACOLO ECONOMICO: I FATTORI DELLA CRESCITA
I risultati raggiunti dall’economia italiana fecero parlare di miracolo economico: i suoi tassi di crescita furono, almeno fino agli inizi dagli anni sessanta, tra i più elevati del mondo. Ciò portò a dei risultati: Turismo di massa, scolarizzazione, modernizzazione delle abitudini sociali e dei costumi, una maggiore parità dei sessi, una laicizzazione della società.
Il decollo industriale e il boom delle esportazioni dipesero da:
1. La liberalizzazione degli scambi, e quindi l’apertura dei mercati europei ai prodotti italiani.2. Una rapida modernizzazione dell’industria leggera (finalizzata alla produzione di massa e fondata sul fordismo) possibile anche
grazie ai fondi derivati dal piano Marshall. Il comparto propulsivo fu quello automobilistico, che, a causa dello scarso potere d’acquisto della popolazione, aveva un forte
indirizzo estero. Anche la produzione di elettrodomestici andava a gonfie vele: l’Italia fu il terzo produttore mondiale di frigoriferi ed il primo di
lavastoviglie. Anche l’industria edilizia fu un settore in ampia crescita, disordinata ed incontrollata, con gravi danni conseguenti per l’ambiente.
Sorgono nuovi poli industriali: la dislocazione industriale delle industrie si modificò, in quanto nacquero nuove imprese di dimensione più piccole accanto al tradizionale “triangolo” del nordovest.
L’INTERVENTO DELLO STATO
Un importante fattore che aiutò al compiersi del “miracolo economico” fu l’intervento dello stato: circa il 20% del prodotto interno lordo fu rappresentato da investimenti pubblici.
Con la nascita dell’Eni (Ente nazionale idrocarburi) si ebbe la fine della fase liberista. L’Eni assorbì l’Agip, gestiva i nuovi giacimenti di metano in val padana, potenziò le attività di estrazione e raffinazione, fornì alle imprese ed ai consumatori energia a basso costo. Gestita dal democristiano Enrico Mattei, si dotò di management e di tecnici d’alto livello e diversificò i settori d’investimento.
Contemporaneamente l’industria siderurgica fu totalmente ristrutturata con la creazione della Finmeccanica.
L’Iri estese il proprio controllo al settore cantieristico, siderurgico, alle compagnie di navigazione, all’elettricità e alla telefonia.
Nel 53 fu varata la legge con lo scopo di regolamentare la gestione dei fondi della Cassa per il Mezzogiorno per gli investimenti industriali, così un consistente flusso di finanziamenti fu indirizzato verso i poli di sviluppo (tra cui Cagliari). Tuttavia questi, a causa degli sprechi, della gestione clientelare dei fondi, del poco lavoro offerto, portarono ad una mancata ricaduta positiva sull’economia meridionale.
Lo stato creò il ministero delle Partecipazioni statali, al fine di coordinare le aziende possedute dalla mano pubblica.

I COSTI SOCIALI: LA CONDIZIONE OPERAIA E L’ARRETRATEZZA DELLA SOCIETÀ
La faccia negativa del miracolo economico fu:
Compressione dei diritti e delle libertà sindacali : Negli anni 50 molti lavoratori attivi nei sindacati subirono da parte degli imprenditori gravi discriminazioni.
Sprezzo della tutela e della sicurezza nel lavoro : il lavoro era reso duro, nocivo e pericoloso dai pesanti ritmi di lavoro e le scarse norme di sicurezza.
Lo sviluppo mostrava così le sue contraddizioni: l’occasione propizia del boom non fu sfruttata a dovere, aumentando gli squilibri storici dell’economia e della società italiana, che vedeva persone con un tenore di vita ottime e persone con uno scarso. Molte famiglie italiane in condizioni di arretratezza: impiegavano la maggior parte del loro reddito a soddisfare i bisogni primari, come l’alimentazione, comunque insufficiente.
Il modello di sviluppo teso a favorire i consumi privati danneggiò quelli pubblici (sanità, istruzione, servizi, ecc), che non costituirono quello strumento di redistribuzione dei redditi che in altri paesi europei si era accompagnato alla crescita economica.
MUTANO I RAPPORTI DI FORZA E RIPRENDE L’ATTIVITÀ SINDACALE
Per poter soddisfare la maggiore quantità di domanda era necessario aumentare le industrie, e con esse il personale addetto. I salari così videro un rialzo, dato che, soprattutto per le lavorazioni specialistiche, la manodopera a basso costo non era più possibile. Contemporaneamente i prezzi aumentarono, rendendo i prodotti italiani meno competitivi. Il vantaggio dell’industria italiana andava pian piano svanendo. Il rafforzamento della classe operaia, portò ad un invigorimento delle attività sindacali e le lotte di fabbrica. I primi esempi li abbiamo nel 1961 a Milano.
Gli anni del centrismo
L’EGEMONIA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA NELLO STATO E NELLA SOCIETÀ
Gli anni 50 furono caratterizzati dal consolidamento dell’egemonia della Democrazia cristiana, nello stato e nella società. L’assenza di ricambio politico comportò l’identificazione del partito di maggioranza relativa con lo stato. Le articolazioni della struttura istituzionale erano occupate da personale legato al principale partito di governo e ai suoi alleati. Una caratteristica della Dc era il suo interclassismo, che le permetteva di raccogliere larghi consensi in quasi tutte le regioni italiane e nei diversi ceti sociali. La base ideologica che fortifico la variegata base sociale cattolica fu l’anticomunismo e la difesa dei valori tradizionali. Importante fu il controllo esercitato sull’insegnamento scolastico grazie alla guida fino al 79 del ministero della Pubblica istruzione. Durante il boom economico vi fu una contraddizione della Dc:
Da una parte il richiamo ai valori cristiani come fondamento culturale Dall’altra parte l’ “americanizzazione” degli stili di vita.
La stessa società dei costumi e del benessere cominciò a minare le basi stesse del predominio della Dc. La modernizzazione, dunque, portava con sé conseguenze controverse per le stesse forze che la promuovevano e la guidavano.
LA CRISI DEL CENTRISMO
Tali contraddizioni portarono alla rottura della formula politica adottata da De Gasperi, il centrismo. Nello stesso partito di maggioranza, alla morte di De Gasperi, si aprì lo scontro tra corrente riformista (Fanfani e Gronchi) e quella moderata (Pella).
Al termine della prima legislatura (1953) emersero i limiti di queste difficoltà: le “leggi eccezionali” limitarono ulteriormente gli spazi di azione politica, proponendo una difesa dell’ “ordine pubblico” in funzione antisindacale. Questi erano segnali dell’indebolirsi della capacità egemonica delle forze moderate.
Alle elezioni del 53 la Dc ottenne il 42 % dei voti, non sufficiente a raggiungere il bonus previsto dalla “legge truffa” (dal 50% al 66%). Comunisti e socialisti non solo non furono emarginati, anzi accrebbero i loro consensi, così come la destra neofascista del Msi.
Le forti problematiche sociali rendevano sempre più necessario allargare le basi sociali del sistema politico:
Aumento della produttività e abbassamento dei salari; Aumento delle migrazioni interne;
Una parte della stessa Dc, quella riformista guidata da Fanfani, addirittura era orientata all’allargamento dell’area di governo al Psi. Il quadro centrista non era più in grado di esprimere e di rappresentare sul piano politico i processi di trasformazione che attraversavano la società italiana. La decisione presa nel maggio 1960 dal Msi di convocare il suo sesto congresso a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, spinse l'opposizione a scendere in piazza, repressa con violenza, con le conseguenti dimissioni di Tambroni.

LA SVOLTA DEL CENTROSINISTRA
Nella Dc si imposero le forze riformiste, ora guidate da Aldo Moro che lanciò la strategia del centrosinistra (inglobare il Psi ed escludere i tradizionali alleati moderati e conservatori). Le condizioni a sinistra furono poste dalla rottura del patto tra comunisti e socialisti. Il Psi aveva abbandonato ogni riferimento alla vecchia tradizione massimalista. I socialisti andavano maturando una propria collocazione politiche, che vedeva nella collaborazione con la Dc la possibilità di realizzare un ampio riformismo che incidesse nel disordinato e squilibrato sviluppo italiano. La linea del centrosinistra era sostenuta da:
I più dinamici gruppi privati (Fiat, Pirelli, Olivetti): Perché speravano che l’entrata al governo dei socialisti potesse portare alla pacificazione sociale nelle aziende.
Le più grandi aziende pubbliche (Eni, Iri).
Nel 1962 si formò il primo governo di centrosinistra, presieduto da Fanfari (alleanza tra Dc, Psdi, Pri e socialisti).
Gli anni sessantaFATTORI INTERNI E INTERNAZIONALI DELLA TRASFORMAZIONE POLITICA
L’evoluzione del sistema politico, con l’ingresso del Psi nell’area di governo, fu favorita da numerosi fattori internazionali.
Un profondo rinnovamento religioso promosso durante il pontificato di Giovanni XXIII con il concilio Vaticano II.
Vi erano inoltre ragioni interne:
1. Le profonde trasformazioni sociali intervenute in un periodo di intenso sviluppo economico.2. L’Italia si è conquistata un posto tra i paesi più industrializzati: i lavoratori divennero protagonisti della politica.3. Il ciclo di sviluppo andava rallentando, con l’inizio di un periodo di depressione. Molte aziende fallirono e molti furono licenziati.4. Per superare tali crisi gli imprenditori si mossero su due strade:
o Concentrazione delle industrie in pochi grandi gruppi: Le piccole e le medie imprese furono assorbite da altre più grandi. Tale fenomeno, oltre che nazionale, fu anche
internazionale. Società come Eni, Pirelli o Fiat parteciparono alla tendenza dell’economia internazionale a costruire società multinazionali.
o Meccanizzazione dei processi lavorativi: Gli industriali ammodernarono il processo produttivo introducendo nuove tecnologie e sistemi di lavoro.
5. Dal 1966 riprese l’espansione economica, dovendo far fronte all’internazionale diminuzione di domanda. Tale ripresa economica non significò per le classi lavoratrici maggior benessere:
o Disoccupazione elevata.o I salari restarono stazionari.
6. Nel Mezzogiorno gli investimenti effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno non produssero i risultati sperati.o Nel sud furono installate industrie (siderurgiche e chimiche) che non assorbivano molta forza lavoro.o L’emigrazione rimaneva ancora l’unica soluzione per i lavoratori del sud.
PROGETTI, REALIZZAZIONI E LIMITI DEL CENTRO SINISTRA
Progetti: Il programma economico del nuovo governo di centro sinistra sottolineava la necessità di un’ampia programmazione dell’intervento dello stato nell’economia, al fine di:
o Utilizzare le risorse pubbliche per “riforme correttive” che riequilibrassero le storture dello sviluppo italiano.o Realizzare una redistribuzione del reddito e sanare le situazioni sociali e territoriali di arretratezza. o Creare servizi sociali efficienti nel campo dell’istruzione, della sanità e altri settori pubblici.
Il Psi richiedeva per dare il suo appoggio:o La creazione dell’ente Regione;o La riforma della scuola media: Fu unificata e l’obbligo scolastico fu elevato a 14 anni. o La nazionalizzazione dell’energia elettrica: Le industrie elettriche vennero nazionalizzate con la creazione dell’Enel, che
avrebbe garantito la programmazione delle risorse energetiche e la loro distribuzione a prezzi controllati. Le resistenze al nuovo governo furono forti soprattutto dal Psi. Molti progetti mancarono, tra cui la riforma tributaria che indusse
imprenditori e gruppi finanziari al blocco degli investimenti ed alla loro protezione da eventuali tasse con l’esportazione degli stessi. Ciò genero una spirale di regresso che portò alla crisi del governo Fanfani, sostituito da successivi di Moro che però promettevano tanto ma poco realizzavano.
Nel 1964 sorsero preoccupanti tentativi reazionari. Ad esempio il “piano solo” approntato da Giovanni De Lorenzo.

Le lotte operaie e la contestazione studentesca
LE CONTRADDIZIONE DELLA MODERNIZZAZIONE E I MOVIMENTI DI CONTESTAZIONE
Il malessere sociale determinò la ripresa delle lotte operaie. Agitazioni sindacali, lotta per le pensioni, fermate improvvise del lavoro erano tappe di un movimento di lotta nelle fabbriche senza precedenti. Famoso lo sciopero di 200 milioni di ore al fine di avere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro. Si coniugava la critica dell’organizzazione del lavoro imposto dal sistema di fabbrica con esigenze egualitarie in campo salariale. Lo scoppio di tale protesta fu parallelo ad una avviata dagli studenti.
Aumento della popolazione scolastica (determinato dalla riforma della scuola media) che non riusciva ad essere accolta decentemente dalle strutture scolastiche ancora obsolete.
Per questo nacquero le prime proteste studentesche, in primo luogo una richiesta di democratizzazione del sistema scolastico, ancora legato a sistemi classisti finalizzati al favoreggiamento delle gerarchie sociali. Lo stesso accadde nelle università, dove nel 1968 il numero degli studenti era raddoppiato. La protesta fu innescata a danno del ministro della Pubblica istruzione Luigi Gui, ritenuto inadeguato ad affrontare la gravità dei problemi che la scuola doveva affrontare.
La “contestazione” si trasformò in un rifiuto generalizzato dei modelli economici e culturali della civiltà capitalistica.
INSTABILITÀ E RIFORME: VERSO NUOVI ORIENTAMENTI POLITICI E CULTURALI
Tali rivolte, contrariamente agli altri paesi, perdurarono fino al 1975 circa, con delle conseguenze:
Generale orientamento a sinistra del paese; Drammatica trama del terrorismo; Innovativo ciclo di riforme che intendevano soddisfare le richieste della società:
o Furono varate le Regioni;o La legge attrattiva per i referendum;o Riforma delle pensioni;o Riforma fiscale;o La legge sull’equo canone, o La riforma sanitaria;o La riforma della Rai;o Fu approvato lo “statuto dei lavoratori”;o Fu introdotto il divorzio;o Il nuovo diritto di famiglia;o L’abolizione dei manicomi;o La legge sull’interruzione di gravidanza.
I risultati ottenuti con i referendum erano spia di una progressiva avanzata delle forze politiche della sinistra, con una conseguente riduzione dell’adesione alla Dc. Finalmente, anche in Italia, fu retta da un sistema politico capace di consentire l’alternanza tra i diversi partiti alla guida del governo. Questa trasformazione sarà bloccata dalla crisi che nascerà in seguito all’emergere del terrorismo di sinistra.
In seguito al ciclo di lotte sindacali dell’autunno caldo, inizio un periodo in cui il terrorismo di destra, al fine di determinare nel paese una svolta reazionaria e destabilizzare la penisola italiana nell’importantissimo bacino strategico del Mediterraneo, diede il via ad un ciclo di attentati.
La passività dello stato davanti a questo fenomeno, fece si che esso si potessi esprimere in tutta la sua violenza. In questo contesto ebbe inizio una nuova crisi economica mondiale, che segno la fine di un’epoca nella storia del Novecento.