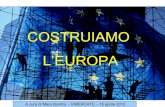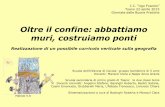I RIFIUTI UN PROBLEMA DA AFFRONTARE - compost.it · d) una volta non era così ... costruiamo i...
Transcript of I RIFIUTI UN PROBLEMA DA AFFRONTARE - compost.it · d) una volta non era così ... costruiamo i...
I RIFIUTIUN PROBLEMA
DA AFFRONTARE
Parte III percorsi didattici
e le schede operative
M
EDIE
E
S
UPERIORI
P E R L A G E S T I O N E D E I R I F I U T I L A V O R I A M O I N C O M U N E
CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
Carta riciclata trattata senza impiego di cloro
This document was created with FrameMaker 4.0.2
1
Presentazione
La proposta educativa si articola in cinque percorsi,ognuno relativo ad un aspetto del problema rifiuti.
I materiali sono da considerare come un repertorio di«idee e suggerimenti». Coerentemente con quanto espressonel capitolo II, parte prima: «L’Educazione Ambientale e lefasi del progetto», i percorsi non si configurano comesequenza obbligante di Unità Didattiche, ognuna struttu-rata per prerequisiti, obiettivi, attività e verifiche. Offronoproposte e attività utilizzabili come «mattoni» di un per-corso originale, che ogni insegnante deve adeguare al pro-prio contesto locale (la classe, la realtà territoriale, ecc.).Per questa ragione, spesso i collegamenti con le disciplinenon sono resi espliciti. Ogni attività può suggerire, sulpiano curriculare, ad insegnanti con competenze discipli-nari diverse numerosi ed originali approcci e retroazioni.
Tale metodologia è valida per tutte le classi; le attivitàproposte, pur non presentando differenze significative, unavolta collocate nel proprio contesto scolastico ed ambien-tale, risulteranno assolutamente originali. È stata sceltaquesta strada perché il progetto educativo non è assimila-bile ad un progetto ingegneristico o alla catena di montag-gio. È piuttosto un progetto parziale, con ipotesi dipartenza e obiettivi generali, che va affrontato con lanecessaria «flessibilità» per consentire all’insegnante dimodificare il percorso «in itinere», laddove emergesseronuove domande, opportunità di approfondimento, spuntipeculiari.
Pertanto, le attività suggerite, che in alcuni casi svi-luppano una sequenza, in altri sono o complementari o inalternativa, lasciano ai docenti il compito di strutturarepercorsi calibrati opportunamente, in relazione ai varilivelli di scolarità degli studenti, alle specificità dell’ambitourbano e territoriale di appartenenza, alle proprie compe-tenze.
I Percorsi comunque costituiscono un quadro di rife-rimento coerente, che si sviluppa, attraverso cicli ricorrentidi produzione di immaginario, costruzione di conoscenza,lavoro sul campo, lungo alcune direttrici:
◆
dal vicino al lontano, dal locale al globale;
◆
dall’immaginario soggettivo al coinvolgimento collet-tivo;
◆
dal comune alla capacità di cogliere le complessità;
◆
da una visione parziale e segmentata dei problemi allavisione dell’ambiente come sistema di relazioni;
◆
dalla trasmissione di informazioni ad una ricerca da svi-luppare insieme;
◆
dal capire all’agire, dalle conoscenze all’azione per lariqualificazione dell’ambiente.
Le attività sono introdotte, talvolta, da note di presen-tazione che ne giustificano l’inserimento nel contesto glo-bale della proposta didattica, per facilitare la ricostruzionedel percorso logico e metodologico complessivo. Ogni atti-vità è, comunque, presentata con una descrizione più omeno analitica della parte operativa e delle possibili oppor-tunità didattiche e formative ad essa connesse ed è corre-data da schede operative.
■
Percorso 1
Il rifiuto questo sconosciuto.
Ovvero l’approccio al problema.
■
Percorso 2
La natura ricicla, e l’uomo?
I rifiuti come esempio di cicli «aperti».
■
Percorso 3
La pattumiera: alla ricerca del prima e del poi.
La ricerca sul campo nell’ambiente «vicino» per capire iproblemi globali.
■
Percorso 4
Giochiamo con i rifiuti.
Come il rifiuto diventa risorsa… «divertente».
■
Percorso 5
L’ambiente è anche mio, e…
La responsabilità è anche nostra, facciamo qualcosa.
This document was created with FrameMaker 4.0.2
P
RESENTAZIONE
2
Obiettivi Generali
Obiettivi Generali Fasi del Progetto
Rilevare le preconoscenze e le rappresentazioni mentali degli allievi per analizzare le nozioni ac-quisite nel tempo e/o attraverso i media.
I Fase - La ricerca delle motivazioni e l’approccio al problema
Individuare le interazioni esistenti tra la propria azione quotidiana, sia biologica che sociale, e la questione rifiuti.
I Fase - La ricerca delle motivazioni e l’approccio al problemaIII Fase - Il lavoro sul campo
Studiare attraverso le discipline i vari aspetti dei rifiuti: storico, linguistico, economico, sociale ecc.
II Fase - La conoscenza del problema
Analizzare e comprendere il ciclo naturale e saper fare un confronto tra questo e il ciclo antropico.
II Fase - La conoscenza del problema
Studiare la tipologia dei rifiuti, il loro destino at-tuale e il loro impatto sull’ambiente.
II Fase - La conoscenza del problema III Fase - Il lavoro sul campo
Imparare a collegare la problematica dei rifiuti con quelle del verde, dell’acqua, dell’aria…
II Fase - La conoscenza del problema
Conoscere il sistema della raccolta, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti più comuni.
II Fase - La conoscenza del problemaIII Fase - Il lavoro sul campo
Acquisire la capacità di raccogliere dati, di fare progetti, relativamente alla problematica dei ri-fiuti.
III Fase - Il lavoro sul campo
Acquisire la capacità di elaborare i dati al fine di formulare proposte, fornire soluzioni.
IV Fase - L’elaborazione dei dati, il prodotto e la comunicazione
Saper fare proposte, progetti ed esprimere le pro-prie opinioni sulla problematica dei rifiuti.
IV Fase - L’elaborazione dei dati, il prodotto e la comunicazione
P
RESENTAZIONE
3
Piano di lavoro
Percorso Temi e concetti Attività
1
Il rifiuto questo sconosciuto
La percezione e l’approccio al pro-blema
a) rappresentazioni mentali degli allievi
b) approccio percettivo al proble-ma rifiuti
c) definizione del problema rifiuti
◆
Cosa ti fa venire in mente laparola rifiuto?
◆
Un rifiuto, una storia…
◆
Invento una storia
◆
C’era una volta…
◆
A caccia di… rifiuti
◆
Una rete di… rifiuti
2
La natura ricicla, e l’uomo?
I rifiuti come esempio di «cicli aperti» creati dall’uomo
a) usa e getta e riciclo, l’importan-za del fattore tempo
b) biodegradabilità e non soloc) tra rifiuto e risparmiod) il limite delle risorse
◆
Riciclo, riuso e abbandono
◆
I tempi dell’usa e getta
◆
I concetti da non buttare
◆
Intatto o… deteriorato
◆
Concetti alla… moviola
◆
Da cicale a… formiche
◆
Tutti per uno o… ognuno persé?
3
La pattumiera: alla ricerca del prima e del poi
La ricerca sul campo nell’ambien-te vicino per capire i problemi
globali
a) tra artificiale e naturaleb) gli atteggiamenti degli altri: ieri
ed oggic) gli imballaggid) una volta non era cosìe) dal locale al globalef) tra responsabilità e conflitti
◆
Il sentiero artificiale
◆
Non lo butto perché…
◆
Il tesoro di famiglia
◆
Necessario o… voluttuario
◆
Quanto… imballaggio
◆
Caro nonno… I rifiuti del pas-sato
◆
Cibi… in pattumiera
◆
Il poi… della pattumiera
◆
Il gioco di ruolo
4
Giochiamo con i rifiuti
Per cambiare atteggiamento im-pariamo a giocare
con i rifiuti
a) il gioco di scopertab) costruiamo i nostri giochi con i
rifiutic) dal gioco alla denuncia
◆
Scopriamo le storie del cor-tile… (o strada, o piazza)
◆
Caccia ai proprietari
◆
Costruiamo la ludoteca
5
L’ambienteè anche mio, e…
La responsabilità è anche nostra, facciamo qualcosa
a) per l’ambiente faccio… iob) ho capito ed allora… consiglioc) coinvolgere per convincere
◆
Ronde ecologiche
◆
Un bosco di… carta
◆
Carta riciclata in proprio
◆
Anche per riutilizzare e rici-clare ci vuole arte
◆
Operazione strada pulita
◆
Ecomuseo di strada
◆
Consigli ecologici per gli acquisti
◆
Giornata dell’imballaggio inutile
◆
Facciamo il compost
4
Percorso 1Il rifiuto, questo sconosciuto
Premessa
I ragazzi vivono in mezzo al “problema rifiuti”: è faciledistinguerlo come tale? Per quale motivo dovrebbero occu-parsi del problema rifiuti? Qual è la molla che fa scattare la«voglia di cambiare» una situazione che è propria dellaquotidianità e dell'esperienza dei nostri allievi e che nonincide direttamente sui loro bisogni e sul loro immediatointeresse?
Sono queste le domande che il docente si trovadavanti all'inizio di un percorso di Educazione Ambientalesui rifiuti.
Come rispondere ? Quali strategie utilizzare nell'attivitàdidattica per cambiare i comportamenti su un tema tantoscottante quanto poco percepibile da ragazzi della scuoladell'obbligo e del biennio delle superiori?
Per questo è importante dedicare un primo momentodel percorso didattico al censimento, alla definizione e alladiscussione delle preconoscenze e delle rappresentazionimentali degli allievi a proposito del tema-problema scelto.L'alunno non è mai «tabula rasa», perché possiede conce-zioni e sistemi autonomi di pensiero che, derivano dal
«mondo» in cui è vissuto e dalle esperienze fatte. Un'ampiaindagine sulla situazione di partenza (non solo cognitivama anche affettiva ed emozionale) consentirà al docente di«calibrare» il suo piano di lavoro e scegliere i percorsi e gliinterventi didattici il più possibile «vicini» alla sensibilità eal vissuto dei propri allievi favorendone così la motiva-zione e la voglia di «cambiamento».
Gli interventi didattici da proporre sono molti, noi neproponiamo alcuni che ci sembrano i più interessanti edadatti per affrontare la tematica dei rifiuti. Le attività espo-ste qui di seguito non costituiscono una sequenza obbli-gante. Sta al docente scegliere quella che più si adatta allivello della classe e al suo contesto ambientale. Tutterispondono alla stessa esigenza di avviare il lavoro rile-vando l'immaginario presente in classe per poter indi-viduare e definire il problema dal punto di vista degliallievi. Ovviamente le diverse attività si possono tra lorointrecciare e completare a seconda delle esigenze deldocente.
Per meglio evidenziare il livello scolare delle varie atti-vità abbiamo utilizzato i seguenti simboli:
Scuolamedia “E. Fermi”Andria (BA)
I
L
RIFIUTO
,
QUESTO
SCONOSCIUTO
P
ERCORSO
1
5
M
Scuole Medie
S
Scuole Superiori
Attività
M S
Cosa ti fa venire in mente la parola rifiuto?
Un'attività sulle rappresentazioni mentali e le pre-conoscenze legate al rifiuto (Cap. II - parte prima par. 2.2)può cominciare con una semplice domanda:
«Cosa ti fa venire in mente la parola rifiuto?»
alla qualerisulterà evidente, anche agli allievi, che non esiste la«risposta esatta». Nell'ambito della classe si farà compilarela
scheda operativa n.1
(pag. 9) raccogliendo su un cartel-lone o sulla lavagna idee, definizioni e percezioni indivi-duali raggruppate secondo categorie (aspetti negativi easpetti positivi, definizioni, espressione di emozioni, perce-zioni ecc.). Lo scopo dell'attività è quello di «accendere ladiscussione» e scoprire inaspettati luoghi comuni. Si puòipotizzare che le definizioni più comuni riguardino adesempio, un'idea di rifiuto come qualcosa di «brutto, peri-coloso, da allontanare ecc.». Interessante anche mettere aconfronto le idee dei ragazzi su due parole come
AMBIENTE
e
RIFIUTI
per evidenziare l’idea che laprima ha una connotazione positiva e la seconda negativa.Sarà interessante verificare quale idea, percezione, defini-zione condivisa si realizzerà al termine dell'attività, nonchéla ricostruzione che i ragazzi faranno della stessa (meta-discussione): un punto di partenza per «aprire» il problemaed individuare o, quanto meno giustificare, piste di cono-scenza ed attività successive per la seconda fase del pro-getto. I risultati di questa prima attività che ci vengonodall’Istituto Tecnico «Sen. O. Jannuzzi» - Andria (BA)sono riportati nei grafici, a pag. 6.
M S
Un rifiuto, una storia…
Un'altra attività che può mettere in evidenza l'espe-rienza dei ragazzi può essere proposta invitandoli ad indi-viduare un rifiuto all'interno della classe e a ricostruirne,attraverso un fumetto e/o un racconto, quelle che pensanosiano state le trasformazioni a partire dalla sua originecome oggetto.
In questa occasione gli insegnanti, oltre a raccogliereinformazioni su preconoscenze e rappresentazioni mentali,potranno cogliere le opportunità per le varie discipline,trattando quegli argomenti che i ragazzi avranno necessitàdi conoscere ed approfondire. Ad esempio potranno emer-gere incertezze cognitive connesse con l'approvvigiona-mento delle materie prime, le loro trasformazioni, ladistribuzione delle merci, l'energia relativa a tali processi(fonti, consumi, sprechi ecc.). Ma il racconto può essereanche preso dal libro di storia ed allora diventa «La storia
dei contenitori metallici» come quella che perviene dallaScuola Media «Padalino» di Fano, riportata qui sotto.
M
Invento una storia
Rilevare l'immaginario degli studenti facendo levasulla loro voglia di raccontare, di creare storie fantastichediventa un'attività molto utile ed interessante per iniziareil lavoro conoscitivo su termini e concetti che sono in rela-zione alla parola rifiuto. Nell'attività viene proposta unastoria che ha un inizio ma non ha né uno sviluppo né unafine: queste sono lasciate alla creatività degli studenti.
Si presenta la
scheda operativa n. 2
(pag. 10) e silascia compilare dagli studenti. Al termine dell'attivitàattraverso il confronto tra i vari elaborati si raccoglierannoinformazioni su preconoscenze e rappresentazioni mentali.Queste costituiranno un’opportunità di lavoro per lediverse aree disciplinari che tratteranno gli argomenti evi-denziati nei racconti e potranno costruire un glossario ter-minologico legato alla parola rifiuti.
La Storia dei contenitori metallici
1795
Napoleone offrì 12000 Franchi di premio a colui ocoloro che avessero trovato un modo di preservare ilcibo per le sue armate.
1810
Il premio fu vinto da Nicolas Appert che applicò la ste-rilizzazione ai cibi.
1880
In Inghilterra viene installata la prima linea automaticaper la produzione di barattoli.
1930
Produttori europei sviluppano i contenitori perbevande in forma di bottiglia, chiusi con tappi acorona.
1935
In Inghilterra si vende per la prima volta birra in lattinedi questo tipo.
1963
Un americano Ernie Fraze inventa il sistema «EasyOpen» letteralmente apertura facilitata con linguetta astrappo.
1964
Si producono i primi contenitori in due pezzi e con essisi introduce il concetto di tutto alluminio.
E la storia continua…!
P
ERCORSO
1 I
L
RIFIUTO
,
QUESTO
SCONOSCIUTO
6
M S C’era una volta…
Seguendo il sentiero della fantasia, che i ragazzi cono-scono bene, si può chiedere di inventare favole e/o dram-matizzazioni che abbiano come protagonisti i rifiuti nelloro rapporto con il resto del mondo; a titolo di esempio(per la Scuola Media Inferiore) nella scheda operativa n.3 (pag.11) riportiamo una favola che può essere ancheletta ed analizzata dai ragazzi prima dell'attività proposta.Il docente di discipline umanistiche potrà cogliere l'oppor-tunità di far analizzare un testo o «brani» scelti doveemerga, nella storia, nelle descrizioni, nei personaggi, ilproblema dei rifiuti.
Anche la lettura di un quadro potrà essere una buonaopportunità didattica per affrontare e riconoscere il pro-blema dei rifiuti. Da una Scuola Media è pervenuta unafavola un po’… «rimata». Ve la proponiamo qui di seguito.
Il Rifiuto EroeC'era una volta un bel bosco con alberi sani e rigogliosi.
Tutto era tranquillo ma, un brutto giorno, arrivarono degliuomini con la faccia losca. Erano su di un camion, tiraronofuori un pesante sacco, lo aprirono e c'era… una motosega.Purtroppo un albero fu tagliato. Fu estratta la cellulosa, conquesta furono prodotti dei fogli e infine dei quaderni. Questiultimi giunsero in un negozio e furono acquistati dai bam-bini che andavano a scuola. Due di questi erano Simona eCristiano. Alla fine dell'anno scolastico i quaderni erano
finiti; Simona uscì e buttò il suo in un contenitore per il rici-claggio della carta. Cristiano, invece, lo buttò nel comune sac-chetto della spazzatura. Il primo quaderno finì in un centroper il riciclaggio, il secondo in una discarica. Dal quaderno diSimona fu prodotto un blocco di carta riciclata.
Il quaderno di Cristiano trovatosi in una discarica, dopoun viaggetto, disse:
«Ma che posto è questo?Sogno o son desto?C’è una puzza micidialeche al naso mi fa male!»Si accorse allora che molti altri rifiuti come lui erano
nella discarica:«Sveglia ragazzi!Oh, ma siete pazzi?Ve ne state qui senza reagire,ma volete vivere o morire?»… … I rifiuti decisero allora, di fare una rivoluzione. Si
misero tutti in fila indiana e cominciarono a camminare: laloro meta era il contenitore per il riciclaggio della carta.
Mentre camminavano cantavano:«Mille pericoli abbiamo superato,e molti ostacoli abbiamo schivato.Noi siamo dei rifiutiche voglion esser riciclatiper questo lotteremoe così sopravviveremo!»E con coraggio, sfidando il traffico della città, arrivarono
I.T.I.S. «Sen. O. Jannuzzi» - Andria (BA)
Rifiuti tossici
Estinzione flora e fauna
Raccolta diff. e riciclo
Malattie
Inquinamento aria
Sporcizia
Raccolta differenziata
Sentire negativo
Cassonetto
Inquinamento
Che cosa ti viene in mente pensando alla parola
rifiuti
?
Immaginario collettivo
Vissuto individuale
21,5%43,8%
10,8%
6,2%
17,7%
24,1%
11,2%
19,8%
18,1%26,7%
I
L
RIFIUTO
,
QUESTO
SCONOSCIUTO
P
ERCORSO
1
7
al contenitore e ci entrarono. Dopo poco tempo erano già deifogli di carta riciclata, proprio come quelli su cui sto… scri-vendo.
(Scuola Media «E. Porcu» di Quartu S. Elena)
M
A caccia di… rifiuti
Molte volte il problema dei rifiuti non è percepitodagli allievi come non lo è dagli adulti. L'attività ha loscopo di stimolare i ragazzi a riconoscere i rifiuti come pro-blematica ambientale che ci riguarda.
L'attività consiste in un'uscita libera, ossia «
senzaconsegne»
, nella zona intorno alla scuola, precedente-mente scelta dall'insegnante che già ne conosce le caratteri-stiche dal punto di vista dei rifiuti (nella zona ci sonomolti cestini, ci sono i cassonetti della raccolta differen-ziata, c’è un parco non molto pulito ecc.). Ritornati inclasse si fa scrivere ai ragazzi che cosa li ha particolarmentecolpiti durante l'uscita.
Al termine di questa fase occorre nuovamente com-piere lo stesso percorso della prima uscita, ma questa volta«
con la consegna»
di rilevare i «segni» dei rifiuti, ossiatutto ciò che è rifiuto e/o tutto quello che con esso è colle-gato.
Rientrati a scuola si confrontano le rilevazioni dellaprima uscita con quelle della seconda segnalando
gliaspetti positivi e quelli negativi e confrontando ciò chesi è visto prima con ciò che si è visto dopo
. Le varieosservazioni comporranno un cartellone comune che evi-denzierà la «realtà» della zona rispetto al problema deirifiuti, nei suoi aspetti positivi e negativi.
M S
Una rete di… rifiuti
Dopo la ricognizione sull'immaginario e le precono-scenze dei ragazzi sarà possibile avvicinarsi al tema rifiutidal loro punto di vista, cercando di individuare un pro-blema, connesso alla tematica dei rifiuti, che è presente nelterritorio o che li coinvolge nella vita quotidiana. Per avvi-cinarsi allo studio del problema scelto si può organizzarel'attività in aula per gruppi di 8-10 ragazzi. Si individua unaspetto del problema rifiuti presente nella realtà territorialedei ragazzi (discarica abusiva nelle vicinanze della scuola,area verde urbana degradata da rifiuti, ecc.) e tanti ele-menti biotici ed abiotici, connessi al tema prescelto, quantisono i partecipanti (ad es.: alberi, animali vari, terreno,operatore ecologico, vari tipi di rifiuti, cassonetto, ecc.).Gli elementi possono essere scelti dall'insegnante o,meglio, censiti dagli studenti attraverso le attività comequelle prima descritte («Cosa ti fa venire in mente la parolarifiuto» e/o «Caccia ai… rifiuti»). Il ruolo di ciascun parte-cipante viene trascritto su un foglio (100x70 cm) che,posto sul tavolo, sia visibile a tutti i componenti di ciascungruppo disposti in cerchio attorno ad esso. A ciascun
gruppo viene quindi consegnato un gomitolo di lana (ospago, o nastro colorato) ed un pennarello. Al via del con-duttore un partecipante comincia l'attività: trattiene uncapo del filo di lana, passa il gomitolo ad un altro parteci-pante al quale, secondo lui, si sente «legato» ed esplicita larelazione ipotizzata, in forma di frase di senso compiuto. Ilpartecipante così «contattato» trattiene il filo e passa ilgomitolo ad un altro, esplicitando anch'egli una relazione.Il gioco continua fino a realizzare «una rete di relazioni».La discussione successiva è facilitata se, mentre si gioca, larete e le relazioni vengono trascritte e lasciate come «trac-cia» sul foglio posto sul tavolo. Terminato il gioco, infatti,si invitano i «portavoce» dei gruppi ad illustrare le traccerisultanti e ad esprimere le loro prime impressioni; even-tuali integrazioni potranno essere offerte dai componentidei vari gruppi. Si chiederà poi di illustrare i «significati»dell'attività realizzata. La lettura dell'immagine prodottadall'intreccio del filo di lana sul cartellone è immediata,tutti individuano: «il reticolo, l'intreccio… la rete» for-mata dalle relazioni che legano i vari elementi presi in con-siderazione, e quindi, l'ambiente, insieme di fattori viventie non, come rete-sistema di relazioni. Da qui nasce lariflessione che tra gli elementi di un ecosistema in rela-zione tra loro, ve ne sono alcuni più spesso coinvolti, altrimeno, relazioni più scontate ed altre meno, elementi più omeno riconoscibili come parti significative del sistemaindagato. Vi sono quindi punti «caldi» in cui la rete è piùfitta: forse ci troviamo di fronte al cosiddetto «
fattorelimitante»
dell'ecosistema… e pertanto si potrà chiedere«
Cosa accadrebbe nella rete realizzata se venisse a man-care la specie x o venisse inquinata l'acqua o il ter-reno…?»
. La domanda, e la discussione successiva,consentirà di chiarire l’intuizione dell’interdipendenza tra ivari fattori di un ecosistema e come l'intervento distruttivosu di un elemento possa indurre modificazioni irreversibilisu tutto il sistema. Si potrà inoltre mostrare che anche tragli elementi non direttamente legati si può riconoscerequalche relazione, rileggendo la rete complessiva delle rela-zioni, (il sistema che si è costruito), in cui quegli elementisono collocati. A volte ci si sforza di trovare relazioni menoevidenti per coinvolgere un giocatore «dimenticato»; que-sto si verifica perché i ragazzi spesso scelgono l'elemento acui relazionarsi a seconda del rapporto di simpatia di chi lorappresenta. È evidente che altre riflessioni che potrannoemergere, riguarderanno prevalentemente i diversi «tipi» direlazioni. Relazioni cognitive («le buste di plastica degra-dano il prato, le deiezioni degli animali concimano il ter-reno») oppure valoriali («i ragazzi non rispettano glialberi… »). È quindi possibile una lettura dei valori che siesplicitano nei vari momenti dell'attività: nella scelta deglielementi che «entrano in gioco», nella scelta dell'elementocon cui ci si mette in relazione, nella relazione espressa tradue elementi. Quest'ultima, infatti, può essere a varilivelli: dall'espressione di un legame «fisico», di letturaimmediata, a quella di un legame logico, emotivo, divalori. Se poi a giocare con gli stessi elementi dell'ecosi-
P
ERCORSO
1 I
L
RIFIUTO
,
QUESTO
SCONOSCIUTO
8
stema sono più gruppi distinti, si possono alla fine con-frontare le due «reti» prodotte e riflettere su come la letturadi una situazione reale sia condizionata dai punti di vistadi chi partecipa al gioco, per cui anche nella ricostruzionedelle relazioni entra in gioco la soggettività. L'attività sidimostra efficace anche nell'ambito della costruzione diconoscenze (scheda operativa n. 4 pag. 14). Essa si prestasia all'indagine di preconoscenze e di rappresentazionicontaminate dall’immaginazione (costituendo, pertanto,una buona alternativa, alle attività prima descritte) sia
come strumento di verifica durante le varie fasi di un pro-getto per accertare l'acquisizione cognitiva delle relazioniesistenti negli ecosistemi: è ovviamente adattabile in varicontesti didattici.
A livello formativo questo gioco può contribuire araggiungere la consapevolezza che gli studenti fanno partedi un sistema in cui sono in relazione con tutti gli altri ele-menti e che quindi non possono ignorare le conseguenzeche i comportamenti umani, non «compatibili», possonoavere sull'ambiente.
MS S
CHEDA
1 P
ERCORSO
1
9
MS
Scheda 1Che cosa ti fa venire in mente?
Indica almeno otto parole o frasi, o immagini che ti vengono in mente pensando alla parola scritta dentro il cerchio:
AMBIENTE
RIFIUTI
P
ERCORSO
1 M S
CHEDA
2
10
M
Scheda 2Se arrivassero gli extraterrestri
Alcuni extraterrestri, che non sanno niente del Pianeta Terra, atterrano di notte in una discarica di rifiuti:
❑
Immagina la loro relazione sul Pianeta Terra o disegna l’avvenimento utilizzando una tecnica a tua scelta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
❑
Che tipo di rifiuti secondo te raccoglierebbero come campione da portare sul loro Pianeta? Elencali
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
M S
CHEDA
3 P
ERCORSO
1
M
Scheda 3C’era una volta…
Leggi attentamente e analizza la seguente fiaba:
❑
Il Paese Delle Cose Che Succedono
C’era una volta un Paese molto lontano da qui, che sichiamava Paese Delle Cose Che Succedono.
Questo Paese veramente c’è ancora, ma sono successealcune cose che l’hanno messo nei guai. Tanto tempo fa eraun Paese felice: era situato in una Valle verde e ridente,percorsa da un Torrente dalle acque chiare e piene di pesci.I bambini ed i ragazzi del Paese andavano in tutte le sta-gioni a giocare sui Prati, che costeggiavano le rive del Tor-rente.
C’erano molti animali, nei Prati come nel vicinoBosco, e gli uomini consideravano gli animali come altriabitanti della Valle, con uguali diritti e doveri.
Il Bosco, fitto di antichi alberi, si arrampicava fin sullependici dell’alta Montagna che sovrastava la Valle, e cheincuteva agli uomini timore e reverenza. Il Paese era pic-colo e molto grazioso: le case di legno e pietra eranocurate, con i fiori alle finestre, le strade erano pulite, i bam-bini giocavano nelle vie e nelle piazze, i vecchietti si sede-vano a prendere il sole. Nelle giornate d’estate i rumoriprovenienti dalle case e dalle botteghe degli artigiani simescolavano allo scrosciare del torrente e allo stormiredelle foglie. Si vedeva insomma che chi abitava in quelPaese faceva molta attenzione a starci bene, ed avevarispetto di se stesso, degli altri e in fondo anche del Paese.
Era un Paese felice, ma non dobbiamo farci ideestrane: anche qui la gente moriva, anche se per fortunaquasi solo da vecchi; c’erano le malattie, i temporali, gliincendi, l’inverno era lungo e freddo, il lavoro faticoso. Atutti questi problemi gli abitanti cercavano insieme lerisposte: non c’era indifferenza, anche nelle difficoltà nonci si sentiva soli, e tutti si sforzavano di trovare per tuttisoluzioni contro il freddo, la fatica, le malattie, il buio e lescomodità. Nel Paese abitava anche un vecchio saggio
Mago, che si chiamava Alarico: per tutta la sua lunga vitasi era occupato con passione ed attenzione di tutto quelloche viveva nella Valle, uomini, animali, piante e pietre, esapeva tutto quello che c’era da sapere, e anche qualcosa dipiù. Egli ricordava cose che gli altri avevano dimenticato,perché non si rendevano conto della loro importanza, equello che succedeva alla sua Valle era come se succedesse alui. Tutti quanti si rivolgevano a lui per capire e per deci-dere, e si affidavano con fiducia a quanto diceva, anche sespesso le sue parole erano un po’oscure e i suoi consigli unpo’ severi.
Alarico aveva un figlio di nome Arturo, che era diven-tato anche lui un Mago ed aveva per la Valle la stessa pas-sione del padre: quindi aiutava Alarico con le sue idee einvenzioni, che con il trascorrere degli anni si facevanosempre più originali e utili.
Con il passare del tempo Alarico, che nel frattempoveniva chiamato «l’Antico», si faceva sempre più vecchio esaggio, e Arturo veniva acclamato da tutti per le sue genialitrovate, tanto da meritarsi il nome di «Futuro». Special-mente i giovani frequentavano con entusiasmo la suascuola, ove trovavano incredibili soluzioni ai loro problemispiccioli. Era faticoso andare al pozzo a prendere l’acqua?Furono inventati tubi e pompe, e l’acqua chiara del Tor-rente zampillò direttamente dentro le case. Nelle lunghesere d’inverno il lume delle candele era troppo fioco? Fuancora la forza del Torrente a venire in aiuto agli uomini,che la imbrigliarono in una macchina magica e la spedi-rono attraverso fili volanti ad illuminare tutte le case delPaese. Grazie alla genialità ed al tenace lavoro di Arturo edei suoi allievi, il Paese Delle Cose Che Succedonoconobbe un’era felice: le case erano calde, le malattie sem-pre più rare e meno pericolose.
Furono inventate macchine che aiutavano l’uomo neilavori più pesanti ed altre che gli permettevano di spostarsisenza fatica sempre più lontano e sempre più velocemente.Si scoprirono utilizzi fino ad allora inimmaginabili perl’acqua del fiume, le piante del bosco e le pietre della mon-tagna. Gli uomini del Paese Delle Cose Che Succedonoerano molto felici, e in più orgogliosi della propria intelli-genza che aveva creato tutte quelle belle cose: avevano la
P
ERCORSO
1 M S
CHEDA
3
12
sensazione di essere molto potenti, addirittura i padronidella Valle, del Paese, del Bosco e della Montagna, anzichéesserne solamente gli abitanti insieme agli altri esseri. Ala-rico e la sua antica saggezza vennero messi completamenteda parte, e ad Arturo venivano fatte sempre più spessorichieste che lo preoccupavano, perché le soluzioni che sipotevano trovare andavano a vantaggio solo degli uomini,o addirittura solo di alcuni di essi, e a svantaggio di tutti glialtri esseri viventi e non viventi della Valle. Gli accaddesempre più spesso di dire «no» a queste richieste eccessive,cercando di spiegare i motivi ai suoi studenti, ma quelli siarrabbiavano perché non li aveva accontentati e se la pren-devano con lui, finché‚ cominciarono a non dargli più rettae ad applicare di nascosto le sue idee e invenzioni per farnequello che pareva a loro. I risultati non tardarono a giun-gere: la Valle ridente si trasformò ben presto in un postosudicio e disordinato, dove ciascuno badava solo a renderepiù bella la sua casa e il suo pezzetto di terra, a danno ditutto il resto. Piano piano il Torrente fu derubato delle sueacque e nel suo letto furono scaricate le acque puzzolentidelle case e delle officine, che diventavano sempre piùgrandi e rumorose per produrre sempre più cose. Nei Pratiche circondavano il Torrente la terra inaridì e in seguito vivennero gettati i rifiuti di quello che veniva consumato eabbandonato: e diventavano sempre di più, una vera e pro-pria montagnola brutta e puzzolente.
La vera Montagna invece fu scavata per ricavarneminerali e sassi, sempre più minerali e sassi per farci sem-pre nuove cose: fino sulla cima vennero costruite comodestrade, e per far questo molti alberi furono abbattuti. Moltialtri alberi furono anche abbattuti per ricavarne legno per imobili e pasta per la carta, e quel poco che restava del mae-stoso Bosco era pieno di cartacce e pattume dei turisti:quasi come i Prati. Pareva che gli uomini avessero dimenti-cato il passato, e che non si preoccupassero del futuro: pen-savano solo al presente, ma anche il presente in realtà erabrutto, loro non erano felici, anzi. Solo che cercavano allaloro tristezza soluzioni che peggioravano la situazioneinvece di risolverla. Presto i pochi animali sopravvissutiabbandonarono la Valle, e l’intera natura cominciò a ribel-larsi all’operato dell’uomo: ad ogni pioggia la Montagnainferocita faceva cadere sul Paese sassi e fango, il Torrente sigonfiava al di sopra degli alti e rigidi argini e le sue acquepuzzolenti spazzavano case e giardini. Perfino l’aria el’acqua erano diventate velenose e portavano misteriosemalattie. Ma quel che era peggio era che adesso gli stessiuomini parevano colpiti da una malattia sconosciuta, che lirendeva tanto più avidi quanto più possedevano, sempremeno capaci di condividere le cose con gli altri, sempre piùcattivi, sempre più infelici. Arturo ed Alarico venivanoscansati da tutti, e i loro sforzi per cercare qualche rimedioalla situazione li facevano solo odiare sempre di più: manon potevano rassegnarsi alla triste fine della loro Valle, ecosì fuggirono per il Mondo in cerca di aiuto, portandocon loro la propria sapienza ed il magico «Libro Delle CoseChe Succedono». Su questo libro compariva tutto quello
che succedeva nella Valle, e poi ci restava disegnato sopra:portandolo con sé‚ i due Maghi potevano essere sempreinformati e potevano mostrare con esattezza quanto erasuccesso, nella speranza di trovare l’aiuto di cui avevanobisogno. Alarico, infatti, sapeva bene che la Valle potevaancora risanarsi da sola, se la lasciavano in pace: per aiu-tarla erano però necessarie due Magie: una era molto sem-plice, e un tempo tutti la conoscevano, era la «Magia CheFa Le Cose Nuove Da Quelle Vecchie». Non serviva ariportare i sassi e gli alberi alla Montagna ed al Bosco, aripulire i Prati, a far tornare l’acqua nel Torrente e gli ani-mali nella Valle: ma insegnava a ricavare le cose di cui siaveva bisogno da quelle che non servivano più, con un po’di ingegno e di pazienza, invece di andare sempre a pren-dere nuovo materiale dalla Valle. Inoltre con questa Magiasi risolveva il problema della montagnola puzzolente cheaveva invaso i Prati, e che cresceva ogni giorno di più. Manon poteva servire a niente se prima non si guariva lamalattia che aveva colpito i cuori degli uomini, che nonerano più capaci di capire quello che stavano facendo, e perquesto occorreva un’altra Magia, ben più complicata e fati-cosa. Bisognava costruire un «Libro Che Fa Succedere LeCose», che può venire realizzato solamente dai bambini,perché‚ solo loro hanno diritti sulle Cose Che DevonoAncora Succedere.
Alarico e Arturo avevano tentato di realizzarlo con ibambini del proprio Paese, ma gli adulti se ne erano accortie avevano buttato via tutto; poi si erano resi conto chepoteva essere interessante, e avevano fatto scrivere ai bam-bini quello che pareva a loro. Ma non funzionava. Alloraavevano cominciato a dar noia ai due Maghi per farsi spie-gare come si faceva la Magia. A questo punto i due eranofuggiti via dal Paese, inseguiti da alcuni malvagi che vole-vano impadronirsi di questa formula o comunque impe-dire che loro la usassero. I due Maghi erano talmentestanchi e tristi che i loro poteri si stavano indebolendo:inoltre erano stati tanto tempo a contatto con personearide e cattive che ogni tanto si dimenticavano persino ilmotivo per cui si davano tanto da fare. Dovevano ricordar-selo ogni giorno l’uno con l’altro, parlarsi dei pesci e deglialberi e delle case con le finestre fiorite e ripassare i nomi ditutti i bambini del Paese finché‚ ritrovavano la forza perandare avanti. Per fortuna, quando ormai le loro speranzeerano ridotte al lumicino, i due Maghi arrivarono a Cer-taldo, dove incontrarono alcuni gruppi di Bambini con iloro Maestri: questi ascoltarono con attenzione la loro sto-ria, e si commossero e preoccuparono per le difficoltà incui versava il loro Paese.
Anzi, ragionandoci bene, si resero conto che ancheCertaldo correva gli stessi rischi, e probabilmente moltialtri Paesi, quindi a maggior ragione era urgente cercare diimparare la Magia per costruire tutti insieme un «LibroChe Fa Succedere Le Cose». Allora Alarico e Arturo, rin-cuorati, insegnarono come prima cosa ai bambini la«Magia Che Fa Le Cose Nuove da Quelle Vecchie». Poiiniziarono a spiegare loro cosa dovevano fare per costruire
M S
CHEDA
3 P
ERCORSO
1
13
il Libro: ma non riuscirono neanche a terminare la listadegli ingredienti, dovettero salutare frettolosamente iragazzi raccomandando loro di fare del loro meglio e fug-gire, perché‚ i loro inseguitori li avevano scovati. Impiega-rono lunghe settimane per riuscire a far perdere le proprietracce, ma appena fu loro possibile tornarono: e non riusci-vano a credere ai propri occhi! I ragazzi avevano lavorato digran lena, cercato tutti assieme soluzioni e suggerimenti,costruito disegni e inventato storie. Con l’aiuto dei Maghie la Magia che i ragazzi avevano dimostrato di possedere, il
«Libro Che Fa Succedere Le Cose» fu presto fatto, e in menche non si dica sul «Libro Delle Cose Che Succedono», chei due Maghi avevano ancora con loro, si videro gli influssibenefici che la Magia stava avendo anche sul loro lontanoPaese. E chissà su quali altri. Magari anche su Certaldo.
(I Paese Delle Cose Che Succedono è di Maria Fran-gioni e Patricia Gabrielli)
■ Chi sono i protagonisti?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Perché il Paese delle Cose che Succedono era felice?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Chi ha fatto diventare «brutto e infelice» il Paese?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Chi avrebbe potuto salvare il Paese?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Che cosa bisognava costruire per salvare il Paese?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Chi ha costruito il «Libro Che Fa Succedere le Cose?»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Perché?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ Che cosa ci metteresti tu nel «Libro Che Fa Succedere le Cose?»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P
ERCORSO
1 S S
CHEDA
4
14
S
Scheda 4I nodi… delle relazioni
■
Dopo aver costruito la “rete” dei rifiuti cerca di trovare quegli elementi che nonsono correlati.
■
Ricostruisci una loro eventuale relazione rileggendo le relazioni che legano glielementi “slegati” ad altri elementi, passando quindi attraverso un incrocio,ovvero un “nodo” della rete che indichiamo con gli elementi A, B, C, D
■
Le coppie di fattori A/D e B/C sono direttamente legate da relazioni già esplicitatenella rete.
■
Ricerca le possibili relazioni A/B, B/D, D/C, C/A. Il grafico evidenzierà un collegamento indiretto attraverso il “nodo” che potràservire da stimolo per la ricerca di collegamenti concettuali o valoriali possibili.
A
B
D
C
15
Percorso 2La natura ricicla e l’uomo?
Premessa
In natura tutto viene riciclato.A partire da questo assunto possono derivare una serie
di importanti conoscenze che sono alla base dell’ecologia,ma al contempo «cariche» di connotazioni di valore. Lerelazioni esistenti tra i vari elementi, biotici ed abiotici, sipresentano come intricati sistemi a rete. Sistemi che costi-tuiscono fattori di stabilità e di equilibrio dinamico chepermangono se le azioni, in particolare quelle dell’uomo,
I.M.S. “Erasmo da Rotterdam” Sesto S. Giovanni (MI)
non superano alcuni limiti, oltre i quali si scatenano rea-zioni che possono mettere in crisi irreversibile gli ecosi-stemi.
Questo percorso si pone, pertanto, come obiettivi lacostruzione di alcuni concetti di base dell’EducazioneAmbientale (ambiente come rete di relazioni, ciclo, limite,risorsa, ecc.) e di una metodologia d’indagine e di studiodella realtà che rappresenta una sorta di prerequisito peracquisire una mentalità reattiva verso i problemidell’ambiente.
In questo senso i rifiuti, per quanto già dettonell’introduzione, rappresentano una pista agevole, sempreche l’approccio tenga conto delle sensibilità e delle espe-rienze preesistenti ed emergenti nella scolaresca.
A questo proposito bisogna sempre prendere in consi-derazione strategie che tengano viva la motivazione inizialee che alimentino l’interesse nell’allievo.
Attività
M S Riciclo, riuso e… abbandono
Partiamo dal mondo in cui vivono i ragazzi e invitia-moli a fare un censimento degli oggetti che più frequente-mente usano durante la giornata, compresi gli arredi, i capidi abbigliamento, gli zaini, il vasetto con la marmellata, igiornali…
Dall’elenco semplice si passa a raggruppare gli«oggetti» riferendosi a quello che sarà il loro «destino»; siprefigura il percorso (investirà anche l’immaginario deiragazzi) che gli oggetti compiranno fino a connotarsi comerifiuto, scheda operativa n. 5 (pag.20)
Una classificazione si può fare in termini di possibile:a) riuso b) riciclo c) abbandono. Analizzando le pos-
sibilità di riuso dei vari oggetti, ve ne saranno alcune diimmediata intuizione, come l’abitudine di cedere abiti vec-chi, ed altre meno immediate, come l’uso di materiali (es.grossi imballaggi, televisori), per attività creative a scuola oper giocare. Per quanto riguarda il riciclo, esso offre l’occa-sione per la trattazione di contenuti disciplinari e di appro-
P
ERCORSO
2 L
A
NATURA
RICICLA
E
L
’
UOMO
?
16
fondimenti che permettono di introdurre concettiimportanti come quelli di materie prime, materie seconde,di ciclo vitale, di biodegradabilità (v. attività «Concetti danon buttare»), di risparmio energetico. Per rendere «visi-bili» questi aspetti, per creare l’occasione di pensare con-cretamente, si può organizzare la raccolta differenziata (dicarta o di lattine) all’interno della propria classe per poiriutilizzare i rifiuti per inventare giochi, attività didatticheo utensili diversi.
Vi sono, infine, gli oggetti che andranno sicuramentebuttati via, diventeranno inevitabilmente rifiuti da elimi-nare e a molti basterà non vederli più per pensare che sva-niscano nel nulla. Può essere questo il momento pertrattare argomenti come i sistemi di smaltimento e le tipo-logie delle discariche, per definire la dimensione dellaemergenza rifiuti. A questo punto una visita alla discaricapiù vicina, dove vengono portati i rifiuti abbandonati,potrebbe essere la conclusione di questa attività.
M S I tempi dell’usa e getta
Un’altra possibile direzione di indagine che si puòdelineare a seguito dell’attività di «censimento» di oggettidi uso quotidiano, è quella dell’analisi dei tempi, differen-ziando gli oggetti a seconda della loro durata, viene imme-diato considerare i rapporti che esistono tra i tempi di:
PRODUZIONE UTILIZZO SMALTIMENTONon sempre sono rapporti equilibrati; infatti i tempi
di produzione sono a volte lunghi, ancora più lunghiquelli necessari per la formazione delle risorse naturali uti-lizzate (materie prime), per oggetti che «vivranno»… qual-che minuto.
Per l’utilità di alcuni oggetti la cosa è inevitabile,ma… è sempre così? I tempi di smaltimento poi, superanodi gran lunga quelli della vita di un oggetto e resta comun-que un’incognita il reale processo di degrado ambientaleche si accompagna alla sua distruzione. Il docente per farprendere coscienza del rapporto tra produzione/consumo/utilizzo, potrà far compilare la scheda operativa n. 6(pag.21).
A tale proposito molti si appellano al principio di bio-degradabilità per attribuire innocuità ad un prodotto, ipo-tizzando la sua dematerializzazione in una natura «amica»,favorendo così l’abitudine all’abbandono. È evidente chein un’attività come «Riciclo, riuso e… abbandono» e «Itempi dell’usa e getta» si pone significativamente l’atten-zione sul «futuro» e, quindi sulle dimensioni dell’incer-tezza e dell’imprevedibilità che ad esso inevitabilmente siaccompagnano.
Non è facile prevedere il futuro, ma la consapevolezzadell’incertezza può stimolare cautela e buonsenso nei com-portamenti del presente.
M S I concetti da non buttare
L’approccio ai concetti di biodegradabilità, di inqui-namento e di riciclo risulta quasi sempre difficoltoso siaper la complessità sia per l’insieme di conoscenze che essicomportano.
Tale approccio può avvenire attraverso un questiona-rio che rivela le preconoscenze dei ragazzi come quelloriportato nella scheda operativa n. 7 (pag. 22).
La lettura e l’analisi dei risultati dei questionari per-mette di individuare le figurazioni mentali dei ragazzi,l’attenzione che pongono alle «cose» del loro ambiente egli spazi culturali in cui si muovono e da cui ricevono sol-lecitazioni.
Le risultanze possono essere discusse in classe, avendocura che tutti gli alunni intervengano per esprimere la pro-pria opinione e per giungere ad una definizione condivisa.
M Intatto o… deteriorato
Con la seguente attività è possibile seguire le modifi-cazioni di alcuni rifiuti-tipo (frutta, pane, giornale, vetro,pezzo di plastica, lattina ecc.). Far compilare la schedaoperativa n. 8 (pag. 23) ad ogni allievo e dopo procederecon l’esperimento di verifica sotto riportato.
Attività di laboratorioPredisporre tre campioni uguali composti da sei rifiuti-
tipo (verdura, pane, giornale, vetro, limatura di ferro opaglietta da cucina, plastica).
Sotterrare il primo campione in luogo aperto e ben indi-viduabile, avendo cura di non ammucchiare i sei rifiuti, perfacilitare l’osservazione successiva (SUOLO).
Immergere il secondo campione in un vaschetta colmad’ACQUA. Porre i sei rifiuti del terzo campione in un luogoben areato ed osservabile (ARIA).
Tenere sotto osservazione i campioni: ARIA e ACQUA.Rilevare sistematicamente, ogni settimana, per la durata
di due mesi:a) colore; b) forma; c) volume; d) consistenza; e) altro;annotando le variazioni su un’apposita scheda.L’osservazione effettuata sul «visibile» (ARIA E
ACQUA) permette di formulare ipotesi sul «non visibile»(SUOLO) e di verificarle sensorialmente al termine delperiodo stabilito.
Dalla comparazione delle modificazioni avvenute (enon) nei tre campioni è possibile pervenire ad una primageneralizzazione relativa alla biodegradabilità, ai tempi incui avvengono tali modificazioni e ai fattori che le favori-scono o le determinano. Le conoscenze e i concetti acqui-siti costituiscono un punto di partenza per procedere dalvicino al lontano e dal locale al globale tenendo contodelle variabili della quantità e della qualità.
L
A
NATURA
RICICLA
E
L
’
UOMO
? P
ERCORSO
2
17
M S
Concetti alla… moviola
Un esperimento come quello descritto nell’attivitàsulla biodegradabilità, unitamente al questionario propo-sto nella scheda operativa n. 7, possono facilitare l’approc-cio ai concetti d’inquinamento e di riciclabilità.
«… L’inquinamento è il degrado dell’ambiente causatoda immissioni da parte dell’uomo (e non) di sostanze, anchenon tossiche, in quantità tali che i cicli biogeochimici non rie-scono a smaltirle risultandone alterati… ».
«… L’inquinamento è un’alterazione delle caratteristichefisiche, chimiche o biologiche dell’acqua, dell’aria, della terrache può, o potrà risultare pericolosa per la vita umana equella di altre specie… »
(1966 National Academy of Science).
Definizioni come quelle sopra riportate non tengonoconto delle variabili, «quantità», «qualità» ed «estensione»del fenomeno nel tempo e nello spazio. Pertanto bisognamirare a che ogni allievo comprenda che l’inquinamento èun’alterazione in un equilibrio di relazioni che caratteriz-zano un ecosistema complesso: non sarà difficile far com-prendere che lo «stallatico» (si pensi alle deiezioni animalidei grandi allevamenti zootecnici), pur biodegradabile(riciclabile dalla natura), in quantità eccessive e concen-trate determina il peggioramento della qualità delle acquesuperficiali e profonde; d’altro canto, il vetro, sostanza nonriciclabile «naturalmente», pur non essendo immediata-mente collegabile all’idea di «inquinamento», se dispersonell’ambiente in certe quantità comporta, comunque,degrado del paesaggio.
È evidente che ogni rifiuto, pur riciclabile dalla naturao dalla tecnologia umana, può risultare comunque inqui-nante (senza, qui, tener conto di ciò che comporta perl’ambiente la sua produzione).
Non per niente sulle etichette di alcuni contenitorisono frequenti due avvertenze:
«Riutilizzabile», «Nondisperdere nell’ambiente»
.Due facce dello stesso problema, due avvertenze che
possono costituire spunto di una prima problematizza-zione.
Attenzione, quindi: semplici esperimenti di biodegra-dabilità possono risultare «parziali» se non fuorvianti.
M S
Da cicale a… formiche
Le migliaia di tonnellate di rifiuti quotidiani sonocostituite anche da materie prime che «costano» e nonsono inesauribili: carta (cellulosa), vetro (silicati), plastica(petrolio), alluminio (bauxite), ferro e metalli si ritrovanoframmisti alle sostanze organiche dei rifiuti alimentari.
Nei cassonetti, quindi, finisce invisibilmente anchequell’enorme quantità di energia impiegata per ricavaredalle materie prime lattine, bottiglie, shoppers…
Ha senso dissipare, incenerire le materie prime (esau-ribili) contenute nei rifiuti?
Raccolta differenziata e riciclaggio permettono unrientro di costi, grazie alla vendita di materiali recuperati econtribuiscono alla riduzione della quantità e dei volumitrattati negli impianti (inceneritori, discariche, ecc.).
La separazione dei rifiuti urbani pericolosi (medicinaliscaduti, pile, ecc.) accompagnata da un idoneo smalti-mento finale, elimina o, quanto meno, riduce le possibilitàdi inquinamento. Sempre partendo dalla discussione sullerisultanze del questionario è possibile pervenire alla neces-sità della differenziazione dei rifiuti a monte del riciclo.
L’obiettivo è facilmente conseguibile costruendo con iragazzi una tabella come quella predisposta nella
schedaoperativa n. 9
(pag. 24 ).
◆
Fissata l’attenzione su un oggetto, si risale alle materieprime necessarie per realizzarlo e all’impiego di energiae lavoro per estrazione e trasformazione;
◆
successivamente si individuano i processi occorrenti peril riciclo ed il luogo in cui esso avviene (l’attività puòessere ripetuta con diversi tipi di rifiuti riciclabili).
Dopo la compilazione della scheda, sono facilmenteevidenziabili alcuni «nodi» correlati al riciclaggio:a) il riutilizzo delle «materie seconde» riduce il depaupera-
mento di quelle «prime» e permette il risparmio totaledell’energia impiegata per la loro estrazione;
b) la raccolta differenziata è resa obbligatoria dalla diffe-renziazione sia dei processi che dei luoghi in cui il rici-claggio avviene.
M S
Tutti per uno o… ognuno per se?
Completiamo questa sezione dei percorsi didatticicon un gioco, tanto coinvolgente e divertente, quanto effi-cace nel «mettere a nudo» concetti e comportamenti cheriguardano l’uso delle risorse.
Per esso non c’è limite o soglia minima d’età: bambinio docenti ecologisti… è sempre una nuova scoperta!
Le regole
Sul tavolo vengono messi a disposizione dei giocatori2n + 2 fermagli che costituiscono la posta in gioco (se igiocatori, indicati con n sono 10 i fermagli saranno 22).
Al «Via» del conduttore ciascun giocatore cercherà diprendere i fermagli.
Allo «Stop» verrà raddoppiato il numero di fermaglirimasti sul tavolo senza superare la prima posta (in questocaso 22 fermagli). I giocatori devono osservare assolutosilenzio, perciò non possono parlare tra loro se non perindicazione del conduttore.
Vince il premio chi raggiunge 2n + 4 fermagli (nelcaso citato 24 fermagli).
L’obiettivo del gioco è conseguire il premio. Il con-duttore può rileggere le istruzioni, ma non può risponderea domande.
P
ERCORSO
2 L
A
NATURA
RICICLA
E
L
’
UOMO
?
18
Come si giocaDopo aver disposto 8 - 10 ragazzi seduti intorno ad
un tavolo ed i rimanenti in piedi alle loro spalle con fun-zioni di osservatori, il docente dispone sul tavolo i fermagli(possono essere utilizzati anche semi di legumi o… ciocco-latini!) in quantità coerenti a quanto disposto nelle regole.
Quindi legge lentamente e chiaramente le «regole». Alvia del docente, si verifica frequentemente che i giocatori siimpadroniscano subito di tutti i fermagli che formano laposta.
In questo caso il docente dichiara finito il gioco eritira i fermagli posseduti dai giocatori senza dare spiega-zioni.
Il motivo infatti si evidenzierà rileggendo le regole:«… Allo stop verrà raddoppiato il numero di fermagli
rimasti sul tavolo… ».Il docente può, a questo punto, invitare i ragazzi a
riprovare. Rilegge, pertanto, le regole e tra i giocatori puòsorgere la necessità di una riflessione volta ad ottimizzare imodi della partecipazione al gioco per conseguire il pre-mio. Può quindi dare il permesso di parlare. Si arriva nor-malmente ad accordi tra i giocatori per favorire ilraddoppio della posta e continuare a giocare.
Il docente potrà «disturbare» i tentativi di accordoridando improvvisamente il VIA: ed ecco che potrà esserciqualcuno dei ragazzi che, incurante della discussione inatto o degli accordi realizzati, cercherà di «arraffare» iltutto, magari senza raggiungere il numero richiesto di fer-magli per vincere il premio!
Il docente potrà fare vari tentativi in modo che simanifesti la maggiore quantità e qualità possibile di dina-miche.
Qualcuno continuerà ad autolimitarsi e prendere daltavolo un numero «limitato» di fermagli e, forse, ci saràqualcuno che… vincerà!
Il gioco, che inizialmente si presentava decisamente ditipo individuale, si trasforma in qualcosa di diverso: ènecessaria la collaborazione di tutti perché, si possa giun-gere al «termine».
Alla fine del gioco (qualunque essa sia), s’invitano igiocatori, individualmente, a far emergere le impressioni,nonché ad esplicitare e motivare il proprio comporta-mento ed il proprio punto di vista manifestatosi durante ilgioco. Una «lettura» di quanto accaduto potrà essererichiesta ai ragazzi che, in piedi, hanno svolto funzione diosservatori. Emergeranno così le ambiguità delle regole, iripensamenti, la voglia di vincere ed i tentativi frustrati di
accordo, indifferenza al «premio»… e tante altre coseancora! Dopo questo primo «giro», il docente potrà invi-tare a riflettere sul gioco e sui suoi significati: emergerà chesi tratta di un gioco che consente, con una certa facilità, diaccostarsi a concetti propri dell’Educazione Ambientale,quali quello di «limite delle risorse», laddove i fermaglisono una metafora del concetto di «risorsa». L’attività quiproposta introduce al concetto di esauribilità delle risorsenaturali ed in materia di rifiuti permette di cogliere, peranalogia con il comportamento tenuto durante il suo svol-gimento, come sia indispensabile un’autolimitazione edun’autoregolamentazione per evitare di giungere al puntodi non ritorno (quando, cioè «finisce il gioco e senza vinci-tori!»). Il concetto di limite, allora, da concetto puramentenegativo, si «carica» di connotazioni valoriali positive. Essonon rappresenta più esclusivamente un ostacolo alla realiz-zazione personale e alla libertà individuale, ma un fattoreindispensabile per ricercare l’equilibrio tra uomo edambiente, tra risorse e consumi… tra nord e sud delmondo.
Limite, equilibrio, difesa dell’ambiente e delle risorsenaturali, irreversibilità, sviluppo compatibile, ecc.: il gioco,come semplice pretesto didattico, permette l’apertura sugrandi tematiche ambientali e ha una forte componentevaloriale.
Esso infatti mette in evidenza come sia inevitabile lacooperazione, la solidarietà, il sentirsi parte di un sistemapiù vasto, per raggiungere un benessere accettabile pertutti.
Ultima considerazione: è innegabile che tali attivitàcosì come altre attività di ruolo o di simulazione, hannouna grande validità anche dal punto di vista relazionale, inquanto permettono a tutti di entrare in una situazione chenon è percepita come «istituzionale» e, pertanto, può con-sentire a tutti di esprimere opinioni ed imparare a con-frontare i reciproci punti di vista.
È oltremodo evidente come la fase della riflessione,che fa seguito al gioco (ma non solo a questo), consente diavviare un processo di grande importanza per l’EducazioneAmbientale e non solo per essa: «imparare ad imparare»,laddove sono favoriti apprendimenti attraverso prove ederrori, valutazioni dei propri comportamenti in relazionead un fine da raggiungere e ad un determinato contesto,riflessioni sulle proprie scelte e sulle loro conseguenze,acquisizioni consapevoli dei limiti del proprio modo diinterpretare ed agire.
P
ERCORSO
2 M S
CHEDA
5
20
M
Scheda 5Buttare, buttare, buttare
Riprendi l’elenco degli oggetti che più utilizzi durante la tua giornata o all’interno della tua classe e soffermati sui motivi per i quali si buttano i diversi prodotti e dove vengono generalmente buttati.
NOTA BENE:
◆
Le motivazioni possono essere: sono completamente consumati, non c’è tempo per ripararli, non c’è in casa chi li ripari,non c’è l’artigiano vicino che li ripara, sono passati di moda, sono monouso, ne sono stati cucinati troppi, sono staticucinati male, si sono deteriorati, erano degli avanzi.
Oggetti Perché vengono buttati Dove vengono buttati
I
NDUMENTI
1. giubbino
2. scarpe
3. calzini
4.…
5.…
C
IBI
1. pane
2. carne
3.…
4.…
5.…
A
RREDI
1.…
2.…
3.…
4.…
5.…
O
GGETTI
DI
USO
COMUNE
1. zaino
2. penna
3. matite
4. spazzolino per denti
5.…
MS S
CHEDA
6 P
ERCORSO
2
21
MS
Scheda 6I tempi del prodotto/rifiuto
Dopo aver condotto una ricerca su come si producono, come si utilizzano e come si smaltiscono gli oggetti della tua giornata prova a prevedere il rapporto fra tempi di produzione (tp), tempi di utilizzo (tu) e tempi di smaltimento (ts) dei dieci oggetti più utilizzati
■
Rispetto al tempo di utilizzo (tu) stila una classifica degli oggetti a partire dal piùutilizzato nel tempo a quello meno utilizzato
■
Rispetto al rapporto tra tu/tp e tu/ts stila una classifica di quelli ambientalmentepiù sostenibili (tu/tp e tu/ts molto grandi)
OGGETTO è fatto di.. tp tu ts tu/tp tu/ts
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10
P
ERCORSO
2 MS S
CHEDA
7
22
MS
Scheda 7I concetti da non… buttare
BIO_DE_GRA_DA_BI_LI_TÀ
■
Conosci la parola BIODEGRADABILE?
■
Dove e quando l’hai incontrata?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Che cosa significa per te?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Elenca tre «cose» che pensi siano
Sì
l
No
l
Biodegradabili Non biodegradabili
M S
CHEDA
8 P
ERCORSO
2
23
M
Scheda 8Intatto… deteriorato
Se lasciassi dei rifiuti di un pic-nic e tornassi dopo un anno in che condizioni pensi di ritrovare?
◆
una lattina
◆
un panino
◆
una mela
◆
un tovagliolo di carta
◆
le posate di plastica
◆
un bicchiere di vetro
■
Quali degli oggetti elencati sopra sarebbero:
■
Verifica con un esperimentoProva a sotterrare in alcuni vasetti gli oggetti sopra elencati, annaffiali ogni 8giorni. Che cosa è successo in ogni vasetto:
dopo un mese: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dopo due mesi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
quali si sono trasformati e perché?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTATTI DETERIORATI SPARITI
P
ERCORSO
2 MS S
CHEDA
9
24
MS
Scheda 9Dal prodotto al rifiuto e… ritorno
Dopo aver svolto alcune ricerche su materie prime e consumo energetico, compila la seguente scheda
Prodottofinito
Materiali Materie prime
Energia per produrlo
(Joule o Kcal)
[S]
Tecnica di riuso
Energia per produrlo dal riciclo
(Joule o Kcal)
[S]
Differenza di energia
[S]
bottiglia vetro siliciofrantumazione/fusione
lattine alluminio bauxite fusione
giornali carta cellulosa macerazione
25
Percorso 3La pattumiera. Alla ricerca del prima e del poi
Premessa
Guardare con occhi diversi la realtà di tutti i giornipuò favorire scoperte inimmaginabili, e, comunque, puòfar nascere la consapevolezza che il modo di percepire,conoscere e pensare l’ambiente è diverso da un soggettoall’altro e persino nello stesso soggetto in diversi momenti.Le attività qui di seguito suggerite possono consentire,agilmente, il raggiungimento di significativi obiettivicognitivi in vari ambiti disciplinari. Sono, comunque, utiliper evidenziare alcuni «modelli» che influenzano la nostraconoscenza fatta spesso di ingiustificate aspettative edincredibili preconcetti, ed i comportamenti che ne deri-vano sono da considerare poco raccomandabili per la sal-vaguardia ambientale. Per cominciare proponiamo «Ilsentiero artificiale»: un’attività liberamente adattata allaqualificata esperienza di Educazione Ambientale del Cen-tro di Pracatinat in Piemonte. Il passaggio che si propone èda mozzafiato: dal bosco alla pattumiera! Scopriamo il per-ché.
Attività
M S Il Sentiero artificiale
Come si gioca.L’insegnante prepara precedentemente un percorso di
circa 20 metri in un sentiero di un bosco.Su questo ed ai due lati (fino ad una distanza di un
metro), sul terreno, sui rami, fra i cespugli, sui sassi, ecc.distribuisce una dozzina di oggetti «artificiali» (prodottidall’azione dell’uomo): una busta di plastica, un nastrocolorato, il tappo di una penna, una moneta, un fermaglio,ecc., in modo graduale dal più visibile al più mimetico edin modo che per la forma, il colore, la dimensione e laposizione possano essere individuati più o meno facil-mente. I partecipanti sono quindi invitati a percorrere il«sentiero» (reso, così, artificiale): di esso non conoscono néla fine né il numero degli oggetti collocati; devono, quindi,individuarne il più possibile, annotandoli su un taccuino,senza toccarli e in assoluto silenzio.
Al termine del percorso, l’animatore chiede a tutti ilnumero degli oggetti individuati, quindi comunica ilnumero degli oggetti nascosti e tutti ripercorrono il sen-tiero in senso inverso, cercando di identificare gli oggetti
I.T.I.S. “Sen. O. Jannuzzi”Andria (BA)
P
ERCORSO
3 L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
26
mancanti «all’appello», sempre senza toccarli e senzacomunicare con gli altri. Terminato il gioco, l’animatoreconfronta gli oggetti elencati da ciascuno e, accompagnatodal gruppo, li raccoglie, permettendo a tutti di conoscerela loro collocazione.
Durante il percorso di andata i partecipanti incon-trano prima oggetti di una certa grandezza, evidenza efamiliarità, poi quelli meno rispondenti alle aspettative chei primi oggetti hanno creato. Generalmente non indivi-duano tutti gli oggetti, perciò nel percorso di ritornoconoscendo il numero degli stessi, fanno più attenzione,rallentano il passo, si distanziano per osservare meglio.Avendo cambiato direzione, scoprono altri oggetti grazie aldiverso punto di vista, alla direzione della luce, ai riflessidel sole, guardando perfino nelle fessure e sui rami deglialberi.
Può, quindi partire una riflessione sul modo di osser-vare ciò che ci sta intorno.
Si discute sull’essere «artificiale» degli oggetti, si rileval’importanza del punto di vista, sia topologico, sia riferitoalle differenze percettive dei singoli partecipanti. Si eviden-zia il mimetismo per forma o colore e l’importanza delrapporto luce/colore.
In situazioni di difficoltà emerge la disponibilità amodificare le strategie di ricerca, ad immaginare l’oggettomancante in base alle scoperte già fatte e ci si rende contoche la realtà non è vista così come è, ma in funzione delloscopo che ci si prefigge e che comunque si ha sempre unavisione parziale di essa.
Emerge il peso delle aspettative in un’attività diricerca o di esplorazione dell’ambiente, l’importanza del«punto di vista» nel condizionare la conoscenza: elementidi indubbio significato formativo per accrescere la capacitàdi cogliere relazioni tra gli elementi naturali ed antropici.Così, mentre si esercita una capacità percettiva di distin-guere l’oggetto dallo sfondo in cui è collocato, si acquistaanche la consapevolezza della estraneità o meno diquell’oggetto all’ambiente in cui si trova.
Si costruisce così anche una nuova attenzione a«vedere» quei rifiuti che tappezzano i nostri percorsi quoti-diani.
Risulta evidente come tale attività può essere finaliz-zata a costruire un atteggiamento di ricerca, ad «aprire gliocchi» su tanti e diffusi comportamenti che l’uomo ha conle merci ed i rapporti che queste hanno con l’ambiente cir-costante; imparando così a reagire all’indifferenza oall’assuefazione di fronte al degrado quotidiano.
M S Non lo butto perché…
Molti sono gli oggetti che hanno un legame con chi lipossiede. Ricordate la famosa coperta di Linus? Come farea creare questo legame al fine di conservare un oggetto per-sonale ed «allungarne» la vita?
L’insegnante farà scrivere un racconto o fare un dise-
gno sul gioco o sul capo di abbigliamento preferito.L’attività proposta ha l’obiettivo di far riflettere i
ragazzi sui motivi che spingono a conservare un oggettopersonale.
Dopo aver riflettuto sui propri atteggiamenti ilragazzo viene messo a confronto con gli atteggiamentidegli altri: i compagni, i fratelli, la mamma, i nonni ecc.Tutto questo da una parte per indagare sulle idee e gliatteggiamenti collettivi e, dall’altra, per fare un confrontoche permetta la riflessione degli allievi su cosa spinge glialtri (genitori, nonni, compagni ecc.) a conservare.
Dopo aver chiesto ai genitori, ai nonni, al compagnopreferito, alla sorella e/o al fratello, all’insegnante:1. Quali oggetti non butteresti mai via?2. Perché non lo butteresti?3. Dove lo conservi?4. Come lo conservi?
Far compilare la scheda operativa n. 10 (pag. 33).Sarà forse possibile scoprire che il nonno tiene nel suo
cassetto segreto le lettere che ha scritto nella sua giovinezzae la mamma tiene con molta cura nell’armadio il suovestito da «sposa» oppure… ed allora quante storienascono dietro ad un semplice oggetto conservato!
A questo proposito un’indagine molto interessante èstata svolta dagli allievi dell’I.T.I.S. «Sen. O. Jannuzzi»Andria (BA) e i cui risultati sono rappresentati nella tabellasoprariportata.
M Il tesoro di famiglia
Parafrasando un celebre detto si potrebbe sostenereche «chi trova rifiuti, trova un tesoro».
In una discarica o nel cassonetto del quartiere ciò puòrisultare quantomeno faticoso, ma la propria casa puònascondere «tesori» inimmaginabili ed in luoghi insospet-tabili: la pattumiera, ovvero, il tesoro di famiglia!
Valori materiali
Valori affettivi
Che cosa non buttereste mai?
Personaggi:mamma, sorella, nonna, papà,
nonno, fratello, io
I.T.I.S. «Sen. O. Jannuzzi» Andria (BA)
53%
47%
L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
P
ERCORSO
3
27
La propria abitazione può essere ritenuta oggetto dilavoro sul campo, quando si analizzano problemi, processi,situazioni che, appartenendo al quotidiano, alla routine,non sono mai approfonditi dai ragazzi, né sono oggetto diriflessione «spontanea».
In questo senso «
la pattumiera
» consente all’alunnodi muoversi in una ristretta area d’indagine, ma operandoin profondità ed attivando le sue capacità di analisi, diriflessione, di comparazione, di concettualizzazione, non-ché quelle indicate come «qualità dinamiche» (assunzionedi responsabilità, espressione di un pensiero autonomo,spirito di iniziativa, (vedi prf. 2.2 capitolo II parte prima).
Eccoci, quindi, al vero e proprio lavoro d’indagine.L’attività proposta suggerisce di accertare la quantità
dei rifiuti abitualmente conferiti all’interno degli spazidomestici in una settimana tipo, annotandoli sulla
schedaoperativa n. 11
(pag. 34).Si può, pertanto, suggerire di accertare la qualità dei
rifiuti abitualmente conferiti all’interno degli spazi dome-stici (di quali materiali siano composti, a quali funzioniservano, a quali bisogni corrispondano).
Annotati i rifiuti raccolti nell’ambito della propriafamiglia ed operando in momenti successivi, è possibilescoprire vari ordini di relazioni: oggetto/materiale, oggetto
/funzione, oggetto/scopo oggetto/bisogno, oggetto/pro-venienza (prossima e remota).
Il risultato finale può essere riportato nella
schedaoperativa n. 12
(pag. 35).Un’attenta lettura della scheda compilata, può con-
sentire di cogliere somiglianze e differenze, classificando idati ottenuti secondo diversi criteri:a) i RSU più frequenti;b) i materiali organici ed inorganici;c) quali rifiuti l’alunno ritiene «inquinanti» e perché;d) i vari rifiuti inorganici, la loro provenienza, l’origine dei
materiali.Si possono così facilmente evidenziare almeno due
dati:
◆
carta di vario genere e cartone che costituiscono l’ele-mento più presente;
◆
vi sono materiali che formano grandi gruppi: plastica,vetro, metallo e altri piccoli gruppi non facilmenteidentificabili (soprattutto oggetti di materiale misto).
«Sporcarsi le mani» con i rifiuti prodotti in casa haindubbiamente il vantaggio di porre attenzione su ele-menti concettuali di enorme rilevanza come biodegradabi-lità, inquinamento, riciclaggio.
Il percorso didattico adottato richiama necessaria-
Tabella riassuntiva i dati relativi ad un numero complessivo di dieci famiglie nell’arco di una settimana
Tipi di rifiuti
Lune
dì
Mar
tedì
Mer
cole
dì
Gio
vedì
Ven
erdì
Saba
to
Dom
enic
a
Totale sett.
Media giorn.
Bottiglie in PET e PVC 10 7 7 6 6 6 6 48 6,8
Contenitori shampoo, creme…
3 5 5 2 6 5 5 31 4,4
Vassoi di PS espanso 3 6 2 4 4 1 2 22 3,1
Bicchieri e piatti di plastica 6 7 8 10 8 12 20 71 10,1
Lattine 13 11 6 8 10 8 12 68 9,7
Bottiglie e barattoli di vetro 2 6 3 12 4 10 6 43 6,1
Contenitori di cartone 3 5 4 7 4 5 5 33 4,7
Sacchetti di plastica 6 4 6 5 6 5 4 36 5,1
Peso medio dei sacchetti in chilogrammi (per famiglia)
2 1,5 2 2 2,5 4 3 17 2,5
Scuola Media «E.Porcu» Quartu Sant’Elena (CA)
P
ERCORSO
3 L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
28
mente collegamenti con precedenti esperienze di educa-zione scientifica (intorno a concetti come biodegradabilità,inquinamento… ) in modo da poter verificare le rappre-sentazioni concettuali precedentemente costruite intorno aquestioni fondamentali come il rapporto «organico-inor-ganico» e «rifiuto inquinante» (vedi attività: intatto edeteriorato e concetti alla moviola).
Un’attività che si svolga tra le pareti domestiche offrel’opportunità di sviluppare l’osservazione, guardando cosefamiliari con «nuovi occhi», per poi riflettere sui propricomportamenti. Ciò che infatti sfugge comunementeall’attenzione dei ragazzi, anche per il «ruolo» particolareche si riveste in famiglia, può essere individuato ed analiz-zato a scuola.
Uno degli scopi formativi a cui si può mirare è quellodi essere consapevoli delle motivazioni che portano atalune scelte di consumo e, quindi, all’acquisto di un pro-dotto in una tale confezione anziché in un’altra: in situa-zioni «semplici», quotidiane, apparentemente innocue,possono nascere occasioni per riconoscere le proprie dina-miche decisionali. Nel momento del confronto in classe sipossono individuare i comportamenti «ricorrenti» ed ipo-tizzare, ad esempio, gli effetti della pubblicità.
Si può suggerire agli alunni un’attività da svolgere acasa, riponendo gli alimenti acquistati dai propri genitori etabulandoli a seconda del materiale di cui sono fatti inmodo da compilare la scheda operativa n.13 (pag. 36).
Così hanno fatto gli studenti della Scuola Media «E.Porcu» di Quartu Sant’Elena (CA), rilevando il quantita-tivo di rifiuti di dieci famiglie per una settimana. I risultative li proponiamo nel riquadro a pagina 27.
L’insegnante avrà l’opportunità di valutare le capacitàdi riconoscere le «materie prime» e di illustrare i contenutiriguardo alla provenienza delle stesse, riferendosi al lororapporto con l’ambiente (es. legname per carta e cartoni,petrolio per la plastica, la bauxite per l’alluminio ecc.).
Altro sviluppo possibile è quello di considerare i con-tenitori dal punto di vista dei «costi energetici», indivi-duando poi gli involucri più «costosi» (anche se tale analisipuò mantenersi ad un livello di tipo qualitativo).
I risultati della tabella a doppia entrata potrannoessere utilizzati per analizzare le varie definizioni di conte-nitori «vantaggiosi» per far emergere, anche se non imme-diatamente individuata, un’altra problematica: l’impattoambientale e l’inquinamento derivanti dallo smaltimento.Potrebbe infatti risultare che un basso costo energetico edun minimo utilizzo di materia prima, non siano sempre«indici di vantaggiosità». Ad esempio talune qualità dishoppers (sacchetti di plastica) molto funzionali comecontenitori per la spesa per le caratteristiche di elasticità,resistenza, impermeabilità si rivelano poi inidonei, seppurriusati, come contenitori di rifiuti, data la non biodegrada-bilità e lo sviluppo di gas nocivi durante la fase di smalti-mento mediante incenerimento.
Un’altra direzione di lavoro può essere offertadall’analisi del rapporto tra scelte di acquisto e pubblicità.
Per i prodotti acquistati si raccolgono le pubblicità rintrac-ciabili sulla carta stampata e si relaziona su quelle televisivecon una griglia di analisi di questo tipo:
quali sono i messaggi su cui si basa la pubblicità?Quali quelli espliciti e quelli nascosti? Di cosa si vuol con-vincere l’acquirente? Quale si dimostra più efficace?
M S Necessario o… voluttuario
La scelta di un materiale e di un contenitore da partedi un produttore di una merce può obbedire a moltenecessità quali igiene, «fascino» ed estetica del prodotto,maneggevolezza; di rado privilegia motivazioni ecologiche.
L’attività che segue tende ad acquisire tale consapevo-lezza senza cedere a tentazioni moralistiche ed anacronisti-che. Considerando le stesse confezioni dell’attivitàprecedente, si può suggerire di compilare la scheda opera-tiva n. 14 (pag. 37).
L’attività potrà facilmente spiegare che:◆ alcuni metodi di conservazione dell’alimento (metodo
Appert) prevedono, oltre alla chiusura ermetica,l’azione del calore; quindi si restringe la possibilità discelta del materiale.
◆ Il vetro «trasparente» comunica l’idea di genuinità,mentre un numero maggiore di involucri dà «prezio-sità» al prodotto.
◆ La qualità di alcuni contenitori richiede imballaggiulteriori nella fase di trasporto (si pensi alla fragilità delvetro).
M S Quanto… imballaggio
Gli italiani producono annualmente 20 milioni ditonnellate di rifiuti solidi urbani e gli imballaggi ne costi-tuiscono il 40% in peso ed il 60% in volume.
Il «peso» della pubblicità grava anche su involucri edimballaggi, oltre a produrre tanta carta stampata consu-mando alberi in pagine patinate, manifesti e volantini.
Tutte le attività che inducono a riflessioni sui compor-tamenti e sulle scelte sono occasioni per scoprire i valoriche, molto spesso in modo nascosto, sovrintendono allescelte individuali.
Si possono invitare gli alunni, con l’aiuto dei genitori,e per una settimana, a raccogliere i contenitori che sonoserviti per portare a casa gli alimenti acquistati e consumati(lattine di bibite, scatole di piselli, buste di latte, ecc.). Idati facilmente acquisibili sulla natura del contenitore, ilpeso, separato e complessivo, ed il volume, possono com-pletare, con l’aiuto dell’insegnante, la scheda operativa 15(pag. 38).
I dati trovati potranno poi essere rappresentati anchegraficamente. In classe, infine si potrà compilare unascheda complessiva per ogni materiale che contenga i datirilevati da ogni alunno.
L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
P
ERCORSO
3
29
M
Caro nonno… i rifiuti nel passato
È importante conoscere il passato per poter interpre-tare il presente e fare previsioni sul futuro. L’attività sugge-risce di iniziare con domande del tipo: pensando alla vitache conducevano i tuoi nonni, quando avevano la tua età,quali rifiuti pensi che producessero? Dove li mettevano?Confrontando la loro vita con la tua chi ritieni producessepiù rifiuti?
Attraverso un’intervista ai nonni non sarà difficileandare a verificare le ipotesi di partenza.
Utilizzare il questionario della
scheda operativa n. 16
(pag. 39), proporlo ai nonni e agli anziani del quartiere,elaborarlo ricavando i dati più interessanti per avviare unadiscussione sul cambiamento dei comportamenti ieri eoggi. Sarebbe opportuno coinvolgere nella discussioneanche i nonni invitandoli a portare a scuola gli oggetticonservati che ricordino un «mondo» passato (giochi fatticon materiali poveri, oggetti per cucinare o per riscaldarsi,fatti artigianalmente, i loro attrezzi di lavoro ecc.).
M S
Cibi… in pattumiera
◆
Nei rifiuti solidi urbani finisce ogni anno circa il 10%del pane prodotto (120-160 grammi/abitante algiorno) a cui vanno aggiunti gli scarti di paste alimen-tari e affini (70-80 grammi /abitante al giorno).
◆
Sono un quantitativo di 400.000 tonnellate all’anno inItalia.
◆
Nei rifiuti solidi urbani finisce ogni anno circa il 15%della carne acquistata (carne ancora commestibile!) chesi stima in 50 chilogrammi/abitante all’anno. Sonooltre 400.000 tonnellate circa. Il totale di queste duecomponenti rappresenta il 5% (forse anche di più) deirifiuti solidi urbani, all’interno della frazione organicache rappresenta il 30% circa. (AA.VV. «Nuova ecologiatoscana» Progetto di ricerca per la preselezione e il recu-pero dei RSU ed assimilabili).
◆
Una forte campagna contro questo tipo di comporta-mento, inaccettabile sia dal punto di vista etico che daquello economico (3000 miliardi di lire di sostanza ali-mentare ancora commestibile nei rifiuti ogni anno),potrebbe portare ad una diminuzione di questo spreco.
◆
La semplice diminuzione di questo comportamento del20% porterebbe ad una riduzione del quantitativo dirifiuti di 160.000 tonnellate annue.
Riflettere sullo spreco nella società dei consumi èmeno coinvolgente che calcolare quanto pane finisce ognigiorno nella spazzatura della propria abitazione.
È quanto si propone di fare per un’immediata verificache le statistiche non sono numeri, astrazioni delle qualinon siamo responsabili: i ragazzi possono così verificareche comportamenti «minimi», quotidiani, tanto scontatida sembrare non determinati da una scelta, contribuiscono
ai risultati collettivi di cui parlano le statistiche.
Sei sicuro che tutto ciò che si elimina dagli alimentiprima e dopo la loro presenza in tavola, sia da buttar via?»
Una domanda come questa può suggerire una nuovaattività sulla ricerca di alcune forme di «riciclaggio» comele ricette risparmio che utilizzano resti di alimenti ancoracommestibili.
Perché non domandarlo alla nonna e raccogliere lericette in un «libro di cucina» fatto, perché no, in cartariciclata?
■
CARO NONNO… ..
Dalle interviste ai nonni effettuate dagli alunnidella Scuola Media «Padalino» di Fano risultano iseguenti dati:
◆
persone intervistate 55 di cui 33 donne e 22 uomini
◆
32 abitavano in campagna
◆
17 in città
◆
6 nella zona del mare
◆
le date di nascita degli intervistati vanno dal 1901 al1932.
Rifiuti organici:
◆
in campagna erano utilizzati per gli animali, oppureposti in una buca insieme alla cenere perché diven-tassero concime;
◆
in città venivano gettati nella spazzatura.
Capi d’abbigliamento:
◆
l’abbigliamento era essenziale;
◆
in molte famiglie c’era l’abito che si utilizzava soloper i giorni di festa;
◆
in campagna un paio di scarpe e un abito potevanoservire a più persone; molto diffusi erano gli zoccoli(spesso fatti e aggiustati in casa);
◆
gli abiti venivano passati a fratelli più piccoli e ria-dattati; se si strappavano, venivano rammendati, poiusati come stracci, quando erano troppo logori;
◆
in città venivano infine dati allo straccivendolo;
◆
in campagna si utilizzavano pezzi di stoffa nei lavoridei campi (es. per legare le viti… );
◆
le calze, si facevano in casa, ai ferri.
Giocattoli:
◆
erano pochi e fatti in casa;
◆
bambole fatte con il granturco, di pezza, di lana, dicera ecc.;
◆
cerchi di legno o ricavati dalla bicicletta,
◆
fischietto fatto di canna,
◆
oggetti di legno,
◆
palla di pezza, biglie.
P
ERCORSO
3 L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
30
M S Il poi… della pattumiera
Forse è giunto il momento di accostare le cifre dei«vicini» imballaggi ammucchiati nel cassonetto dei rifiuti,alle «lontane» discariche che non bastano più, ad iniziativepossibili di raccolta differenziata e di riciclaggio, alleimmense risorse sprecate. Temi, concetti, attività e visiteguidate che potranno consentire scoperte interessanti, talida avvicinare sempre più i nostri ragazzi alle vere originidel problema e alle possibili soluzioni.
Sotto gli occhi dei ragazzi crescono montagne dirifiuti, che possono suscitare una curiosità: qual è la desti-nazione dei RSU?
L’esperienza dei ragazzi, spesso, finisce al cassonettovuotato dall’automezzo dell’Azienda di Nettezza Urbana.
Si può pensare di rivolgersi agli operatori ecologici,preparando un’intervista, selezionando domande significa-tive per conoscere il ruolo dell’operatore ecologico, il rap-porto di lavoro, la destinazione dei rifiuti, le difficoltànello svolgimento del lavoro, le condizioni ottimali dilavoro.
L’organizzazione di una visita guidata ad una discaricaè un’occasione di mobilitazione delle qualità dinamichedei ragazzi che, senza avere preventive informazioni, pos-sono distribuirsi i ruoli, secondo le competenze, assu-mendo compiti diversi.
L’attività sul campo, infatti, comporta una fase orga-nizzativa che si può così sintetizzare:1 decidere «cosa fare» sul posto;2 distribuire i compiti relativi alle operazioni da com-
piere;3 disporre gli strumenti necessari;4 provvedere al mezzo di trasporto;5 ottenere i permessi dalla scuola e dai genitori;6 ipotizzare i tempi necessari e gli eventuali «bisogni» dei
ragazzi.L’assunzione di «compiti di realtà», contestuale al
lavoro sul campo, ha una notevole forza didattica ed edu-cativa: evidenzia e sviluppa qualità dinamiche, ma, al con-tempo, favorisce qualità «relazionali» (solidarietà digruppo).
Sul campo, infatti, ciascun ragazzo può svolgere unruolo: fotografare, prendere appunti, disegnare schizzi,intervistare, manovrare il registratore o una videocamera,misurare, annotare impressioni, cose, azioni, ecc.
Il lavoro sul campo offre all’indagine l’opportunità diverificare le ipotesi, correggere con l’esperienza le rappre-sentazioni contaminate dall’immaginazione, cogliere unagran quantità di dati suscettibili di riflessione e approfon-dimento, stabilire relazioni, conoscere fasi di un processoche sfugge all’esperienza quotidiana. I ragazzi possonoregistrare aspetti strutturali e funzionali (drenaggio delpercolato e captazione del biogas), assistere alle fasi di sca-rico e copertura dei R.S.U., annotare la frequenza diingresso degli automezzi, assistere e registrare la «pesa»,ecc.
A visita ultimata, ci si può recare presso gli Ufficidell’Azienda, per intervistare i responsabili della gestionedello smaltimento dei rifiuti e trovare risposte a nuovedomande quali: cosa accadrà quando la discarica saràcolma? È difficile reperire altri terreni? Quali effetti puòavere il «percolato»? E il biogas? Quali garanzie offrono iteli di rivestimento? Ecc.
Una visita in una discarica può far emergere chiara-mente la differenza fra sviluppo lineare e sviluppo ciclicodi un fenomeno, nonché l’irreversibilità del primo.
In questo senso il lavoro sul campo offrirà ancora unavolta all’indagine di verificare le ipotesi, correggere conl’esperienza le rappresentazioni non corrette, cogliere dativisibili ed invisibili, riconoscere relazioni tra rifiuti edimpatto ambientale che sfuggono all’esperienza quoti-diana.
M S Il Gioco di ruolo
Un gioco di ruolo, al termine di un progetto didat-tico, può determinare un’occasione di verifica delle attivitàprecedentemente svolte, perché comporta l’utilizzazionedelle conoscenze, dei dati e dei documenti acquisiti; mapuò essere utilizzato in fase iniziale del progetto e, quindiconsentire di «aprire» il problema e delineare esigenze ebisogni di conoscenza a partire dalle proprie rappresenta-zioni mentali e dalle proprie sensibilità. L’attività si basasulla simulazione di una situazione reale che configura un«conflitto» realmente presente o che potrebbe realistica-mente verificarsi nel territorio.
Nel gioco i partecipanti devono trasformarsi da «spet-tatori» in «attori» del conflitto, accettando di assumere unanuova identità (ruolo), di indossare «panni» (responsabi-lità) altrui e di agire e reagire il più spontaneamente possi-bile.
In tal caso i partecipanti interpretano ruoli edimprovvisano situazioni utilizzando unicamente un«dispaccio d’agenzia» e le «carte dei ruoli» (vedi più avanti)fornite all’inizio dell’attività.
Il gioco non richiede particolari regole, né particolarimateriali e, data la sua struttura, non può essere previsto apriori ciò che succederà!
Nella fase preparatoria, il conduttore presenta il pro-blema alla base del «conflitto» ed i personaggi che entranoin gioco (i ruoli); quindi assegna a gruppi di 2/3 elementiil ruolo e la «carta del ruolo», ovvero la posizione rispettoal problema del soggetto impersonato a favore, contro oneutrale da sostenere nel confronto simulato. Le «carte deiruoli» possono anche essere elaborate mediante preventivaattività di gruppo ed assegnate successivamente, per sor-teggio, ai gruppi individuati.
Vengono qui di seguito riportati temi e materiali uti-lizzabili nell’attività (ogni riferimento a fatti realmenteaccaduti è da considerarsi assolutamente casuale).
Il «conflitto» prescelto, nella versione presentata,
L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
P
ERCORSO
3
31
potrà sembrare particolarmente complesso; esso ha,comunque, solo funzione esemplificativa e di descrizionedi alcuni presupposti della metodologia (il tema è stato,comunque, utilizzato in una terza classe di una scuolamedia come prova di verifica al termine di un articolatopercorso didattico). Pertanto possono essere «allestiti» temie materiali adatti al territorio d’interesse, al «conflitto» pre-scelto ed al grado di scolarità degli alunni (si può pensare,per le scuole dell’obbligo, a conflitti in cui ruoli possonoessere animali, piante, ecc.) e, di conseguenza, realizzarevari adattamenti, anche organizzativi, della metodologia.
DISPACCIO D’AGENZIAEFFETTO N. I. M. B. Y. - «NOT IN MY BACK YARD»
S. Martino, ridente e pittoresco paese posto lungo la sta-tale Belbosco - Limpidacqua, è stato individuato dallaRegione come sede della nuova discarica controllata interco-munale (la discarica servirà, infatti, anche i comuni di S.Pasquale, S. Giorgio, S.Vito, S. Teramo per lo smaltimentofinale dei RSU). Essa sorgerà alla periferia del paese (circa 1Km) nei pressi di una frazione.
Il Sindaco si rende conto che serpeggiano preoccupazionie malumori e ha indetto un’assemblea cittadina in municipio,per discutere il problema e coinvolgere i cittadini nella deci-sione finale.
Secondo alcuni la discarica è essenziale per risolverel’annoso problema della presenza di alcune discariche incon-trollate e insalubri nelle quali vengono occultati i rifiuti.
L’impianto si presenterebbe sicuro, dotato, di modernetecnologie e potrebbe, in un’ottica di sviluppo, con il futuroinceneritore e l’impianto di compostaggio, alleggerire la giàpesante disoccupazione di S. Martino.
Su questa posizione sono schierate la società costruttrice,le organizzazioni sindacali ed alcuni amministratori comu-nali dei comuni interessati.
Decisamente contro e schierato il «Comitato Cittadinocontro la discarica»; mentre le associazioni ambientaliste,consapevoli della gravità del problema dello smaltimento deirifiuti, vogliono avere più informazioni per capire meglio.
Il Sindaco nutre qualche preoccupazione sulla possibilitàche l’assemblea giunga a buon fine, perché nel paese la «tem-peratura» è già alta e le polemiche si sprecano. I risultatidell’assemblea verranno esaminati dalla Commissione regio-nale incaricata.
Se il confronto porterà ad un orientamento unitario,questo costituirà un forte vincolo alla decisione della Commis-sione stessa.
In caso contrario, essa deciderà autonomamente.Va ricordato che, anche in assenza di accordo, «l’autore-
volezza» e la «fondatezza» delle diverse posizioni potrebberocomunque condizionare il parere della Commissione regio-nale.
REGOLE PER L’ASSEMBLEA
(da leggere e consegnare in copia a ciascun ruolo)1. Ogni gruppo deve «identificarsi» nel ruolo assegnato.
2. I diversi «attori» devono confrontarsi in un’assemblea(«l’inchiesta pubblica») diretta da un presidente, espri-mendo le proprie argomentazioni (pro, contro o di media-zione).
3. Prima dell’inizio dell’assemblea, i gruppi possono riunirsi(venti minuti) per definire la strategia da adottare inassemblea ed in particolare stabilire ed annotare su carta:quali sono gli obiettivi «irrinunciabili» da perseguire neldibattito; quali sono gli obiettivi eventualmente «negozia-bili» ovvero quelli rinunciabili a condizione che se ne rag-giungano alcuni o altri; quali argomentazioni e datiutilizzare per esporre la propria posizione e per svilupparlae difenderla nel corso del dibattito.
4. Ogni ruolo ha a disposizione tre minuti per presentare, alprimo giro di interventi, la propria posizione.
5. L’assemblea dura quarantacinque minuti
.
LE CARTE DEI RUOLI
(ogni «carta» va consegnata al gruppo di ragazzi pre-scelto o selezionato, in modo che solo quest’ultimo ne sia aconoscenza)
SOCIETÀ «ECOTUTTO» S.p.A. (costruttrice della discarica).
Intende realizzare le opere secondo le prescrizioni dilegge, è preoccupata per l’opposizione che potrebbe venire daicittadini perché ha già molto «penato» per la scelta del sitoall’interno del territorio comunale di S. Martino, che apparecomunque il più idoneo, visti i caratteri geologici dell’area (lecaratteristiche tecniche del progetto e le argille del sottosuoloassicurano infatti che non vi siano percolazioni nelle falde).
La società inoltre sta incontrando una fase di espansionea livello nazionale, grazie alla serietà del suo operato. Unabattuta di arresto, che significherebbe la perdita dell’appaltoper la gestione del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, potrebbe provocare la perdita di alcuni finanziamentinazionali e potrebbe mettere in discussione i piani di sviluppoapprontati.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La realizzazione della discarica porterà l’occupazione di30 nuove unità lavorative in una situazione di crisi pesantedell’economia di S. Martino. Sono perciò favorevoliall’impianto e sperano di poter trovare qualche punto diincontro con gli ambientalisti.
COMITATO CITTADINO CONTRO LA DISCARICA
Lo slogan è «N.I.M.B.Y.» che, nel caso specifico, significa«ovunque… ma non a S. Martino!»
Il Comitato è formato, per lo più, dai residenti nei pressidel sito prescelto per la discarica. Minaccia ulteriori e piùdure proteste: la discarica è troppo vicina per poter essere sop-portata. Il Comitato non ha il consenso di quella parte di abi-tanti che vivono nel versante opposto del territorio comunale.Il Comitato non vuole esaminare nemmeno i dettagli tecnicidell’impianto.
P
ERCORSO
3 L
A
PATTUMIERA
. A
LLA
RICERCA
DEL
PRIMA
E
DEL
POI
32
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTEL’impresa incaricata non è affidabile! Sono giunte voci di
impianti realizzati dalla stessa , in altre zone, che sono statigestiti con disattenzione.
Sperano che il Sindaco faccia gli interessi della colletti-vità dando le necessarie garanzie per il controllo dell’im-pianto.
Qualche perplessità è suscitata anche dall’eccessiva vici-nanza di nuclei abitati.
Si potrebbe realizzare altrove, in aree marginali, lontanodai centri abitati, senza sottrarre suolo pregiato all’agricol-tura. Ma bisogna, contestualmente, attivare la raccolta diffe-renziata ed il riciclaggio!
IL SINDACOÈ nei guai!Da un lato, il tempo speso per le azioni amministrative
che hanno determinato la concessione edilizia, l’appalto, ilfinanziamento alla «ECOTUTTO» e gli impegni presi,anche in campagna elettorale, per risolvere il problema deirifiuti; dall’altro un consenso, tra la gente, sempre più ridotto.
Nella maggioranza che governa S. Martino ci sonomalumori, l’opposizione imperversa, mentre le amministra-zioni di S. Giorgio e S. Vito hanno già offerto il proprio terri-torio (più ricco di aree marginali) per il sito dei nuoviimpianti di smaltimento.
STAMPANon ha interessi specifici.Ma sulla discarica di S. Martino si sono dette tante
sciocchezze, anche se sono sempre più insistenti le voci di cor-ruzione.
Partecipa alla pubblica inchiesta con il solo scopo di rac-cogliere dati certi ed informazioni sulle posizioni in gioco, maè decisa ad evidenziare contraddizioni e deformazioni.
Ritiene di rappresentare l’opinione pubblica veramenteobiettiva ed onesta.
NOTAIl ruolo di «presidente dell’assemblea» è normalmente
svolto da un docente, ma può essere ricoperto da un elemento(ragazzo o adulto) anche esterno alla classe.
Il suo compito è fondamentalmente quello di coordinare
l’assemblea (compito, normalmente, non facile), ma può eser-citare un ruolo attivo nel sollecitare interventi, argomenta-zioni e dati a supporto delle tesi sostenute, stimolandopossibilità di mediazioni ed accordi; deve reprimere con garbogli eccessi verbali ed evitare con cura di prendere posizione perl’uno o l’altro schieramento.
In questo senso potrà evidenziare le affermazioni prive di«fondamento» (annotandole durante il dibattito) perdelineare nelle successive fasi dell’attività didattica nuove pistedi ricerca; può, infine, utilizzare le argomentazioni ed i datiutilizzati per verificare l’acquisizione di conoscenze relativead un percorso didattico realizzato.
Al termine del gioco si può somministrare un questiona-rio di autovalutazione come quello riportato nella schedaoperativa n. 17 (pag. 40), i cui risultati possono essere utiliz-zati per la fase di discussione successiva.
Le valenze formative del gioco di ruoloAlcune opportunità didattiche del gioco di ruolo sono già
state evidenziate in premessa e nella descrizione della proce-dura. Durante il gioco, ad ogni modo, si scatenano tutte ledinamiche relazionali che intervengono in situazioni reali edogni ruolo è impegnato nel ricercare soluzioni e nuove argo-mentazioni per far passare la propria posizione.
Emergono informazioni ed aspettative personali, rela-zioni interpersonali e modi di vivere, nonché le varie conce-zioni del mondo e della vita sociale in particolare.
Possono verificarsi situazioni di aggressività verbale enon sempre si perviene alla mediazione delle posizioni(accordo), ovvero all’obiettivo indicato nel gioco per sollecitarele dinamiche.
Ciò permette di verificare la capacità di entrare in situa-zioni, di mettersi nei panni altrui, di formulare ipotesi, diesprimere giudizi, di migliorare capacità dialettiche, di rico-noscere i diversi punti di vista, adattandosi e rispondendo asituazioni imprevedibili, riconoscendo le «zone d’ombra» delleproprie conoscenze specifiche nella necessità di gestire situa-zioni di conflittualità.
In questo senso la discussione che deve opportunamentefar seguito «all’assemblea» può consentire di far emergere ivalori individuali ed inerenti al ruolo, allorquando vieneaffrontata la complessità dei sistemi ambientali e sociali, persuggerire maggiore consapevolezza e flessibilità.
MS S
CHEDA
10 P
ERCORSO
3
33
MS
Scheda 10Non lo butterebbe mai via…
Dopo aver preparato un questionario per raccogliere i dati utili, compila la seguente tabella:
Chi?Gli oggetti
che non butterebbe mai via sono:
Perché?Dove e come li conserva
La mamma
Il papà
La nonna
Il nonno
Mia sorella
Mio fratello
L’insegnante
… … … … … … …
… … … … … … …
… … … … … … …
P
ERCORSO
3 MS S
CHEDA
11
34
MS
Scheda 11Caccia al tesoro
Fai l’elenco dei rifiuti di casa per una settimana
■
Confronta il tuo elenco con quello dei tuoi compagni e trova i rifiuti che durantela settimana sono più frequenti:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Compila una tabella come quella qui di seguito:
■
Dove sta il tesoro?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giorno Rifiuti che ho trovato nella pattumiera
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Rifiuti più frequenti
Funzione ScopoSono
ricicla-bili?
Di quale materiale?
barattolo contiene pomodori igienico Si latta
vassoio contiene frutta protezione Sì polistirolo
MS S
CHEDA
12 P
ERCORSO
3
35
MS
Scheda 12Da dove provengono
Compila la tabella seguente dopo aver censito i rifuti di casa:
RSU materiale funzione scopo bisognoprovenienza
prossimaprovenienza
remota
barattolo lattacontiene
pomodori pelati
igiene alimentaresuper-
mercatoindustria
buccia organico rivestimento protezione alimentare mercato agricoltura
vassoio polistirolocontenitore
carneigiene alimentare
super-mercato
industria
P
ERCORSO
3 M S
CHEDA
13
36
M
Scheda 13Quanta ricchezza nella borsa della spesa
Aiutati dai vostri genitori dividete gli alimenti acquistati in una settimana–tipo in relazione al materiale di cui sono fatti i contenitori e compilate la seguente scheda
■
Elabora i dati trovati in una settimana evidenziando il numero di confezioni:
■
Confronta i risultati con quelli dei tuoi compagni.
AlimentoCarta e Cartone
Vetro Metallo Plastica Legno Altro
latte
✘
pasta
✘ ✘
Materiale numero di confezioni
carta e cartone
vetro
metallo
plastica
legno
altro
MS S
CHEDA
14 P
ERCORSO
3
37
MS
Scheda 14Necessario o… voluttuario
Rifletti sull’utilità o l’inutilità del contenitori di alcuni prodotti che compri o che vedi sullo scaffale del supermercato e compila la tabella che segue
■
Chiedi ad almeno 20 persone che incontri al supermercato come mai comprano undeterminato prodotto e riporta quanto nell’acquisto influisca l’aspetto esternodel contenitore o la pubblicità:
Domanda:
Compri un determinato prodotto perché?1. leggi l’etichetta e la confronti con quelle di altri prodotti2. ti piace la confezione3. hai visto la pubblicità e ti ha convinto sulla sua bontà4. perché costa meno5. altro… … …
■
Elaborando le risposte ho ottenuto:
… … … % delle persone comprano un determinato prodotto perché leggono l’etichetta e la confrontano con quelledi altri prodotti
… … … % delle persone comprano un determinato prodotto perché attratti dalla confezione
… … … % delle persone comprano un determinato prodotto perché hanno visto la pubblicità e sono convinti chesia buono
… … … % delle persone comprano un determinato prodotto perché costa meno
… … … % delle persone comprano un determinato prodotto per altro (specificare)
ProdottoIl contenitore
è necessario è voluttuariopuò essere sostituito
è utilizzato perché
vino nel cartone
✘
da vetroper scopi
economici
P
ERCORSO
3 MS S
CHEDA
15
38
MS
Scheda 15Quanto imballaggio
Nome dell’alunno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
settimana dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Confronta i dati trovati con quelli dei tuoi compagni.
Materiale contenitore Peso in hg Volume in dm
vetro
carta e cartone
Totale
M S
CHEDA
16 P
ERCORSO
3
39
M
Scheda 16Caro nonno… I rifiuti del passato
Questionario ai nonni del quartiere
■
Prova a chiedere ai tuoi nonni o a qualche anziano che conosci:
1. Qual era la durata degli oggetti come: capi di abbigliamento (vestiti e scarpe), arredi e suppellettili, oggetti per la cucina,altro (specificare).
2. Dove andavano a finire gli scarti dei cibi o degli oggetti che diventavano non più utilizzabili?
3. Cosa si faceva per conservare più a lungo gli oggetti?
4. Quali erano i «riutilizzi» più comuni dei vari oggetti prima di diventare rifiuti?
5. Descrivi una tua giornata di quando avevi la mia età. Di solito quanti oggetti buttavi via in un giorno?
6. C’è un oggetto della tua giovinezza che hai ancora conservato?
P
ERCORSO
3 S S
CHEDA
17
40
S
Scheda 17Il gioco di ruolo
■
Nome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Cognome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Secondo te come hai giocato?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Pensi che per giocare meglio sarebbero state necessarie ulteriori informazioni?
■
Avresti preferito giocare un altro ruolo?
■
Se sì, quale?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Perché
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Nel gioco erano messi in evidenza i conflitti che sorgono quando bisogna sce-gliere tra salvaguardia ambientale e occupazione. Qual è la tua personale opi-nione a riguardo?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■
Se si fosse trattato di una fabbrica dove in futuro potresti trovare lavoro, che opi-nione avresti avuto?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sì
l
No
l
Sì
l
No
l
41
Percorso 4Giochiamo con i rifiuti
Premessa
Tra la pattumiera di casa e la discarica ci sono…strade, piazze, giardini.Possiamo andare alla ricerca delsenno perduto dei nostri consumi. In città o nelle areeperiurbane vi sono luoghi dove sono sparpagliati rifiutiprodotti dai gesti abitudinari di ogni giorno. Spesso,quindi, non sono luoghi visibilmente «sporchi» (neancheeccessivamente puliti): spazi di verde, piazze del mercato,strade secondarie e cortili, ecc. Qui la sporcizia si insinuacome abitudine nell’osservare, lo sguardo che scivola via,incalzato dalla fretta del passaggio e dell’ora tarda, dalladisattenzione, dalla ripetitività, come il gesto che si ripete.La presenza di questi rifiuti è, quindi, quasi invisibile allanostra attenzione; essi non ci danno eccessivamente fasti-dio perché sono «sempre lì», frutto di passaggi umani,deposito di segni degli avvenimenti più quotidiani e piùnormali: pacchetti di sigarette, scatole, tappi, lattine, car-tacce di vario tipo e quant’altro vi si deposita.
Essi sono frutto di un lento accumulo in cui è possi-bile orientarsi e raccogliere le storie delle persone (adulti,bambini, famiglie, ecc.) che hanno, con i loro gesti,lasciato «segni».
Da questo punto di vista tali luoghi rappresentanouna specie di «sito archeologico»: posti dove è possibilelavorare sul terreno, alla ricostruzione di quelle storie i cuidocumenti sono lì a terra, pronti a raccontare.
L’attività che proponiamo offre, dunque, un diffe-rente punto di vista del problema rifiuti, molte volte esor-cizzato a parole e considerato nel suo stereotipo di valorenegativo e dunque «ovunque purché lontano da me e dalmio giardino». Esso stimola una lettura che avvicina ilgesto distratto alla responsabilità quotidiana. Questo tipodi luogo, con i rifiuti sparpagliati diventa il sito archeolo-gico in cui «scavare»; in cui scoprire la sovrapposizionedelle cose qui accadute, le relazioni degli avvenimentiattraverso la ricerca e la scoperta dei segni abbandonati.Può essere un viaggio nella memoria del luogo. Si faràanche attenzione alla presenza di eventuali «richiami» asituazioni di degrado: recinzioni abbandonate, angoli tra-sandati, esercizi commerciali poco curati. Ogni giorno, noi
tutti, costruiamo le nostre storie, che si intrecciano, chelasciano segni dove passiamo e dunque rifiuti.
Legare le storie ad un principio di responsabilità: iltempo è costruito dalle nostre scelte, i luoghi raccontanonoi stessi, per sapere che gettare una carta per terra (oinquinare un fiume) sono scelte fatte sulla base di valori (odi disattenzione ai valori altrui) e non sono oggetti sparsicasualmente nel nostro mondo. Seguire questo percorsovuol dire perseguire anche un altro obiettivo, quello di farcambiare l’accezione negativa di rifiuto in quella positivadi risorsa. Il gioco sta nel far assumere all’allievo il ruolofantastico dell’archeologo, dell’investigatore. Il percorso,nella sua conduzione esclusivamente «tecnica», si basa sullametodologia di ricerca archeologica denominata «ricogni-zione a terra», ed ha come obiettivo quello di costruirerelazioni tra avvenimenti e valori che li hanno determi-nati.
Un rifiuto può diventare «risorsa» nel momento in cuilo si utilizza per costruire un gioco, per realizzare un«oggetto utile», per creare una «ludoteca» di classe.
M S Scopriamo le storie del cortile (o strada o piazza)
Caratteristiche del luogo: piazza, cortile, area incoltaresiduale, giardino pubblico e qualsiasi altro luogo che pre-senti la caratteristica di una diffusione di rifiuti abbastanzasedimentata, ma non molto visibile.
Giunti sul luogo scelto dall’insegnante, gli alunni ven-gono invitati ad osservare, anche aiutandosi con un dise-gno, il luogo nel quale si trovano.
L’insegnante può presentare l’esperienza come ungioco di scoperta, una specie di «giallo» da risolvere.L’obiettivo è quello di far scoprire molti degli avvenimentiaccaduti nel luogo attraverso le «testimonianze rifiuto»presenti. La consegna consiste nell’invitare i ragazzi, indi-vidualmente, a cercare i rifiuti più o meno visibili presentisul terreno, disegnare su fogli di un blocchetto i tipi diversie raccoglierne in una busta due o tre al massimo (si puòanche fare una gara a chi disegna più tipi diversi). L’accor-
P
ERCORSO
4 G
IOCHIAMO
CON
I
RIFIUTI
42
tezza è quella di rappresentare ogni oggetto rinvenuto suun solo foglio, per questo si consiglia di usare un blocco afogli piccoli per ogni alunno. Terminato il lavoro si dà unaprima organizzazione al materiale trovato e rappresentato .
Su un grande foglio di carta da pacchi vengono appic-cicati a turno, con il metodo del domino, i singoli disegni,così da avere un quadro completo di ciò che è stato tro-vato. Il criterio della costruzione del domino è libero,lasciando alla scelta individuale dei ragazzi la possibilità diraggruppare i propri ritrovamenti per categoria di mate-riale, funzioni, colore ecc. (con i più grandi si aprirà qui unaltro aspetto da approfondire: le motivazioni in base a cuihanno scelto questo o quell’accostamento). In classe, dopoaver attaccato sul muro il «Grande Domino dei Rifiuti», sitirano fuori dalle buste i propri oggetti. Ci si dispone incerchio con i rifiuti di fronte e, a turno, si comincia ad illu-strarli. Qui la conduzione dell’insegnante deve restaremolto aperta, comunque è bene consigliare ai ragazzi uno«schema» di illustrazione che contenga:◆ perché è stato scelto, cosa lo ha colpito;◆ chi e perché può averlo lasciato a terra;◆ con quali altri oggetti, tra tutti quelli portati in classe,
può essere collegato da un avvenimento che li rendacomuni, o comunque in relazione.
I collegamenti individuati è bene che vengano resivisibili con un filo di lana, così da creare una rete di rela-zioni sul pavimento della classe. È bene, inoltre, che ven-gano recuperate nelle relazioni anche gli oggetti disegnatinel Grande Domino appeso alla parete. Discutendomolto, al termine del gioco avremo una serie di fatti acca-duti e ricavati dagli oggetti, evidenziati, nei loro collega-menti, dalla rete di fili di lana sul pavimento. Questiavvenimenti possono essere scritti o disegnati, collocati inuna temporalità relativa (prima, dopo, nello stesso tempo)e rappresentati nel modo che si ritiene maggiormenteopportuno. Questa attività, sostanzialmente, mette incampo una serie di abilità e qualità d’indagine che hannoal centro l’interpretazione. Per questo i materiali accumu-lati possono essere usati in vario modo: da uno studio dellecategorie generali dei rifiuti trovati (in base al DPR 915/82) alle possibilità di essere riciclati. Ma può anche essereutilizzato per un programma di educazione alla storia checonsenta l’accesso al concetto di tempo e relazioni tempo-rali.
M Caccia ai proprietari
Utilizzando la metodologia e i materiali del percorsoprecedente, si va alla ricerca dei proprietari di alcuni rifiutirinvenuti nel terreno. Il percorso è da impostare come unvero e proprio «giallo» da risolvere con l’obiettivo di sco-prire la provenienza di uno o più rifiuti, individuare chipuò averli lasciati e, al termine, riconsegnarli al proprieta-rio con una cortese lettera in cui lo si invita a deporlo nelcassonetto. Non sempre, naturalmente, è possibile fare
questo gioco: soltanto in presenza di rifiuti che siano visi-bilmente collegabili al sistema urbano immediatamentevicino al luogo scelto: in genere esercizi commerciali, diffi-cilmente privati cittadini. Le scritte sulle buste, ad esem-pio, possono aiutare molto, così come oggetti rinvenuti eriferibili ad un unico negozio della zona. Questo obiettivoconsente di tornare sul posto e studiare il luogo contestua-lizzandolo nel tessuto circostante, sotto l’aspetto della«produzione del rifiuto». Si tratta di un punto di vista che,per le abilità che attiva, ha qualche valore generale sulpiano educativo, in quanto colloca il percorso didattico inuna dimensione di «valori». La stessa restituzione delrifiuto al proprietario è senz’altro una «azione perl’ambiente» che può essere maggiormente efficace, sulpiano educativo, della pulitura di un cortile.
M Costruiamo la ludoteca
Seguendo le schede operative n. 18-19 (pag. 43-44)si può insegnare agli allievi a modellare giochi con la carta-pesta. Si possono costruire birilli, scacchi, plastici e burat-tini per giocare. Riciclare, riutilizzare, sono due parole chenel campo della tematica dei rifiuti diventano importantiin un percorso educativo che abbia come obiettivo il cam-biamento di comportamenti e l’assunzione di responsabi-lità. Utilizzare i rifiuti per costruire giochi tradizionali ofantastici, diventa un’attività efficace al fine di «far toccarecon mano» la chiusura del ciclo: risorsa-rifiuto-risorsa;inoltre sdrammatizza e rende divertente una problematicasempre più spesso collegata a inceneritori da costruire, adiscariche al limite della capienza, a sacchi abbandonati aibordi delle strade ecc. Riutilizzare i rifiuti per giocare avvi-cina i ragazzi ad un passato che non conoscono, quello incui i loro nonni utilizzavano proprio gli scarti per giocareed allora quattro legni ed una tavola diventavano un«bolide di formula uno»; gli stracci di un vestito vecchiouna bambola, la carta da buttare veniva ripiegata per fareaereoplanini, barchette, frecce ecc. Inoltre si può proget-tare una vera e propria ludoteca di classe.
Anche i rifiuti come bottiglie di plastica, lattine,vasetti di yogurt, possono costituire materie prime per rea-lizzare giochi.
Tanti possono essere gli spunti che vengono da questaattività e tanti possono essere gli stimoli che ci arrivanodagli stessi alunni, che sono gli «esperti» migliori in fattodi giochi.
M S
CHEDA
18 P
ERCORSO
4
43
M
Scheda 18Facciamo la cartapesta
Come realizzare la cartapesta
■
La realizzazione della cartapesta prevede le seguenti fasi di lavoro:
1. Raccolta di un abbondante quantitativo di carta possibilmente di giornale (non patinata)
2. Sminuzzamento della carta: più i pezzettini sono piccoli, maggiore sarà la qualità del prodotto finito
3. Si fa bollire l’acqua con i pezzetti di giornale per circa mezz’ora
4. Si lascia a bagno in acqua bollente per un giorno intero
5. Completato il periodo di ammollo si estrae dal recipiente una manciata di carta per volta. Si strizza la «palla», ma noneccessivamente, poi si batte sul tavolo con martelli di legnoLa palla di carta deve essere battuta molto forte fino a quando non si riesce più a leggere nessuna scritta del giornale uti-lizzato. Terminata la battitura la poltiglia ottenuta va «sfibrata», cioé grattata con la punta di un coltello alla ricerca dipiccoli noduli o piccoli fogli non ancora battuti.Utilizzare per questa operazione guanti da cucina.Attenzione: la Fase 5 è quella più delicata e va eseguita con molta precisione.
6. Quando il mucchietto di pasta sfibrata è pronto, si prepara la colla.Per preparare la colla si possono seguire due procedimenti: o si utilizza polvere di colla ed acqua rimestando continua-mente finché si ottiene una consistenza simile a quella del miele;oppure si fanno bollire 3 tazze di farina con 9 tazze di acqua fino a consistenza voluta e si aggiunge un cucchiaino diaceto perché il tutto non si deteriori.
7. Si impasta la colla con la pasta sfibrata facendo molta attenzione a non lasciare bolle di aria e ad aggiungere la colla pro-gressivamente volta per volta
8. Si lavora l’impasto fino a quando, infilando un dito nello stesso, si ottiene un foro i cui bordi si presentano omogenei esenza creste.
Con la cartapesta si possono realizzare: plastici, burattini, giochi; personaggi per il presepe, statuette ecc.
P
ERCORSO
4 M S
CHEDA
19
44
M
Scheda 19Facciamo la carta riciclata
Come realizzare la carta riciclata
■
La realizzazione della carta riciclata prevede le seguenti fasi di lavoro:
1. Raccolta di un abbondante quantitativo di carta diversificata (possibilmente non patinata)
2. Sminuzzamento della carta
3. Messa a bagno in acqua calda per una notte
4. Frullatura dell’emulsione formatasi al punto 3
5. Preparazione del telaietto delle stesse dimensioni del foglio che si vuole produrre
6. Stesura dell’impasto sul telaietto in modo che lo spessore sia uguale in tutte le sue parti
7. Scolatura dell’acqua e prima asciugatura
8. Separazione del foglio dal telaietto e asciugatura definitiva
■
Le attività didattiche e la carta riciclata
Le attività didattiche legate al laboratorio per la produzione della carta riciclata rappresentano un percorso del pro-getto di Educazione Ambientale sui rifiuti e si collocano nella fase del lavoro sul campo, evidenziata nella parte generale dicostruzione del progetto.
Le attività portano, quindi alla realizzazione di un obiettivo concreto che si può evidenziare in tre prodotti diversi:
1. realizzazione di carta riciclata2. utilizzo per la produzione di oggetti vari con la carta riciclata prodotta3. indagine per una settimana sulla quantità dei rifiuti (ad esempio nel cestino dell’aula) dopo aver tolto la carta da rici-
clare
È molto importante che l’attività didattica non finisca solo con la produzione di carta riciclata bensì con la realizza-zione di un prodotto utile (quadro, taccuino, diario, piccolo quaderno ecc.) che faccia comprendere la trasformazione del«rifiuto carta» in risorsa immediatamente utilizzabile.Inoltre abbinare il riciclo della carta con la diminuzione dei rifiuti èun percorso educativo che permette di far comprendere al ragazzo l’importanza del riciclo.
45
Percorso 5L’ambiente è anche mio e…
Premessa
È questa la parte conclusiva dei percorsi, in cui lascuola stabilisce un dialogo con le istituzioni e con i citta-
Scuola media “Odescalchi” – Ladispoli (Roma)
dini, cercando alleati per cambiare la realtà. L’obiettivo èsollecitare le trasformazioni di abitudini di vita consoli-date e poco rispettose delle risorse e degli equilibriambientali.
In questo senso le attività suggerite si ispirano all’ideache la scuola può esercitare un ruolo importante di «solle-citatore» di responsabilità nei confronti dei problemiambientali, sia al suo interno, coinvolgendo ragazzi edinsegnanti, sia nei confronti dei cittadini e della pubblicaamministrazione, in modo che la scuola torni ad esserepromotrice di culture ed esigenze di cambiamento ed ilragazzo possa sentirsi partecipe della vita della comunità inmodo propositivo ed essere considerato «cittadino» a pienotitolo.
La concretezza e la rilevanza locale del problemarifiuti, il lavoro sul campo, possono facilitare il legame trascuola e territorio.
È attraverso l’impegno ad «agire» che con più evi-denza si mettono in discussione gli atteggiamenti ed icomportamenti personali: un passo obbligato per arrivaread assumersi la responsabilità delle scelte nei confrontidell’ambiente.
L’azione per l’ambiente non deve essere una costru-zione propagandistica di iniziative, ma la conseguenzalogica di un processo di scoperta della realtà e delle possi-bilità concrete, commisurate alle capacità dello studente,di agire per cambiarla. In questo modo la mentalità ecolo-gica si manifesta nella sua ricerca di coerenza non per acri-tica adesione ai modelli comportamentali propostidall’insegnante, ma per profondo convincimento dellanecessità che i comportamenti non siano in contrasto conle conoscenze acquisite: l’azione per l’ambiente assume,così, funzione formativa. Di qui l’idea che ognuna delleattività di seguito proposte possano essere concepite, sianegli aspetti di merito che organizzativi, in modo da deter-minare la più incisiva proiezione territoriale del ruolo dellascuola: in questo senso si avrà cura di predisporre efficacistrumenti informativi e pubblicitari delle iniziative pro-mosse (comunicati-stampa, volantini, manifesti ecc.) perassicurarsi i più ampi coinvolgimenti (famiglie, quartiere,amministratori, commercianti ecc.) nella valorizzazione
P
ERCORSO
5 L’
AMBIENTE
È
ANCHE
MIO
E
…
46
dei «prodotti» realizzati dai ragazzi (interventi di pulizia,mostre, dibattiti, raccolte differenziate, prodotti riciclati,manifestazioni di sensibilizzazione ecc.). Lo sbocco «natu-rale» di ognuna delle azioni proposte è una «Conferenza diOrganizzazione con i responsabili della pubblica ammini-strazione» per discutere e analizzare insieme il problema, lepossibili soluzioni e le iniziative da intraprendere nei con-fronti della cittadinanza, a cui la scuola può dare il suocontributo.
M S Ronde ecologiche
Le nostre aree verdi urbane sono spesso gestite e fruitein modo improprio: incuria, inciviltà, ma soprattutto…tanti rifiuti.
Costruire una mappa della qualità delle aree verdiurbane presenti nel proprio territorio può essere un’occa-sione formativa per le classi ed, al contempo, può fornirealle autorità e a tutta la cittadinanza dati ed informazioniricavati dalla propria attività di esplorazione e di cono-scenza.
Questionari, interviste, documentazioni video e foto-grafiche: l’azione per l’ambiente può partire da attività diricerca di dati e di opinioni, da socializzare nella scuola, nelquartiere, nel paese, con volantini o manifestazioni pubbli-che.
È un’occasione «forte» per l’organizzazione di attivitàindividuali e di gruppo, in cui cogliere i cambiamenti inatto nella sensibilità e nei comportamenti dei ragazzi.
Si possono, ad esempio, promuovere ed organizzare«ronde ecologiche» che vigilino sul territorio urbano perprevenire l’abbandono incontrollato di rifiuti e sensibiliz-zare i cittadini a comportamenti più corretti, completandol’intervento con la produzione di cartelli che segnalino aicittadini (e ai responsabili amministrativi) l’infrazione.
M Un bosco di… carta
Un modo indiretto, ma altrettanto efficace, di porrel’attenzione sui grandi sprechi di materiale cartaceo cherichiamano le immense azioni di disboscamento è quellodi promuovere la raccolta differenziata della carta.
Cifre incredibili che possono stimolare e giustificareun’iniziativa a scuola di raccolta che preveda una campa-gna di sensibilizzazione della cittadinanza al problema, uncentro di raccolta autogestito dalla scuola, premi costituitida quaderni e blocchi, ovviamente, in carta riciclata esoprattutto tanti alberelli (da richiedere, eventualmente aivivai del Corpo Forestale dello Stato) da piantumare ed«adottare» nelle vicinanze della scuola o, comunque, inaree degradate e di interesse pubblico. L’idea per comuni-care l’iniziativa all’esterno potrebbe essere la realizzazionedi un «bosco interno alla scuola» fatto con la carta raccoltae di un «bosco esterno alla scuola» con la piantumazione di
alberelli. L’iniziativa potrebbe essere completata facendodeliberare al Consiglio di Istituto l’obbligatorietà dell’usodi carta riciclata per le attività di segreteria e degli altriuffici nella scuola. È evidente che attività come queste,oltre a fornire occasioni di approfondimento disciplinari(raccolta dati, pesa, percentuali e indici di raccolta, diffu-sione di consumi, ecc.), consentono, con una certa abilitàdidattica, di porre l’attenzione su concezioni e processi disfruttamento delle risorse e dell’ambiente che non tengonoconto della loro esauribilità e degradabilità, coniugandotemi locali con le grandi questioni planetarie quali l’effettoserra e le massicce deforestazioni che avvengono nel suddel mondo.
M Carta riciclata in proprio
Un modo per dimostrare la fattibilità di alcuni inter-venti di recupero e di riciclaggio dei rifiuti è rappresentatodalla semplice realizzazione di carta riciclata a scuola.Dopo averla realizzata seguendo le istruzioni contenutenella scheda operativa n. 19 (percorso 4 pag. 44) bisognacommercializzarla, inventando utilizzi originali ed ade-guati alla qualità che si è riusciti a produrre.
Per i più grandi vale la pena pensare anche ad una verae propria campagna pubblicitaria, con tanto di produzionedi materiale grafico e video, per appoggiare la commercia-lizzazione. Spingendosi fino ad un calcolo di investimentoeconomico.
M S Anche per riutilizzare e riciclare ci vuole arte
Quest’attività mette immediatamente in evidenza lapossibilità di decontestualizzare gli oggetti per valorizzarnele potenzialità riguardo, ad esempio, al riuso.
L’intento è quello di sollecitare la capacità di «vedere»anche ciò che non è esplicito od ovvio: tutti possonoessere, infatti, portati a guardare una bottiglia di plasticavuota immaginando un personaggio birillo, un salvada-naio capiente, un espositore di conchiglie e di ciottoli difiume o, addirittura, un modello di uno studio stratigra-fico del suolo!
Pertanto si possono stimolare i ragazzi a pensare aicontenitori come qualcosa da riutilizzare o riciclare (seproprio non se ne può fare a meno!), proponendo airagazzi di ipotizzare creativamente il riuso dei vari conteni-tori per funzioni diverse e, perché no, anche decorative edartistiche!
M S Operazione strada pulita
Questa attività ha come obiettivo il coinvolgimentooperativo di alunni ed eventualmente cittadini nella puli-
L’
AMBIENTE
È
ANCHE
MIO
E
… P
ERCORSO
5
47
zia di una strada (o di un bosco o di un’area verde urbana),in modo da dimostrare che, spesso, basta un minimo diimpegno e di partecipazione per tenere pulito un luogo.Può essere pensata e studiata insieme ai ragazzi, tenendoconto dei necessari interventi burocratici ed organizzativi.
Oltre alle varie comunicazioni e richieste di autorizza-zione, sarà bene coinvolgere eventuali commercianti pre-senti sulla «strada» (anche per utili sponsorizzazioni),nonché a guanti, pinze e bustoni per la raccolta dei rifiuti.Utili contatti con la locale azienda di nettezza urbanapotranno assicurare lo smaltimento finale dei rifiuti rac-colti.
M
Ecomuseo di strada
L’idea è fondamentalmente quella di realizzare un«percorso» (non solo in senso fisico) educativo per grandi ebambini.
Su opportuni tabelloni o su tavoli espositivi possonoessere sistemati tutti i «prodotti» delle attività realizzate ascuola:
◆
merci riciclate o riusate;
◆
posters e/o foto che riassumano il percorso di rifiuti,reale ed ideale;
◆
immagini di discariche abusive diffuse nel territorio, odei punti più trasandati che richiamano alla trasanda-tezza e l’accumulo improprio dei rifiuti, raccolte dalle«ronde ecologiche»;
◆
foto relative ad esperienze ed esperimenti realizzati ascuola sui concetti basilari che riguardano i rifiuti,come ad esempio la biodegradabilità ;
◆
foto e grafici che riguardino «il tesoro di famiglia» (laproduzione familiare e locale di rifiuti);
◆
informazioni sui procedimenti della raccolta differen-ziata e del riciclo, con «Istruzioni per l’uso»;
◆
dati e grafici sulla locale produzione di rifiuti e sullostato dello smaltimento ufficiale;
◆
imballaggi e contenitori «ieri ed oggi», (con immagini ereperti d’epoca), con poster di commenti sulla filosofiadell’usa e getta;
◆
consigli «ecologici « per gli acquisti;
◆
le «ricette risparmio» per il riciclaggio degli avanzi ali-mentari;
e quant’altro si ritenesse utile esporre e comunicare inrelazione al percorso didattico realizzato.
L’ecomuseo può terminare con… prove di assaggio di«ricette risparmio», fatte con ciò che l’indifferenza o lanegligenza avrebbe reso rifiuto.
Recuperare dalla tradizione tante buone pietanze, rea-lizzate con gli avanzi alimentari, per dare una rispostaall’altra faccia, quella più conosciuta, del consumismo eper ricordare che più di un milione di tonnellate di cibifiniscono in pattumiera.
M
Consigli ecologici per gli acquisti
In base alle conoscenze acquisite si può strutturare,con i ragazzi, un «decalogo» (es. uso di vassoi di cartoneper frutta e verdura al posto del polistirolo o dellevaschette di plastica; acqua minerale in bottiglia di vetro arendere e non in quelle di plastica… ).
Si può scrivere anche ai distributori di bibite, latte,chiedendo quanto incida il costo della confezione sulprezzo del prodotto, o, più in generale, quali siano le moti-vazioni per cui il prodotto non è stato confezionato inmodo più ecologico (es. latte in scatola invece che nellabottiglia di vetro). Un «prodotto» del genere può essereutilizzato per azioni di sensibilizzazione in famiglia, ascuola o nel quartiere, coinvolgendo eventualmente ildirettore del supermercato o, meglio, esponendogli diret-tamente le motivazioni dei suggerimenti raccolti.
Tale attività può opportunamente configurarsi comemomento di verifica.
Conoscenze, valori, qualità dinamiche possono essereattentamente valutate con opportune griglie osservativesenza tralasciare indizi emergenti che possono prefigurare«nuovi» comportamenti individuali.
S
Giornata dell’imballaggio inutile
Forse è giunto il momento di realizzare una «Giornatadell’imballaggio inutile», con una azione diretta di sensibi-lizzazione e di composta protesta: recarsi «in modo visi-bile» (striscioni, manifesti ecc.) al supermercato, fare unasimbolica spesa settimanale (previo accordo mirato con lefamiglie), pagarla regolarmente, per poi lasciare allo stessosupermercato tutto l’imballaggio inutile, compreso quellodelle merci alimentari e non, utilizzate nel corso della setti-mana precedente. Come a dire: «È vostro, non ci serve,tenetevelo!»
Se il percorso didattico avrà avuto una sua «coerenzainterna», tale «azione per l’ambiente» non apparirà unaforzatura e potrà risultare anche divertente sensibilizzare iconsumatori sul continuo aumento di inutili imballaggi eprotestare contro i supermercati ed i produttori perché,così facendo, non fanno che scaricare sulla collettività icosti (monetari ed ambientali) relativi all’acquisto dellamerce ed allo smaltimento dei rifiuti.
È evidente che va mantenuta l’accortezza di struttu-rare ed organizzare attività come quelle descritte in modoche i ragazzi vivano l’iniziativa come «protagonisti» di uncambiamento possibile.
P
ERCORSO
5 L’
AMBIENTE
È
ANCHE
MIO
E
…
48
M S Facciamo il compost
Le scuole di Colle Val d’Elsa dopo aver sperimentato,attraverso osservazioni ed attività di laboratorio, la strut-tura del suolo, la sua permeabilità, la presenza di micro-fauna nel suolo, la presenza di microrganismi in un infusodi paglia, hanno tratto queste conclusioni:
◆ In natura i materiali biologici vengono degradati da unamoltitudine di organismi diversi (muffe, protozoi, batteri,piccoli animali… ).
◆ Questi organismi si nutrono di materiali biologici discarto.
◆ Il luogo dove in natura avviene la degradazione è il suolo,ed in particolare lo strato superficiale.
◆ In natura tutto ciò che risulta di scarto per un gruppo diorganismi, è di nutrimento per altri.
Quindi:IN NATURA NON ESISTONO RIFIUTI.
◆ Da cui deriva la conclusione fondamentale:il modo più corretto per smaltire i nostri rifiuti (organici) èimitare i cicli naturali.
Per confermare questa ultima conclusione le scuolehanno fatto il seguente importante esperimento finale e lopropongono alle altre scuole:
SMALTIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI MEDIANTE DECOMPOSIZIONE BIOLOGICA
E PRODUZIONE DI COMPOST VERDE.
Materiali occorrentiRifiuti organici accuratamente selezionati; bidone per
compostaggio (composter); attrezzi per giardinaggio.
EsecuzioneSi introducano con lezioni teoriche, materiali audiovi-
sivi, inchieste ecc. le caratteristiche merceologiche dei rifiuti esi spieghino i concetti base della raccolta differenziata. Si fac-cia quindi portare a scuola un quantitativo di rifiuti organiciaccuratamente selezionati, chiedendo magari un coinvolgi-mento attivo delle famiglie. Le scuole dotate di mensa inoltredovrebbero recuperare gli avanzi e gli scarti di cucina. Siimmettano poi i rifiuti all’interno di un bidone per compostseguendo scrupolosamente le indicazioni date dalla casa
costruttrice. Nell’arco di un periodo di tempo che va da tre acinque mesi, secondo le condizioni ambientali di tempera-tura, umidità, tipo dei rifiuti usati, struttura del suolo ecc, irifiuti si decomporranno generando un compost verde di altaqualità utile per la concimazione di orti e giardini comeammendante. Durante il periodo di formazione del compost,si possono fare dei prelievi di materiale, ed osservare come alsuo interno si sviluppi una flora microbica molto simile aquella presente nella lettiera.
Le classi coinvolte a questo punto hanno tratto alcuneconclusioni:
◆ I rifiuti organici vengono trasformati in una sostanza, ilcompost, di aspetto molto simile all’humus osservato nelbosco.
◆ Gli organismi ivi osservati sono molto simili a quellidell’humus.
Quindi◆ È possibile, utilizzando i microorganismi e simulando le
condizioni del bosco, ottenere materiali simili all’humusdai rifiuti.
◆ È possibile riciclare buona parte dei rifiuti organici ren-dendo il sistema umano simile a quello naturale.
◆ «È POSSIBILE CHIUDERE IL CERCHIO».
S A caccia di… discariche
Lo hanno fatto gli studenti dell’I.T.G «De Lorenzo»di Potenza all’interno di un progetto denominato «Gli stu-denti impegnati come sentinelle dell’ambiente».
Sono andati alla ricerca di discariche controllate enon, hanno valutato gli effetti causati dalla non bonificadelle stesse e hanno fatto le analisi sulla qualità e la quan-tità dei rifiuti prodotti nel proprio ambiente.
Tutto questo al fine di definire una mappatura di pic-cole e grandi discariche non controllate presenti sul loroterritorio, con lo scopo di arrivare ad una denuncia dellestesse alla pubblica amministrazione.
Il risultato di questo lavoro è stato poi raccolto inschede che oltre alla località dell’area indagata contengonol’immagine fotografica a documentazione del tipo di rifiutipresenti nelle discariche non controllate e la descrizionesulla tipologia degli stessi.