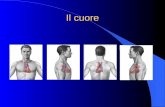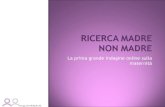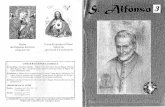Figlie della Chiesa copia...La nostra dolcissima Madre ce la ottenga e faccia di noi tutte un cuor...
Transcript of Figlie della Chiesa copia...La nostra dolcissima Madre ce la ottenga e faccia di noi tutte un cuor...

MARIA OLIVA BONALDO
Figlie della Chiesa

PRESENTAZIONE
Tra i numerosi scritti che testimoniano il grandeamore per Gesù e la Chiesa della nostra Fondatrice,la Serva di Dio Maria Oliva Bonaldo del CorpoMistico, “Figlie della Chiesa” occupa un posto spe -ciale.
Nel 1934, quando l'Istituto viveva soltanto nelsuo cuore, ci aveva offerto con i 33 foglietti il primoStatuto dell'Opera, ampio tentativo iniziale di darevoce alla sua ispirazione carismatica e alla suacomprensione del mistero della Chiesa, basandosisulla Parola di Dio, la Liturgia, il Magistero.
Nel 1973, dopo 35 anni di vita della nostraFamiglia, la Madre, in obbedienza al ConcilioVaticano II, ha voluto consegnarci la sua ampiariflessione sul carisma alla luce degli insegnamenticonciliari, in modo che il Capitolo Generale del1974 potesse accoglierne tutta la ricchezza e attua -lizzarla nelle Costituzioni rinnovate.
È straordinario l'impegno di questa donna ottan -tenne, che con la freschezza del primo amore ècapace di rileggere con grande lucidità il vissutodell'Istituto, attenta non solo al passato e al presen -te, ma con grande apertura al futuro.
3
1a edizione 19732a edizione 19773a edizione 19931a ristampa 2 0 1 0

CJJC
Lourdes, 15 agosto 1973
Carissime figliuole e sorelle capitolari,
«il Capitolo speciale» e la Commissione capi -tolare successiva hanno affidato a me, alle Sorelleconsigliere e ad alcune altre Sorelle lo studiodelle Costituzioni perché il prossimo capitoloelettivo, che sarà pure legislativo, possa compi -larle definitivamente.
A me è stato assegnato il I° capitolo, sintesidelle Costituzioni stesse, e ho dovuto quindi esten -dere il mio lavoro, pur da un punto nuovo diosservazione, a tutto il loro contenuto. Mi preme -va farvi cogliere lo spirito nostro con le sueespressioni e chiarire l’uno e le altre con faciliriflessioni.
Per questo il lavoro si presenta diviso in cin -que fascicoli, ognuno dei quali raccoglie sotto unsolo titolo:
a) alcuni principi su cui si basa il nostro spirito;b) le sue espressioni principali;c) riflessioni, ricordi, prospettive...
5
Puntualizza sinteticamente i principi pere n n iracchiusi nello spirito che anima e deve continuarea vivificare la sua Famiglia religiosa; specifica leespressioni concretizzate nel tempo; si attarda inriflessioni che spiegano diffusamente le scelte com -piute ed indicano le prospettive aperte dal Concilio,per intrapre n d e re percorsi adeguati alle nuovesituazioni sociali ed ecclesiali.
Possiamo considerare un prezioso patrimonioper noi il metodo di riflessione e discernimento uti -lizzato dalla Fondatrice. Mettendoci in sintonia conLei, vogliamo continuare a vivere con attiva parte -cipazione la nostra vocazione ecclesiale, attente alleindicazioni e sollecitazioni della Chiesa nostraMadre, felici di dare il nostro apporto filiale allaconoscenza del grande Mistero che ci attrae e cispinge alla testimonianza.
Queste pagine ci riconfermano nell'amore aGesù e alla Chiesa, suo mistico Corpo; ci ridonanoslancio missionario e ci spingono ad accogliere consempre maggiore disponibilità l'azione dello Spiritoin noi, per essere ogni giorno di più a gloria delPadre.
Sorella Sotgiu Maria Teresa di Gesù CrocifissoSuperiora Generale
4
25 marzo 2010Solennità dell’Annunciazione del Signore

Per questo ho cercato questo spirito nuovosoprattutto nei documenti del Vaticano II, nei qualilo Spirito santo l’ha mirabilmente riversato contutte le sue espressioni: biblica, liturgica, teologi -ca, pastorale, ecumenica, missionaria, escatologi -ca e ho tutto rielaborato prevalentemente coi testistessi del Concilio che, come i testi biblici deln o s t ro primo statuto, secondo il proprio modo sonoanch’essi spirito e vita (DV).
Ho pure dato un nuovo orientamento per lacompilazione delle Costituzioni: la vita religiosa ètrattata dopo i due primi fascicoli dedicati esclu -sivamente alla nostra vita ecclesiale che è l’esem -plare essenziale e vitale della vita religiosa e chelogicamente dovrà avere la precedenza anchenelle Costituzioni.
Prima di ogni dialogo, consultazione o discus -sione pregherei ogni sorella di esaminare tuttopersonalmente, di vedere se i cinque punti espri -mono chiaramente il nostro spirito, se le cinquecorrispondenti espressioni sembrano sufficiente -mente adattabili alle esigenze del nostro tempo esoprattutto se spirito ed espressioni esprimonoautenticamente «lo spirito delle beatitudini»,senza il quale il mondo non può essere trasfigu -rato e offerto a Dio (LG 31).
Le vostre osservazioni e i vostri suggerimentisaranno preziosi per una successiva rielaborazio -
7
I cinque capitoli hanno i seguenti titoli che sin-tetizzano il loro contenuto:
1. Il nostro Mistero2. Partecipazione sacramentale 3. Partecipazione carismatica4. Partecipazione specifica5. Partecipazione pienaI principi schematicamente, le espressioni bre -
vemente, le riflessioni diffusamente.Per la revisione delle Costituzioni, iniziata dal
«Capitolo speciale», mi erano stati dati due oppo -sti suggerimenti: o fare solo qualche ritocco, oritoccarle tutte. L’opposizione in realtà non c’è,perché il primo suggerimento si riferisce all’es -senziale, che non va toccato, o con cautela; ilsecondo si riferisce all’accidentale, che può esse -re tutto mutato con spirito nuovo, da normenuove, da nuovi orientamenti, sempre più adatti ainostri tempi e ai nuovi campi dell’apostolato (PC20).
Lo spirito nuovo che la Chiesa ci sollecita apromuovere è indubbiamente lo spirito avvertitodalla Chiesa del Concilio: un’animazione diSpirito santo che dovrà investire tutta la nostravita, tutto il nostro modo di sentire e di agire,«perché possiamo rendere presenti Dio Padre e ilFiglio suo incarnato: compito della Chiesa enostro» (GS 21).
6

ne. Non aspettatevi un trattatello con precisi prin -cipi e conseguenti argomentazioni: spunti dottrina -li sì, ma senza nessuna pretesa dottrinale.
Ho scritto ex corde per voi e basta.Ai piedi di Gesù e col rosario fra le mani non vi
mancherà la luce che viene dall’alto e che in que -sto lavoro dovrà venire soprattutto dall’altare .
La nostra dolcissima Madre ce la ottenga efaccia di noi tutte un cuor solo nel cuore del suocuore, Gesù.
Vostra aff. ma Madre e Sorella
8
Il nostro mistero

11
SPIRITO
Le Figlie della Chiesa per la loro consacrazionebattesimale e religiosa, si propongono di glorifica-re Dio Padre nostro (Mt 6,9), Padre di tutti (Ef 4,6),Fonte d’amore (AG 2), da cui è scaturito il mirabi-le sacramento della Chiesa (SC 5) loro Madre (LG6), Corpo e pienezza di Cristo (Ef 1,23), che loSpirito santo unifica (LG 4) nella comunione e nelministero e che in Maria, Madre della Chiesa, haraggiunto la sua perfezione (LG 65).

1312
RIFLESSIONI
Siamo nate nella Chiesa per glorificare DioPadre nostro inserendoci nel piano universale sca-turito dalla sua carità che è l’organica unità di tuttii suoi figli, sicché come è creatore di tutti possaanche essere tutto in tutti (AG 2).
A chi ci chiedeva agli inizi: Qual è il fine dellavostra opera? rispondevamo: La gloria del Padreceleste.
La dizione fu accettata nella prima stesuradelle Costituzioni, grazie a San Matteo che è l’e-vangelista del Padre celeste, del Padre del cielo.
San Giovanni che più di cento volte parla delPadre, non ha un cenno sul cielo e così San Paoloe gli altri agiografi neotestamentari.
Nell’approvazione definitiva, dopo qualcheresistenza teologica, il Padre celeste fu sostituitoda «Dio Padre nostro» (Mt 6,9) frequente in SanPaolo, che accettammo con intimo gaudio perchérestava nella sua personale distinzione la «Fonte
ESPRESSIONI
La Chiesa manifesta agli uomini il suo Misterocon la Parola di Dio che ne è la rivelazione.
Le Figlie della Chiesa vivono di ogni Parolache esce dalla bocca di Dio (Mt 4,4), l’accolgonocon l’ascolto personale e comunitario, privato epubblico, la meditano come Maria nel loro cuore(Lc 2,51) e danno la precedenza a quella che laChiesa propone giorno per giorno e commenta aisuoi figli.
Si dedicano allo studio sacro sulla base di unaformazione globale (GS 60) che consenta un’ag-giornata catechesi, l’umile intelligenza dellaRivelazione e l’accostamento alla teologia partico-larmente mistica, perché le facoltà naturali esoprannaturali dell’intuizione, dell’ammirazione edella contemplazione si orientino verso le mirabiliRealtà che il Padre nasconde ai sapienti e agli intel-ligenti e rivela ai semplici (Lc 10,21).

1514
santo ci ha ricondotti dove Gesù mirava e ci hariesortato a pregare il Padre di tutti gli uomini pertutti gli uomini.
Ci ha pure insegnato a glorificarlo rivelandociil mistero della sua gloria.
L’incomunicabile gloria di Dio, nella storia delpopolo di Dio è rappresentata e promulgata dateofanie e dossologie stupende:
La mia gloria sarà sempre nuova (Gb 29,20).La gloria di Jahvé si levò sopra i cherubini (Ez
10,4).La gloria di Jahvé dimorò sul monte Sinai e la
nube lo riempì per sei giorni (Es 24,16).La gloria di Jahvé in cima al monte, aveva l’a -
spetto di un fuoco divoratore (Es 24,17).Il sole che sorge brilla su tutta la terra, la glo -
ria di Jahvé sopra ogni cosa (Ec 42,16).I cieli la narrano col loro mirabile ordine, la
cantano schiere innumerevoli di angeli, la terratutta la deve proclamare e promuovere:
Voi in oriente glorificate Jahvé (Is 24, 15).Proclamate fra i popoli la sua gloria (Ps 96,3).Popoli tutti, lodate il Signore, glorificatelo
nazioni tutte (Ps 117, 1 ).Tutti i popoli contemplano la tua gloria (Ps 97,6).Su tutta la terra si spande la tua gloria (Ps 57,6).O terre tutte, acclamate al Signore, inneggiate
alla gloria del suo nome (Ps 65,1- 2).
d’amore» (AG 2; 1Cor 15,28) in cui si immerge-vano gli occhi di Gesù che tutto riferiva a gloriadel Padre suo.
Nella revisione delle Costituzioni, oggi pre-scritta, a Dio Padre nostro che include l’invoca-zione insegnataci da Gesù stesso, osiamo aggiun-gere la precisazione Padre di tutti (Ef 4,6), sugge-rita dallo Spirito santo a San Paolo e alla Chiesadel Vaticano II per ricordarci che compito dellaChiesa è di rendere partecipi tutti gli uomini dellasalvezza operata dalla redenzione e per mezzo diessi ordinare effettivamente il mondo intero aCristo, a gloria di Dio Padre (AG 2).
Quest’ampiezza ci sgancia dalle nostre personee dai nostri gruppi, per farci sentire la responsabi-lità della salvezza universale.
Quando Gesù insegnava agli Apostoli la gran-de preghiera aveva davanti agli occhi e nel cuorela lunghezza, la larghezza, l’altezza e la profon-dità (Ef 3,18) del suo Mistero di salvezza, implo-rava che tutte le lingue santificassero il nome delPadre suo, che tutti i cuori accogliessero il suoregno, che tutte le volontà facessero la suavolontà, che si moltiplicassero le messi per il panedi tutti, che la giustizia e la carità fosse in tutti eper tutti la libertà dal male.
Ma noi siamo gretti e limitati, ignoriamo odobliamo le dimensioni dell’amore. Lo Spirito

1716
suo con gli Angeli santi e in lui saremo assuntinella gloria di Dio Padre (Mt 16, 27; Mc 8,38).
Per entrare in questo piano d’amore, in questoregno e tempio di Dio in cui tutti dicono: Gloria!la porta è stretta (Mt 7,13).
L’ha aperta Gesù annientandosi. Vi è entrataper prima Maria che piacque all’Altissimo perchépiccolissima, poi San Giuseppe, il più piccolo nelregno dei cieli, gli Apostoli, piccolo gregge, iSanti che seppero ritornare fanciulli e vi entrere-mo anche noi se come i fanciulli apprenderemodalla Chiesa nostra Madre a imitarli cantandonella liturgia semplicemente le lodi dei cherubinie dei serafini e vivendo nella spontanea povertà dispirito che esprimono col loro bisogno di tutti eche ha fatto trasalire di gioia Gesù nello Spiritosanto: Ti glorifico, Padre, Signore del cielo e dellaterra, perché hai nascosto queste cose ai sapientie agli scaltri del mondo e le hai rivelate ai picco -lini. Sì, Padre, perché questo è stato il tuo bene -placito (Lc 10, 21).
Il mirabile sacramento
Storicamente, come risulta dalla biografia diOlga, siamo nate nella Chiesa per la salvezza deinostri fratelli, i figli suoi. Ma la figura della
La liturgia prolunga il gloria degli Angeli eraccoglie e tramanda tutti gli inviti della Scritturacon la sua ininterrotta dossologia che si concentrain Gesù, gloria del Padre.
Ogni lingua proclama che Gesù Cristo è ilSignore a gloria del Padre (Fil 2,11).
La Chiesa loda, benedice, adora, glorifica e ringra-zia Dio per la sua gloria immensa « che è Cristo» (S.Ireneo), di cui sono pieni i cieli e la terra.
Il Padre della gloria le ha dato «spirito di intel-ligenza e di rivelazione della conoscenza di Lui»(Ef 1,17) «in cui il Padre è stato glorificato eviene glorificato» (Gv 14,13).
La Chiesa ci ripete continuamente l’esortazio-ne di San Paolo: «d’un solo animo ad una voceglorificate Dio, Padre del Signore nostro GesùCristo» (Rm 15,6) e ininterrottamente, nel miste-ro eucaristico che è l’azione di grazie più perfetta«dà al Signore gloria e potenza, dà al Signore lagloria del suo nome» (Ps 29,1-2), «glorifica Diooffrendo azioni di grazie» (Ps 50,23), rende lodealla sua gloria per Cristo, con Cristo, in Cristo.
Egli non è solo per noi un Dio vicino (Jahvé),un Dio-con-noi (Emmanuele), è Dio in noi suocorpo, suo compimento e pienezza. Come luisaremo risuscitati dai morti a gloria del Padre (Rm6,4). «In lui riceveremo da Dio Padre onore e glo -ria» (2Pt 1,17) quando verrà nella gloria del Padre

1918
a tutti gli uomini, sia fedeli che infedeli (CD 13) e sicomunica a ogni comunità ecclesiale che esercitauna vera azione materna nei confronti delle anime daavvicinare a Cristo (PO 6).
Ritenendola l’immagine più atta a sottolinearei doveri nostri di figlie, vorremmo introdurla ogginelle Costituzioni e ci conferma in questo propo-sito ciò che disse Pio XI quattro anni prima chel’opera nascesse, solo ora venuto a nostra cono-scenza:
«È opera veramente benedetta da Dio. Mi piacetanto anche l’appellativo Figlie della Chiesa chedimostra le relazioni essenziali fra anime consacra -te a Cristo e la Chiesa loro Madre .
Quale amore c’è di più puro, di più forte, di piùtenero che l’amore tra la madre e le figlie, tra lefiglie e la Madre! Tale sia l’amore delle nuoveFiglie della Chiesa per la Chiesa loro Madre (PioXI a Mons. Ciro Scotti).
Tanto nella prima come nella seconda stesuradelle Costituzioni si preferì l’immagine del CorpoMistico di Cristo che poi emerse nei documenti con-ciliari anche per lunghezza di trattazione, come quel-la che meglio esprime la comunicazione ininterrottadella vita divina e la sua progressiva crescita fino allapienezza del cielo.
Il suo spirito uno e identico nel capo e nellemembra dà a tutto il corpo vita e moto (LG 7) e il
Chiesa Madre nostra (LG 6), che ci ha suggeritoil nome, non è stata introdotta nelle Costituzioni.
Vi era come implicita.Agli inizi le qualità della nostra Madre erano il
solo nostro programma: volevamo essere «unasola cosa» (Gv 17,11) perché la nostra Madre èuna e unica; volevamo la santità, perché la nostraMadre è santa; volevamo raggiungere con la pre-ghiera e la sofferenza tutti i nostri fratelli per por-tarli al suo cuore universale; ci sentivamo figliedei suoi Pastori e soprattutto del Pastore supremo,perché è la sola Chiesa rigorosamente apostolica.
Non ci mancò qualche approfondimento teologi-co della sua maternità e il primo statuto diceva: «IIVerbo che nel seno di Maria si è fatto uomo, nellaChiesa si è fatto Madre, ci porta nelle sue viscere, cinutre della sua sostanza, ci difende dal maligno e cidà alla luce della vita eterna».
L’immagine della Chiesa Madre appare appenanei documenti del Vaticano Il ma traspare in tutticome la sua identità.
La Chiesa è la Santa Madre Chiesa. La Chiesachiamata... Madre nostra (LG 6).
Lo Spirito santo rigenera i credenti in Cristonel fonte battesimale come in un seno (AG 15).
Il Sacro Concilio si propone di rinvigorire ciò chegiova a chiamare tutti nel seno della Chiesa (SC 1).
La materna sollecitudine della Chiesa si estende

2120
Abbiamo pure sostituito al termine mistero iltermine quasi sinonimo di sacramento preferitodal Concilio, per esprimere la realtà misteriosa delpiano della salvezza, del disegno d’amore cheinclude l’umanità e il cosmo, e mantiene tutta lacreazione nell’ansiosa attesa della sua piena mani-festazione.
Con la terminologia preconciliare si poteva forseritenerlo uno dei dogmi del simbolo, mentre è unMistero globale che li comprende tutti, un sacra-mento in senso generale e analogico, produttore edistributore dei sacramenti, un segno perennementee fficace della grazia e della gloria, dei beni presentie futuri che al di sopra di sé, come pure nel simboloapostolico e atanasiano, ha solo l’augusta Tr i n i t à ,principio, modello e vertice tanto della Chiesa invi-sibile come della Chiesa visibile.
Questo sacro mistero dell’unità della Chiesa haper supremo modello e principio l’unità nella Tr i n i t àdelle Persone, di un solo Dio Padre e Figlio nelloSpirito Santo (UR 2).
La Chiesa universale si presenta come unpopolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio edello Spirito santo (LG 4).
Il Concilio certamente ha voluto presentare laChiesa come segno di questa realtà visibile e invi-sibile e come vessillo innalzato sui popoli (UR 2),perché il mondo la riconosca quale realtà sociale
suo Capo riempie dei suoi doni il corpo che è laChiesa, affinché ella sia protesa e pervenga a tuttala pienezza di Dio (LG 7).
Il nostro inserimento in questo misteriosoCorpo è espresso nelle Costituzioni col terminedisusato di incorporazione che non appare neitesti conciliari e non dà rilievo all’intimità dellenostre relazioni col Padre, con Gesù, con la Madrenostra e i nostri fratelli.
Per questo abbiamo aggiunto all’immagine delcorpo l’espressione paolina che la completa: ple -roma, pienezza di Cristo (Ef 1,23).
Intorno alla Madre c’è tutta la famiglia: siforma in lei, si espande da lei, si estende con lei.
Il Concilio presenta la Chiesa composta di«uomini chiamati a formare già nella storia dell’u-manità la famiglia dei figli di Dio che deve cresce-re costantemente fino all’avvento del Signore, cheunita in vista dei beni celesti e di essi arricchita,cammina insieme con l’umanità tutta, ed è comeun fermento della società umana destinata a rinno-varsi in Cristo e a trasformarsi anch’essa in fami-glia di Dio» (GS 40).
A questa pienezza il Concilio allude quandoa fferma che la Chiesa «ha il suo supremo modellonella Famiglia divina» (UR 2); che è «un insiemedi fratelli animati da un solo spirito e per mezzo diCristo nello Spirito portati al Padre» (LG 28).

2322
Lo Spirito Santo
L’Operatore di questa nostra comunione perGesù, con Gesù, in Gesù, è lo Spirito santo, mira-bilmente operante nella Chiesa (LG 44) il mirabi-le sacramento dell’unità (SC 5).
Egli opera sempre fortemente e soavementecome con Gesù, che ha condotto e spinto neldeserto (Mt 4,l; Lc 4,l; Mc 1,12), e coi Santi checonduce per mano come una mamma e spinge conbraccio disteso (Dt 5,15; Ps 135; Ps 112) all’eroi-smo.
Le sue operazioni sono tutte mirabili.Non si sa donde venga e dove vada (Gv 3,8).La Chiesa segue fedelmente il suo andare e
attende appassionatamente il suo venire dai cena-coli eucaristici per diffondere la luce che è la vitadegli uomini (Gv 1,4), per fare di tutti un solocorpo e un solo spirito (Ef 4,4) e ampliare la pie-nezza di Cristo a gloria del Padre.
Le operazioni dello Spirito santo sono sgorga-te, in questa nuova teofania, dal cuore dellaChiesa con la sovrabbondanza di una novellaPentecoste e hanno per oggetto i singoli figli diDio e tutto il popolo di Dio.
Lo Spirito santo plasma, riempie, vivifica, conso-lida, regge, chiama, ispira, grida, anima, sollecita,stimola, spinge, rinnova, santifica, raduna, aggrega,
della storia e suo fermento (GS 44).Già presente in mistero per virtù di Dio, essa
cresce visibilmente nel mondo col compito di ren-dere presente e quasi visibile Dio (GS 21).
Questo piano universale per la salvezza delgenere umano non si attua soltanto in una manie-ra per così dire segreta (AG 2).
Il Concilio auspica l’epifania e la realizzazionedel piano divino nel mondo e nella storia, perchési attui all’evidenza la storia della salvezza (AG 9)e la Chiesa, universale sacramento della salvezza,lo svela e insieme lo realizza (GS 45).
È il mirabile sacramento scaturito dal costatodi Cristo morente sulla croce (SC 5) e Dio ha con-vocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù,autore della salvezza e principio di unità e pace ene ha costituito la Chiesa, perché sia, per tutti eper i singoli, sacramento visibile di questa unitàsalvifica (LG 9).
Queste accalorate affermazioni del Conciliospiegano l’insistente richiamo della Chiesa aldovere della testimonianza cristiana e religiosa,perché sia sempre più visibile l’invisibile ricchez-za del suo Mistero in cui si riversa e da cui sieffonde tutto l’Amore di Dio.

2524
uomini alla partecipazione della sua stessa vita, nontanto ad uno ad uno, ma riunendo i figli dispersi inpopolo e raccogliendolo in organica unità, e ha eff u-so e continua a effondere la sua divina bontà, sicchécome di tutti è il Creatore, possa anche essere tuttoin tutti (AG, 2).
Abbiamo per questo riunite le tre operazioni delloSpirito santo sottolineate dalle Costituzioni, cioè: l aChiesa è aggregata, retta e santificata dal suo Spirito(Cost., Capitolo 1), nell’operazione che le suppone ele comprende tutte, cioé: la Chiesa è dallo Spiritosanto intimamente unita (UR 2).
Nella nuova liturgia la Chiesa implora che loSpirito santo ci riunisca in un solo corpo per lacomunione al Corpo e al Sangue di Cristo (PreceEuc. II), che per la pienezza dello Spirito santo,diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spi-rito (Prece Euc. III).
È l’eco della profezia di Gesù: «Saranno congre -gati da oriente e da occidente, da settentrione e damezzodì, alla mensa del Regno di Dio» (Lc 13,29) edella sua Preghiera al Padre per la consumazione deisuoi nell’unità trinitaria (cf Gv 17, 22) che il Conciliosotto l’impulso dello Spirito santo ha proclamato intutta la sua pienezza e ampiezza cosmica, per raff o r-zare la fede nella risurrezione della carne, ravvivare lasperanza nella vita futura, indicare nell’unità la matu-razione dei frutti della carità. Questo piano si attua
unifica, ma anche da una semplice comparazionenumerica risulta evidente, nei documenti conciliari enella liturgia postconciliare, la prevalenza delle suemozioni per adunare, aggregare, unire e sospingereverso l’unificazione universale.
Lo Spirito santo in tutti i tempi dà l’unità inti -ma e ministeriale alla Chiesa (AG 4).
L’azione dello Spirito santo conserva e fa pro -gredire nell’unità della fede (LG 25).
Lo Spirito santo chiama tutti gli uomini a Cristo eli aggrega all’unico popolo di Dio (AG 15).
Lo Spirito Santo che abita nei credenti e tuttariempie e regge la Chiesa intimamente tutti con -giunge in Cristo (UR 2).
Si nota pure un orientamento nuovo nella teo-logia del Concilio e nella conseguente liturgiacirca l’azione dello Spirito santo.
Appare infatti diretta più alle membra che almembro del Corpo Mistico, più al Popolo di Dioche alle singole persone.
La teologia mistica che mira direttamenteall’unione personale con Dio, sembra parta dalpunto opposto: l’unione con Dio sarebbe fruttodell’unità fraterna, più che suo germe.
Al Padre, il quale per mezzo di Cristo nellapotenza dello Spirito santo continua a radunareintorno a sé un popolo da un punto all’altro dellaterra (Prece Euc. III), piacque di chiamare tutti gli

2726
la beata; ha visto scorrere la misericordia di pro-genie in progenie e ha ascoltato i gemiti dellepopolazioni depresse e le implorazioni dellemasse affamate; ha distinto le voci di tutti i figli diAbramo più numerosi delle stelle del cielo e dellearene del mare e le aspirazioni di tutto il Popolo diDio; ha esultato piena di grazia sotto lo sguardodell’Altissimo e ha magnificato per tutti ilSignore.
Ora è glorificata in cielo nel corpo e nell’anima(LG 68) e la santa Chiesa contempla con gioia in leicome un’immagine purissima di ciò che essa tuttadesidera e spera di essere (SC 103).
Sublime fra le stelle (Inno: Ave Maris Stella), chepiù si accendono per lei più sfavillano per Dio,scompare come a Cana e traspare nella gloria di suoFiglio; riceve amore e onore per riversarli centupli-cati in lui, accetta le nostre povere lodi e le indirizzaal Signore come novelli magnificat.
Per questo vorremmo che brillasse innanzi allanostra peregrinante famiglia e da essa fosse a tuttimanifestata, testimoniata e preannunciata qualesegno di sicura speranza e di consolazione, finchéverrà il giorno del Signore (LG 68).
Nelle prime nostre Costituzioni scompare nelMistero della Chiesa.
Nelle seconde non emerge.La vogliamo al vertice, come nella Costituzione
perennemente nella Chiesa che prega insieme elavora affinché l’intera pienezza del cosmo si tra-sformi in Popolo di Dio, Corpo di Gesù Cristo eTempio dello Spirito santo, e in Cristo, centro ditutte le cose, sia reso ogni onore e gloria alCreatore e Padre dell’universo (LG 17).
Maria
Nessuno guarda Gesù come lei, sua Madre!Nessuno ci guarda come lei, nostra Madre.
Perché nessuno è più di lei, in Cristo suoFiglio, quasi sacramento e segno e strumento del-l’intima unione con Dio e dell’unità con tutto ilgenere umano (LG 1).
La sua unione trasformante con Dio è giunta atale meravigliosa efficienza che le ha trasformatoperfino le viscere e ha effuso nel mondo la luceeterna (Prefazio della Madonna).
La sua unità con tutti i figli di Dio le ha dilata-to così ineffabilmente il cuore che tutti possonochiamarla Madre e rifugiarsi nel seno della suamisericordia (da O Domina mea).
Dall’alto, in Dio, perché tutta la creazione laudisse, col Verbo in grembo e lo Spirito santosulle labbra, ha proclamato santo il Nome delSignore e ha udito tutte le generazioni proclamar-

2928
contemplata e accolta per essere vissuta e diffusa.Lo studio sacro era centrato sulla Sacra
Scrittura, particolarmente sui testi di SanGiovanni e di San Paolo che illustrano luminosa-mente il Mistero di Cristo.
La Parola di Dio era sempre seguita dalla Paroladella Chiesa che la interpreta infallibilmente ed è diquei primi anni la stampa a forte tiratura delle dueencicliche di Pio XII, Mystici Corporis e D i v i n oa f f l a n t e S p i r i t u che tutte dovevano leggere, studia-re e meditare. Contemporaneamente si commenta-va un Compendio di teologia ascetica e misticaalternata da spunti di patrologia e sociologia. Si dif-fuse allora largamente la Catechesi di San Cirillo ela dottrina sociale della Chiesa.
L a rgo spazio è sempre stato dato alla dottrinamistica di San Giovanni della Croce, di Santa Te r e s ad ’ Avila e di Santa Teresa del Bambino Gesù, agli studiascetici di P. Plus, Garrigou Lagrange, ColumbaMarmion, Chevier, Gratry, Fulton Sheen.
Nostro pane quotidiano era il canto liturgicoche ci inseriva spontaneamente nel nostro Misteroe ce lo faceva vivere, presentandoci il Padre,Gesù, Maria, i Santi vivi e vicini con le loro vociautentiche e vibranti dalle pagine dell’Usualis,nostro libro personale come il Messale e l’Ufficiodivino.
Al nostro studio sacro è mancata nei primi anni
dogmatica sulla Chiesa: «Madre di Dio e Madre degliuomini, soprattutto in preghiera presso il Figlio suo,finché tutte le famiglie dei popoli siano felicementeriunite in un solo Popolo di Dio, a gloria dellaSantissima e indivisibile Trinità» (LG 69).
Formazione dottrinale
È una dimensione che Gesù ha affidato, in duemissioni ben precise, allo Spirito Santo e allaChiesa.
Lo Spirito santo forma a vivere in Cristo conl’animazione della Chiesa e la Chiesa con la pre-dicazione del Vangelo e i Sacramenti.
La formazione cristiana suppone, logicamentenon cronologicamente, la formazione umana, delcorpo e dello spirito umano creati per vivere inCristo.
La Chiesa chiede per l’uno e per l’altro il godi-mento dell’integrità che facilita, particolarmente agliiniziati, la vita in Cristo. La formazione della Figliadella Chiesa è la formazione cristiana nelle suedimensioni principali; prima, la dottrinale.
Lo studio sacro è stato programmato fin dagliinizi, prima della stessa orazione, cui doveva for-nire il contenuto che è la Verità cercata, amata,

3130
nostra rivista «Mater Ecclesiae» che dovrà sempremantenersi ortodossa e aggiornata.
Ma perché le nostre case e chiese siano davvero«centri di pietà eucaristico-mariana» come prescri-vono le nostre Costituzioni, non dimentichiamoche in passato si centrava quasi esclusivamentesulla pietà mariana, oggi si centra quasi esclusiva-mente sulla dottrina mariana ed è bene che noi noneccediamo per l’una a scapito dell’altra.
La dottrina, in tutte le sue dimensioni, sarà ilseme della pietà; la pietà il fiore della dottrina,come avrebbe voluto suggerirvi l’opuscolo che hoscritto per voi ancora non nate: «RespiriamoMaria».
la programmazione, oggi indispensabile per esi-genza della formazione non solo, ma più ancoraper la testimonianza che siamo chiamate a darealla Verità in questo nostro mondo umanistico edissacralizzato
Solo le prime Figlie della Chiesa poterono segui-re un vero corso di teologia; poi lo studio sacro rego-lare restò ristretto al centro della formazione e allepoche case con superiore preparate.
Di fisso e impegnativo c’era solo l’art. 139delle Costituzioni che lo esigeva dallo sforzocomunitario e personale di tutte.
Oggi è esteso all’intera Congregazione e una inca-ricata ha la responsabilità di proporre il programmaannuale e di accogliere attraverso discrete consulta-zioni le proposte e le osservazioni delle sorelle.
I due temi principali saranno sempre il biblico el’ecclesiale: la Parola di Dio e della Chiesa, su cuisi regge la nostra formazione e la nostra vita.
Ci accosteremo con prudenza alle novità teolo-giche, non sottovalutando la teologia perenne cheè stata lodata anche da Gesù: «Bene dixisti de me,Thoma» e la parola del Sommo Pontefice, in par-ticolare, ci sarà luce e guida.
Sarà tenuto gran conto dei nuovi orientamentidottrinali della mariologia; non mancherà mai lanostra presenza ai convegni e corsi mariani esosterremo a costo di qualunque sacrificio la

Partecipazionesacramentale

35
SPIRITO
Le Figlie della Chiesa partecipano sacramen-talmente all’intima natura e alle qualità essenzialidella loro Madre; umili segni e strumenti anch’es-se dell’intima unione con Dio e dell’unità di tuttoil genere umano (LG 1).
Partecipano pure alle sue funzioni: sacerdotale,profetica e regale; alla sua più intima vocazioneche è di pregustare, nella mutua carità e nell’uni-ca lode della Trinità beata, la Liturgia della gloriaeterna (LG n. 51), e alla sua vocazione, oggi piùurgentemente sentita, che è di salvare e rinnovareogni creatura, perché tutte siano ricapitolate inCristo (AG n. 1).
Partecipano infine alla sua missione universaleche è di orientare effettivamente, per mezzo degliuomini, il mondo intero a Cristo con la mediazio-ne universale di Maria.

3736
RIFLESSIONI
Come partecipiamo alla «natura» della Chiesa
La definizione conciliare della genuina naturadella Chiesa «quasi sacramento o segno e strumento»(LG 1) dei beni supremi, «l’intima unione con Dio el’unità con tutto il genere umano» e l’insistenza delConcilio nel chiedere al figli della Chiesa la testimo-nianza di tali beni, rivelano la ricchezza della fonteche li effonde e rende possibile la testimonianza.
È il Mistero Pasquale, in cui siamo tutti eccle-sialmente segni e strumenti dell’intima unionecon Dio e dell’unità coi fratelli e da cui sgorganoi sacramenti che ci fanno segni e strumenti perso-nalmente. La virtualità unitiva del MisteroPasquale forma la Chiesa che coi sacramenti, incui ininterrottamente la riversa, forma i suoi figlicomunicando loro la sua identità.
Il Battesimo li incorpora nella Chiesa (LG 11),li predispone ad essere strumenti di salvezza (LG33), araldi della fede (LG 35), a dare tutti, nellavarietà, testimonianza della mirabile unità del
ESPRESSIONI
La partecipazione delle Figlie della Chiesa allavita della Chiesa si realizza soprattutto per mezzodella Liturgia, anima di ogni altra partecipazione.
La Liturgia le introduce nella Famiglia di Dio(LG 28), le associa alla lode della gloria del Padre,le immerge nel Mistero della morte e della risur-rezione del Signore, fonte dei sacramenti, le nutreall’unica mensa del Verbo e del Pane della Vita ele unisce nella comunione ecclesiale e universale.
Un’animazione assidua le farà sempre piùcoscienti della ricchezza di questi doni sacramen-tali e le impegnerà a sforzarsi di prolungare lacomunione liturgica, che è fraterna e gerarchica,nella vita di ogni giorno, con la carità diffusa neiloro cuori dallo Spirito santo, tendendo all’unitàimplorata da Gesù perché il mondo creda e cheannuncia l’avvento di Cristo, come proclama laChiesa; di essere sempre più riconoscenti verso ilSignore, che opera in tutti i suoi figli grandi cose.

3938
cità, l’apostolicità.L’unità è assicurata alla Chiesa da Gesù che
l’ha voluta sua, unica sua, sempre una e unica,nonostante le divisioni che non possono dividerelo spirito.
È assicurata dalle successive qualità che sonole sue componenti e di cui essa è il vertice. Gesùinfatti, prima di pregare per l’unità dei suoiApostoli, ha pregato per la loro s a n t i t à, cheessendo la perfezione della carità ha necessaria-mente l’urgenza dell’unione, della comunione,d e l l ’ u n i t à .
Li ha poi mandati in tutto il mondo e lo Spiritosanto ha impresso in loro uno slancio universale,ma è evidente dai documenti neotestamentari illoro bisogno profondo di incontri fraterni, di agapisante, di assemblee oranti.
Più la Chiesa si espandeva, più s’affaticava perraccogliersi, riunirsi, sentirsi una (cf At 2,44-47).La sua convergenza verso un centro unificante èl’istanza della sua stessa cattolicità.
E per questo è autenticamente apostolica egelosa della sua apostolicità che ha conservato,con l’unità della fede nel Simbolo degli Apostoli,per la sua ininterrotta successione apostolica e perla fedeltà alla sua forma costituzionale organica egerarchica.
Le qualità essenziali della Chiesa sono espres-
Corpo Mistico di Cristo (LG 32).La Confermazione conferma gli iniziati, svi-
luppando le possibilità battesimali, vincolandolipiù perfettamente alla Chiesa e arricchendoli diuna speciale forza dello Spirito santo... per essereveri testimoni di Cristo (LG 10).
L’Eucaristia è il vincolo dell’unità, perché ciban-dosi del Santissimo Corpo di Cristo, tutti mostranoconcretamente la unità del Popolo di Dio che da que-sto augustissimo Sacramento è adeguatamente espres-sa e mirabilmente effettuata (LG 11 ).
La Penitenza e l’Unzione degli infermi ripara-no, riqualificano, ridonano funzionalità o vigoreai segni, agli strumenti, ai testimoni indeboliti dalmale morale e fisico.
Il Matrimonio e l’Ordine Sacro assicurano lacontinuità e la perennità della testimonianza: ilprimo significando e partecipando al Mistero diunità e di fecondo amore che intercorre fra Cristoe la Chiesa (LG 11), il secondo inserendo total-mente nella Chiesa e in Cristo Gesù, gli eletti innome di Cristo a pascere la Chiesa con la Parola ela Grazia di Dio (LG 11).
alle «qualità» della Chiesa...
L’intima natura della Chiesa è evidenziatadalle sue qualità essenziali: la santità, la cattoli-

4140
te santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il quale colPadre e lo Spirito santo è proclamato il solo Santo,amò la Chiesa come sua sposa e diede se stessoper essa al fine di santificarla, e la congiunse a sécome suo corpo e l’ha riempita col dono delloSpirito santo per la gloria di Dio (Prefazio dellaDedicazione della Chiesa).
La sublime dottrina è tradotta dalla liturgia insublime contemplazione.
Nel tuo amore per gli uomini, hai voluto stabi -lire la tua dimora dove è raccolto il tuo popolo inpreghiera e con la tua azione incessante edifichila tua famiglia come tempio dello Spirito santo incui splenda il fulgore della tua santità (Prefaziodella Dedicazione della Chiesa).
Questa Chiesa, misticamente adombrata nelsegno del tempio, tu la santifichi perennementecome sposa di Cristo, Madre lieta di una moltitu-dine di figli, per collocarla accanto a te, rivestitadi gloria (LG 39).
La Chiesa santa tende ininterrottamente allasua santità escatologica.
I suoi ministri devono ascendere ad una sem-pre maggiore santità, nutrendo e dando slanciocon l’abbondanza della contemplazione alla pro-pria attività (LG 41).
La vita religiosa, che appartiene alla santitàdella Chiesa, deve aumentarla.
se e sottolineate soprattutto dalla liturgia che tra-duce in implorazioni le affermazioni dottrinali egli orientamenti pastorali del Concilio.
L’unità dei fedeli che costituiscono un solocorpo in Cristo è rappresentata e prodotta colSacramento del pane eucaristico (LG 3).
A noi che ci nutriamo del suo Corpo e del suoSangue dona la pienezza dello Spirito santo, per -ché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solospirito (Prece Eucaristica III).
Guarda con amore, o Dio, la Vittima che tustesso hai preparato per la tua Chiesa e a tuttiquelli che mangeranno di questo unico pane eberranno di questo unico calice, concedi che riu -niti in un solo corpo dallo Spirito santo, diventinoun’offerta viva in Cristo, a lode della tua gloria.
O Dio misericordioso, concedi alla tua Chiesaradunata dallo Spirito santo, di servirti con tota -le dedizione e di formare in te un cuor solo (PreceEucaristica IV).
Conservaci nel tuo nome, affinché tutti siamouno (Gv 17,11).
La santità è lo stato della Chiesa: lo stato glo-rioso di Gesù che si prolunga nel suo corpoMistico.
La Chiesa, il cui sacro mistero è esposto dalsacro Concilio, è per fede creduta indefettibilmen-

4342
principio creò la natura umana e volle infine radu-nare i suoi figli che si erano dispersi (LG 13).
Per questo scopo Dio mandò il Figlio suo, al qualeconferì il dominio di tutte le cose, perché fosseMaestro, Re e Sacerdote di tutti, Capo del nuovo euniversale popolo dei figli di Dio (LG 13).
Questo carattere di universalità che adorna edistingue il popolo di Dio, è dono dello stessoSignore e con esso la Chiesa cattolica, efficace-mente e senza soste, tende ad accentrare tutta l’u-manità con tutti i suoi beni in Cristo Capo, nell’u-nità dello Spirito di Lui (LG 13).
Tutti gli uomini sono quindi chiamati a questacattolica unità del Popolo di Dio, che presigna epromuove la pace universale e alla quale in variomodo appartengono e sono ordinati sia i fedelicattolici sia gli altri credenti in Cristo, sia infinetutti gli uomini dalla grazia di Dio chiamati allasalvezza (LG 13).
E la Chiesa inviata per mandato divino allegenti per essere sacramento universale di salvez-za, rispondendo alle esigenze più profonde dellasua cattolicità e all’ordine specifico del suoFondatore, si sforza di portare l’annuncio delVangelo a tutti gli uomini (AG 1).
Queste affermazioni conciliari confermano ilnostro credo sulla qualità essenziale e sostanzialedella nostra Madre, oggi più esposta alla contesta-
Questa santità si manifesta e si deve manifesta-re nei frutti della grazia che lo Spirito santo pro-duce nei fedeli (LG 39).
E la liturgia la implora incessantemente.Ricordati, Padre santo, della tua Chiesa diffusasu tutta la terra; rendila perfetta nell’amore(Prece Eucaristica III).
O Dio, che hai promesso al tuo popolo il germedi giustizia, custodisci la santità della tua Chiesa.
Cristo, che hai dato alla tua Chiesa vergine castaun solo sposo, rendila immacolata e santa.
Padre santo, che hai voluto chiamarci figlituoi, fa’ che la tua Chiesa sia proclamata santa intutta la terra.
Sapiente santificatore, santifica la tua casa ela tua famiglia, affinché la Città celeste, la nuovaGerusalemme, tua Sposa, appaia a tutti gloriosa.
Così la Chiesa trova in Dio la sua forza e deci-de nel suo cuore il suo viaggio.
Passando per la valle del pianto la cambia inuna sorgente; anche la prima pioggia l’ammantadi benedizioni (Ps 84,7).
La cattolicità della Chiesa risale alle antichepromesse di Dio e alla stessa creazione.
Il popolo di Dio, pur restando uno e unico, sideve estendere a tutto il mondo, affinché si adem-pia l’intenzione della volontà di Dio, il quale in

4544
terra.L’ a p o s t o l i c i t à della Chiesa è documentata
dalla storia.Edificata su Pietro (LG 8), fondata sugli
Apostoli (AG 9), si è sempre sorretta, nelle suesecolari vicende, sui successori di Pietro e degliApostoli uniti con lui, per opera dello Spirito santo.
La nostra è l’unica Chiesa di Cristo che nelsimbolo professiamo una, santa, cattolica e apo-stolica e che il Salvatore nostro dopo la risurrezio-ne diede da pascere a Pietro affidandone a lui eagli Apostoli la diffusione e la guida (LG 8).
La fedeltà della successione apostolica non èriconosciuta alla Cattedra di Pietro da molte chieseche la preghiera comune unisce, e Paolo VI la riaf-ferma come una realtà della storia che trascende lastoria stessa: «L’apostolicità della Chiesa... prero-gativa a noi stessi mirabile, a noi stessi che abbia-mo esperienza della nostra fragilità e conosciamocome la storia la documenti ed insieme sappiamoquanto coerente, quanto fedele sia la successionedel mandato di Cristo agli Apostoli, discesa finoalle nostre umili e meravigliate persone, quantoinesplicabile e quanto vittoriosa la secolare perma-nenza della Chiesa, sempre viva, sempre idonea aritrovare in se stessa una incoercibile giovinezza»(Paolo V I , A l l o c u z i o n e, 14 sett 1964).
Il processo di unificazione e il riconoscimento
zione.Come ci sentiamo figlie delle Chiese locali e
disponibili filialmente al loro servizio, così ci sen-tiamo figlie della Chiesa universale e pronte aseguire le sue direttive universali.
L’ideale dei primi anni «per la Chiesa e per ilmondo» non può scolorirsi: fa parte dell’impegnobattesimale che la nostra consacrazione e il nostroparticolare carisma devono rendere sempre piùcosciente ed efficiente.
Anche in ciò la liturgia è fonte di luce e di fervore:Dio, pure ai nostri giorni vediamo risplendere
i tuoi antichi prodigi. Ciò che hai fatto con la tuamano potente per liberare un solo popolo dal suooppressore, ora lo compi attraverso l’acqua dellarigenerazione per la salvezza di tutti i popoli;concedi che l’umanità intera sia ammessa tra ifigli di Abramo e partecipi alla dignità del popo -lo eletto (Veglia Pasquale).
O Dio, Padre di tutti, a gloria del tuo nomemoltiplica la discendenza promessa alla fede deiPatriarchi, aumenta il numero dei tuoi figli, per -ché la Chiesa veda in larga parte adempiuto ildisegno universale di salvezza nel quale i nostriPadri hanno fermamente sperato ( Ve g l i aPasquale, IV orazione ).
Padre, purifica la tua vigna, custodiscila eincrementala, affinché al tuo cospetto riempia la

4746
degli Apostoli, per formare un cuor solo e un’ani -ma sola nel vincolo del tuo Amore (OrazioneFesta di SS. Pietro e Paolo).
Lo Spirito santo, se non c’è una resistenzavolontaria, ravviva nei figli i tratti caratteristicidella Madre e sacramentalmente, automaticamen-te, con metodi preclusi alle indagini della psicolo-gia e pedagogia umana, implora e ottiene che siinseriscano profondamente nella cattolica unitàdel Popolo di Dio (LG 13), che si santifichino conla sua potenza che santifica tutto l’universo, che siaprano al mondo intero con la luminosa certezzache si completerà, per tutto il Corpo della Chiesa,il Mistero di gloria inaugurato in Cristo e che nontemano di nulla perché posti sulla base incrollabi-le della fede degli Apostoli.
... alle «funzioni» della Chiesa
Le Figlie della Chiesa partecipano alle funzio-ni sacerdotale, profetica e regale della Chiesacome tutti i battezzati.
La rigenerazione e l’unzione dello Spiritosanto le ha consacrate a formare un tempio spiri-tuale e un sacerdozio santo per offrire spiritualisacrifici (1Pt 2,5); le ha fatte araldi della fede (PO2) per proclamare ad alta voce le virtù presenti delRegno di Dio e la speranza della vita beata; le ha
dell’apostolicità della Chiesa sono paralleli e sonoinsieme contrastati.
La Proclamazione dell’infallibilità pontificia,la consacrazione del genere umano al Cuore diGesù perché si faccia un solo ovile sotto un solopastore e le preghiere per l’unità della Chiesa, lihanno difesi e sostenuti specialmente in questonostro secolo.
La Liturgia supplica Dio di difendere dal terroredelle porte infernali la sua Chiesa fondata sulla soli-dità della Pietra apostolica (O r a z i o n e Festa di S.Leone Magno) e di non permettere mai che noisiamo scossi da alcun turbamento, giacché ci haposto sulla base incrollabile della fede del suoi apo-stoli (Cf O r a z i o n e Cattedra di S. Pietro).
Concedi, Dio onnipotente, che tra le vicendetempestose del mondo non si turbino i tuoi figli,ma si conservino fiduciosi sul saldo fondamentodella fede professata e trasmessa dagli Apostoli, equella Roma che prima ha dato la salvezza ladarà per sempre (I n n o Vespri SS. Cirillo eMetodio).
Il Mistero eucaristico consolida la fede nelladottrina apostolica e realizza l’unità dei credentinell’amore.
O Signore, che nutri alla Mensa eucaristica imembri della tua Chiesa, concedi a noi di perse -verare nella frazione del pane e nella dottrina

4948
vizio regale» particolarmente dei laici (LG 36).Con la funzionalità della Chiesa, l’azione
incessante di Dio ci edifica come tempio delloSpirito santo (LG 4) e noi siamo sempre in costru-zione.
La casa di Dio (LG 6) siamo noi ... «Il momen-to della conversione alla fede è come quando dalleforeste e dalle rocce si tagliano i sassi e la legna;quando veniamo catechizzati, battezzati e formatiè come l’essere sgrossati, squadrati e levigati frale mani degli artefici fino a quando non veniamocompaginati insieme dalla carità. La legna e lepietre, se non combaciassero fra di loro secondoun ordine determinato, se non poggiassero tran-quillamente le une sulle altre, se aderendo le unealle altre in una certa maniera non si amasseroscambievolmente, nessuno potrebbe entrare.
Solo quando in una costruzione si vedono le pie-tre e il legname ben compatti si entra sicuri e non siteme il crollo» (S. Agostino, S e r m . 3 3 6 , 1 - 6 ) .
Ebbene, il Signore Gesù volendo entrare edimorare in noi, come se stesse costruendo dice-va: «Vi dò un comandamento nuovo, di amarvi avicenda» (Gv 15,12).
costituite nella libertà regale comunicata da Cristoperché tutte le creature siano soggette al Padre eDio sia tutto in tutti.
La Chiesa, con la sua liturgia orante e operan-te, accumula tutta la carità di Dio e la diffonde conle sue funzioni su tutta l’umanità.
La funzione sacerd o t a l e le è particolarmentepropria. L’assemblea liturgica non assiste soltantoal suo svolgersi, ma vi partecipa direttamente e sefuori del tempio scolorisce, con dinamismo segretoeleva i figli della Chiesa nell’oblazione della vitaquotidiana che unisce i cuori nella carità fraterna.
La funzione profetica della Chiesa ha un forterilievo nella liturgia della Parola che comunicaluce e ardore alle sue espressioni più umili nellerelazioni umane e alle più apostoliche nell’evan-gelizzazione.
La funzione regale è conseguente alle due pre-cedenti.
Anch’essa si svolge in pieno nel Mistero euca-ristico che unisce il Popolo di Dio al suo Re e glicomunica la sua stessa pacifica regalità; ma nonha manifestazioni esteriori.
Lo Spirito santo ha infatti ispirato al ConcilioVaticano Il di trattare espressamente delle dueprime funzioni distinguendole nella loro identità edi approfondire soltanto i contenuti della funzioneregale che nella Lumen gentium appare come «ser-

5150
Per questo oggi si fa tutta a tutti con la sualiturgia e pastorale a tutti i livelli e avverte l’ur-genza di utilizzare gli istituti terreni, convergentiverso l’unità economica, tecnica, culturale, socia-le e politica nel piano della salvezza di cui sono epossono essere inconsci strumenti, per tutto rica-pitolare in Cristo (cf AG 1).
Questa sua specifica vocazione oggi ha una ripre-sa universale, perché la Provvidenza sta preparandole vie alla fraternità umana con la democratizzazionedella società, gli avvicinamenti internazionali e l’u-niversale bisogno di pace.
La Chiesa contemplativa è attenta a questesegnalazioni provvidenziali e vi scorge l’impron-ta del Dito di Dio. Avverte l’animazione delloSpirito del suo Sposo che intimamente la unificaed esternamente sospinge l’umanità verso l’unifi-cazione finale.
... alla «missione» della Chiesa
La Chiesa ha la missione di diffondere la fedee la salvezza del Cristo. Tale missione si esplicaattraverso un’azione tale, per cui essa, in a d e s i o n eall’ordine di Cristo e sotto l’influsso della grazia edella carità dello Spirito santo, si fa pienamente edattualmente presente a tutti gli uomini e popoli per
... alle «vocazioni» della Chiesa
La Chiesa alla mensa eucaristica è tutta tesa versola mensa celeste e la cena dell’eterna gloria.
Vi partecipa sacramentalmente con tutti i suoifigli, particolarmente con quelli che per la lorocarismatica consacrazione sono segni dei benicelesti presenti nel mondo (LG 44) e la pregustasperimentalmente, nei suoi figli contemplativi, neiquali l’intima unione con Dio e l’unità con tutto ilgenere umano (LG 1), hanno raggiunto quaggiù lamassima loro efficienza.
La contemplazione fa convergere in un solo spi-rito, in una sola volontà, in una sola voce (cf Rm15,6), nell’unica lode della Trinità beata (LG 51), lamolteplicità delle espressioni liturgiche, mutevolicome i tempi e gli uomini e le sublima nella liturg i adella gloria eterna che occhio mai non vide, orecchiomai non udì, cuore umano non poté mai desiderare(2Cor 2,9).
La Chiesa pellegrinante la può solo pregustarenell’esercizio della mutua carità (Gv 13,34).
Per questo oggi la Chiesa contemplativa depo-ne le seriche vesti della preghiera, il latino che è lalingua della sua teologia e il canto gregoriano cheesprime il suo spirito contemplativo nella formapiù pura, e prega e canta più in sintonia coi suoifigli.

5352
La Liturgia conviviale fa tutti una sola cosacon lui ed è la causa efficiente ed esemplare diogni altra unione.
Quando siamo nate nella Chiesa come piaunione, la pietà privata prevaleva sulla pietà litur-gica.
Noi, quasi istintivamente, per il nostro stessocarisma, abbiamo tentato tutte le vie per scoprirele misteriose ricchezze della Liturgia.
Il Concilio con la sua piena effusione di SpiritoSanto ci ha pienamente appagate. La nostra primaregola: partecipare alla Messa, vivere la Messa, esse-re le apostole della Messa, è ora teologicamenteesposta, ampiamente trattata e dallo Spinto santostesso rinnovata e spiritualizzata.
La partecipazione delle Figlie della Chiesa saràconsapevole, pia, attiva, (SC 11)... offriranno colSacerdote l’Ostia immacolata offrendo se stesse edi giorno in giorno perfezionandosi nell’unità conDio tra di loro e coi fratelli, di modo che Dio siafinalmente tutto in tutti.
Gli Apostoli hanno attuata, sviluppata e com-piuta la missione di Gesù, come Gesù, col sacrifi-cio di se stessi fino alla morte e con la speranzadella risurrezione.
Essi, molto tribolando e soffrendo, completa-rono ciò che manca ai patimenti di Cristo, a van-taggio del suo Corpo che è la Chiesa (AG 5).
condurli con l’esempio della vita, con la predicazio-ne, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, allafede, alla libertà ed alla pace di Cristo, rendendofacile e sicura la possibilità di partecipare in pieno alMistero di Cristo.
Mossa dallo Spirito di Consiglio, di cui, seoccorra, dispone infallibilmente, essa apprezza eaccoglie tutti gli apporti positivi delle scienzeumane, sperimenta anche temporaneamente meto-di e strutture che non sono in contrasto col dise-gno scaturito dal Cuore del suo Sposo e trae dallaLiturgia della terra e del cielo la forza che la fastrumento dell’universale salvezza.
La Liturgia del Mistero pasquale germina la gra-zia invisibile che germoglia nei sacramenti, suoisegni visibili, e le moltiplica i figli, glieli fortifica,purifica, nutre e sostiene in tutte le vicende della vita.
La Liturgia della Parola, preceduta e prolunga-ta dalla Liturgia delle Ore, glieli matura ed educa,col Verbo che è la vita e la luce degli uomini, allalode della gloria di Dio, al colloquio con Dio nel-l’orazione, all’ascolto e al riposo in Dio nella con-templazione.
Nella Liturgia eucaristica sacrificale culminala sua missione salvifica (PO 5).
Dal Cuore aperto dell’Agnello che è stato ucci-so nasce la Chiesa come una sposa nella gloriadella risurrezione (SC 5).

5554
lei; in ogni Messa Gesù l’ha sotto gli occhi e ripete aciascuno dei presenti: Ecco tua Madre!
La partecipazione sacramentale allo stato glo-rioso di Gesù, anticipato esistenzialmente allaMadre sua assunta al cielo, autorizza a sperare cheMaria, per la proprietà dei corpi gloriosi, sia pre-sente invisibilmente al suoi figli, come lo è sacra-mentalmente Gesù sotto i veli eucaristici e che perla sua presenza ci sia dato un pegno della gloriafutura.
E come non scompare nella Liturgia non dovrebbemai scomparire nella vita: dovrebbe essere presentecome l’aria che, se mancasse, morremmo.
«Respiriamo Maria» scritto anche per voiquando eravate ancora futuribili, vi dice come ladovremmo respirare e come il suo «soffio legge-ro» (1 Re 19,12) ci farebbe respirare Dio.
Formazione liturgica
La partecipazione sacramentale al Mistero diCristo è la partecipazione alla vita della Chiesa, sacra-mento dell’universale salvezza e dell’unificazioneuniversale, che ha in seno il fonte e i fiumi d’acquaviva (Gv 7,38) della morte e risurrezione del Signore,sempre attuali nella sua Liturg i a .
La Liturgia non esaurisce tutta la vita della
Perché non c’è amore, non c’è apostolato, nonc’è missione più grande!
La Liturgia delle «Preci dei fedeli» ha unoslancio che sembrerebbe incomprensibile se nonglielo avesse ispirato lo Spirito santo:
O Salvatore nostro, che avesti la Madre tua aipiedi della croce, concedici per sua intercessione dig o d e re della partecipazione alla tua passione.I n t e rceda per noi la Madre tua, Signore !
Maria, piena di grazia e Madre della Grazia,aggiunge effettivamente al Dono di Dio, il suomodo unico di accoglierlo, di custodirlo, di fargliraggiungere, con la sua intercessione, la sua mas-sima efficienza.
La Chiesa inserisce la sua intercessione al cen-tro del Mistero pasquale e delle sue implorazioniuniversali.
Nella Liturgia è sempre la Madre della Chiesa, laRegina del cielo e del mondo, anche se nel ciclol i t u rgico sembra apparire e scomparire: non apparee ffettivamente mai, perché non scompare mai.L’appello alla sua intercessione è sempre sulle labbradella Chiesa che nei suoi sabati e nelle sue feste mol-tiplica soltanto le espressioni d’affetto, le intensifica,le trasforma in cori e in canti.
La proiezione reale della morte di Gesù nellenostre Messe di ogni giorno, sarebbe irreale senza di

5756
sacramentale ed è, come l’azione dello Spiritosanto, soprattutto animazione.
L’animazione ha bisogno di libertà, di una«devota libertà», ma per essere dolce e forte (Sap8,1) come quella dello Spirito santo, ha pure biso-gno del controllo dell’autorità.
L’animazione liturgica, per collaborare con loSpirito santo nella formazione liturgica, dovrà quin-di dipendere dall’autorità e trascenderla, come il pro-fumo che si espande restando contenuto nel fiore.
L’animatrice liturgica dovrebbe formare nonsolo le partecipanti all’azione liturgica, ma le ani-matrici, imitando Maria nel cenacolo e accanto aGiovanni.
Le meraviglie della Pentecoste si sono svoltesotto i suoi occhi.
Il Vangelo della luce e le Epistole dell’amoresono state scritte accanto a lei e l’Apocalisse conla visione della Donna vestita di sole è lo sfondodella sua assunzione.
Non una parola sulle labbra di Maria, ma la suasola presenza, il suo solo ricordo, erano animazionel i t u rgica, come il suo sabato, le sue feste, le suediscrete apparizioni nella Liturgia eucaristica sonoanimazione liturgica per chi ha dallo Spirito santo lagrazia di sentirla e di compenetrarsene.
L’umanesimo ha rappresentato Maria immer-sa nella meditazione delle Scritture; qualche pio
Chiesa, ma la fermenta e irrora tutta come il cuoree il sangue nel corpo umano. Per questo la forma-zione liturgica è la dimensione principale dellaformazione cristiana, pur restando primaria la dot-trinale, perché l’andate e predicate il Vangelo aogni creatura precede il battezzate tutte le gentinel nome del Padre, del Figlio e dello SpiritoSanto ed è il Verbo della Vita che prepara a rice-vere il Pane della Vita.
La Liturgia del Mistero Pasquale è primaLiturgia della Parola e poi Liturgia eucaristica.
La nostra formazione dottrinale parte da lì, lanostra formazione liturgica centra qui.
Il primo statuto della Congregazione infatti ciimponeva di partecipare alla Messa, di vivere laMessa, di essere apostole della Messa (33Fogliettipag 21).
Oggi dobbiamo parteciparvi più coscientemen-te e attivamente, perché tutto oggi è più dinamicoe la formazione è un processo di crescita, di matu-razione, di perfezionamento che agenti esterni einterni, coscienti e incoscienti operano in noi econ noi.
In noi e con noi opera sempre lo Spirito santo,l’Agente supremo di ogni formazione e, più ditutti gli altri agenti, chi ha da lui l’incarico di for-mare il figli di Dio. La formazione liturgica èdirettamente dipendente dallo Spirito santo perché

58
Partecipazionecarismatica
artista l’ha dipinta presso la Cena del Signore; ilVangelo ci assicura la sua presenza in pienoMistero Pasquale, anche se non dice che Gesù lesia apparso.
Da lei non era mai scomparso: la sua fede nonaveva bisogno né di visioni, né di locuzioni.
Maria ci anima al vero culto di Dio: al silenzio,quando il silenzio è volontà di Dio e alla lode quan-do la esige la sua gloria: alla partecipazione pienadel Mistero Pasquale con l’accettazione piena deidisegni di Dio; alla sua partecipazione «attiva» conla loro esecuzione fedele, e alla sua partecipazione«consapevole» con la meditazione e il ripensamen-to delle parole e delle opere di Dio (SC 11), comeElla faceva sempre «conservando tutto nel suocuore» (Lc 2,51).

SPIRITO
Oltre le ricchezze sacramentali, Dio ha donatoalla sua Chiesa, fra molti altri carismi, il dono didonarsi totalmente a Lui con la professione dellaperfetta carità (cf LG 43).
Non è un normale sviluppo dei doni dello Spiritosanto, ma un’esperienza riservata a chi deve testimo-niare in terra i beni del cielo (LG 44).
Induce ad amare Dio senza divisioni, compen-sazioni e riserve (cf LG 42).
È permanente per la fedeltà di Dio e costringealla fedeltà con le sollecitazioni forti e soavi delsuo Spirito.
È un’anticipazione della vita celeste e dispone apregustarla nella contemplazione (cf LG 44).
61

pellegrine e pronte al servizio della Chiesa dovun-que le chiami.
Il governo faciliterà l’obbedienza reggendosisui principi biblici dell’autorità, del servizio, del-l’interdipendenza per l’edificazione del Corpo diCristo e sui principi ecclesiali del dialogo, dellaconsultazione, della sussidiarietà, condizionatidal principio esistenziale della funzionalità.
Quanto più le Figlie della Chiesa si lascerannostringere da tali vincoli tanto più rappresenteran-no Cristo indissolubilmente unito alla sua Sposa,e tanto più testimonieranno l’amore indissolubiledella Chiesa per Cristo, suo Sposo (LG 44).
63
ESPRESSIONI
Le Figlie della Chiesa, perché la loro comunio-ne sia col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo e laloro gioia sia piena, per impulso dello Spiritosanto traducono in obbligazioni d’amore i consiglievangelici di povertà, castità e obbedienza nellavita comunitaria, ecclesiale, sociale, conforman-dosi così al genere di vita che Cristo Signore siscelse per sé e la Madre sua abbracciò. Con lacastità perfetta si donano quindi esclusivamente aDio sommamente amato, senza divisioni, com-pensazioni, riserve.
Con la povertà evangelica si staccano radical-mente dai beni terreni per testimoniare i beni cele-sti; lavorano infaticabili per trarre tutti a Cristo.
Con l’obbedienza si sottomettono generosa-mente a chi rappresenta Dio (PC 14) per imitareMaria e conformarsi a Gesù, specialmente nei tra-slochi da una casa all’altra, da un luogo all’altro,per quanto lontano, dovendosi considerare come
62

Allora si lasciano case, o fratelli, o sorelle, omadre, o padre, o figli, o campi (Mc 10,29); nonci si congeda da quelli di casa, ma si pone manoall’aratro senza volgere indietro lo sguardo (Lc6,62); non si indugia nemmeno a seppellire ilpadre, ma si va e si lascia che i morti seppellisca -no i loro morti (Lc 9,59-60).
Tale carisma è permanente per la fedeltà di Dioed è come la conservazione rispetto alla creazio-ne: l’introduzione e la stabilizzazione dinamica inuna vita nuova di cui la teologia sta studiando lanatura.
Il teologo Garrigou-Lagrange la paragona allegrazie preternaturali, gratis datae a beneficio dichi le riceve e di tutta la Chiesa.
Forse più propriamente appartiene alle effusio-ni che la Chiesa implora ogni giorno dallo Spiritosanto perché si rinnovi la faccia della terra; è l’in-gresso nella nuova terra e nei nuovi cieli (LG 48)trasfigurati dallo spirito delle beatitudini per esse-re offerti a Dio (LG 31).
Questa è l’impressione dell’anima quando idoni dello Spirito santo si schiudono tutti insiemee il cuore all’improvviso è beato, la mente paga, lavolontà pronta, la terra amica, l’umanità sorella,Dio Padre.
Anche se l’apertura è di un istante, l’anima hascoperto il Regno di Dio e non potrà più dimenti-
65
RIFLESSIONI
La vocazione religiosa
La professione religiosa che vincola in eternoall’Amore Eterno, manifesta i beni celesti dellalibertà da ogni condizionamento terreno (LG 44)e della gioia nella volontà di Dio.
Il possesso di tali beni è ordinariamente il frut-to della esperienza contemplativa, come affermala teologia mistica e la loro testimonianza è pro-porzionata a tale esperienza come conferma l’a-giografia.
Si può quindi dedurre che la professione reli-giosa è possibile solo per un carisma non necessa-riamente richiesto dall’ordinario sviluppo delgerme battesimale, ma che lo sollecita e lo poten-zia o con l’acutezza del pungolo cui non si puòresistere, o con l’attrattiva dell’amore che costrin-ge a cedere.
È la vocazione.
64

esige che le Figlie della Chiesa vengano prepara-te a dare tale testimonianza con una formazioneintensa all’orazione e alla contemplazione, da cuidovranno partire e a cui dovranno convergere tuttele dimensioni della formazione. Alla vigilia dellaprofessione perpetua, la loro volontà dovrà sentir-si libera, ferma, decisa; avida dei vincoli solidi estabili (LG 44) che dovranno unirla a Dio e pron-ta anche a patire la fame e ad andare in Oceania,come si proponeva alle prime aspiranti.
Il carisma della professione è un apporto di for-tezza che si differenzia dal carisma della contempla-zione solo perché non corrobora necessariamente lavolontà nelle sue impressioni ed espressioni aff e t t i-ve. Il suo linguaggio è Mihi autem gloriari oportet inc ru c e ! (Gal 6,14). Davanti alla croce la sensibilitàpuò sentirsi schiacciata, ma l ’ a m o re è forte come lam o rte (Ct 8,6).
Il carisma è questa perfetta carità che nella pro-fessione perpetua dei consigli evangelici raggiun-ge il suo compimento e la sua espressione più alta(RC). La volontà può essere o sentirsi influenzatada tendenze ataviche o ambientali, da meccanismipsichici e pressioni sociali, ma il dono inconfon-dibile della Fortezza spinge e costringe a volere,con la consacrazione totale a Dio, la rinunciapiena di sé e il sacrificio perfetto di tutto.
Questa idoneità a sacrificare liberamente,
67
care il suo Tabor; quell’istante di trasfigurazioneorienterà tutta la sua vita: ella andrà e annunzieràil Regno di Dio (Lc 8,39).
Più spesso uno solo si apre timidamente, laPietà, che intenerisce davanti al tabernacolo e conpiù frequenza nella comunione eucaristica. Gesùcol suo cuore di carne tocca il cuore di carne e lasua chiamata è amore; l’anima non calcola nulla erisponde il suo sì con la disponibilità dell’amoreche misteriosamente lo Spirito santo potenzia,illumina, indirizza, equilibra, estende a tutta l’u-manità e contiene col timore filiale di Dio.
La professione religiosa
I chiamati del Vangelo sono stati tutti sollecita-ti da uno sguardo, o da un invito di Gesù che hadato loro il dono d’intendere ciò che non tuttihanno orecchi da intendere (Mt 19, 12) e di starepermanentemente con lui fin da principio (Gv15,27).
Ma la loro testimonianza se l’è ripromessa solodallo Spirito di Verità che avrebbe mandato dalPadre e la Chiesa si attende oggi dai chiamati unatestimonianza nuova, speciale, splendida (LG 39;AA 31), perché confida nello Spirito che corrobo-ra e radica nell’amore (Ef 3,13). Il nostro spirito
66

La strettura ha dei limiti e c’è libertà di movi-mento per i polsi e per il cuore.
Quanto più però questa libertà è sacrificata e siconsente che i vincoli stringano mani e cuore,tanto più il carisma sprigiona le sue possibilità diunione nuziale con Cristo e di unione ecclesiale inCristo.
I voti vincolano al Creatore e svincolano dalcreato, sottraendo e diminuendo l’uso dei suoi beni.
Operano come le notti di San Giovanni dellaCroce, che li oscurano e ne temperano l’attrattiva.
Sono segnati dalla croce: impressi come sigillisulle labbra e sul cuore (Ct 8,6) passivi come le nottimistiche, indesiderate e desiderabili.
La perpetuità prolunga la strettura fino allamorte, ma frequenti allentamenti impedisconol’infedeltà abituale e favoriscono la ripresa deldono totale a Dio sommamente amato (LG 44).
La stabilità del dono è il frutto dei voti osser-vati, come delle notti sopportate con la Pazienzadi Cristo, che è un frutto dello Spirito santo.
Le notti possono aprirsi in albe di risurrezionee i vincoli possono stringere come amplessi:
La destra di lui intorno al mio capo e la suasinistra mi abbraccerà (Ct 2,6).
Li attrarrò a me nei vincoli di Adamo, con lefunicelle dell’amore (Os 11,4).
Aderiscano con fervore al tuo amore, conforta -
69
spontaneamente, responsabilmente le inclinazionipiù profonde della natura (PC 12) per le esigenzesupreme del Regno di Dio (LG 44), indica la pre-senza del carisma.
La libertà non limita la passività, né la passi-vità trattiene la libertà. Nessuno è più libero deibeati rapiti in Dio. Come respiriamo attivamente epassivamente, così riceviamo il dono fatto da Dioalla Chiesa (LG 43).
La professione religiosa ci fa partecipare gra-tuitamente, in una forma del tutto riservata, allanatura, alle qualità, alle vocazioni, alle funzioni ealla missione universale della Chiesa e ci qualifi-ca stabilmente ad essere un cuor solo, un’animasola, un solo spirito, una sola voce; tutte per tutti,pronte anche a compiere ciò che manca alla pas -sione di Gesù Cristo per il suo Corpo che è laChiesa (Col 1,24).
Questa è la nostra Professione perpetua ancheper designazione giuridica.
I vincoli
Con la Professione perpetua si abbraccia unostato «speciale» (PC 1) caratterizzato da tre vincoliche vincolano a Dio e alla Chiesa per sempre. Sonoanelli nelle ore serene e catene nelle ore buie.
68

Scioglimento
II carisma della professione perpetua è perma-nente da parte di Dio che non ritira i suoi doni einclude una capacità permanente di rispostaall’Amore che ama in eterno.
Radica e fortifica nella carità e apre alle immen-surabili dimensioni del Mistero della Chiesa, ma èpure l’assunzione di un impegno perpetuo, dallaChiesa giuridicamente riconosciuto.
Indubbiamente i voti sono vincoli (LG 44)nuziali impreziositi dall’amore di Cristo che supe-ra ogni intendimento, ma per la loro natura di vin-coli a un certo momento possono stringere il cuore.
La liberazione può apparire desiderabile, ma ilcarisma dell’Amore Eterno può sempre impedireche sia desiderata.
È l’ora in cui urge vigilare e pregare per noncadere nella tentazione (Mt 26,41) dello svincola-mento, sempre più doloroso della strettura, anchese in principio l’impressione è opposta.
L’amore di Dio è acuto come l’inferno (Ct 8,6)e persiste come punta d’amarezza, se incorrispo-sto, o respinto.
È duro ricalcitrare al pungolo (At 26,14): il giova-ne ricco si è imbattuto nella tristezza perpetua.
I vincoli si possono sciogliere, ma la loroimpronta è più profonda e angosciosa delle ango-
71
te dai sacri vincoli religiosi (Rituale), chiede nelrito della professione la Chiesa.
I voti vincolano alla Chiesa, potenziando parti-colarmente la partecipazione alle sue funzionisacerdotale, profetica e regale.
La vita religiosa, con nuovo e speciale titolo, èdestinata al servizio e all’onore di Dio (LG 44).La Chiesa presenta la professione come uno statoconsacrato a Lui e associa l’oblazione dei religio-si al Sacrificio eucaristico (LG 45). Nella vita reli-giosa viene offerto a Dio un eccellente sacrificiodi lode e tale vita costituisce un ministero sacro(PC 7-8).
La vita religiosa appare inoltre un segno chepuò e deve attirare efficacemente tutti i membridella Chiesa a compiere con slancio i doveri dellaloro vocazione profetica ( LG 44).
Lo stato religioso infine meglio preannunzia lafutura risurrezione e la gloria del Regno celeste;in modo speciale manifesta la sua elevazionesopra tutte le cose terrestri e le sue esigenze supre-me e dimostra a tutti gli uomini la preminentegrandezza della virtù di Cristo regnante e la infi-nita potenza dello Spirito santo mirabilmente ope-rante nella Chiesa (LG 44).
70

maternità, componenti dell’integrazione persona-le ed elevate alla dignità di sacramento, per amoredi un Dio nascosto e di innumerevoli figli ignoti.
Tale sublimazione della persona umana sareb-be impossibile se Dio non si fosse in un modo o inun altro rivelato, costringendo il cuore a lasciaretutto per lui: Nessuno viene a me se il Padre nonlo attira (Gv 14,6).
Il cuore ha avvertito l’attrattiva carismatica diDio e il suo ricordo basterà a mantenerlo fedelefino alla morte.
Il voto è un vincolo nuziale che ha il suo fon-damento nel Vangelo, nella dottrina tradizionale enella liturgia della professione:
«Conservino con fedeltà, le nuove spose, l’u-nione con Cristo unico Sposo e quando finalmen-te perverranno al tribunale del sovrano Re, nontemano il giudizio del giudice, ma riconoscano lavoce dello Sposo che soavemente le chiama allenozze celesti» (Rituale della Professione). Il votoè volontà d’amore.
La risposta volo al si vis di Gesù, sempre pas-siva, sempre possibile solo sotto il suo sguardod’amore, dopo il suo invito d’amore è pure attivis-sima: il cuore vuole Dio solo e solo ciò che Diovuole e per sempre.
La totalità e la perpetuità del dono, sebbenecarismatiche, non escludono l’infedeltà, anche se
73
sce esistenziali e mistiche.È l’ora in cui bisogna soprattutto pregare
Maria, di cui il Signore si è servito per chiamarci.Tutte le chiamate infatti si sono avvertite, o
chiarite, o intensificate ai suoi piedi e da lei hannotratto la forza e anche la gioia, le risposte.
La professione ci ha introdotte nella via strettache conduce alla vita (Mt 7,14) e la Chiesa augu-ra il gaudio a chi affronta tale strettura:
Dio vi conceda di percorrere col gaudio diCristo la stretta via che seguiste (Rituale dellaProfessione).
Ed è proprio per non svincolarci da Gesù e ritor-nare indietro che ci siamo con la Professione perpe-tua vincolate anche a lei: forse coi sentimenti diquesta preghiera che non posso dimenticare:
Prend mon coeur sur ton autel, Vierge, mabonne Mère! ... Ah, cache-le bien vite enfermédans le tien, e puis, si quelque jour je te le rede -mande, ne me le rend pas; mais dis-moi en ce jour,dis-moi que je te l’ai donné, qu’il est tien sansretour...
VOTO DI CASTITÀ
Il voto di castità perfetta obbliga alla rinunciadi due esigenze naturali profonde: l’amore e la
72

Queste scelte si devono decidere nell’intimitàeucaristica.
Lo Sposo fa sentire indubbiamente alla sposase per amarlo ha bisogno di essere sostenuta conbevande, rianimata con mele (Ct 2,5), e dovràtagliare il filo di seta che finirebbe per impedirledi volare a lui.
Nel matrimonio, due cuori amandosi si aiutanoad amare Dio. Nella vita religiosa, amandoci ciaiutiamo ad amarlo.
Il pensiero della Chiesa è forse più diretto apromuovere le compensazioni comunitarie cheindividuali e indubbiamente suggerisce quellevolute da Dio e arricchite dal carisma della suapaternità e maternità.
Quanto all’amicizia che è un dono di Dio edilata i cuori in Dio, per effondersi nei fratelli, chioserebbe impedirla?
Paolo VI ne fa l’elogio esaltando il suo appor-to apostolico:
«L’amicizia può essere apostolato elettissimo,anche perché l’amicizia si fonda su affinità spiri-tuali spontanee che procurano diletto e fervore,accendono la fantasia e rendono facili i tentatividell’apostolato, che forse da sé nessuno oserebbecompiere.
L’amicizia come apostolato, Noi la raccomandia-mo come metodo, come allenamento e proprio come
75
intrisa d’amarezza e impegnano a una continuaimplorazione di grazia. Maria ne è la fontana sem-pre piena per tutti. La consacrazione filiale al suoCuore immacolato, inserita nella consacrazionetotale a Dio sommamente amato (LG 44), facilitagli incontri personali con Lui e coi suoi figli, sen-sibilizza alla realtà della Famiglia di Dio, alla fra-ternità con gli Angeli di cui le spose di Cristo imi-tano in terra lo stato e con gli uomini loro fratelli,anche se ignoti e remoti. Il Concilio esprime l’e-missione del voto perpetuo di castità col termine el’immagine dell’amore unitivo. La castità èabbracciata e la motivazione dell’abbraccio è l’a-more. Solo l’amore infatti può anteporre nozzeescatologiche e mistiche a nozze presenti, visibilie sensibili, anche se il centuplo a questo mondo,come ha promesso Gesù, è immediato.
Sono comprese nel centuplo le gioie dellaFamiglia religiosa e il Vaticano II ha puntualizza-to, in modo assai esplicito e impegnativo, chequeste compensazioni affettive sono necessarie,perchè l’amore di Gesù resti unico e forte.
S’affaccia qui la difficoltà della scelta fra lecompensazioni buone. Se il voto esclude il grandebene della procreazione, può anche escluderequalche volta le manifestazioni umane di unabuona amicizia, non richieste dal progresso spiri-tuale, o da esigenze apostoliche reciproche.
74

generosità totale che spinge a dare tutto in silenzio:gioventù, bellezza, ogni sogno, ogni diritto» (PaoloV1, 8.6.1969), liberamente e per sempre.
È il rinnegamento di sé richiesto dalla sequelaChristi. È il quotidie morior di San Paolo. È ilprogramma di San Giovanni della Croce per chiaspira all’intimità con Dio: propendere cioè: «nonal più facile, ma al più difficile; non al più sapori-to, ma al più disgustoso; non al riposo, ma allafatica; non al più, ma al meno; non a voler cosaalcuna, ma a non voler nulla».
Il Capitolo indicherà una forma comunitaria dirinnegamento che supplisca le forme penitenzialidell’astinenza e del digiuno, soppresse dallamaternità della Chiesa. Sarebbe un dovere.
VOTO DI POVERTÀ
Anche la professione del voto di povertà è pre-sentato dal Concilio come un abbraccio (LG 42).
L’immagine francescana dello sposalizio conla povertà mette subito in evidenza che l’emissio-ne e la perseverante fedeltà all’ardua promessanon può venire che dalla volontà irrobustita dallaforza di Cristo.
Il voto fa seguire Gesù e partecipare alla suapovertà (LG 46).
77
interpretazione autentica della carità effusiva e dop-piamente benefica, a chi la esercita e a chi ne ricevei benefici» (Paolo VI, 7.2.1968).
L’amicizia raggiunge la sua sublimazione nel-l’amicizia contemplativa dei Santi.
«Si discorreva soli fra noi con grande nostradolcezza e dimentichi del passato, teso il pensieroverso il futuro, s’indagava in presenza tua che seila Verità, quale fosse per essere la vita eterna deisanti che occhio mai non vide, né orecchio maiudì né entrò in cuore di uomo. E con affetto solle-vandoci verso di te trapassammo a poco a pocotutte le cose corporee e il cielo stesso. E ancoraascendevamo interiormente pensando a Te eammirando le opere tue; e arrivammo ai nostrispiriti e li trascendemmo per giungere alle regionidella vita inesauribile...
Or mentre parlavamo e tendevamo con avidodesiderio a quella, ecco con uno slancio di tuttal’anima l’attingemmo per un istante e sospiram-mo; indi lasciandovi legate le primizie del nostrospirito, ridiscendemmo verso il rumore delle lab-bra dove la parola ha principio e muore.
Che v’ha egli mai di simile al Verbo tuo?»(S. Agostino, Confessioni).Così possano essere sublimate l’affettività fami-
liare e l’amicizia umana, ma «l’amore portato a que-sto vertice suppone una grazia, una vocazione, una
76

figli; la povertà che possiede tutto (2Cor 6,10) con lacertezza che nulla mancherà (Ps 22, 1), anche semanca il necessario.
La povertà esteriore personale e comunitarianon è certo la più ardua.
Le nostre case -non nostre- per la maggiorparte si presentano come colombaie a ridosso dichiese pubbliche. Qui la povertà splende e lesorelle sperimentano l’efficace governo delladivina provvidenza (cf Mt 16,25).
Le poche case nostre, costruite secondo le esi-genze dell’edilizia, non esprimono la povertàevangelica come avremmo desiderato, ma sono ilcentuplo, il soprappiù (Lc 18,30) promesso daGesù. In tali case la povertà appare nella sempli-cità dell’arredamento che non può avere nulla disuperfluo, nemmeno per motivi d’arte, di conve-nienza, di riconoscenza, perché li trascende tutti ilmotivo soprannaturale della testimonianza che,espressa in un modo o nell’altro, con più o menosplendore, tutte le nostre case devono dare.
Avremmo voluto liberarci da ogni proprietàper testimoniare la povertà in modo inequivocabi-le, ma la nostra domanda alla Santa Sede non èstata accolta. Allora si è deciso di cedere gratuita-mente parte del terreno del «Paesetto dellaMadonna» a opere di carità bisognose, perché conla loro unione offrano una testimonianza altrettan-
79
Nell’abbraccio c’è la spinta alla perfetta seque-la, all’unione, all’identificazione.
La liturgia esprime questo movimento gioiosonell’inno delle vergini che corrono verso i benicelesti. Si corre a questo abbraccio per partecipa-re alle ricchezze (Inno Com. della Madonna) dellapovertà di Cristo. Il centuplo è assicurato anche inquesto mondo in case e campi (cf Lc 18,30), oltreche in affetto e gioia. La perfetta sequela è semprecompensata dalla perfetta letizia; la rinuncia ditutto dal senso del possesso: la sua dimensioneecclesiale e sociale, è una testimonianza al mondodel Regno che non è di questo mondo (Gv 18,36).
Un’altra testimonianza è il lavoro.Alla «O Sanctissima» ci hanno viste indefesse
intorno agli ospiti con le nostre aspiranti e recente-mente al «Paesetto della Madonna» col succedersidi quattro cantieri di lavoro delle novizie; è tuttorauna testimonianza che ha cambiato il giudizio dellagente. Non ci dicono povere, ma nemmeno ricche;sono contenti di vederci lavorare come loro e gode-re come loro del frutto del lavoro che è per noi, perloro, per i poveri.
Indubbiamente la testimonianza più visibile dellapovertà esteriore è la volontaria privazione dei benigrandi e piccoli: la povertà che pensa solo di arric-chire Gesù Sacramentato e i fratelli; la povertà dellemamme che si privano anche del pane per sfamare i
78

I poveri si accontentano di una minestra, nonpossiamo pretendere pranzi; si accontentano diuna veste, non possiamo pretenderne tre.
Dormono spesso ammassati in un solo ambiente;non possiamo esigere una cella nostra, un uff i c i onostro, strumenti nostri. Sono gli ultimi, gli emarg i-nati; non possiamo manovrare per essere i primi.
Accogliamoli sempre e nelle solennità dellaChiesa anche in refettorio: sono un sacramento diGesù umile e povero cui non si può negare l’ac-cesso.
Insegnano l’adattamento alla vita, l’accettazionedel poco, l’abitudine della povertà. Domandano dapoveri, ricevono da poveri, ci vangelizzano con laloro povertà rassegnata e ci ricordano l’obbligo cheabbiamo di evangelizzarli con l’attrattiva dellanostra povertà beata che già possiede le ricchezzedel Regno.
Ricordati, o Signore, di queste Sorelle, prega laChiesa, che per tuo amore hanno lasciato tutto,perché trovino in te tutte le cose e, dimentiche disé, si dedichino alle necessità di tutti (Ritualedella Professione).
La povertà interiore ha esigenze ancor piùprofonde e una dimensione ecclesiale e socialemolto più estesa della povertà esteriore di cui è laradice e il vertice.
Le Figlie della Chiesa aspirano perciò ad esse-
81
to apprezzata.Nelle poche case dall’apparenza borghese o
signorile come la «O Sanctissima», essendo menovisibile la povertà comunitaria, renderemo semprepiù umile il nostro servizio e occuperemo i localipiù modesti.
Fin qui il compito della Congregazione.Ma il Concilio mette un forte accento sulla
povertà individuale libera e responsabile e sottraele superiore al dovere di accogliere ogni domandadi dispense.
Le superiore risponderanno sempre tenendoconto della carità; le sorelle invece chiederannotenendo conto dei loro bisogni e insieme dellapovertà abbracciata. Il consenso della superioranon le dispensa dall’ardua promessa di esseresegno del Regno e non basta a giustificarle davan-ti a Dio.
La dispensa può essere un’ingiustizia: puòobbligare alcune a un lavoro eccessivo che com-pensi il lavoro dispensato; può ridurre il necessa-rio alle une per accontentare col superfluo le altre;può sottrarre il sostentamento ai poveri.
L’amore dei poveri, da noi chiamati i G e s ù ( d aOlga MD), il loro esempio e il nostro dovere di ele-varli ed evangelizzarli, saranno i mezzi più immedia-ti per conservare nella Congregazione lo spirito pri-mitivo della nostra povertà evangelica.
80

VOTO DI OBBEDIENZA
Il voto di obbedienza non è presentato dalConcilio come i due precedenti con l’immaginedell’abbraccio, ma come offerta e sacrificio: donototale della volontà (PC 14).
I voti di povertà e di castità sono imitazionedella vita di Gesù, il voto di obbedienza è imita-zione della sua vita e particolarmente della suamorte, nell’ora ch’Egli dichiarò sua, la più vicinaalla risurrezione.
Nessuna virtù infatti fa morire e risorgerecome l’obbedienza. Anche se è un morire lento,perché le gioie e i beni della vita si lasciano unavolta per sempre, ma la volontà è radicata nell’es-sere, e se col voto si dona intenzionalmente tutta eper sempre, normalmente poi si riprende, si rido-na, si riprende di nuovo, finché la pazienza di Diola unisce alla sua Volontà salvifica con l’onnipo-tenza del suo Amore.
La difficile virtù morale si trasforma a poco apoco nella virtù cristiana ed ecclesiale fino a fon-dersi nella virtù teologale della carità e assumernele dimensioni.
Solo a questa obbedienza che è amore e garan-zia dell’autentico amore, forte come la morte, èassicurata la pace della risurrezione.
83
re, per amore di Gesù umile e povero, povere dispirito, non desiderando eccessivamente l’affetto,la stima, il riconoscimento e il ricordo delle crea-ture, servendo senza attendere di essere servite,dando senza pretendere di ricevere e cercando lapiccolezza interiore che possiede il Regno deicieli.
Per arrivare a questo spogliamento è necessa-rio che la chiamata carismatica di Gesù si prolun-ghi nella formazione carismatica del suo Spirito,come è avvenuto per i primi chiamati.
Gli Apostoli avevano inteso di lasciar tutto, manon la speranza di un regno terreno: dopo laPentecoste lasciano veramente tutto e non si glo-riano d’altro che della croce di Gesù.
Molti sono i chiamati a questa gloria, ma pochigli eletti (Mt 22,14) a bere fino in fondo il caliceche la contiene.
Il carisma pieno è questo dono di fortezza, que-sto dono di tutto per tutti.
Il Capitolo deciderà se la Congregazione, coe-rente al primitivo spirito, per rispondere al gridodei poveri (ET 17) e dare una concreta testimo-nianza di povertà interiore, cioè di amore allapovertà, e di povertà esteriore autentica, dovrà orinunciare a possedere o possedere per i poveri(ET 18).
82

con spirito di fede all’autorità; non vi resistonoper non resistere all’ordine stabilito da Dio (Rom13,2); ne ritengono indispensabile la presenza e ilriconoscimento (ET 25); prestano all’autorità laloro collaborazione, perché venga esercitata coldecoro di un servizio evangelico; ne attuano ledecisioni imitando Gesù obbediente per noi finoalla morte, con la speranza che la loro obbedienzatrasformi in cantici i comandi di Dio e cooperialla salvezza del mondo.
L’amore di Dio (LG 42) facilita l’obbedienza,perché crea fra superiori e sudditi rapporti nuovidi comunione.
La Chiesa è il Popolo di Dio e anche laFamiglia di Dio.
Questa immagine che soprannaturalmente èuna realtà, sembra particolarmente riservata airapporti che intercorrono fra i religiosi, anche perla loro convivenza.
Lo spirito di fede può far scorgere nel volto deisuperiori il volto di Dio, l’amore può farvi scorg e r eil volto del Padre. L’amore riduce le distanze e avvi-cina le volontà, perché avvicina i cuori.
Il Concilio, che insiste sulla comunione fraternaper l’osservanza del voto di castità (PC 12), non sot-tolinea la necessità dello spirito di famiglia per l’os-servanza del voto di obbedienza. Forse perché lapaternità e la maternità spirituale erano spesso dege-
85
Le tappe del lungo cammino sono indicate dalConcilio.
L’obbedienza nasce dallo spirito di fede (PC14), cresce con l’amore di Dio (PC 14), si perfe-ziona nello spirito di fede e di amore verso laVolontà di Dio (PC 14).
Lo spirito di fede vede nei superiori i rappre-sentanti di Dio (PC 14). Solo questa certezza difede (ET 25) può indurre a prestare ad essi un«umile ossequio» (PC 14).
Ogni rappresentanza di Dio è inadeguata allasua trascendenza. Solo la fede può far superarequest’abituale inadeguatezza e far accettare comeVolontà di Dio la volontà di un uomo.
Nessuna motivazione sociologica, istituziona-le, giuridica potrebbe persuaderci all’obbedienzacristiana e tanto meno all’obbedienza religiosa.L’obbedienza religiosa non ci distingue, come lacastità e la povertà, dagli altri cristiani, ma ciobbliga a riconoscere più di essi nei superioriecclesiastici e religiosi l’autorità che viene dal -l’alto (Rom 13,1) e il carisma dello Spirito cheregge e governa la Chiesa (1Cor 12,28); e i chia-mati a udire ciò che agli altri non è dato di udire,a vedere ciò che agli altri non è dato di vedere,possono scoprire con la fede questi segreti delRegno di Dio.
Per questo le Figlie della Chiesa sono soggette
84

vo dopo un percorso breve ed arduo, o lungo ed este-nuante, cui il Rituale della Professione perpetua invi-ta, proponendo l’esempio di Gesù che «sempre desi-derando di aderire ai voleri del Padre, fatto per noiobbediente fino alla morte, volle offrirsi vittima per-fetta di amore».
Questa obbedienza amata e desiderata è la stessavocazione religiosa, l’essenza del suo carisma, il suoslancio iniziale per l’intuizione della libertà, della pacee sicurezza di cui è matrice, che intenzionalmentecontinua se lo spirito di fede sollecita gli atti di fedeltàe stabilisce la volontà nella disponibilità di obbediread ogni costo, ed è una partecipazione al Misteropasquale di morte e di vita (ET 24), se lo spirito d’a-more traduce la disponibilità nel desiderio ininterrottodi aderire ai voleri del Padre.
Solo questa obbedienza è spontanea, libera,responsabile (PC 14) come il Concilio la vuole,per la natura stessa del desiderio che è sempre unmovimento immediato, incondizionato, sicurocome l’amore che lo genera.
È l’obbedienza particolarmente sottolineatadalla Parola di Dio nel Mistero pasquale e recen-temente, per tutti i religiosi, dalla Parola dellaChiesa:
«Il senso profondo dell’obbedienza si rivelanella pienezza di questo Mistero di morte e di vitain cui si realizza in maniera perfetta il destino
87
nerate in un protezionismo che aveva ostacolato losviluppo normale della persona umana, della sualibertà e responsabilità e ne aveva arrestato la matu-rità in un pericoloso infantilismo; e forse anche per-ché le forme assolutistiche e dispotiche di governo,di recente esperienza, avevano influenzato anche leautorità religiose, rendendo così artificiose le espres-sioni e le strutture alludenti direttamente o indiretta-mente a rapporti familiari.
Ma il Concilio effettivamente prospetta un’ob-bedienza che senza spirito di famiglia sarebbeimpossibile (PC 15).
Solo l’amore filiale può mettere a disposizionedella superiora tanto le energie della mente e dellavolontà quanto i doni di natura e di grazia (PC 14)e solo un amore soprannaturalmente materno puòfacilitare tale apertura.
La Famiglia religiosa si regge sopra questi duerapporti di maternità e di figliolanza che riflettonole relazioni trinitarie e sono, come per la famigliaumana, strutture essenziali. Misconoscendole, oriducendole a una fraternità senza padre e senzamadre, s’instaurerebbe la democrazia che non è lafraternità e tanto meno la fraternità ecclesiale, per-ché non può creare rapporti d’amore; né naturali,né soprannaturali.
Lo spirito di fede e di amore verso la Volontà diDio (PC 14) è l’obbedienza perfetta, il punto d’arri-
86

distintivo della nostra Congregazione, risale quin-di agli inizi come il conseguente proposito ditestimoniarla nel modo più perfetto, che è l’unio-ne della volontà umana con la Volontà divina nellaprofondità della pace.
Tale stato è riconosciuto dalla patristica, dallateologia e dall’agiografia come il vertice dell’a-scetica e della mistica.
Dante, che raccoglie tutte le espressioni delpensiero e della vita cristiana, lo coglie nella sin-tesi del suo verso più bello:
In la tua Voluntade è nostra pace.Papa Giovanni, che lo sperimentò come tutti i
santi, scrive: La prima, la più grande consolazionedell’obbedienza è quella della pace: Obedientia etp a x .
Prometti a me e ai miei successori obbedienzae riverenza? chiedeva il Vescovo al suoi sacerdotiappena ordinati; e rispondeva al loro: Prometto!con un bacio, dicendo: La pace del Signore siasempre con te!
La pace è sempre unita all’obbedienza e lapace pasquale all’obbedienza pasquale.
Il carisma della perfetta carità può far sprigio-nare dalla sofferenza dell’obbedienza anche ilgaudio, la pienezza della vita dalla morte.
Il giogo allora sarà leggero e il peso soave; ilcuore sovrabbonderà di gaudio in ogni tribolazio -
89
soprannaturale dell’uomo: è infatti attraverso ilsacrificio, la sofferenza e la morte che questi acce-de alla vita» (ET 24). La nostra obbedienza tendea tale pienezza in cui si realizza pienamente ilnostro particolare carisma, che la Liturgia eucari-stica continuamente ci rivela, che si esperimentanella contemplazione.
Le Figlie della Chiesa chiedono il dono della con-templazione, soprattutto per desiderare ardentemen-te di obbedire e per pregustare la vita e la pace, anti-cipate dalla grazia a chi m u o re ogni giorno per farela volontà di Dio. Esse ripetono:
Quanto amo, Signore, la tua legge, tutto il giorno io medito in essa (Ps 11 8 , 9 7 ) .Non dimenticherò mai i tuoi precetti, perché
per essi mi hai dato la vita (PS 118,93).Cammino per una via spaziosa, perché indago
i tuoi precetti (Ps 118,45).Gran pace godono coloro che amano la tua
legge, né trovano inciampo alcuno (Ps 11 8 , 1 6 5 ) .«Le sue figlie obbediscono sempre così? mi
chiese una Suora presente a un mio ordine e all’e-secuzione immediata e ilare di Vilma.
Sì, risposi, e Vilma confermò illuminandosi».Tale carica risale all’esempio di Olga che ci ha
lasciato il testamento: obbedienza, obbedienza,obbedienza (da Olga MD).
Il proposito che l’obbedienza dovesse essere il
88

L’Autorità si regge non solo sulla delegazionedella Chiesa, ma sul principio fondamentale cheogni autorità viene dall’alto (Rm 13,1) e che ilgoverno è un carisma dello Spirito santo (2Cor12,28).
Oggi l’Autorità si confonde sempre più nellacomunità.
«L’Autorità è dissacralizzata, non nel sensoche è negata, ma è valutata in vista della suanecessità funzionale e iscritta nelle competenzeche suppone e richiede. Pur in ultima analisiassommata al vertice, si avvale di tutte le altrepersone competenti ed ode, con gli opportunicanali, i membri dell’istituto prima di decidere...Con ciò non si nega l’aspetto verticale dell’auto-rità.
L’obbedienza, la partecipazione all’opera col-lettiva, come l’iniziativa personale, sono riferite aDio» (Colagiovanni).
Questa svolta, più che alle aperture delConcilio, si può ritenere conseguente alla svoltaantropologica in filosofia e alla democratizzazio-ne nel campo sociale e politico: segni rivelatori diurgenze e appelli umani, universali. Perché vieneda Dio anche l’autorità che ogni uomo ha comecreatura su se stesso e sul creato e, come figlio diDio, sulle proprie espressioni, scelte e decisionicristiane.
91
ne (Mt 11,30; 2Cor 13,4).Se la tua legge non fosse la mia delizia, sarei
già morto nella mia afflizione (Ps 119,92).Inni sono divenuti per me i tuoi precetti, nella
terra d’esilio (Ps 119,54).Io mi delizio della tua legge (Ps 119,70).I tuoi decreti... sono il gaudio del mio cuore
(Ps 119,111).
L’AUTORITÀ
I testi conciliari e post-conciliari trattano del-l’obbedienza non come attuazione di un precisoconsiglio evangelico, di una esplicita Parola diDio (che di fatto non c’è nella Bibbia) ma comeimitazione dello stesso Verbo di Dio umanato eimmolato per fare la Volontà del Padre.
E ciò basta per affermare l’origine evangelicadella vita religiosa.
La Volontà del Padre, per istituzione divina, anoi viene trasmessa autenticamente dalla Chiesaattraverso l’Autorità da essa delegata e dentro ilimiti da lei stessa approvati.
Questo intervento della Chiesa ha suscitato laproblematica sulla natura della vita religiosa el’impoverimento dell’Autorità ne è stata la primaconseguenza.
90

time consultazioni e dei limiti stabiliti dal diritto,sia comune che particolare, i superiori debbonogodere autorità personale» (PC 14).
Il Concilio infatti presenta in modo inconfon-dibile l’Autorità personale e ne enumera le molte-plici obbligazioni che non si possono identificarecoi compiti dell’Autorità collegiale, indicati inve-ce complessivamente.
È l’Autorità personale che deve reggere animea lei affidate come figlie di Dio, guidarle in modoche la loro obbedienza sia attiva e responsabile,ascoltarle volentieri, promuovere l’unione delleloro forze e renderne conto a Dio (PC 14).
È all’Autorità personale che si raccomanda diessere docile alla Volontà di Dio e di esprimere lacarità di Dio (PC 14).
È particolarmente all’Autorità personale che sipresenta l’esempio di Gesù, perché venga eserci-tata in spirito di servizio.
Il Concilio trattando dell’Autorità personale sot-tolinea questo aspetto: «L’esercizio dell’Autorità èun servizio» (PC 14); e la E v a n g e l i c a t e s t i f i c a t i oprecisa che «si tratta di servire nei fratelli il disegnodel Padre» (ET 2 5 ) .
Quest’approfondimento sconcertante ci mettedinanzi il Mistero nascosto di cui San Paolo haintravisto la lunghezza, la larghezza, l’altezza e laprofondità (Ef 3,18); oggetto della preghiera di
93
La Scrittura raccomanda ai figli, e per estensioneai dipendenti, di o b b e d i re ai genitori in tutto, ché ciòè gradito al Signore (Col 3,20); e raccomanda pureai padri, e quindi ai superiori, con un tocco di profon-da umanità di non esasperare i loro figli, perché nonsi scoraggino (Col 3,21).
L’Autorità deve essere verticale, non obliqua edeprimente.
Anche ai superiori «discoli» (1Pt 2,18) si dovràobbedire, ma sarà duro il giudizio di chi governa(Eb 13,17) facendo servire al proprio orgoglio ilcarisma dello Spirito.
L’Autorità è collegiale e personale
La Chiesa trasmette la sua autorità solo straor-dinariamente al collegio e ordinariamente allapersona singola.
«L’obbedienza è più facile, più meritoria esomigliante a quella di Cristo se colui che coman-da fa le veci di Dio, che non se è un delegato dellacomunità» (Escudero). E l’autorità personale èstata recentemente confermata da un decreto dellaChiesa:
«Secondo la mente del Concilio EcumenicoVaticano II e dell’Esortazione A p o s t o l i c aEvangelica testificatio, tenendo conto delle legit-
92

ziario, col compito di programmare mezzi più adattiad attuare il disegno dei Padre; la personale piuttostoa livello esecutivo e pastorale, col compito di appli-care i mezzi al singoli casi.
Sia con la programmazione, sia con l’esecuzio-ne, esprimono ugualmente la Volontà di Dio.
L’una e l’altra dipendono ugualmente dai Ve s c o v ientro i limiti indicati dal Diritto comune e dipendo-no in tutto vi voti dal Romano Pontefice.
L’Autorità personale però, nei testi conciliariappare in primo piano per la continuità del servi-zio che il disegno del Padre richiede e che essapresta con azione parallela all’azione ininterrottadello Spirito Santo, aiutando le religiose a scorge-re il disegno del Padre riflesso nelle loro esigenzeprofonde, a prenderne coscienza, ad attuarlo gior-no per giorno, ora per ora, sostenendole in questoitinerario che non ha soste e intervenendo sempre,quando influenze naturalistiche lo scolorissero.
Questo servizio diuturno suppone una sensibi-lità spirituale e una donazione di sé che solo dalcarisma dello Spirito santo si può umilmente spe-rare.
Per questo nella prima stesura delle Costituzionisi propose di richiedere, per l’Autorità personalegenerale della Congregazione, l’attitudine alla con-t e m p l a z i o n e .
La proposta non fu accolta e si richiese invece
95
Gesù e anelito del suo Cuore.Quella preghiera e quell’anelito hanno ottenuto
sul Collegio apostolico l’effusione dello Spirito e ditutti i suoi carismi, compreso il carisma del governo.Lo Spirito santo ha incominciato subito ad attuare ildisegno del Padre confermando per la Chiesa laforma istituzionale voluta da Gesù, con la designa-zione di Pietro a capo reale e rappresentativo dellasua stabilità, vitalità e unità.
Il carisma del governo, eminente in Pietro egaranzia dell’unità apostolica, ha insieme corro-borato singolarmente gli Apostoli e ha offertoattraverso i tempi il modello dell’unità di ministe-ro e di magistero della Chiesa Cattolica, in cuitutti i Vescovi governano, in comunione fraterna egerarchica, col successore di Pietro.
Dall’Autorità suprema del Romano Pontefice edai Vescovi in comunione con lui, il carisma delgoverno viene trasmesso al Popolo di Dio.
Così si va attuando il disegno del Padre; questocollegamento realizza l’unità gerarchica che assicu-ra l’unità eucaristica, germe e pegno dell’unità esca-tologica, della consumazione nell’unità (Gv 17)implorata da Gesù per la gloria del Padre.
L’Autorità personale e l’Autorità collegiale sono,per la loro origine e finalità soprannaturali, nellostesso piano, ma vengono distinte in un ordine diver-so: la collegiale a livello elettivo, legislativo, giudi-
94

sottolinea compiti dell’Autorità religiosa in generema specialmente della più rappresentativa delleFamiglie stesse, cioè dai Capitoli, alle cui sollecitu-dini la Chiesa col motu Proprio Ecclesiae sanctaea ffida, prima che alle Autorità personali, il compi-mento di sostenere continuamente un adeguamentoche non si può fare una volta per sempre, cioè coiCapitoli speciali.
Dialogo e consultazione
L’Autorità ha il dovere di controllare le suedecisioni con l’apporto del dialogo e delle legitti-me consultazioni che possono trasmettere laVolontà di Dio, anche se non autenticamentecome l’Autorità stessa.
Oggi l’Autorità non può sottrarsi né al dialogo néalla consultazione, perché la Santa Chiesa su ciò si èespressa chiaramente e l’Evangelica testificatio l eproclama esistenziali, originarie (ET 23 36).
Le nostre Costituzioni ammettevano implicita-mente il dialogo (art. 88) e i nostri consigli generalie locali, estesi spesso alle sorelle presenti, hanno percosì dire anticipato le attuali consultazioni per lo spi-rito di famiglia con cui ci siamo sempre governate,anche sotto forme e con espressioni a volte impera-tive e spesso spicciative.
Indubbiamente la Chiesa vuole facilitare quel-
97
«l’esimia prudenza» suggerita da San Tommaso;perché il carisma del governo è in pienezza nellaChiesa, viene direttamente da lei che, sempre ani-mata dallo Spirito del Consiglio, è sempre anima-trice dei suoi figli col suo Magistero Supremo.
Il governo, docile alla Volontà di Dio (PC 14),che la Chiesa trasmette è, come per i governati,semplice obbedienza al Sommo Pontefice e aiVescovi in comunione con lui.
L’Autorità collegiale apparentemente non halo stesso rilievo nei testi conciliari.
Il Concilio tratta esplicitamente dell’Autoritàreligiosa nel Decreto Perfectae caritatis ma soprat-tutto in relazione all’obbedienza religiosa, quindiprimieramente e diffusamente dell’Autorità perso-nale e solo alla fine e in forma concisa dell’Autoritàc o l l e g i a l e .
Le affermazioni però della costituzione Lumengentium al capitolo VI dedicato ai religiosi, sebbe-ne non accennino a nessuna Autorità, né persona-le, né collegiale degli Istituti, le sottointendono.
Quando infatti il Concilio dice che le famigliesviluppatesi per l’autorità della Chiesa nel campodel Signore... forniscono ai loro membri gli aiuti:a) di una maggiore stabilità nel modo di vivere;b) di una eccellente dottrina per il conseguimentodella perfezione;c) della comunione fraterna della milizia di Cristo;d) di una libertà corroborata dall’obbedienza (LG 43),
96

zioni della base e dei vertice siano ora convergen-ti, ora divergenti per la polivalenza di non pocherealtà umane (ET 28). Dirimere la questione spet-ta alla Superiora e per far tacere ogni critica inter-na ed esterna bisognerà radicarsi nella convinzio-ne che l’obbedienza consiste nel fare la Volontà diDio espressa da un uomo per ciò che riguarda laperfezione (LG 42), non nel fare la cosa migliore.
La cosa migliore, anche nel campo del bene, èobbedire; lo ha dimostrato Gesù per tutti i tempi.
La valutazione del bene migliore può variaresecondo i punti di vista e la Chiesa ci induce a con-siderare legittimo anche l’ordine che apparissemeno buono (ET 28), anzitutto perché il rifiuto del-l’obbedienza porta con sé un danno spesso graveper il bene comune (ET 28) e soprattutto per imita-re Gesù che imparò mediante la sofferenza che cosasignifica obbedire (Eb 5,8).
Anche il dialogo e la consultazione devonoavere dei l i m i t i. La Chiesa li vuole, ma nessun testoconciliare permette di considerarli come un condi-zionamento, un indebolimento, una riduzionedell’Autorità, come è realmente accaduto.
Il dialogo e la consultazione possono incideresul contenuto della decisione dell’Autorità; posso-no determinare una flessione e anche un cambia-mento della decisione che però, quando non è con-tro la legge di Dio e le Costituzioni e quando non
99
l’obbedienza spontanea, libera e responsabile (PC4) che con la Professione religiosa è stata sponta-neamente, liberamente, responsabilmente promes-sa a Dio e giuridicamente convalidata.
Tale facilitazione non dovrà indebolire l’obbe-dienza, perché il dialogo e la consultazione saran-no una sincera ricerca della Volontà di Dio (ET25), tanto da parte dell’Autorità, come da partedelle sorelle.
La ricerca potrà concludersi in tre modi:– Le motivazioni della base coincideranno con
quelle del vertice. L’obbedienza sarà evidente-mente volontaria, spontanea; pronta all’esecuzio-ne e ad assumerne le responsabilità. In questocaso felice, essa sarà un esercizio virtuoso, unsacrificio desiderato, non una morte.
– Si potrà presentare il caso opposto, che cioènon sia possibile la coincidenza dei pareri. LaVolontà di Dio in tale caso sarà che si obbediscaalla decisione dell’Autorità, anche se il contenutodella decisione non sembrasse Volontà di Dio.Solo una certezza di fede (ET 25) potrà rendere, inquesto caso, l’obbedienza volontaria, spontanea,attiva e responsabile. Solo l’amore di Gesù sapràtrovare la vita in questa morte (Cf ET 29) e perquesto la Chiesa raccomanda ai superiori di risve-gliare nelle comunità tali certezze (Cf ET 25).
– C’è pure un terzo caso, che cioè le motiva-
98

obbligassero sempre in forza del voto (con pro-porzionata parità e gravità nelle inosservanze).
Sua Eminenza il Cardinale Piazza non ritenneprudente tale estensione e limitò l’intervento delvoto ai casi gravi.
Ma dopo trent’anni di esperienza, rivalorizzareil voto costitutivo della vita religiosa e particolar-mente della nostra, sarebbe un vero ritorno alnostro spirito primitivo, quando l’indipendenza,oggi così facile nelle piccole cose e spesso anchenelle grandi, non era nemmeno pensabile.
Oggi, in cui è sempre più accentuato il contrastotra la ferma moralità cristiana e la dilagante permis-sività amorale, la rivalutazione del voto di obbe-dienza sarebbe la prova più concreta che la nostraCongregazione non intende far prevalere l’attratti-va delle opinioni correnti sul senso profondo dellavita religiosa, e attraverso il dialogo e la consulta-zione condotta con la serenità che li rende possibi-li, si obbliga più radicalmente all’obbedienza, per-ché ha scoperto che è amore.
101
implica un male grave e certo (ET 28), può esseresempre presa personalmente e liberamentedall’Autorità anche se non coincidesse con le con-clusioni del dialogo e della consultazione.
L’Autorità non è nemmeno obbligata a ricorre-re sempre al dialogo e alla consultazione per pren-dere le sue decisioni.
La loro frequenza e durata dovrebbe ancheessere condizionata dal principio di funzionalità,perché dialoghi e consultazioni a non finire intral-cerebbero, piuttosto che aiutare, lo svolgimentodella vita e delle opere.
Le Costituzioni, come limiteranno l’eserciziodell’Autorità, dovranno limitare anche il ricorso aldialogo e alla consultazione; suggerire di frenarlise degenerassero in contestazioni e di non calco-larli se indebolissero evidentemente lo spirito reli-gioso, sempre tenendo presente però lo spirito delConcilio che li prescrive, per il loro valore e illoro apporto di luce, di forza, di sicurezza, nelgoverno della Congregazione.
Ciò che importa alla Chiesa e a noi è che laVolontà di Dio sia ricercata, amata ed eseguita dachi comanda e da chi obbedisce, come l’ha sem-pre ricercata, amata ed eseguita Gesù.
Per questo sarebbe desiderabile che leCostituzioni e i comandi dell’Autorità conformidirettamente o indirettamente alle Costituzioni,
100

col doppio carisma del governo universale e del-l’infallibilità di Magistero.
Noi dipendiamo da Lui come persone singole ecome comunità per la consacrazione battesimale,vi voti per la consacrazione religiosa e per lo spi-rito particolarmente ecclesiale della nostraCongregazione.
La nostra Congregazione poggia sulla pietra; lanostra casa è fabbricata sulla roccia.
La fede nell’Autorità, su cui Gesù personal-mente ha edificato la sua Chiesa, riservandosi ilcompito di edificarla continuamente fino allacompletezza escatologica, la certezza che controdi essa, per la Parola di Gesù, non può prevalerel’errore, è tutta la nostra sicurezza.
Abbiamo voluto nascere a Roma per immer-gerci nella grande vita della Chiesa «così viva,così palpitante a Roma, che allargava sempre piùpensieri e cuori... Oh, le beatificazioni e canoniz-zazioni dei Santi, lo spettacolo di San Pietro allamorte di Pio XI e all’elezione di Pio XII (i dueSommi Pontefici che ci approvarono vivae vocisoraculo prima dell’approvazione canonica), lavisione del dolce Gesù in terra benedicente la cittàe il mondo dalla loggia vaticana...» (da Olga MD):sono ricordi indimenticabili per le prime Figliedella Chiesa.
«Le frequenti udienze pontefice ci mettevanole ali ai piedi nelle corse allo steccato per vedere
103
AUTORITÀ NOSTRE
Autorità civili
Sono Autorità nostre anche le Autorità civili,perché anch’esse vengono dall’alto e Gesù haaffermato questa verità proprio davanti ad una diesse.
Dobbiamo dipendere dalle Autorità civili cometutti e più di tutti, perché religiose, cioè obbligatea tendere alla perfetta carità (PC 11).
Sottostare alle leggi civili e fiscali, prima chedovere di carità, è dovere di giustizia: è il nostrocontributo umano al bene comune e all’ordinetemporale che ci ripromettiamo dall’eserciziodell’Autorità civile e di cui tutti godiamo e speria-mo di godere.
Ma sono particolarmente nostre le Autorità eccle-siastiche, istituite da Gesù per elevarci all’ordinesoprannaturale e le Autorità religiose, approvatedalla Chiesa per aiutarci a vivere stabilmente in essoe a rispondere alle sue esigenze universali.
Autorità ecclesiastiche
Il Sommo Pontefice è la suprema Autoritàecclesiastica: è il Servo dei servi e dei figli di Dio,
102

cipazione della Congregazione alla vita dellaChiesa, allo scopo di approvare le attuazioni diquelle realizzabili nelle rispettive diocesi, se dicarattere locale, e estendere quelle di carattereuniversale a tutta la Congregazione, in conformitàalle Costituzioni.
Per i recenti ridimensionamenti dei rapporti fral’attività pastorale e religiosa, le Figlie della Chiesadevono mantenersi fedeli alle loro norme, ma ancheattente ai desideri dei loro Vescovi e pronte a collabo-rare nei limiti delle possibilità dentro il piano dellaChiesa locale, anche, se occorra, col sacrificio, nondello spirito proprio, ma delle loro opere.
Autorità religiose personali
Nel governo dei religiosi le Autorità personalihanno compiti ben precisati che qui riassumiamo:La superiora deve rendere conto a Dio delle animea lei affidate (PC 14);
– essere docile alla Volontà di Dio; – esercitare l’autorità in spirito di servizio; – esprimere la carità di Dio; – reggere le sorelle come figlie di Dio; – promuovere la loro spontanea obbedienza; – concedere loro la dovuta libertà; – guidarle in modo che la loro obbedienza
sia attiva e responsabile;
105
il Papa, per toccare il Papa, per dire al Papa anchesolo: Noi Vi vogliamo bene, Padre santo, viviamoper Voi, soffriamo con Voi, vorremmo condurretutti a voi.
E la nostra Serva di Dio poté perfino dirgli, conle parole della Piccola Santa, ciò che avremmovoluto dire tutte: Santo Padre, nel Vostro cuoreche è il cuore della Chiesa, io voglio essere l’amo-re!» (da Olga MD).
Simile fede e simile affetto ci legava pure ainostri Vescovi. Si voleva concretare con la cessio-ne alle loro chiese locali di tutti i nostri beni.
Olga descrive umoristicamente la mia trepida-zione nei raduni al Palazzo Patriarcale di Veneziaper l’esame delle Costituzioni: «La Madre osser-vava... contenta di ciò che la Chiesa faceva; pron-ta a cedere, ma con l’occhio supplice nei puntidelicati, come il restar povere, dando tutto al Papae ai Vescovi...» (da Olga MD), ciò che fu possibi-le solo prima dell’approvazione canonica.
Ma la disponibilità filiale delle Figlie dellaChiesa verso i loro Pastori in comunione colPastore supremo, non è mai venuta meno e nondeve mai venir meno.
L’articolo 236 delle Costituzioni sottolineaquesto dovere che impone al Capitolo generale diesaminare in particolare le proposte suggeritedagli Ordinari per una più attuale e feconda parte-
104

La Superiora generale
Le prime nostre Costituzioni assegnano allaSuperiora generale, ed esclusivamente a lei, iltitolo di Madre, perché dovrebbe avere qualitàumane distinte e spirito di carità autentico.
Il Concilio insiste piuttosto sull’esercizio del-l’autorità come servizio e la Superiora generaleemerge dai documenti conciliari come la servadelle sue sorelle.
Il contrasto è solo apparente, perché nessunopiù della madre è a servizio dei figli, nessuno savigilarli, ascoltarli, conversare con loro, guidarli,incoraggiarli come lei.
La Superiora generale è sorella in Cristo ditutte le sue sorelle e assume «il titolo di madre»per esprimere la sua maggiore libertà di donarsi atutte, per portare tutte a Cristo.
Fra noi ciò è riuscito facilmente finora. Possodire con San Paolo: «Le sorelle non mi trattanocon minor riverenza per il fatto che sono sorella,anzi mi servono meglio, proprio perché sono loromadre e madre amata».
Anche teologicamente alla Superiora generalepuò competere il titolo di madre, come rappresen-tante di Dio (PC 14) che è carità paterna e mater-na, che è Padre ed è più tenero della madre chepalleggia il suo bambino, e in Gesù nostro Fratello
107
– ascoltarle volentieri;– promuovere l’unione delle loro forze;– decidere e comandare ciò che si deve fare.Ogni superiora deve assumersi tali obblighi,
ma il loro disimpegno potrà essere diretto o indi-retto e svolgersi con modalità diverse a livello digoverno generale e locale.
Una Superiora locale può seguire personal-mente le sorelle, può ascoltarle immediatamente,servirle anche materialmente, esprimere visibil-mente la carità di Dio, promuovere più efficace-mente la loro formazione continua, la loro comu-nione e la loro collaborazione apostolica.
Per questo l’Evangelica Testificatio precisache la presenza e il riconoscimento dellaSuperiora sono indispensabili in ogni comunità.Né la Superiora generale, né il Consiglio può sup-plirla. Ciò ammesso, è pure certo che gli impegnidi governo gravano in modo anche numericamen-te più gravoso sulla Superiora generale che dovràrendere conto a Dio delle anime di tutte le sorellea lei affidate (PC 14).
Bisognerà quindi che nel Capitolo elettivo siaprofonda l’esigenza di una madre, di una guida, diuna animatrice che desideri soprattutto l’unionecon Dio, in Gesù e con le sorelle sue spose, nelvincolo dello Spirito santo.
106

sorelle, la Superiora generale le guiderà in modoche trovino conforto nella sua verga e nel suobastone (Ps 22,4) e praticamente:
dovrà garantire tutta la sua efficacia agli ele-menti della vita religiosa: lo studio sacro e l’ora-zione, la partecipazione liturgica, l’ascolto dellaParola di Dio e della Chiesa, la vitalità e la testi-monianza dei voti, la comunione fraterna e gerar-chica, lo spirito apostolico;
dovrà pure verificare se il lavoro è conformealla vocazione dell’Istituto, che è il dono radicalee totale di sé per la Chiesa e per il mondo, con lacollaborazione alla pastorale della Chiesa e conl’assistenza caritativa occasionale;
dovrà definire con chiarezza i due ambiti del-l’attività esterna e della vita comune (ET 26),tenendo conto il più possibile della proporzioneesemplare tra la vita privata e la vita pubblica delSignore che si ritenne fin dagli inizi l’elementodifferenziale della nostra Congregazione.
La Superiora generale, per il carisma delloSpirito santo, nell’ambito della Congregazionepotrà e dovrà essere con Lui l’animatrice dellospirito delle Beatitudini.
I documenti conciliari assegnano prevalente-mente al laicato il compito dell’animazione del-l’ordine temporale e riservano ai religiosi il subli-me compito di testimoniare in modo splendido e
109
«è come la donna che spinta dall’affetto naturale èsollecita a nutrire il suo bambino col suo latte ecol suo sangue». La Superiora generale dunque,come una madre e più di ogni altra superiora:
– provvederà quanto occorre alle sorelle e aipoveri (ET 21);
– veglierà per loro, prevenendo con carità iloro bisogni;
– sarà per tutte vincolo di unione (Cost. 283); – sarà a loro servizio (ET 24), fino al sacrificio
della salute e della vita, a imitazione di Gesù cheamò la Chiesa e per essa sacrificò se stesso;
– assicurerà le condizioni indispensabili per laloro vita spirituale (ET 26), vigilando che non siaffievolisca lo spirito di contemplazione e l’atti-vità non sottragga tempo all’orazione (Cost.241);
– solleciterà la loro collaborazione oltre i limitigiuridici, particolarmente in seno al suo Consiglioche dovrà essere, per tutta la Congregazione, ilmodello della loro unione familiare.
Il Concilio, nel delineare la figura dellaSuperiora, sottolinea la sua funzione di g u i d a che èessenzialmente materna e nella Lettera agli Ebrei siidentifica con l’autorità che la esercita: «I superiorisono le guide che devono rendere conto delle animeloro affidate» (PC 14; Eb 13,17).
Per poter compiere il suo ufficio con gioia, nongemendo, ché ciò non sarebbe vantaggioso per le
108

– la diffusione del Magistero supremo.Tutto ciò primieramente con la segreta fecon-
dità dell’orazione privata e pubblica e con la sof-ferenza accettata come un dono per la salvezza deifratelli: finalità suprema della Chiesa a gloria delPadre. Perché la Congregazione porti questi fruttidi salvezza (PC 25) sempre più abbondanti, laSuperiora generale imiterà la dolcissima VergineMadre di Dio, la cui vita è modello per tutti (PC25).
A lei, Vergine prudentissima, chiederà la pru-denza, particolarmente quando il lavoro comunedovrà concludersi con la sua decisione.
A lei, Madre della Chiesa, chiederà il carismadella maternità spirituale, perché le sorelle si sen-tano guidate e animate a formare un cuor solo nelsuo Cuore.
La Superiora locale
Gli obblighi della Superiora generale sono glistessi per la Superiora locale, ma alleggeriti dallasua responsabilità condivisa.
La convivenza continua, con un gruppo limita-to di sorelle, le consente un disimpegno più faci-le, perché la permanenza in uno stesso ambienteevidenzia maggiormente le esigenze comunitariee pastorali, facilita i rapporti spontanei, semplifi-
111
singolare che il mondo non può essere trasfigura-to e offerto a Dio senza lo spirito delle beatitudini(LG 31).
È una trasfigurazione che solo lo Spirito santo,Anima della Chiesa, può animare e operare e in cuisi associa, col carisma del governo, come umilistrumenti, anche i superiori.
È quindi dovere particolarmente dei superiori, esingolarmente della Superiora generale, risvegliarenelle comunità le certezze della fede che devonoguidarle, promuovendone lo studio e la meditazio-ne, che hanno lo scopo di approfondirle e di tradur-le in vita (ET 25).
È pure dovere della Superiora generale far pro-prie le iniziative e le finalità della Chiesa nei varicampi come quello biblico, liturgico, dogmatico,pastorale, ecumenico, missionario e sociale (PC 2c)e sensibilizzare tutta la Congregazione a ritenerecompiti propri:– la partecipazione e la collaborazione alla pasto-
rale ecclesiale;– il culto eucaristico; – l’animazione liturgica; – la catechesi a tutti i livelli;– la formazione delle apostole laiche; – l’apostolato sociale; – l’apertura ecumenica; – l’espansione missionaria;
110

amore sincero, la loro spontanea, attiva, responsa-bile obbedienza; per concedere loro, con amorosaprevidenza, la dovuta libertà; perché sia ricercatacordialmente e adempiuta fraternamente insiemela Volontà di Dio (PC 14).
Autorità religiose collegiali
Finora abbiamo avuto una sola Autorità colle-giale, il Capitolo. Il Consiglio generalizio avrebbedovuto funzionare collegialmente, in senso stret-to, solo per eventuali dimissioni.
La collegialità è un principio che si è impostoquasi violentemente, sotto la spinta dello spiritodemocratico attuale. La Chiesa certo trarrà, daquesto segno dei tempi, le sue nuove strutture digoverno. Il recente Decreto del 2 febbraio 1972trattiene e contiene la collegialità, ma anche lariconosce, perché le deliberazioni collegiali riflet-tono meglio le aspirazioni della Congregazione ela responsabilità delle decisioni, troppo gravosaspesso per un’unica persona, è condivisa e cosìalleggerita.
Ma una collegialità troppo frequente e controppi compiti ostacolerebbe la funzionalità delgoverno e indebolirebbe gli strumenti e i mezzi dicui ordinariamente ha bisogno chi governa: lalibertà di movimento, l’intuizione delle situazioni,
113
ca il governo e la dipendenza.La Superiora locale è la «prima Sorella», la
sorella maggiore che ha particolarmente il compi-to di mantenere viva l’unione con la Madre e lospirito di famiglia.
Lo spirito di famiglia è stata la prima espressio-ne, riconosciuta anche dai laici, della nostra vita reli-giosa che è nata, si può dire, intorno all’altare.
Ignare del Diritto comune e non possedendoancora alcun diritto privato, nostra norma era l’i-mitazione della Chiesa Madre nostra, nell’azioneimmediata e visibile delle assemblee liturgicheove tutto era previsto, preordinato, organizzato,perché la partecipazione sia piena, fervida,responsabile (Cf SC 24), anche quella dei bambi-ni e dei vecchi.
Alla liturgia si ispiravano i nostri rapporti, riu-nioni e consultazioni che si svolgevano abitual-mente alla mensa. E, come nella mensa eucaristi-ca, vi erano esclusi le divisioni, i giudizi maligni,le liti (da Ubi caritas); Gesù era davvero in mezzoa noi.
La comunione eucaristica trasfondeva tutta lasua forza unitiva nella comunione comunitaria e sistabiliva spontaneamente quel clima di famigliache facilita alle sorelle l’apertura d’animo con lasuperiora e alla superiora l’esercizio dell’autoritàpersonale di cui deve godere per promuovere, con
112

Verità evangelica e in particolare quella segnalataper noi dalla Chiesa, e rinnovare ciò che non si puòconservare con lo spirito dinamico impresso in noidalla Chiesa: questo il compito del Capitolo.
L’importanza generale e straordinaria di talecompito richiede elementi qualificati per spiritoreligioso, spirito di famiglia, buon senso, compe-tenza, e profondamente convinti della propria ina-deguatezza, perché non venga intralciata l’azionedello Spirito santo e sia favorita l’effusione delsuo dono di Consiglio.
La scelta delle delegate al Capitolo assumequindi una importanza conseguente e richiedemolto senso di responsabilità.
Il Consiglio generalizio
Composto dalla Superiora generale e dalle sueConsigliere, potrebbe essere collegiale:– per le elezioni agli uffici generali che si rendes-sero vacanti;– per gli adattamenti temporanei di qualche puntodelle Costituzioni, dietro richiesta delle Chieselocali;– per l’accettazione temporanea di qualche opera
nuova;– per la soluzione tempestiva di affari straordina-
ri; – per le eventuali dimissioni.
115
la tempestività spesso necessaria per le risoluzio-ni urgenti, ecc. Con la responsabilità diminuireb-be forse anche l’impegno del governo e l’unitàdella Congregazione, ridotta quasi esclusivamen-te all’unità di magistero, si presenterebbe carente.
Il Capitolo generale
È la prima Autorità della Congregazione.La sua collegialità non è quella democratica, per-
ché anche le deliberazioni capitolari sono condiziona-te dall’obbedienza vi voti al Sommo Pontefice, vinco-lo che noi conserveremo anche se venisse sciolto dalnuovo Diritto, per il filiale amore da cui spontanea-mente ci vogliamo legare, per mantenere sempre piùstretta la nostra unione comunitaria ed ecclesiale.
I lavori del Capitolo elettivo si svolgeranno rigoro-samente, come il Diritto della Chiesa prescrive e leCostituzioni precisano.
Gli altri lavori rifletteranno ciò che Paolo VI hadetto della Chiesa:
«La Chiesa, quand’è fedele a se stessa, ha il dupli-ce e simultaneo carisma della fedeltà e della velocità,perché possiede la Verità divina ed eterna, extratem-porale e ultratemporale, che mentre la conserva nellasua vivente identità, la spinge a sempre continuo per-fezionamento e rinnovamento» (Paolo VI, 7-3-1973).
Conservare ciò che non si può rinnovare: la
114

Partecipazione al governo
Tutte partecipano al governo con le loro delegateal Capitolo e con le elette dal Capitolo al compitigenerali e specifici della Congregazione.
Sarà bene che oltre le Consigliere generalisiano elette dal Capitolo anche la Segretaria el’Economa generali, la Delegata per le Missioni ele Incaricate generali. Tali cariche saranno bendeterminate dalle Costituzioni, perché la parteci-pazione al governo sia una collaborazione che lofaciliti e non lo intralci o lo sostituisca.
Per una maggiore partecipazione della base sipotrebbe aggiungere al Consiglio generalizio e allealtre Incaricate generali la Commissione delleConsigliere e Incaricate generali con le delegate del-l’ultimo Capitolo presenti a Roma, da convocare econsultare in casi di particolare bisogno e incertezza.
Tutte le sorelle partecipano inoltre al governo econ le consultazioni generali e con le consulte difamiglia, di cui il Consiglio potrà tener conto nellascelta delle Superiore e delle consigliere locali.
Il rinnovamento continuo della Chiesa impe-gnerà la Congregazione a un continuo rinnovamen-to e basterà per questo applicare l’articolo 236 delleCostituzioni e le norme del Concilio, particolar-mente del documento post-conciliare E c c l e s i a eS a n c t a e (Decreto applicativo del PC).
117
Le Consigliere generali partecipano attualmenteal governo col loro consiglio e accogliendo o meno,con le loro deliberazioni, le proposte dellaSuperiora generale.
Il nostro stile di famiglia ha sempre escluso finqui il «voto segreto» e nelle relazioni quinquenna-li alla Santa Sede ci siamo sempre difese con lasua inutilità per noi.
Era di fatto così. Le nostre riunioni diConsiglio si sono sempre concluse con un «votopieno». O le consigliere accettavano pienamentela nostra proposta, o noi accettavamo pienamenteil loro parere contrario.
Le Costituzioni e il Direttorio dovranno tenerconto di questo stile e spirito nostro che non vuolea ffatto escludere le sagge e prudenti norme dellaChiesa, ma le include anzi spontaneamente nellasua norma suprema che è l’amore.
La nostra prassi di Consiglio non potrà forsecontinuare sempre così ed essere approvata.
Si potrebbe proporre:1) o di distinguere il Consiglio familiare dal
Consiglio collegiale, conservando al primo il solovoto consultivo;
2) o di conservare il Consiglio com’è nelleCostituzioni approvate e introducendo la prassi col-legiale solo come prescriverà il Diritto comune.
116

Formazione religiosa
Si dovrebbe dire con più precisione carismati-ca, perché non è esigenza battesimale ma solo vir-tualità, capacità di ricevere i carismi dello Spiritosanto e di formare le anime a riconoscerli ed even-tualmente ad accoglierli.
È quindi una formazione straordinaria e neces-saria solo ai chiamati da Dio a testimoniare interra i beni celesti (LG 44).
Consiste nel collaborare con lo Spirito santoper far intendere la portata dell’invito di Dio, lesue esigenze supreme, lo spirito e il contenuto deiConsigli evangelici che dopo la Professione reli-giosa si tramuteranno, per la nostra libera volontà,in precetti. Questa formazione specifica dei perio-di detti appunto «di formazione» e particolarmen-te del noviziato, dovrà continuare tutta la vita,essere la formazione caratteristica della nostravita religiosa, un avanzamento progressivo versola perfezione della carità (PC 4), come precisa ilConcilio. La formazione religiosa suppone edesige una formazione cristiana almeno inizial-mente integrale; corpo anima e Spirito santodevono convivere insieme nella persona umanapartecipe della divina natura.
Soltanto sulla base di questa unità è possibileuna formazione carismatica che, corredata da una
119
Il Capitolo attuale potrà quindi, e forse dovrà,suggerire e stabilire nuove forme di vita e di apo-stolato e, conseguentemente, anche nuove formedi governo, purché la radicalità dello spirito evan-gelico e del nostro spirito non venga compromes-sa da ibride realizzazioni.
Conclusione pratica
Perché l’obbedienza sia facilitata, amata e pos-sibilmente eseguita con gioia, tutte le impegnatenel governo considereranno come loro primoimpegno la partecipazione attiva ai compiti dipietà, di studio, di lavoro, di apostolato chedovranno assegnare, servendo davvero le sorelle afianco delle sorelle come una di loro.
Ciò, si comprende, nei limiti del possibile, chel’amore allargherà sempre più, moltiplicando conla gioia le forze.
È un’esperienza dei nostri primi anni, quandola superiora si confondeva con le sorelle, sponta-neamente, proprio come una di loro.
E, grazie a Dio, è un’esperienza anche di ogginelle case dove la Superiora è la serva di tutte,l’ancella del Signore come la Madonna.
118

che spesso costituiscono una vera contro ricchez-za dello spirito, provocante il «Guai a voi!» delSignore contro chi usurpa i beni dati dal Creatorea tutti.
La nostra povertà di spirito dovrebbe arrivarealla nudità di spirito descritta da San Giovanni dellaCroce; al distacco dalla comprensione, dalla stima,dall’amore delle creature.
Raramente affrontiamo questi deserti e Dio cifa giungere alla beatitudine della vita eterna con lesue prove, le malattie, la vecchiaia, la nudità dellamorte.
La formazione delle chiamate a testimoniare lavita eterna (LG 44), dovrebbe orientarle a pregustarla,a ffrontando questa via stretta che conduce alla vita(Mt 7,14) e le umiliazioni incluse nel patire che bastaa ciascun giorno (Mt 6,34) da cui fiorisce, comehanno sperimentato tutti i Santi, la perfetta letizia apo-stolica (Fioretti di S. Francesco).
La formazione metterà contemporaneamentein luce l’entità della rinuncia totale e i limiti del-l’uso dei beni materiali insistendo:
– sullo spirito di semplicità nell’abitazione,nell’arredamento, nel vestito, nella mensa, chedeve distinguere la nostra povertà apostolica;
– sull’abbandono alla Provvidenza, che non con-sente di preoccuparsi e di disporre personalmente dieventuali offerte, stipendi, assicurazioni, ecc.
121
sana Psicologia, illuminata dalla Parola di Dio edella Chiesa, sostenuta dall’animazione liturgica eda una partecipazione liturgica sempre più piena,attiva e consapevole (SC 48), conduca gradual-mente la Figlia della Chiesa, a testimoniare ilVangelo fino a rivelare al mondo lo spirito dellebeatitudini (LG 31).
La castità perfetta lo rivela perché rivela l’amoredi Dio che la fa abbracciare. Solo l’amore di Dio,infatti, chiama alla castità religiosa in forma decisiva( E T 13) e primo compito della formazione è render-ne sempre più consapevole l’anima.
Secondo dovere: aiutare a distinguere il dono pre-zioso (ET 13) della sublimazione nello stato religioso,che il Padre concede ad alcuni (ET 15), del donocomune dell’integrazione nello stato coniugale, siapure elevato a dignità di sacramento.
Terzo dovere: precisare le rinunce che lacastità perfetta comporta, le compensazioni checonsente e le mortificazioni che la perfezionanosempre più, moltiplicandone la fecondità.
La povertà volontaria rivela direttamente lospirito delle beatitudini e ne è il compendio.
La formazione dovrà subito far rilevare il pri-mato della povertà di spirito consigliata a tutti, maparticolarmente ai poveri volontari, a noi, perchéla rinuncia dei beni materiali non potrà mai com-pensare il possesso esclusivo dei beni personali
120

zioni d’amore che le rendono possibili.L’amore infatti fa scaturire da ogni rinuncia un
arcano senso di possesso e da ogni offerta la gioia diuna libertà libera dai suoi condizionamenti.
La Chiesa, divinamente ispirata, per otteneredai suoi figli prediletti un’obbedienza sempre piùsoprannaturale, suggerisce un nuovo metodo diformazione che consiste nella ricerca fraternadella Volontà di Dio per mezzo del dialogo e dellaconsultazione (ET 25).
Ad essi si dovrà sempre ricorrere quando siapossibile funzionalmente, ma non dovrà mai man-care la disponibilità di collaborare insieme e disottomettersi infine alla decisione di chi rappre-senta Dio.
Il punto più delicato della formazione all’obbe-dienza religiosa è l’allenamento all’esercizio dellalibertà che si deve concedere.
Le scelte e le iniziative personali saranno sem-pre limitate dagli impegni assunti e dal riconosci-mento indispensabile dell’autorità, sull’esempio diGesù, che ha dichiarato di essere venuto non perfare la sua volontà, ma la volontà del Padre e diaverla fatta sempre (Gv 8, 29).
Gesù ha dato la vita liberamente, per iniziativapersonale e ha obbedito fino alla morte al Padre suo.
Le due realtà si sono fuse nell’amore.Libertà e obbedienza sono una realtà sola per chi
123
– sulla dipendenza nell’uso di oggetti che siritenessero anche necessari; per il nostro partico-lare spirito che vuole regolata dall’obbedienza lastessa virtù della povertà;
– sul dovere del lavoro per il mantenimentoproprio, della propria famiglia religiosa e deipoveri (ET 20), cui si dovrà provvedere, se occor-ra, anche con la privazione personale e comunita-ria del necessario.
Perché la nostra povertà esterna sia apostolica,particolarmente in questo tempo in cui si fa piùincalzante che mai il grido dei poveri (ET 17), saràsempre ricordata la effettiva povertà dei nostri inizi,così esemplare che il popolo ci distingueva come les u o re povere ( d a Olga MD) e saranno mostrate allechiamate ad essere povere come Gesù, prima cheagli altri, le prove, anche esterne, dell’autenticapovertà (ET 1 8 ) .
La formazione all’obbedienza religiosa è la piùardua e impegnativa.
I documenti conciliari e post-conciliari presen-tano l’obbedienza religiosa come rinuncia com-pleta (PC 14) e come offerta totale (ET 27) dellavolontà per conformarsi più pienamente a Cristoobbediente (LG 42) e per partecipare all’offerta diCristo.
La formazione dovrà illuminare questi dueaspetti: della rinuncia e dell’offerta e le motiva-
122

sue conseguenze inevitabili, e dalle ricchezzedella sua immacolata concezione. Ella l’ha pro-nunciato nella «libertà perfetta» (Gc 1,15) cheobbedisce alla sola legge interiore dell’amore evede nelle leggi umane i raggi di questo unicosole.
È la «libertà vera» che la Chiesa chiede alPadre per tutti i suoi figli; la libertà dei figli di Dio(LG 14), semplice, spontanea e ordinata, in cuil’autorità trova il suo pieno riconoscimento (ET25).
La Chiesa ammira in Maria ciò che desidera espera di essere (SC 103). Noi dobbiamo formare aquesta ammirazione, aspirazione e speranza chesono le espressioni della libertà raggiunta, e all’u-mile «sì» che la esprime integralmente.
125
ama: «Ama e fa’ quello che vuoi» (S. A g o s t i n o ) .Perché il rapporto fra l i b e rt à e o b b e d i e n z a si realiz-za a tre livelli e possiamo dire a quattro:
a) a livello infantile: la libertà è spesso capric-cio e l’obbedienza sottomissione esterna;
b) a livello di maturità umana: la libertà è rego-lata dalla ragione e l’obbedienza è accettata invista del bene che produce;
c) a livello soprannaturale: la libertà è regolatadalla fede e l’obbedienza è accettata perché èVolontà di Dio;
d) a livello religioso: la libertà è «la libertàlibera» (PC 14) dei figli di Dio: l’atto di obbedien-za è un atto di libertà che risale al libero donodella libertà nella Professione religiosa: l’obbe-dienza è amore. La Figlia della Chiesa dovrà ten-dere a questo amore di cui l’obbedienza assicural’autenticità e la nostra formazione religiosa dovràapprofondirne il contenuto.
Il voto di obbedienza è espressione, come glialtri due voti, della nostra consacrazione radicale,ma più degli altri due le imprime questo suggellodi autenticità.
Maria, perché vergine e perché povera, piac-que a Dio, ma lo concepì nelle sue viscere per ilsuo umile: sì!
L’umile sì di Maria ha tutta la pienezza che glideriva dalla esclusione in lei del peccato e delle
124

S P I R I TO
Le Figlie della Chiesa vogliono essere come laloro Madre, ferventi nell’azione e dedite alla con-templazione, ma in modo che l’azione sia ordinata esubordinata alla contemplazione, il visibile all’invi-sibile, la realtà presente alla futura città verso laquale sono incamminate.
Per vivere e testimoniare il Mistero d’amore che èla Chiesa con la carità diffusa nel loro cuori dalloSpirito santo, partecipano alla morte e risurrezione delSignore compiendo liturgicamente, col lavoro e con lacollaborazione alla pastorale della Chiesa e la pena di
127
Partecipazionespecifica

Dedicano due tempi, di un’ora ciascuno, all’o-razione personale, insostituibile collaborazioneecclesiale;
– abitando preferibilmente appartamenti o casepiccole e povere, attigue a centri di animazioneeucaristica;
– dirigendo case per incontri ed esperienze dipreghiera, o di temporanea distensione spirituale;
– mostrando la presenza della Chiesa, nella suaforma più piena, in qualche casa di pura vita con-templativa.
La loro collaborazione alla pastorale dellaChiesa locale si estende a tutti i settori dell’apo-stolato diretto: parrocchiale, interparrocchiale,diocesano, familiare, scolastico, operaio... e laloro collaborazione alla pastorale della Chiesauniversale si esprime soprattutto con la diffusionedel suo Magistero.
Le Figlie della Chiesa accettano anche, ecce-zionalmente, oltre l’impegno comunitario dellacarità occasionale e l’assistenza ai genitori e aqualche Sacerdote bisognoso, qualche altra operacaritativa con illuminato adattamento delleCostituzioni.
129
ogni giorno, ciò che manca alla Passione di Gesù peril Corpo di Lui. Per questo prolungano nella loro vitala partecipazione liturgica al Mistero pasquale, allef u n z i o n i della Chiesa, e:
– adorano il Padre in spirito e verità;– animano il culto eucaristico, in particolare
l’Adorazone pubblica del S.S. Sacramento;– collaborano alla pastorale della Chiesa locale e
universale nelle loro dimensioni spirituali, particolar-mente nella formazione delle apostole secolari;
– cercano di sollevare ed elevare i cuori con lagioia che è il dono pasquale di Gesù, il frutto delsuo Spirito e una anticipazione della manifesta-zione escatologica dei figli di Dio, attesa congemiti da tutta la creazione.
ESPRESSIONI
Per acquistare e conservare lo spirito contem-plativo, le Figlie della Chiesa osservano fedel-mente il silenzio evangelico e si impongono ilsilenzio interiore che dispone all’ascolto delVerbo.
128

concessione di Paolo VI, ad erigere almeno unmonastero a Fatima, dove speriamo che le Figliedella Chiesa «compiendo ciò che manca al sacri-ficio incruento della Vittima gloriosa che suinostri altari non può più né patire né morire» (33Foglietti pag. 18) collaborino, con la loro immo-lazione incondizionata, alla pastorale di tutta laChiesa.
Il Capitolo speciale ha esteso il beneficio di unaripresa spirituale straordinaria a tutta laCongregazione con le «solitudini», stabilendo cioèche qualche casa, e la stessa casa di Fatima, sia riser-vata anche a una clausura temporanea e alla strettao s s e r v a n z a .
Se la perfezione però è favorita dalla vita contem-plativa, non vi è legata e la Chiesa ha il supremoimpegno di presentare Cristo che sempre obbediscealla Volontà del Padre che lo ha mandato (LG 46).
Noi abbiamo quindi obbedito alla volontà deiSommi Pontefici che ci hanno spinto insistente-mente all’azione con «l’augurio di ogni migliorfrutto di bene nel campo della carità», con l’inci-tamento «a una alacrità di opere che ci farannoricche davanti a Dio», «a iniziative benefiche dipartecipazione alla multiforme vita della Chiesa»,«a un fattivo spirito di carità» e «ad essere per laChiesa di Dio vere figlie consacrate al suo servi-zio», «all’impegno apostolico di far sempre più
131
RIFLESSIONI
La nostra parte
Presentare Cristo ai fedeli e agli infedeli men-tre Egli contempla sul monte (LG 46 ), primeggiafra tutti gli impegni della Chiesa.
Noi non abbiamo abbracciata la vita contem-plativa, perché allora ci sarebbe stata preclusa e iola ritenevo più adatta ai tempi moderni con unosbocco apostolico, nel rapporto inverso da quellogeneralmente in uso nelle nuove congregazioni,cioè di trenta a tre fra la vita privata e pubblica,come nella vita del Signore.
L’enciclica di Pio XII sull’apertura dei monasterici parve una conferma e lo stesso Pio XII, personal-mente da noi interpellato sulla scelta tra la vita con-templativa e apostolica, ci additò «la sofferenza nel-l’apostolato» come il vertice della perfezione.
Oggi il Concilio ha rimesso al vertice la vitacontemplativa con la sua solitudine e il suo distac-co totale e noi ci siamo affrettate, per benigna
130

incontri ed esperienze di preghiera e progettammo il«Paesetto della Madonna» per compiere ed accoglie-re opere di carità di altre Congregazioni e testimo-niare l’unione nella carità.
La formazione delle Figlie della Chiesa è unicae non può essere che unica: contemplativa e apo-stolica, perché tale è la natura della loro Madre edella loro Congregazione.
Però lo Spirito santo che spira dove vuole e comee quando vuole (Gv 3,8), può spingere più verso lacontemplazione che verso l’apostolato e viceversa, ein tempi e modi diversi, impensati, suoi.
Eventi, pressioni psico-fisiche, influenzeambientali possono pure condizionare e mutare leinclinazioni dello spirito.
Se ciò avviene nei periodi di formazione, èfacile aprire alle anime la loro via; ma ciò puòavvenire quando una religiosa, per seguire lenuove tendenze, mancherebbe di fedeltà alle suepromesse perpetue.
La clausura e l’apertura delle case sociali ecaritative offrono la possibilità di esperienze chenon sottraggono nulla al sacrificio offerto a Dio,perché Dio stesso per mezzo della Chiesa nevuole mutare la forma e l’intensità.
L’apostolato che compie la passione di Gesù èla prima forma scelta per noi dalla Chiesa vivaevocis oraculo di Pio XII.
133
conoscere e amare Maria e la Chiesa».Paolo VI ha elevato la nostra vita di A d o r a z i o n e
al livello della vita contemplativa (dalla lettera alS u p e r i o re dei Sacramentini) e Giovanni XXIII l’a-veva incoraggiata col suo ricco dono di incenso pale-stinese. Da un anno Sua Santità ci ha designateall’Adorazione in Santa Maria Lata al Corso per l’u-nità della Chiesa.
Dio vuole da noi indubbiamente il servizio e lapreghiera, il fervore dell’azione e la dedizione allacontemplazione che è garanzia della sua autenti-cità e fecondità.
La Chiesa ci chiede pure l’azione caritativa:non c’è dubbio. Le aperture nel campo sociale ecaritativo si erano imposte anche prima delConcilio per volontà esplicita della Chiesa.
Il Decreto di approvazione definitiva dell’8 giu-gno 1957 le riconosce con un’ampiezza che ci sor-prese, perché non richiesta e non desiderata.
Avevamo infatti una sola casa esclusivamentedi carità, aperta dagli inizi per i genitori dellesorelle bisognosi di assistenza.
Le nostre specifiche finalità restarono approva-te e confermate, ma il desiderio della Chiesa, cosìgiuridicamente espresso, ci indusse ad aprire laporta alle opere sociali e caritative.
Accettammo dapprima le attività più vicine alnostro programma: le case di esercizi spirituali, di
132

della Chiesa, è detto che penetra tutte le cose, anchele profondità di Dio (1Cor 2, 10).
La Chiesa è scaturita dal costato di Gesù more n -te (SC 5) che sempre attira: Mi attirerò la mia Sposa(Os 2,16); continuamente animata dallo Spirito santoe arricchita dalle sue virtù, dai suoi doni, dai suoifrutti, dai suoi carismi, dalle sue beatitudini, dallesue promesse e dalle sue esperienze gloriose, anelaalla perfetta unione con Cristo: la sua vita è nasco -sta con Cristo in Dio (Col 3,3).
Anche se ciò non appare, i gemiti dello Spirito:Vi e n i ! (Ap 22,17 ), sono i suoi gemiti: Vieni, SignoreG e s ù ! (Ap 22,20).
N e l l ’ attesa gli esprime, con le diuturne salmodie,tutta la sua umanità; invoca la Madre dellaMisericordia di mostrarle, dopo l’esilio, Gesù, ilFrutto benedetto del suo seno e già lo pregusta, nellesue comunioni eucaristiche e mistiche, come Ve r b oe Pane della vita.
La Chiesa contemplativa possiede: la conoscen -za che è la vita eterna (Gv 17,3) e, in senso biblico,l’unione con Dio: Ti sposerò nella fedeltà e tu cono -scerai il Signore (Os 2,22); l’unione della fede, vivi-ficata dalla grazia: Ti sposerò nella giustizia e neld i r i t t o (Os 2,21); l’unione dell’amore corroborato daanticipazioni di gloria: Ti sposerò nella tenerezza en e l l ’ a m o re (Os 2,2).
La liturgia ha tutta la carica sacramentale della
135
La contemplazione pura e il servizio dei fratel-li nelle opere di misericordia corporale, sono dueforme suggerite dalla carità, ispirate dal Concilioe in precedenza approvate dalla Santa Sede, checompletano la fisionomia delle Figlie della Chiesae le fanno più simili a quella della loro Madre.
Spirito contemplativo
Il nostro programma iniziale: «contemplative eperché tali apostole» è stato confermato dalloSpirito santo che spira in queste due inseparabilidirezioni da tutti i testi conciliari.
Le divergenze dei teologi pre-conciliari circala contemplazione e l’azione sono superate. Nonci può essere contemplazione senza sbocco apo-stolico, né attività apostolica senza spirito con-templativo.
La vita religiosa, possibile solo in forza di uncarisma di fortezza, è essenzialmente contemplativae apostolica, perché i doni dello Spirito santo opera-no come il loro Donatore che è l’Amore; s e m p e rq u a e t u s, sempre estatico e semper agens, sempree ff u s i v o .
Il Concilio presenta la Chiesa fervida nell’azionee dedita alla contemplazione, non viceversa come cisaremmo aspettati. Perché il fiume appare primadella sorgente; e dello Spirito santo stesso, A n i m a
134

del Verbo di Dio che è la vita degli uomini (Gv 1,4). «Se tacesse il tumulto della nostra carne, taces-
sero i fantasmi della terra, se tacessero anche icieli e anche l’anima tacesse e trapassasse se stes-sa, non fermando su di sé il pensiero, se tacesseroi sogni e le rivelazioni immaginarie e ogni parolae ogni segno e quest’unica Parola rapisse e assor-bisse e riponesse chi l’ascolta nell’intimità dellagioia e la vita continuasse così, non sarebbe que-sta la beatitudine?» (S. Agostino, Confessioni).
Le Figlie della Chiesa dovrebbero imporsiliberamente questa ascesi dura e dolce del silenziocome nei primi anni, quando il «silenzio d’amore»era la nostra unica regola suggellata dall’eroismodelle nostre Serve di Dio.
Per preparare e prolungare la Liturgia noi dedi-chiamo due ore all’orazione.
Le «due ore» nella stesura delle Costituzionisono «due tempi di un’ora» e, oggi, col Capitolospeciale «due tempi prolungati di orazione».
Si è badato a non fissare cronologicamente talitempi, ma ad esprimere il desiderio che, per resta-re nel nostro spirito, le Figlie della Chiesa devonoprolungarli spontaneamente il più possibile, ancheoltre un’ora, quando il dovere, o la carità, lo con-sentano.
Grazie a Dio, le nostre impegnative A d o r a z i o n ipubbliche ce lo impongono e il buon popolo conti-
137
contemplazione della Chiesa.Lo Spirito santo invita tutti i suoi figli alla con-
templazione, a gustare e vedere quanto è soave ilSignore! (Ps 34,9).
Noi, per la grazia battesimale, potenziatadall’Eucaristia, e per la Professione religiosa, possia-mo e dobbiamo essere contemplative nella fede.
Ma la Liturgia, come ha bisogno di ampi cena-coli per svolgersi esteriormente, ha bisogno di unclima contemplativo per sprigionare tutte le suepossibilità sacramentali.
La contemplazione è possibile anche fra leoccupazioni, preoccupazioni e relazioni assorben-ti, se il clima contemplativo, fatto di silenzio, diascolto e di colloquio con Dio, è conservato erispettato.
Il silenzio dispone all’ascolto del Verbo eall’incontro con l’amore.
È questa la sua motivazione più profonda e lalogica della nostra prima formulazione per segna-larlo e distinguerlo: «silenzio d’amore».
Non è il silenzio inerte dell’apatia e suppone ilsilenzio evangelico che esclude ogni parola oziosa einclude tutte le parole fraterne.
È il silenzio contemplativo che attua la propor-zione evangelica tra la vita privata e pubblica delSignore anche fra il turbine delle vicende umane,perché nulla può turbare la sua segreta ricerca di Dio,
136

misericordia l’acqua zampillante che sale allavita eterna (Gv 4, 14) e attendiamo pazientemen-te che Egli ce ne apra in cuore la fonte.
Perché anche lo Spirito viene in soccorso allanostra debolezza, non sapendo noi né che cosa siha da chiedere, né come convenga chiedere; malo Spirito in persona intercede per noi con gemitiinesprimibili e colui che scruta i cuori sa quale èil desiderio dello Spirito, sa che Egli intercede afavore dei santi secondo gli intendimenti di Dio(Rm 8,26).
Quando poi ci sentiamo anche una «terrasenz’aria» invochiamo «l’aria benedetta in cui c’èsempre il Signore» (Respiriamo Maria, pag 21) etrascorriamo il nostro tempo di oranti ai suoi piedi.
Indubbiamente, perché è Madre nostra, Ellaprega sempre per noi, che centocinquanta volte algiorno la imploriamo con la spesso disattenta, masempre affettuosa supplica: «Santa Maria, Madredi Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’oradella nostra morte».
Nella lezione spirituale ascoltiamo il Signoreche ci parla con la sua rivelazione e, ricordandoche l’ascolto etimologicamente include l’udire el’obbedire, ci facciamo guidare dai dottori dellaChiesa e illuminare, nelle vie dell’orazione, daisuoi dottori mistici, particolarmente da SanGiovanni della Croce che ha tratto la sua dottrina
139
nua a distinguerci come «le suore che pregano».Le prime Figlie della Chiesa hanno difeso
coraggiosamente davanti alla stessa A u t o r i t àecclesiastica le loro «due ore di orazione» conl’intima compiacenza del Cardinale Piazza carme-litano, nostro primo consigliere e protettore.
Le consideravano una garanzia della lorofedeltà al Signore e una testimonianza della suapreferenza esemplare per la vita nascosta e con-templativa.
Sarebbe leggerezza ridurle senza giusti motivi;si negherebbe l’esemplarità a un aspetto della vitadi Gesù che è divinamente esemplare in tutte lesue anche minime linee, come in tutte le sue divi-ne parole.
Modello della nostra orazione privata e suasostanza è la Liturgia. Dalla Liturgia prendiamo itesti, alla Liturgia conformiamo i pensieri, i senti-menti, le espressioni.
Con Gesù e la Chiesa adoriamo il Padre, lo rin-graziamo per le sue effusioni universali d’amore edi vita, ripariamo le nostre colpe e le colpe deinostri fratelli, imploriamo grazie pasquali di risur-rezione per noi e per tutti. Non ci leghiamo a nes-sun metodo o schema, ma partendo dall’umileadorazione e dal riconoscimento della nostramiseria, sentendoci una terra senz’acqua (Ps 62,2)davanti a Dio, speriamo di ottenere dalla sua
138

Chiesa che ha sempre venerato le Divine Scritturecome ha fatto per il Corpo del Signore;
con l’insegnamento religioso anche nelle scuolestatali, l’assistenza religiosa nel mondo del lavoro,l’inserimento nei movimenti liturgici, mariani,pastorali, vocazionali, ecumenici, missionari, ecc;
con la diffusione della Dottrina della Chiesa,particolarmente del Romano Pontefice e col «farconoscere e amare sempre più Maria e la Chiesa»come ci hanno raccomandato esplicitamente ilVicario di Cristo e come vogliono le nostreCostituzioni, che intendiamo di osservare con lafaticosa e onerosa pubblicazione delle nostreRiviste «Ecclesia Mater» e «Mater Ecclesiae».
Questo articolo conclusivo delle nostreCostituzioni ci impegna di più oggi, dopo la pro-clamazione della maternità ecclesiale di Maria.
La Chiesa ha raggiunto in Maria la sua perfe-zione (LG 65); Maria è il modello della sua vitacontemplativa e apostolica: il nostro modello.
Come non possiamo andare al Padre se non perGesù e non possiamo andare a Gesù se il Padrenon ci attira (Gv 6,65), così non possiamo andarea Maria, e tanto meno condurre a lei i nostri fra-telli, se lo Spirito di Gesù e del Padre non ci attrae,o non ci sospinge.
Supplichiamolo di spirare in noi, perché Mariasia conosciuta, amata e lodata anche per mezzo
141
dai testi più intimi della Scrittura e stimola l’ani-ma a tradurli in vita con l’accettazione dellavolontà del Signore e la conformità alla Vittimaperenne dell’altare per la salvezza del mondo.
Spirito apostolico
L’umile collaborazione alla pastorale dellaChiesa e l’animazione delle collaboratrici secola-ri è l’unica opera esterna in cui abbiamo esercita-to la nostra funzione profetica fin dagli inizi.«L’aiuto ai parroci» è lo specifico apostolato percui siamo state approvate.
Però noi vogliamo, come la nostra Madre, chel’azione sia ordinata e subordinata alla contempla-zione (SC 2) e per questo, affermato il primatoapostolico del dono intimo di sé, che costituisceda sempre nella Chiesa la santità e che s’effondeintorno come il profumo dei frutti dello Spirito,collaboriamo:
con la partecipazione pubblica alla liturgia el’animazione liturgica;
con l’Adorazione pubblica del SantissimoSacramento che alimenta egregiamente il cultodovuto al Padre in spirito e verità (Gv 4,24) e conl’animazione eucaristica;
col culto della Parola di Dio, a imitazione della
140

se dalla nostra prassi, salvo eccezioni impostedalla «necessità della carità»
Vigilanza da parte delle collaboratrici e delleresponsabili, perché il più esteriore non prevalgasul più interiore, illimitato come la carità, chevuole solo ciò che Dio vuole.
I Vescovi dall’alto - Episcopi- e i Superiori colloro carisma coglieranno a volo la volontà di Dionel Magistero supremo dello Spirito santo e cer-cheranno con noi come compierla.
Obbedendo, non potremo fare di più.
Dobbiamo aprirci meglioEvitare anzitutto le improvvisazioni, che non
vuol dire mortificare le ispirazioni, le iniziative,l’originalità, la creatività.
Vuol dire solo organizzare forze e risorse per laChiesa, compenetrarle del suo Spirito, orientarleverso la sua pastorale, sacrificarle, se occorra, per-ché la sua pastorale si affermi e cresca.
Guardare indietro al passato per cogliere nellesue grandiose realizzazioni apostoliche, special-mente attraverso la storia e l’agiografia, le mozio-ni sempre attuali e sempre attuabili dello Spiritosanto che è il divino Animatore della Chiesa, dellasua unità e del suo pluralismo, per non scostarcimai dalla sua pastorale ecclesiale nelle nostreumili realizzazioni.
143
nostro come Madre di tutti, che ha sofferto indi-stintamente per tutti e vuole tutti salvi.
Queste sono le nostre forme di collaborazionealla pastorale locale: parrocchiale, interparroc-chiale, diocesana e universale, esclusivamentespirituali, e dell’Apostolato diretto, che una fede-razione dell’Unione Superiore maggiori promuo-ve in Italia.
Per il prodigioso impulso del recente Conciliopastorale, oggi tutte le Congregazioni si aprono aquesta nostra specifica missione; noi dobbiamosolo aprirci di più e meglio, con più slancio e conpiù preparazione.
Dobbiamo aprirci di piùOgni casa dovrà essere una casa della parroc-
chia, come un prolungamento degli ambienti par-rocchiali, sempre disponibile.
Disponibilità massima anche nella partecipa-zione alla pastorale particolarmente parrocchialeprevista dal piano pastorale e preventivamenteaccordata con gli Ordinari e i Parroci.
Ricorso nei casi dubbi all’Autorità religiosasuperiore e larghezza negli adattamenti tempora-nei, specialmente nelle case straniere, purché nonsi alteri lo spirito della Congregazione con richie-ste sproporzionate alle nostre possibilità ed esclu-
142

v i t a? (Mt 16,26) e ripete a chi ha orecchi da inten-dere: Se vuoi essere perfetto, va’, vendi ciò che haie dallo ai poveri, poi vieni e seguimi! (Mt 19,2 1).
Ciò suppone sguardi che penetrino tutte le cose(1 Cor 2,10) con lo Spirito di Dio e impone unaformazione antropologica e sociologica che tendaalla contemplazione.
Dobbiamo aprirci con più slancio.Lo slancio esprime il fervore della carità che
ha raggiunto la pienezza della contemplazione.Può esprimere anche la pienezza della vita ed è
sempre provvidenziale, ma per l’apostolato nonbasta: è inadeguato.
Olga ci ha fatto vedere che slancio occorre pertoccare i cuori! Nessun piano pastorale ai suoitempi e quale apostolato!
Il fervore la slanciava in tutte le direzioni: coibambini in parrocchia, con le studenti in casa, conle bagnanti alla spiaggia, coi malati all’ospedale,coi vecchietti abbandonati nel tuguri... non la fer-mava nessuno, nemmeno io che restavo presa dalsuo fuoco.
La fermò la meningite, ma lo slancio del suo Sìal Padre, al Figlio, allo Spirito santo, si prolungòfino all’orlo dell’incoscienza.
Gli attuali piani pastorali potranno apparente-mente frenare i nostri slanci apostolici, ma ordi-
145
Guardare al p re s e n t e, ai segni del nostro tempo.La secolarizzazione che struttura la società
moderna e compenetra, con processo sempre piùaccelerato, innumerevoli organismi, associazioni,gruppi, pur non essendo una ideologia, né assu-mendo atteggiamenti negativi di fronte alla fede,alla religione, alla Chiesa, preclude l’influenzapastorale alla maggior parte della società e spe-cialmente alla gioventù.
Che ci suggerisce questo segno dei tempi?Di tenere aperta, come ci suggeriva vent’anni fa
il «nostro Cardinale», la porta delle Costituzioniall’art. 317 che prevedeva il nostro inserimento nelmondo del lavoro, della scuola statale, dei condo-mini e la nostra penetrazione, partendo dalleAdorazioni pubbliche, in tutti gli ambienti, associa-zioni, gruppi per animare all’unione col proprioParroco, col proprio Vescovo, col Papa, che è ilnostro specifico programma.
Guardare al f u t u ro. Lo slancio pastoraleimpresso dal Concilio presuppone l’avvio da unlivello che non ammette affermazioni e concor-renze umane e non permette negligenze.
La Chiesa è comunione di tutto l’amore di Dioa tutto il mondo (W. Balthasar). La pastorale dellaChiesa propone al mondo l’interrogativo fonda-mentale del Vangelo: Che gioverebbe all’uomog u a d a g n a re il mondo intero se poi perde la sua
144

semper agens nel suo cosmo.Tale preparazione esige una metodologia che oggi
le Chiese locali portano a conoscenza di tutti con laloro stampa e coi loro seminari, corsi, conferenze.
È preciso nostro dovere approfittare largamen-te di queste possibilità di preparazione adeguata aibisogni particolari di ogni Chiesa.
È pure nostro dovere tenerci aggiornate con l’usodel mezzo di comunicazione sociale più adatto pernoi consacrate, con l’abbonamento ai periodici dellereligiose consigliati dai Vescovi e dalla UnioneSuperiore Maggiori e con l’attenzione vigile agliorientamenti pastorali del Romano Pontefice.
Tutto ciò senza sottovalutare il nostro metodoiniziale che si esprimeva col «dialogo» oggi sug-gerito a tutti dal Concilio.
Si dialogava coi «Gesù» che entravano unodopo l’altro a mezzodì nelle nostre casette diSanto Stefano e San Maurizio, per la minestra, esorridevano alla sorella che alla fine improvvisa-va immancabilmente una lezioncina evangelica.
Nelle case, il dialogo prendeva toni diversi conle mamme, con le nonne, coi piccoli; nei mercatiapriva speranze di benedizioni celesti, mentre lenostre borse si riempivano di frutta e di verdura;negli uffici non veniva mai provocato e si espri-meva più col sorriso che con la parola; in treno si
147
nandoli e coordinandoli li purificheranno dall’e-goismo personale e comunitario.
Dio purifica anche così e stronca pure ognislancio se vuole una purificazione maggiorecome ha fatto con Olga, perché spoglia di spiritoproprio e piena di Spirito santo operasse mirabil-mente nella Chiesa (LG 44).
Dobbiamo aprirci con più formazione.Il nostro impegno apostolico è stato assunto da
tutte nel Battesimo, sottoposto alla Chiesa per l’ur-genza della nostra vocazione e assegnato a noi espli-citamente da Pio XII quando gli chiedemmo di con-cretarlo con la preghiera e la penitenza in clausura.
La necessità di una programmazione non fusentita da nessuna di noi agli inizi «in cui c’è sem-pre più Spirito santo»; il fervore suppliva a tutto.
Oggi sarebbe temerario contare solo sul fervo-re e s’impone, per l’imperativo religioso socialeda tutti avvertito, una preparazione che parta dachiari principi teologici, si aggiorni con la cultura,si arricchisca nelle esperienze liturgiche, si quali-fichi con l’approfondimento dei consigli evange-lici, si specializzi nella collaborazione alla pasto-rale e nell’animazione, si perfezioni sempre piùcon l’imitazione della Chiesa sempre attiva e sem-pre contemplativa, di Gesù sempre in comunionecol Padre e coi fratelli, di Dio semper quaetus,
146

Perché questo sia veramente benefico bisognarispettare alcune condizioni. Si deve anzituttoverificare se il lavoro assunto è conforme allavocazione dell’Istituto. Conviene anche definirecon chiarezza i due ambiti. Bisogna soprattuttosaper passare dall’attività esterna alle esigenzedella vita comune, preoccupandosi di garantiretutta la loro efficacia agli elementi della vita pro-priamente religiosa» (ET 26).
Che faremo oggi e in seguito?Obbediremo ai nostri Vescovi in comunione
col Papa; obbediremo nelle Chiese locali, con unocchio sempre aperto alle segnalazioni dellaChiesa universale.
Non ci rifiuteremo a nessuna esperienza, a nes-sun rischio per collaborare alla pastorale sempredinamica dei nostri Vescovi, ma se l’accordo conRoma sarà perfetto.
Il Capitolo dovrà affrontare questo difficileproblema in tutte le sue dimensioni e studiare,proporre, precisare i modi di risolverlo.
Forse non basterà tenere aperta la porta delleCostituzioni come consigliava il «nostroCardinale» e nemmeno la porta della disponibilitàmassima ai voleri della Chiesa Madre nostra. Saràforse necessario distinguerci, restando unite nel-l’apostolato di fondo, per aprire a tutti la via che
149
faceva qualche volta polemico, ma sempre domi-nato dal desiderio intenso di salvare le anime e diportare tutti a Gesù.
Il Popolo di Dio ci era vicino come alla Messa.La pastorale dell’amore non può mai venir
meno: oggi la continuiamo anche con la corri-spondenza, perché Olga e Maddalena ce ne dannola possibilità.
La preparazione potrà esigere impensate aper-ture domani.
Attualmente la più «rischiosa» come afferma ilSanto Padre è l’equipe che era anche un nostrosogno.
A Padre Lombardi suggerivamo appunto di ten-tarla col suo prodigioso ascendente e sacrificammola nostra Vilma; ma poi la Chiesa non approvò l’e-sperienza. Un tentativo si fece con la Federazione«Apostolato diretto» che non ebbe seguito.
Vorremmo ritentarla al «Paesetto dellaMadonna» nel campo della carità ma gli ostacolisi moltiplicano.
Alcune sorelle che furono coinvolte in movimen-ti locali simili, anche autorizzati, si disorientarono.
L’Evangelica testificatio ha ora precisato laforma sicura della collaborazione alla pastorale inequipe:
«Alcuni sono portati a lavorare in gruppi dilavoro, aventi un proprio regime...
148

comunitarie e il silenzio nelle case.Saranno formate all’attività apostolica dal-
l’immediatezza dei loro rapporti ecclesiali esociali, dalla loro iniziale collaborazione allapastorale e dalla penetrazione nelle famiglie cheschiuderanno orizzonti sempre nuovi alla loroazione apostolica e la impegneranno sempre piùcoscientemente nel Mistero della salvezza.
Qui s’inserirà la Dottrina sociale della Chiesaper chiarire, completare, approfondire e organiz-zare ciò che avranno appreso dalla vita.
Una formazione specifica qualificata non potràessere data a tutte, ma sarà riservata alle sorelleche avranno la capacità di riceverla e tradurla inanimazione dottrinale, o biblica, o liturgica, omissionaria, ecumenica, vocazionale, ecc. secon-do i bisogni e le richieste delle Chiese locali e lepossibilità e disponibilità della Congregazione.
La formazione alle attività caritative e socialisarà per tutte a livello comune.
Per le sorelle prevedibilmente inclinate ad essesarà completata da scuole e corsi esterni purchénon si alteri il nostro stile di vita e la proporzioneevangelica che lo caratterizza (su ciò dovrà pro-nunciarsi chiaramente il Capitolo).
Il nostro stile di vita sarà assicurato se nonmancherà mai la presenza della Mamma, la piùnecessaria perché la famiglia non si disgreghi.
151
conduce al cielo e la P o rta del Cielo (L i t .Lauretane).
Formazione specifica
La nostra formazione specifica, cioè la formafondamentale di vita che ci distingue dalle altre,sarà gradualmente teorica, pratica e animata dallospirito di famiglia, come la formazione che si diceappunto familiare.
Le Figlie della Chiesa impareranno a vivere lavita contemplativa e attiva della Chiesa vivendonella Chiesa (SC 2).
La Chiesa prega ed esse impareranno a pregare.Saranno aiutate a fare orazione dalle opere dei gran-di maestri dell’orazione e dall’esempio dei Santi.
Dovranno giungere a non separare la Liturgiadall’orazione che ne è la preparazione e il prolun-gamento nella vita.
Le Figlie della Chiesa si eserciteranno e abi-tueranno a leggere, riflettere, ascoltare e meditarela Parola di Dio; ad accoglierla in silenzio, a con-servarla nel cuore come Maria e, come lei, a loda-re Dio con la Parola di Dio.
L’indice certo di tale progresso sarà il timbrosempre più devoto delle preghiere personali e
150

Partecipazione piena
Per questo la Chiesa ha centrato in lei il dise-gno del Padre (cf LG 64) che i Misteri del Rosariodispiegano, e ci fa ripetere come i bambini il salu-to angelico che ne è il sottofondo.
Noi formiamo alla contemplazione e all’azionecol Rosario al braccio e nel cuore e ci aiuteremocon tutto ciò che potrà aiutarci a farlo conoscere,amare, gustare: cicli, sacre rappresentazioni, cele-brazioni, forme nuove; promuoveremo soprattuttola sua diffusione e il suo amore.
152

SPIRITO
La partecipazione piena al Mistero di Cristo edella Chiesa, pienezza di Lui, è la partecipazionemistica:
– la conoscenza che Gesù chiede ininterrotta-mente al Padre per i suoi eletti e per coloro che perla loro parola credono in Lui, affinché l’Amorecol quale il Padre lo ha amato sia in essi e Lui inloro; la conoscenza superiore a ogni intendimen-to che San Paolo ha implorato piegando le ginoc-chia davanti al Padre, da cui ogni famiglia prendenome, affinché tutti siano ripieni, in tutta pienez-za, di Dio;
– l’esperienza che San Giovanni dopo avervisto, udito, toccato il Verbo della vita augura atutti: la comunione, cioè, fra noi e con chi ci guidae la comunione col Padre e col Figlio suo GesùCristo perché la nostra gioia, frutto dello Spirito,sia piena.
Questa pienezza di grazia è un dono delloSpirito santo, ordinariamente preceduto e accom-pagnato da profonde purificazioni; una partecipa-zione sperimentale della morte e della risurrezio-ne del Signore per l’universale salvezza.
155

RIFLESSIONI
Lo spirito nostro nella Chiesa
Lo spirito nostro, il cosiddetto «carisma dellafondazione», l’impulso spontaneo che agli inizi ciha fatto affrontare derisioni, opposizioni, diffi-coltà di ogni genere in clima di guerra e di lottecivili, è evidente nelle brevi biografie delle nostreServe di Dio, particolarmente di Olga.
Quando il Cardinale Piazza, nostro primoappoggio, all’indomani della morte di Olga, a cin-que anni dalla fondazione, mi ordinò di scrivereper noi alcuni cenni della sua vita consacrata, ioscrissi subito senza previsioni, senza preoccupa-zioni pubblicitarie, senza ricerche di documenti edi testimonianze, con tutta sincerità e obiettivitàciò che mi dettava il cuore, né sentii mai il biso-gno, nelle ripetute ristampe, di ritocchi, revisioni,ampliamenti.
Dalle prime pagine appare che sentendomiindicibilmente spinta a impedire la dannazioneeterna delle anime, pregavo, soffrivo e sospiravoun gruppo di figliuole che mi aiutassero a pregaree soffrire per esse. È l’iniziale espressione delnostro spirito che le prime Figlie della Chiesahanno compreso, condiviso e tradotto nel pro-
157
ESPRESSIONI
Le Figlie della Chiesa per partecipare da figlieal Mistero della salvezza, invocano umilmente loSpirito di Pietà che le ha unite come piccola fami-glia nella grande Famiglia di Dio.
Lo Spirito di Pietà farà loro gustare e vederecome è soave il Mistero della Famiglia di Dio cheè la Chiesa e le solleciterà a comporre e ricompor-re nella loro famiglia religiosa la sua esemplareunità, perché il mondo creda in Gesù e nella suamissione salvifica.
La loro pietà comunitaria si esprime preferibil-mente verso il Cuore della Vittima gloriosa chetrae tutti a sé, verso la Madre e Regina dellaChiesa, centro materno dell’unità e verso SanGiuseppe, che la Chiesa pellegrinante implora peressere congiunta a Cristo.
Onorano fra i Santi, particolarmente i SantiApostoli e con culto speciale San Pietro su cuiGesù edificò la sua Chiesa e San Giovanni e SanPaolo che ne illustrarono il Mistero.
Loro modello è Santa Teresa del BambinoGesù che per partecipare pienamente al Misterodella salvezza, nel cuore della sua Madre laChiesa volle essere l’Amore.
156

fratelli il nostro fine immediato. La comunionenostra il mezzo per raggiungerli insieme.
Il nostro spirito oggi è quello di ieri; quellodella Chiesa che è comunione sacramentale, fra-terna e organica, salvifica, apostolica, pasquale,mistica... come l’ha implorata Gesù e per questo èsacramento dell’universale salvezza a gloria delPadre.
È comunione sacramentale
Io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato,affinché essi siano una sola cosa come noi siamouno... io in loro e tu in me... e ho fatto loro cono -scere il tuo nome e lo farò conoscere, affinchél’Amore, col quale mi hai amato sia in essi e io inloro (Gv 17).
È comunione gratuita col Padre, col Figlio, con loSpirito santo; la Liturgia lo proclama riconoscente:
Padre santo, per il Sangue del tuo Figlio e lapotenza dello Spirito santo tu hai ricostituito l’u -nità della famiglia umana disgregata dal peccato,affinché il tuo popolo, radunato nel vincolo dia m o re della Trinità, formasse la tua ChiesaCorpo di Cristo e tempio vivo dello Spirito(Prefazio VIII domenica per annum).
Le Tre Persone presenti in noi operano sacra-mentalmente, con la loro unità, la nostra; con la
159
gramma «patire e morire per la Chiesa e per ilmondo».
Lo scolorì «il nostro Cardinale» che nella ste-sura delle Costituzioni ci suggerì di sostituirlo conquesta amplificazione: «Loro programma è cono-scere e amare la Chiesa, lavorare e soffrire per ilsuo trionfo» cui mi affrettai di aggiungere: a imi -tazione di Gesù, che amò la Chiesa e per essasacrificò se stesso (Ef 5,25) perché la dimensionedel patire riassume almeno le altre tre che erano,anche nel precedente programma, gli implicitipresupposti.
Le Costituzioni precisarono invece che la nostraCongregazione trasse ispirazione dalla Preghierache Gesù rivolse al Padre per l’unità della Chiesa,a ffinché il mondo credesse in Lui e nella sua mis-sione salvifica a gloria del Padre stesso.
Sgorga dalla preghiera di Gesù
Questo contenuto evangelico del nostro spiritoci confermò nella sicurezza che il nostro patireavrebbe dovuto consistere soprattutto nello sforzoquotidiano per comporre, ricomporre, perfeziona-re la comunione nostra e con tutti ed essere cosìChiesa, sacramento dell’universale salvezza agloria del Padre (LG 48). La gloria del Padre èdunque il nostro fine supremo. La salvezza dei
158

gia divina in tutte le dimensioni e impegna allacarità «paziente, benigna, che non porta invidia,non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, che nullafa di sconveniente, non cerca il suo interesse, nonsi irrita, non serba rancore per il male, non godedell’ingiustizia, ma si rallegra del trionfo dellaverità; tollera tutto, crede tutto, spera tutto, tuttosopporta, non viene mai meno» (1Cor 13,4).
La comunione coi fratelli comporta «che ciamiamo a vicenda d’amore fraterno, che ritenia -mo gli altri più degni di onore, che siamo ferven -ti di spirito, che ci rallegriamo con chi è nellagioia e piangiamo con chi è nel pianto, che abbia -mo vicendevolmente sentimenti concordi... che, seè possibile, per quanto dipende da noi, viviamo inpace con tutti gli uomini» (Rom 12, 10 ss).
La comunione fraterna vuole che non abbia -mo, verso alcuno debiti di sorta, eccetto quellodello scambievole amore (Rom 13,8) che ci man -teniamo tutti d’accordo, alimentando lo stessoamore, unanimi, concordi nel sentire (Fil 2,2), chesempre perseguiamo l’amore tra noi e verso tutti(Tes 3,12), che ci rivestiamo di tenera compassio -ne, di bontà, di umiltà, di mitezza, di pazienza,sopportandoci reciprocamente e perdonandoci sequalcuno ha motivo di rimprovero verso un altro,come il Signore ha perdonato a noi (Col 3,12-13).
La comunione fraterna tende all’unità dello
161
loro distinzione, la nostra pacifica convivenzanella diversità dei doni e delle funzioni.
La comunione sacramentale raggiunge la suapienezza nell’Eucaristia, che la potenzia colCorpo e col Sangue di Cristo, e la sua perfezionesuprema in cielo, nella Comunione dei Santi.
È comunione fraterna e organica
che si modella nel Mistero Trinitario per trasfor-mare la famiglia umana, una e complessa, in fami-glia di Dio.
Anche per questa sua struttura esistenziale, ècomunione fraterna e gerarchica, comunione difratelli fra loro e con chi fa le veci di Dio.
Gesù l’ha implorata con queste due dimensioni:Padre santo, conservali nel tuo nome... affin -
ché siano una sola cosa con noi (Gv 17,11).Padre, io prego per essi e non per essi soltan -
to, ma anche per quelli che per mezzo della loroparola crederanno in me, affinché tutti siano unasola cosa (Gv 17, 20-21).
Vincolo della comunione fraterna è la carità,che è dono di Dio: Per quanto riguarda la caritàfraterna non avete bisogno che ve ne scriva, per -ché avete imparato da Dio stesso ad amarvi gliuni gli altri (1Tess 4,9).
La comunione coi fratelli attua questa pedago-
160

causa di salvezza (Eb 5,8-9).Oggi la comunione gerarchica è contestata,
perché è indebolita la fede nella spiritualità dellaChiesa istituzionale e Paolo VI ha sull’argomentoquesta pagina illuminatrice:
« Voi conoscete quali sono i requisiti, anzi i fatto-ri di questa superlativa espressione dell’umanità: lafede, lo spirito, la gerarchia. È la Chiesa, la nostraChiesa. La quale, se è comunione, che cosa compor-ta? Cioè, qual è la dinamica di tale definizione?
Se la Chiesa è comunione ella comporta unabase di eguaglianza: la dignità personale, la fratel-lanza comune; comporta una progressiva solida-rietà (Gal 6,2), comporta un’obbedienza discipli-nata e una collaborazione leale, comporta unarelativa corresponsabilità nella promozione delbene comune. Ma essa non comporta una egua-glianza di funzioni; chè anzi queste sono benedistinte nella comunione ecclesiale, che è organi-ca e gerarchica, è corpo dalle diverse e ben quali-ficate responsabilità, ecc.
La conclusione è questa: dobbiamo aumentarein noi il senso comunitario e le virtù corrispon-denti, cioè dobbiamo crescere nella carità: questotermine deve acquistare senso, valore, pratica:questo è lo spirito comunitario al quale il Concilioci vuole formati e fedeli».
163
spirito nel vincolo della pace. Un corpo solo euno spirito solo, come una sola è la speranza allaquale siamo stati chiamati per la nostra vocazio -ne. Un solo Signore, una sola fede, un solo batte -simo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopratutti, opera in tutti ed è in tutti (Ef 4, 3ss).
La comunione gerarchica ci vuole figli obbe-dienti a Dio (Col 3,20) e a chi fa le veci di Dio (PC14), a chi ci guida a lui (Eb 13,17).
Obbedite alle vostre guide e siate loro sotto -messi, giacché esse vegliano per le anime vostrecome coloro che debbono renderne conto, affinchéquesto compiano con gioia e non gemendo, ché ciònon sarebbe vantaggioso per voi (Eb 13,17).
La comunione gerarchica è la forza dellacomunione fraterna; la dipendenza dal vertice chedà fermezza alla base.
Una volta purificate le vostre anime nell’obbe -dienza alla verità in vista di un fraterno amoresenza finzione, amatevi gli uni gli altri con cuorepuro, intensamente (1Pt 1,22).
L’obbedienza è l’espressione più sicura dellacarità, la garanzia della sua autenticità ma ne èpure la dimensione più ardua. Può chiedere gran-di sofferenze e provocare forti gemiti e lacrime(Eb 5,7) come a Gesù che imparò, quantunqueFiglio, per le cose patite l’obbedienza e, reso per -fetto, divenne per tutti coloro che l’obbediscono
162

fede e comunica la fede, fino alla sua pienezzanella Comunione dei Santi.
Gesù è venuto; l’avvento liturgico lo richiamae lo ripresenta annualmente, quotidianamente,ininterrottamente: Gesù e il suo «pleroma» (Ef4,1) è in continuo divenire; lo preannuncia, lomanifesta e lo anticipa «l’unità dei fratelli» (PC15) che è Lui sotto le apparenze ecclesiali, comesotto le apparenze eucaristiche.
È comunione apostolica
Io per essi prego e non chiedo che tu li tolgadal mondo, ma che li custodisca dal maligno.Come tu li hai mandati nel mondo, anch’io li homandati nel mondo (Gv 17,9).
La consacrazione religiosa, che corona la con-sacrazione battesimale per cui siamo Chiesa apo-stolica, riservandoci esclusivamente a Dio, ci alli-nea di diritto con gli Apostoli, sebbene la nostracollaborazione alla pastorale sia minima e lanostra prestazione caritativa quasi soltanto occa-sionale.
Come gli Apostoli ci siamo infatti preoccupatesubito di «far conoscere e amare la Chiesa» nelvicinato, nella parrocchia, nella chiesa locale e diavvicinare i cuori al Santo Padre con la diffusionedella sua parola.
165
È comunione salvifica
perché produce la fede che salva:Padre, siano una sola cosa in noi, così il mondo
creda che tu mi hai mandato (Gv 17,21).Siano perfetti nell’unità e il mondo riconosca
che tu mi hai mandato e li hai amati come haiamato me (Gv 17,23).
Il Concilio fa eco a queste parole: l’unità deifratelli annuncia l’avvento di Cristo (PC 15).
È la fede che salva, perché mette in comunica-zione con Dio e la fede nasce dalla predicazionee la predicazione ha luogo per mezzo della Paroladi Dio (Rm 10, 17).
La comunione fraterna è la Parola di Dio viva:non giunge per audizione ma per visione; non è ilVangelo scritto, ma il Vangelo vivente.
Per questo San Luca la indica come secondafonte della perseveranza nella fede:
E tutti perseveravano nel farsi istruire dagliApostoli, nella comunione fraterna, nell’eucari -stia e nella preghiera (At 2,42).
La preghiera è salvifica, perché è fede.L’Eucaristia è lo stesso Mistero della salvezza,
perché è l’inesauribile mistero della fede.La comunione ecclesiale per la presenza di
Gesù che ha promesso di essere in mezzo a quelliche si riuniscono nel suo nome, è comunione di
164

re a un sessennio l’adesione dell’Istituto.Bisognerà che dalla nostra comunione aposto-
lica emerga frequente e concorde il desiderio dicollaborare da figlie, con l’attività, alle loro ini-ziative pastorali spirituali, e con la preghiera, atutte le altre, in modo vivo e sentito.
I nostri Vescovi devono sentirci figlie e il SantoPadre più di tutti, come quando, nate da poco nellaChiesa, con l’audacia dei piccoli, si chiedeva alPapa perfino la direzione spirituale. Ciò ora sareb-be impossibile, ma è sempre possibile la disponi-bilità interiore a perfezionare in tutte le suedimensioni la nostra comunione apostolica.
Se tutti siamo Chiesa e quindi sacramento del-l’universale salvezza, il Vicario di Cristo e iSuccessori degli Apostoli lo sono più di tutti per ilSacramento dell’Ordine che li fa strumenti quali-ficati e insostituibili della salvezza.
Per il nostro spirito dobbiamo essere in comunio-ne apostolica con loro: isolandoci da loro e isolando-ci in comunità, indeboliremmo la forza apostolicache dovrebbe impedire la perdita delle anime.
È comunione pasquale
Consacrali nella verità, la tua parola è verità...Per essi io consacro me stesso, affinché anch’essisia consacrati in verità (Gv 17,17.19).
167
La Chiesa guardò alle opere e ci approvò per leopere che ritenne direttamente apostoliche, ma ilnostro carisma di comunione apostolica per la sal-vezza dei fratelli a gloria del Padre non fu puntualiz-zato con sufficiente evidenza dalle Costituzioni chesi limitavano a sottolineare la nostra devozione pergli Apostoli, in particolare per San Pietro e per SanPaolo e San Giovanni che illustrarono il Misterodella Chiesa, e a raccomandarci il loro culto.
Il nostro spirito sarebbe stato anzi soffocato daprogrammazioni, se non estranee, indubbiamentemeno apostoliche, se il Concilio non avesserimesso in primo piano, dopo il ritorno al Vangelo,il ritorno al carisma proprio degli Istituti.
Il nostro spirito esige che al culto degliApostoli aggiungiamo una concreta professione difiliale dipendenza dal Vicario di Gesù e dai suc-cessori degli Apostoli uniti con lui, e la nostradisponibilità piena ai loro orientamenti.
Dal Vicario di Gesù dipendiamo vi voti ma nonsarebbe una Figlia della Chiesa quella che avessebisogno di ricorrere alla forza del voto per condi-videre il pensiero di Colui che ha il carisma ordi-nario del governo di tutta la Chiesa in gradosuperlativo e unico.
Riguardo ai Vescovi, l’attenzione che i Capitolidevono prestare alle loro richieste, secondo leCostituzioni, è insufficiente, perché può rimanda-
166

E Maddalena, con gli occhi carichi di giocon-dità, mi chiedeva di morire per l’unità dei fratelli.
È la nostra missione.Gesù ci ha volute nella Chiesa, fondata sugli
Apostoli e Madre di Santi, perché fra i solenniOrdini, le benefiche Congregazioni e gli apostoli-ci Istituti secolari, ci fosse anche un gruppetto dicuori disposti ad accettare il patire come un donoper la salvezza dei fratelli.
Ma la nostra comunione non sarebbe pienamentepasquale se il patire e il morire non producessero lagioia immediata che Gesù chiede al Padre: P a d re . . .dico queste cose affinché essi abbiano in se stessi lamia gioia nella sua pienezza (Gv 17, 3); cheGiovanni promette e si ripromette con sicurezza:Queste cose scriviamo, affinché la nostra gioia siac o m p l e t a; che la Liturgia implora e spera con la stes-sa immediatezza: O Dio... concedi alla tua Chiesadi essere associata con Maria alla passione diCristo, per part e c i p a re alla vita del Signore risort o(Messa dell’Addolorata).
O Salvatore nostro, che avesti la Madre tua aipiedi della croce, concedici per sua intercessionedi godere della partecipazione alla sua passione(Uff. della Madonna).
Per questo il centro della nostra pietà è il Misterodella Vittima gloriosa che apre a tutti il Cuore, «fontedi vita e di ogni consolazione» (Litanie del S. Cuore) .
169
La consacrazione è un «votarsi al sacrificio»(PC 14) e la consacrazione battesimale, che ci fapartecipare sacramentalmente alla Passione diGesù, ci impegna tutti alla sua conseguente parte-cipazione esistenziale.
Tutti siamo «votati al sacrificio» (PC 14).Compiere ciò che manca alla Passione di Gesù
per il Corpo di lui che è la Chiesa (Col 1,24) èdovere di tutti.
La Liturgia lo estende a tutti.O Signore, fa’ che ci rendiamo, come Maria,
disponibili al mistero della nostra redenzione (CfComune Messa della Madonna).
Concedi a noi di partecipare con fede alla pas -sione gloriosa dei tuo Figlio che ora celebriamonel mistero (Orazione sulle Offerte, dom. XXXIIper annum).
O Signore, fa’ che completiamo in noi per lasanta Chiesa ciò che manca alla passione diCristo, che vive e regna nei secoli ( M e s s adell’Addolorata).
La consacrazione religiosa intensifica il dove-re battesimale di tale partecipazione e la nostravocazione particolare lo assume come suo doverespecifico per la salvezza universale.
Non sai che la nostra vocazione è il patire?diceva Olga a una sorella restia a comprendere laforza salvifica della sofferenza.
168

Stella del mattino» (2Pt 1,19) e «nella sua lucesplenda anche per esse la luce» (Mt 6,34).
È un punto d’arrivo che ha però un punto dipartenza: l’iniziazione a camminare in questadirezione, l’accettazione dell’affanno che basta aogni giorno, l’esercizio paziente della carità e del-l’obbedienza che assicurano la comunione frater-na; attuazione dei nostri propositi annuali:
«patire per unire»«servire per unire»«morire per unire».Concordemente, nell’ultimo corso di Esercizi
(1972), abbiamo aggiunto:«gioire per unire».Sarebbe il proposito più espressivo e compren-
sivo del nostro spirito, perché la gioia è un Fruttodello Spirito santo che matura nel travaglio dellacontemplazione e allieta i fratelli sottraendoli alleseduzioni del male e traendoli verso i beni eterni.
Spirito di famiglia
La nostra comunione ecclesiale è di fattocomunione familiare per lo spirito di famiglia chela distingue, e «lo spirito di famiglia proprio deifigli di Dio» (GS 92) ci mostra davvero al mondo«come una famiglia riunita nel suo nome» (PC
171
È comunione mistica
Gesù la vuole per noi: Padre … io voglio che l’Amore col quale mi
hai amato sia in essi (Gv 17,26).E San Paolo la chiede come Gesù al Padre:Per questo io piego le ginocchia al Padre, dal
quale prende nome ogni paternità in cielo e in terr a ,affinché conceda a voi, secondo la sua ricchezzagloriosa, di venire potentemente cor roborati dalloSpirito di lui per lo sviluppo dell’uomo interiore, eCristo abiti per la fede nei vostri cuori; siate benradicati e fondati nella carità, affinché diveniatecapaci, assieme a tutti i santi, di compre n d e re qualesia la larghezza e la lunghezza e la profondità e dic o n o s c e re anche la carità di Cristo, che sorpassaogni conoscenza, onde siate riempiti in tutta pienez -za di Dio (Ef 3,14-19).
A questa contemplazione, che ci ha sostenutenei nostri faticosi inizi e a questa comunione, che èstata sempre il più intenso dei nostri desideri, nonsi arriva quaggiù senza la mortificazione dello spi-rito e la partecipazione nella propria carne alla pas-sione di Cristo. Ma le Figlie della Chiesa la spera-no in terra o in cielo e nel buio delle loro «notti» o«gallerie», guidate e consolate dalla Scrittura,come da lampada accesa in luogo oscuro, attendo-no pazientemente che spunti nei loro cuori «la
170

fra loro solo segni di pace» (Liturgia della Messa)e imitando l’incedere tranquillo e compatto dellafamiglia ecclesiale alla mensa del Signore, che«circondano sempre come rampolli d’olivo»(Liturgia del Corpus Domini).
Non sono quindi pensabili nelle loro riunioni econsulte, come non lo sono nelle assemblee euca-ristiche, le divisioni, i giudizi maligni e le liti(dall’Ubi caritas). Conservano le strutture immu-tabili della vita comune, adattandole come laChiesa alle esigenze del loro tempo:
la preghiera comune, liturgica e privata, coimetodi delle chiese locali;
l’orario comune, in sintonia con l’orario par-rocchiale e civile;
l’abitazione comune, con le eccezioni necessarie;l’abito comune, finché la Chiesa lo riterrà
segno di consacrazione (PC 17), con la sostituzio-ne dell’abito secolare, per motivi di vita e di apo-stolato;
la lezione comune, con prudente e discretalibertà di interventi;
la revisione in comune della vita comunitariaalla luce della Parola di Dio;
la vita comune e non di comunità, per esigenzepastorali e caritative;
le relazioni sociali con espressioni, il più possibi-le, comuni e la partecipazione o il controllo di tutte.
173
15). Ciò è avvenuto spontaneamente, senza unproposito o un programma esplicito.
L’impronta familiare data dalle prime Figliedella Chiesa alla loro convivenza, si è mantenutasempre identica, nonostante l’espansione dellaCongregazione in nazioni straniere.
Lo spirito di famiglia ha sempre mantenutospontanei i loro rapporti fraterni e la loro dipen-denza filiale verso i «rappresentanti di Dio» (PC14) al vertice della Chiesa e al centro dellaCongregazione.
L’immagine della famiglia, frequente nellaLiturgia quotidiana e commovente nella Liturgiadella Passione, è richiamata dal Concilio VaticanoII quando vuole esprimere il sacro mistero dell’u-nità della Chiesa che ha il suo supremo modellonella Famiglia divina (cf UR 24).
Le Figlie della Chiesa modellano la loro vita ela loro organizzazione sulle linee fondamentali eistituzionali che Gesù ha affidato, e il suo Spiritosuggerito, alla loro Madre, sempre attenta ai segnidei tempi (GS 4) per tenere uniti i suoi figli.
Le loro comunioni fraterne si sono ispirate allecomunioni liturgiche, come esorta il loro invitatoriodi famiglia: «Dal corpo eucaristico al corpo mistico».
Partecipano quindi ai compiti comunitari: sop-portando «il peso dei fratelli» (Gal 6,2) comechiede il Rito della Professione, «scambiandosi
172

3,9) e ci appariva con più immediatezza:Gesù, proruppi io all’interrogativo del Padre; Maria, esclamò Olga; Maria, supplicai io; Gesù, replicò Olga;
Tutti e due, dunque, concluse il Padre ridendo;e a tutti e due abbiamo successivamente consacra-ta la Congregazione.
Atutto Gesù, il Verbo fatto uomo che si è unitoin certo modo a ogni uomo; ha lavorato con manodi uomo, ha pensato con mente di uomo, ha agitocon volontà di uomo, ha amato con cuore di uomo(GS 22). Bambino, adolescente, adulto, operaio emessia servo e re, crocifisso e risorto, in cielo econ noi in terra, il Verbo fatto Parola del Diovivente (PO 4) e il Pane degli angeli fatto Panedegli uomini (Lauda Sion), affinché tutti i figlidella Chiesa siano una cosa sola (cf Gv 17,21).
E a tutta Maria, in tutti i misteri della sua vitain tutte le devozioni che li riflettono e illuminano:Ve rgine e Madre del Signore, Addolorata eAssunta, Madre e Regina del cielo.
Ciò senza forzature, con la grazia liturgica chesopraggiunge nuova al ripetersi di ogni mistero diGesù e di Maria nella vita prodigiosa della Chiesa
IL CUORE DI GESÙ. Ma un punto focale c’è
175
Perché la Figlia della Chiesa non può mai esse-re sola.
Se è sola con Gesù sul monte (LG 46), avràcome Gesù dinanzi il mondo intero.
Se sarà sola con Gesù nell’orto, farà comeGesù per tutti la volontà del Padre.
E nell’inevitabile solitudine della morte avrà,come Gesù crocifisso, tutta la Chiesa nel cuore.
Spirito di pietà
La Chiesa è il Mistero della salvezza, perché lasua comunione è con Gesù Salvatore e con Maria,Madre del Salvatore.
La nostra comunione si inserisce nel Misterodella salvezza, se riceve come la Chiesa la suaunità dal Cuore di Cristo e nel centro materno del-l’unità che è la Madre sua.
È quindi indispensabilmente legata e propor-zionata alla nostra pietà.
Il primo incontro canonico con la Chiesa nellapersona di P. Lazzaro Darbonne, Visitatore apo-stolico, ci ha messo di fronte, con Olga, all’urgen-za di scegliere, fra i divini oggetti della nostracomune pietà, quello che emergeva per noi conpiù chiarezza dal nostro «Mistero nascosto» (Ef
174

è l’essenza. Il Concilio ha rimesso in luce l’amoredel cuore «che ha tanto amato gli uomini», perchénon può non amarli, che cerca consolatori e non litrova, che offre consolazioni a chi non le chiede,che spera comprensione da amici addormentati eapre a tutti la fonte della sua misericordia.
Le Figlie della Chiesa colgono queste pulsazionidalla Liturgia che ne è tutta sensibilizzata, voglionoche «il Cuore sanguinante dell’Agnello da cui nac-que la Chiesa sua sposa» (Inno Vespri S. Cuore) siala lampada della loro Congregazione, ne imprimonola sigla sulle porte, perché illumini tutte le loro casee la portano sul cuore per ricordarne l’amore.
Dal Cuore di Gesù apprendono il comandamentodell’Amore e la preghiera dell’amore. Qui sostanocome il passero che ha trovato una casa e la tort o r aun nido ove porre i suoi piccoli (Ps 84,4), nei loro«pii esercizi» (SC 13) approvati dalla Chiesa.
Il culto liturgico del Sacro Cuore è la fontesacramentale per tutti; i loro «pii esercizi» sonofontanelle carismatiche «vivamente raccomanda-te» (SC 13).
Le Figlie della Chiesa vi attingono il fervoredella pietà con la speranza di giungere alla cono -scenza dell’amore di Cristo che supera ogniintendimento (Ef 3,19) e di partecipare alla pas-sione del suo Cuore che si è rivelato per «trarretutti a sé con l’amore» (LG 3; Gv 12,32).
177
nella nostra pietà, anche se nascosto nel Misteronascosto della Chiesa; più intimo che sfolgorante.il Cuore di Gesù, «fatto di donna» (Gal 4,4) e diAmore infinito.
Le Figlie della Chiesa si immergono in questo«centro di decantazione del mondo» che si è dila-tato fino alle sue estreme possibilità umane, pertrarre tutti a sé (Gv 12,32 ) e consumarci tutti inuno (Gv 17,23).
Mentre però la Liturgia le eleva a questo suovertice (SC 10) che accumula tutto l’Amore trini-tario, i documenti conciliari non hanno un solocenno diretto al Cuore di Gesù.
Due volte presentano il suo costato in rapportoal Mistero della Chiesa:
Dal costato di Cristo dormente sulla croce èscaturito il mirabile sacramento di tutta la Chiesa(SC 5).
L’inizio e la crescita della Chiesa sono signifi-cati dal Sangue e dall’Acqua che uscirono dalcostato aperto di Gesù crocifisso e sono preannun-ciati dalle parole del Signore circa la sua morte incroce: E io quando sarò levato in alto da terratutti trarrò a me (Gv 12,32).
L’omissione, o meglio la sostituzione del termi-ne rigorosamente biblico, fu certamente ispirata.
Forse la devozione al Cuore di Gesù si eraimpoverita; il simbolo aveva velato l’amore che ne
176

nostra devozione a Maria Santissima miriamo alcuore in cui la Chiesa ha raggiunto la pienezzadella grazia, della gloria, della maternità e dellaregalità. Maria avvolge la Chiesa come l’aria leg -gera (1Re19,12) in cui c’è il Signore, semprepiena del suo spirito, sempre risonante del suoVerbo (Respiriamo Maria, pag. 18).
In lei si sviluppa spontaneamente la nostra vitabattesimale e religiosa, è più assimilabile la gra-zia, più facile la contemplazione.
Madre della grazia, della luce, della vita, dell’a-more fa «entrare nella nuvola» (Es 24,18) semplice-mente, inducendo al silenzio e all’ascolto del Ve r b oche nel suo seno si è fatto carne e nel suo cuore si faper noi amore, gioia, pace, pazienza, benignità,bontà, longanimità, mitezza, fede, modestia, conti-nenza, castità (Gal 5,22-23) a gloria del Padre.
Le Figlie della Chiesa come non nate attendonotutto da lei e non trascurano nulla di ciò che la riguarda.
Ripetono e fanno ripetere il Rosario, eco prolun-gata della Liturgia, perché il Mistero della salvezzasi imprima nel cuore e sia più facile pregare ininter-rottamente come ha comandato suo Figlio.
Dedicano le loro case a Maria, e le loro chiese,pur con l’osservanza delle norme liturgiche e delleprescrizioni pastorali, sono «centri eucaristicimariani», perché il popolo di Dio incontri semprein esse col Figlio la Madre, la Madre col Figlio
179
Gesù, il Capo del Corpo che è la Chiesa (LG7), dovrebbe essere la nostra specifica devozione,dal punto di vista teologico e logico, ma non lo èdi fatto, forse perché questo aspetto dottrinale esimbolico non ha un rilievo appariscente e marca-to nella Liturgia e nella pietà della Chiesa.
Paolo VI in un’effusione stupenda lo presentacome sintesi di tutta la dottrina e la prassi eccle-siale, e beate le Figlie della Chiesa cui l’amore delCuore di Gesù schiuderà questa luce sfolgorante:
«Cristo, Cristo stesso... Lui, Cristo Figlio diDio, Lui Figlio dell’uomo; Lui, di cui oggi anco-ra celebriamo la nascita sulla terra, è inserito nellanostra storia; Lui, alfa e omega, primo e ultimo fratutti, modello del vero umanesimo, primogenitofra noi tutti fratelli; Lui, immagine misteriosa eirradiante della divinità, rivelatasi amorosaPaternità celeste; Lui non solo tipo a cui riferirsi ea cui guardare per avere la giusta misura d’imita-zione e di confronto, il Maestro cioè, la guida, maaltresì misterioso principio generatore e sorgentein ognuno di noi d’un supplemento di vita; Lui,pane di vita, trasfusore in chi lo accoglie di ener-gie intellettuali, morali, sociali; Capo insommadell’umanità fatta suo Mistico Corpo» (Paolo VI,Messa di Natale 1972).
MARIA MADRE DELLA CHIESA. Anche nella
178

I SANTI. Forse perché il nostro culto dei santinon degenerasse nella molteplicità degli atti este-riori (LG 50), la santa Chiesa ce lo ha limitato allavenerazione di San Giuseppe e degli Apostoli.
Ma noi lo estendiamo particolarmente a tutti,mantenendolo esclusivamente liturgico, come laChiesa ce lo propone e lo vuole.
Solo per il «beato Giuseppe» (LG 50) che spe-riamo accanto a noi e ai nostri fratelli nell’istanteda cui pende l’eternità, varchiamo i limiti liturgicicon frequenti implorazioni, con la preghiera uni-versale raccomandata da Leone XIII e con altriliberi esercizi e letture.
Per gli Apostoli, Liturgia piena, perché s’effon-da tutto il calore sacramentale dei testi, dei segni,dei canti liturgici.
Il culto degli Apostoli non ci chiede solo dicercare dalla loro vita l’esempio, dalla comunionecon loro la partecipazione con loro e dalla lorointercessione l’aiuto (LG 51), ma ci impegna pureallo studio teologico del Mistero della Chiesa cheper primi, pieni di Spirito santo, hanno esplorato emirabilmente illustrato.
Particolarmente il «beato Pietro» (LG 18) lapietra su cui il Signore l’ha edificata come un tem-pio dalle pietre vive; San Paolo, cantore dellacarità che la sente come un corpo in cui la comu-nicazione della carità è essenziale alla vita; San
181
come a Nazareth, e la Madre con tutti i suoi figli,come sul Calvario.
La loro pietà è evangelica e conseguentementesociale: venera e ama Maria come Madre di Dio(LG 52) e degli uomini, Regina di un regno (LG59) che non è di questo mondo ed è nel mondo, enon si appaga di contenuti teologici, perché i figliconoscono la Madre sopratutto con le intuizionidel cuore. Questa intelligenza può ottenerceladirettamente lei e il Concilio ci invita a innalzarea Dio fervide, assidue, anzi quotidiane preghiere,perché col suo aiuto materno possiamo diveniretutti una sola cosa.
Le Figlie della Chiesa esprimono la loro pietàsoprattutto col culto liturgico che pone Mariaaccanto a Gesù nel piano della salvezza e con laloro consacrazione personale e comunitaria cheaffida al suo Cuore «alla sua fedeltà, alla sua sin-golare custodia e al seno della sua misericordial’anima e il corpo, ogni speranza e consolazione,ogni angustia e miseria, ogni compito e lavoro, lavita e il fine della vita, affinché per la sua interces-sione santissima e per i suoi meriti, tutte le loroazioni si conformino alla sua volontà e allavolontà del Figlio suo (O Domina mea) che èesplicita nella preghiera: Pater, rogo ut unum sint(Gv 17,21) incisa in tutti i loro tabernacoli.
180

Nelle prime Costituzioni approvate, lo espri-meva un testo esplicito che fu tolto nelle secondee noi l’abbiamo fatto rientrare nella presentazione,perché essenziale per noi.
Teresa che, non potendo essere missionariad’azione fu missionaria d’amore (Storia di un’a -nima) ci ricorda l’arcana fecondità dell’amore(PC 7), l’attività specifica dello Spirito santo, lapiù attiva della Chiesa.
E ce ne insegna il segreto: la sua umiltà che èstata tradotta col termine di piccolezza e si èespressa nella sua profonda convinzione di impo-tenza e nel suo totale abbandono all’Amore.
Se ritornassimo come i più piccoli del Vangeloanche noi come lei, o prima o dopo, entreremmonel regno dei cieli (ET 54), che è il Mistero dellaChiesa.
Solo i piccoli vi possono entrare, perché laporta dell’umiltà è stretta (Lc 13,24).
Solo al piccoli il Padre rivela queste cose, chenasconde agli autosufficienti (Lc 10,21).
La piccola Teresa ne ha avuto la piena rivela-zione e ha esperimentato che il mistero è l’amorestesso, con cui Gesù è amato dal Padre (Gv17,26), immanente in noi e che può rinnovare lafaccia della terra.
Per questo nel cuore della Chiesa non ha volu-to essere altro che l’Amore.
183
Giovanni che la vede scendere dal cielo come unasposa adorna della gloria di Dio (Ap 21,3) dell’e-suberanza dello Spirito, del gaudio della contem-plazione, della pienezza dell’unione.
Il Concilio conclude il suo mirabile espostosulla comunione della Chiesa celeste quasi inrapimento: il nostro rapporto coi beati non dimi-nuisce affatto il culto latreutico dato a Dio Padremediante Cristo nello Spirito, ma anzi lo intensi-fica (LG 51).
Tutti infatti, quanti siamo figli di Dio, costituia-mo in Cristo una sola famiglia; mentre comunichia-mo fra di noi nella mutua carità e nell’unica lodedella Trinità Santissima corrispondiamo all’intimavocazione della Chiesa; pregustando, partecipiamoalla Liturgia della gloria eterna (LG 51).
La nostra breve storia registra un frequentericorso privato e liturgico agli Angeli che ci hannosempre assistito fraternamente e spesso miracolo-samente, e una tenera pietà verso le Anime sante,particolarmente dei nostri cari, che purificandosilodano Dio come i tre fanciulli nella fornace. Nondimentichiamo di colmare, con la loro memoria,gli spazi liberi del ciclo liturgico.
SA N TA TE R E S A D E L BA M B I N O GE S Ù sta a sé. Laconsideriamo una sorella del cielo e nostrom o d e l l o .
182

La sua azione sradica la superbia della vita eispira l’umiltà della vita, l’abbassamento dellapersona.
La formazione nostra non giungerà mai a taleradicalismo, ma dovrà additarlo come una subli-mazione della dignità umana e disporre ad accet-tare le umiliazioni provvidenziali che immanca-bilmente sopraggiungeranno.
Lo Spirito santo è carità.La contemplazione passiva, cui il Battesimo
predispone, l’accumula come nella Chiesa aPentecoste, per centrarla in Dio ed espanderlagerarchicamente tra i fratelli.
La contemplazione attiva, cui il Battesimosospinge nel suo normale sviluppo, prepara a rice-verla se a Dio piacerà concederla.
La formazione nostra deve concorrere in que-sta preparazione:
aiutando il cuore a regolare la sua affettività(PC 12 );
facendo gustare il cenacolo della casa religiosain cui continuano a svolgersi i misteri dell’amoredi Dio e da cui continua ad espandersi il fuocodell’apostolato (PC 15);
ricordando, con la lettura e la meditazione deldiscorso di Gesù nel cenacolo e della predicazio-ne degli Apostoli, che la carità «è carità solo» sel’Amore col quale il Padre ha amato Gesù è in noi
185
Formazione spirituale
La formazione spirituale, o più propriamentepneumatica, comprende e supplisce le precedentiper la preminente azione dello Spirito santo che,come disse Gesù, trabocca dal seno di chi credein fiumi d’acqua viva (Gv 7,38).
Lo Spirito santo fa le anime docibiles Deo (Gv6,45), pronte a lasciarsi educare, ex - ducere, con-durre fuori di sé e del mondo, da Dio.
Ci guarderemo soprattutto dallo sformarle conuna educazione molle, permissiva, naturalistica.
Le lasceremo affrontare liberamente la mortifi-cazione e lo sforzo; le difficoltà della vita e dell’a-postolato.
Non intralceremo l’educazione dello Spirito.Lo Spinto santo conduce nel deserto e sul
monte, come ha condotto Gesù (Lc 4, 1).Le iniziate dovranno trovare nelle case un
clima abituale di silenzio e di preghiera e la sem-plicità e l’ordine che è «tranquillità e pace» (S.Agostino) ed è una prova mirabile dell’esistenzadi Dio.
Per opera dello Spirito santo il Figlio di Dio siè umiliato e ha preso la forma di servo (Fil 2,7).
184

onore, insigne per la sua dedizione a Dio e a noi.Maria si è data alla contemplazione e all’azionenella proporzione voluta dal Padre, esclusivamen-te per opera dello Spirito santo e la sua dedizioneincondizionata ha attratto in Lei «vasello diumiltà», lo Spirito santo per sempre e per tutti.
Ne è fiorito il Santo dei Santi e ne sono fioritie ne fioriscono i santi.
Lo Spirito santo riempie i cuori svuotati da leie li fa capaci di donarsi a Dio e ai fratelli, comelei.
La promessa di Gesù si realizza spontaneamen-te; la preghiera di Gesù è accolta sicuramente;
Lo Spirito santo, o silenziosamente, o clamoro-samente, irrompe dove c’è lei.
Il cuore diviene come il suo Cuore un «vasellodi devozione», di donazione di sé, nel gaudiocome a Nazareth, nel dolore come sul Calvario,nel fervore come nel Cenacolo.
La consacrazione al Cuore Immacolato Maria,convalidata dal Sommi Pontefici, non è che l’e-spressione di questa devozione interiore ricca ditutti i doni, frutto di tutti i frutti dello Spiritosanto, in cui si effondono tutte le virtù e che è lasantità.
187
e noi (siamo) in Lui.Lo Spirito santo può portarci alla partecipazio-
ne piena del disegno del Padre che è il Mistero diGesù continuamente attuale nella Chiesa.
Lui solo può farci trovare la proporzione, che ildisegno del Padre vuole da noi, fra la contempla-zione e l’azione, perché si raggiunga lo scopodell’ una e dell’altra, che è l’unione con Dio per lasalvezza dei fratelli.
Con Lui la contemplazione ci farà produrre frut-ti di carità e «la necessità della carità» (2Cor 5,14)ci farà lasciare le gioie della contemplazione.
Con Lui la carità ispirerà l’obbedienza sponta-nea, attiva, responsabile (PC 14), libera e l’obbe-dienza sarà carità fraterna e gerarchica.
Per formarci e per formare a questa sensibilitàspirituale abbiamo bisogno soprattutto di Spiritosanto. Gesù ce lo ha promesso e lo chiede conti-nuamente al Padre per noi; ciò basta alla nostrasperanza.
Ma nel misterioso trittico in cui si svolge ildisegno del Padre, lo Spirito santo opera eviden-temente con Maria: a Nazareth, sul Calvario, nelCenacolo scende in Maria, spira col suo consenso,prorompe implorato da lei (Respiriamo Maria pag30). Sono evidenze storiche, teologicamente con-fermate. Maria è il vaso spirituale (L i t a n i eLauretane) ricolmo di Spirito santo, degno di ogni
186

INDICE
Presentazione p. 3
IL NOSTRO MISTERO » 9
SPIRITO » 11ESPRESSIONI » 12RIFLESSIONI » 13Il mirabile sacramento » 17Lo Spirito santo » 23Maria » 26Formazione dottrinale » 28
PARTECIPAZIONE SACRAMENTALE » 33
SPIRITO » 35ESPRESSIONI » 36RIFLESSIONI » 37
Come partecipiamo alla «natura» della Chiesa... » 3 7... alle qualità della Chiesa » 38... alle funzioni della Chiesa » 47... alle vocazioni della Chiesa » 50... alla missione della Chiesa » 51Formazione liturgica » 55
189
CENNI BIOGRAFI CI SU MARIA OLIVA BONALDO
Maria Oliva Bonaldo nacque a Castelfranco Veneto inprovincia di Treviso il 26 marzo 1893. Era la Domenica dellaPalme e questo spiega il nome.
A nove anni perse la mamma e soffrì molto, tuttavia nonle mancarono occasioni utili per la sua formazione e per glistudi, data l'intelligenza brillante e vivace.
Durante la processione del Corpus Domini del 1913,ricevette l'ispirazione di abbracciare la vita consacrata e difondare le Figlie della Chiesa. Passeranno tuttavia venticin-que anni prima che il progetto si compia: ella però non persemai la speranza, nemmeno nelle prove più difficili.
Entrata tra le Figlie della Carità Canossiane, venne man-data a Milano dove studiò all'Università cattolica del SacroCuore e si laureò brillantemente nel 1930 con una tesi intito-lata La Vergine nell'Umanesimo. Iniziato l'insegnamento,divenne anche preside dell'Istituto Manzoni di Treviso, cuicambiò il nome in Istituto Madonna del Grappa.
Ammalatasi seriamente, nell'agosto 1934 a Schio diVicenza, scrisse i 33 foglietti, ossia la regola di vita per l'o -pera, termine con il quale ella chiamava le Figlie dellaChiesa che avrebbe fondato.
A Roma, nella festa del Sacro Cuore, il 24 giugno 1938,il nuovo Istituto prese avvio con le prime quattro Sorelle. Perespresso desiderio del Papa Pio XII nel 1946, Madre MariaOliva divenne Superiora generale dell'Istituto da Lei fondato.
L'Istituto ricevette l'approvazione pontificia nel 1957 esi sviluppò in Italia ed Europa e a partire dal 1962, si diffu-se in Bolivia, Colombia, Brasile, India.
Madre Maria Oliva ritornò a Dio il 10 luglio 1976. L'iterper il riconoscimento della sua santità avviato nel 1987, pro-segue alacremente per giungere al riconoscimento ufficialedella sua santità da parte della Chiesa.
188

PARTECIPAZIONE SPECIFICA p. 127
SPIRITO » 127ESPRESSIONI » 128RIFLESSIONI » 130La nostra parte » 130Spirito contemplativo » 134Spirito apostolico » 140Dobbiamo aprirci di più » 142Dobbiamo aprirci meglio » 143Dobbiamo aprirci con più slancio » 145Dobbiamo aprirci con più formazione» » 146Formazione specifica » 150
PARTECIPAZIONE PIENA » 153
SPIRITO » 155ESPRESSIONI » 156RIFLESSIONI » 157Lo spirito nostro nella Chiesa » 157Sgorga dalla preghiera di Gesù » 158È comunione sacramentale » 159È comunione fraterna e organica » 160È comunione salvifica » 164È comunione apostolica » 165È comunione pasquale » 167È comunione mistica » 170Spirito di famiglia » 171Spirito di pietà » 174Formazione spirituale » 184Cenni biografci su Maria Oliva Bonaldo » 188
191
PARTECIPAZIONE CARISMATICA p. 59
SPIRITO » 61ESPRESSIONI » 62RIFLESSIONI » 64
La vocazione religiosa » 64La professione religiosa » 66I vincoli » 68Scioglimento » 71
Voto di castità » 72Voto di povertà » 77Voto di obbedienza » 83L’autorità » 90
L’autorità è collegiale e personale » 92Dialogo e consultazione » 97
Autorità nostre » 102Autorità civili » 102Autorità ecclesiastiche » 102Autorità religiose personali » 105La Superiora generale » 107La Superiora locale » 111Autorità religiose collegiali » 113Il Capitolo generale » 114Il Consilio generalizio » 115Partecipazione al governo » 117Conclusione pratica » 118Formazione specifica » 119
190

Editrice Istituto Suore Figlie della ChiesaViale Vaticano, 62 – 00165
ROMA 2010
River Press Group - Roma