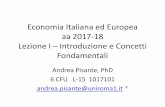Economia regionale
-
Upload
ele-santuzzi -
Category
Documents
-
view
146 -
download
0
description
Transcript of Economia regionale

Economia regionaleL’economia regionale si suddivide in due ambiti: la teoria della localizzazione e le teorie dello sviluppo o della crescita.Lo spazio agisce sul funzionamento di un sistema economico quale fonte di vantaggi o svantaggi. La prossimità spaziale riduce i costi di produzione, grazie ai potenti effetti di sinergia che genera, legando strettamente decisioni allocative e processi di sviluppo. L’economia regionale non è lo studio dell’economia a livello di regioni amministrative, ma quella branca dell’economia che inserisce nello studio del funzionamento del mercato la dimensione “spazio” come risorsa e fattore produttivo autonomo e come elemento fondamentale della competitività. Il fondatore dell’economia regionale è Walter Isard. Prima di lui, autori quali Marshall ritenevano il tempo più rilevante dello spazio. L’introduzione della variabile “spazio” richiede la rimozione delle ipotesi semplificatrici dei rendimenti costanti e di concorrenza perfetta. Come già detto, esistono due grandi filoni nell’economia regionale:
1) La teoria della localizzazione (che studia la distribuzione delle attività nello spazio): ha un approccio microeconomico e statico, che considera agglomerazione e accessibilità, uno spazio fisico-metrico, con dotazione fattoriale data.
2) La teoria della crescita (e dello sviluppo, che studia la crescita economica e del reddito): ha un approccio macroeconomico e dinamico, che considera efficienza allocativa, meccanismi moltiplicativi intraregionali, prossimità relazionale, cumulatività dei processi di crescita e uno spazio uniforme-astratto, con attività produttive e residenziali note.
Localizzazione e spazio fisico-metricoLa più antica concezione di spazio è quella geografica, sintetizzabile in termini di distanza e costi di trasporto.La teoria della localizzazione ha l’obiettivo di mettere in luce i fattori che influenzano la localizzazione delle singole attività, l’allocazione di diverse porzioni del territorio tra produzioni alternative, la spartizione di un mercato tra produttori e la distribuzione funzionale delle attività (come anticipato). Tutto questo è analizzato eliminando ogni specificità geografica attraverso l’ipotesi dell’esistenza di una pianura omogenea, con uguale fertilità (Von Thunen), per interpretare le scelte localizzative attraverso due fattori:
1) Costi di trasporto.2) Economie di agglomerazione.
Esistono teorie della localizzazione al costo minimo (Weber) e modelli, invece, il cui obiettivo è individuare la suddivisione delle aree di mercato, orientate alla massimizzazione del profitto (Losch e Hotelling). Esistono inoltre modelli il cui obiettivo è identificare le aree di produzione, opposte alle aree di mercato: in queste teorie il mercato è puntiforme (il borgo o il centro città), mentre l’offerta si estende su tutto il territorio (Von Thunen). Infine, i meccanismi che regolano la dimensione delle agglomerazioni, la loro specializzazione e la loro distribuzione sono di Christaller e Losch.
Crescita regionale e spazio uniforme-astrattoPer crescita economica regionale si intende la capacità di trovare e ricreare un ruolo all’interno della divisione internazionale del lavoro attraverso l’uso efficiente e creativo delle risorse e l’abilità di una regione di produrre con un vantaggio. Le prime teorie della crescita regionale utilizzano una concezione di spazio uniforme-astratto, non più fisico e continuo. Il vantaggio è la possibilità di utilizzare modelli macroeconomici per i fenomeni di crescita locale. È un approccio di breve periodo.
Crescita locale e spazio diversificato-relazionaleLo spazio diversificato-relazionale permette di recuperare le economie di agglomerazione (anni ‘60/’80) attraverso sinergie e retroazione cumulativa. È una concezione di spazio più immateriale, attraverso le relazioni economiche e sociali. Determinanti per lo sviluppo, in questi casi, sono le esternalità territoriali. Si tratta delle teorie delle sviluppo, finalizzate non tanto a spiegare un tasso di crescita aggregato del reddito o dell’occupazione, ma ricercare elementi tangibili e non.
Crescita regionale e spazio diversificato-stilizzato: verso una convergenza prospettica?Abbandonando l’ipotesi di rendimenti costanti e concorrenza perfetta, negli anni ’90 si assiste all’inserimento delle economie di agglomerazione con rendimenti crescenti. Lo spazio diviene diversificato-stilizzato in punti (ai quali è negata la dimensione), nel quale né le caratteristiche geografiche né territoriali hanno un ruolo. La crescita è endogena e nasce dai vantaggi della concentrazione. Prevale la visione di spazio quale mero contenitore dello sviluppo.
Teorie della convergenza e della divergenza: una distinzione ormai superataI manuali di economia regionale hanno spesso presentato una dicotomia tra teorie delle disparità e modelli che, al contrario, spiegano il perpetuarsi di tali disparità. Il paradigma neoclassico interpreta lo sviluppo come un processo tendente ad un punto di equilibrio. Sul fronte della divergenza son invece collocate le teorie di origine keynesiana. In

anni recenti, grazie al rafforzamento degli strumenti di analisi matematica e modellistica, si è dimostrato che le stesse teorie sono in grado di spiegare sia la divergenza sia la convergenza. Il modello neoclassico non è adatto ad interpretare gli squilibri. Il modello keynesiano è incapace di prevedere limiti di carattere territoriale all’evoluzione.
Gli elementi distintivi delle teorieLo spazio può essere considerato micro o macroeconomico. La crescita può essere associata all’occupazione, al benessere individuale (salari, reddito) raggiungibili attraverso produttività, specializzazione e competitività.
Teorie della localizzazione
Agglomerazione, localizzazione e costi di trasportoLa teoria della localizzazione è quella branca dell’economia che si occupa dell’organizzazione delle attività sul territorio. La distribuzione disomogenea delle materie prime, dei fattori produttivi (capitale e lavoro), della domanda (mercati) impone alle imprese di scegliere la loro localizzazione. In termini cronologici, le prime riflessioni sullo spazio sono contenute nelle teorie delle attività industriali, attraverso la considerazione di entrambe le grandi forze:
1) I costi di trasporto: tutti gli elementi di frizione spaziale (costo della distribuzione delle merci, di comunicazione, di informazioni etc.).
2) Le economie di agglomerazione: quei vantaggi di ordine economico che le imprese ottengono dalla prossimità alle altre. Agiscono in senso opposto ai costi di trasporto. Si riassumono in 3 grandi categorie:
a. Le economie interne all’impresa, dette anche economie di scala.b. Le economie esterne all’impresa ma interne al settore, o economie di localizzazione.c. Le economie esterne all’impresa ed esterne al settore, o economie di urbanizzazione.
L'agglomerazione, intesa nel senso di prossimità, diviene nelle teorie dello sviluppo la determinante endogena nella spiegazione dei processi di sviluppo economico, cumulativi e territorializzati.
Le teorie della localizzazione si dividono in due gruppi, in base agli obiettivi che si pongono:1) Massimizzazione del profitto.2) Minimizzazione dei costi.
Fa eccezione il contributo di Losch, sviluppato in un’ottica di equilibrio spaziale generale economico localizzativo.Economie di localizzazione e costi di trasporto
Weber nel 1909 formula un modello, “il triangolo localizzativo”, in cui analizza 3 fattori:1) Costi di trasporto.2) Mercati delle materie prime.3) Mercati del bene finale.
Il prevalere di un elemento rispetto all’altro determina la localizzazione.Ipotesi semplificatrici:
1) Mercato del bene puntiforme.2) Due mercati delle materie prime.3) Perfetta concorrenza.4) Domanda rigida al prezzo.5) Costi di produzione costanti.
La scelta localizzativa è il risultato di due stadi:1) Il 1° stadio evidenzia la localizzazione che garantisce costi di trasporto minimi. I costi di trasporto totali sono
espressi come funzione del peso (x,y,z), della merce da trasportare e della distanza da coprire (a,b,c):CT = xa + yb + zcDove xa, yb, zc sono le forze di attrazione che spingono l’impresa, orientata verso le materie prime o al mercato, verso un vertice del triangolo.
2) Nel 2° stadio, l’impresa mette a confronto la localizzazione a costo minimo con una localizzazione alternativa, nella quale può godere di economie di localizzazione, quali la disponibilità di manodopera e/o di qualità.
Weber evidenzia le isodapane (sulle quali ha lavorato anche Hoover), curve lungo le quali il costo di trasporto minimo rimane costante. La scelta di rilocalizzazione avverrà se e solo se le isodapane di ogni impresa che misurano un costo aggiuntivo di trasporto pari al vantaggio agglomerativo si incrociano. Non altrettanto dicasi per l’impresa, la cui isodapana non incontra quelle delle altre imprese, per la quale il vantaggio agglomerativo non supera il costo addizionale di trasporto.I limiti del modello dipendono dalla sua natura:
1) Statica (tralascia l’innovazione e la variazione nelle condizioni di distribuzione).2) Transport oriented (è sub ottimale rispetto ad un approccio basato sulla ricerca diretta, anziché in 2 fasi, di
un punto di costo totale di produzione minimo).

3) Astratta: è improbabile riuscire a calcolare l’apporto del peso delle materie prime nel peso del bene finale.4) Di modello di equilibrio parziale: manca qualsiasi allusione a interazioni nei comportamenti d’impresa.5) Supply oriented: la critica più frequente riguarda la domanda rigida e illimitata.
Dimensioni del mercato e costi di trasportoIl modello di Weber nega l’esistenza di luoghi di agglomerazione della popolazione: nega le economie di urbanizzazione. Melvin Greenhut introduce il ruolo della dimensione fisica del mercato nell’ipotesi di una domanda distribuita in modo disomogeneo sul territorio. La presenza di un mercato di vaste dimensioni può compensare, infatti, il maggior costo di trasporto.
Economie di scala e costi di trasporto: le aree di mercatoI modelli finora presentati contrappongono le economie di localizzazione ai costi di trasporto. Un secondo gruppo di modelli abbandona l’ipotesi di una struttura di mercato puntiforme, per rifarsi a quella di una domanda distribuita omogeneamente sul territorio.
Ipotesi:
1) Domanda rigida.2) Due produttori identici.3) Localizzazione data.4) Costo di trasporto costante (si legga: proporzionale alla distanza).5) Costo di trasporto a carico del consumatore.
Ne consegue che: Prezzo di vendita = costo della merce + costo di trasporto. I consumatori sceglieranno il produttore più vicino. Il punto di indifferenza rappresenta la soglia delle due aree di mercato.Nuove ipotesi:
1) I produttori possono godere di economie di scala.2) I costi di trasporto sono a carico del venditore.
Risultati:1) Il produttore che gode delle economie di scala delimita un’area di mercato maggiore.2) I consumatori localizzati più vicino ottengono un vantaggio economico.3) Il produttore può discriminare sul prezzo all’interno della sua area di mercato, nella quale opera in regime di
monopolio, senza perdere quote di mercato. Il modello può essere pertanto quello di concorrenza monopolistica (à la Chamberlin & Lancaster), nel quale la discriminazione sul prezzo si basa sulla distanza.
4) La distanza fisica svolge il ruolo di barriera all’entrata.
Accessibilità e localizzazioneAccessibilità e costi di trasporto: valore e uso del suolo
Secondo le teorie di natura neoclassica, le attività che si localizzano più vicino al centro sono quelle in grado di pagare per una rendita più elevata.Nel capitolo precedente abbiamo visto come i costi di trasporto spingono alla diffusione e le economie di agglomerazione, al contrario, alla concentrazione, senza considerare elementi geografici. Le teorie che stiamo per presentare ribaltano le ipotesi sulla struttura spaziale della domanda e dell’offerta: è il luogo di produzione ad assumere una dimensione spaziale, mentre il mercato viene concepito puntiforme. Abbandoniamo così l’obiettivo di identificazione delle aree di mercato di ogni produttore per trovare la definizione di “aree di produzione”. Queste teorie rispondono ad un principio: l’accessibilità (a mercati di sbocco, dei fattori produttivi e del centro degli affari) per minimizzare i costi del pendolarismo. In questa logica emerge un criterio univoco: il costo del suolo o rendita fondiaria.A differenza del modello di Weber, questo modello vale per attività agricole, produttive e residenziali ed è particolarmente adatto a studiare lo spazio urbano, nel quale è facile ipotizzare l’esistenza di un centro, stabilendo dove la singola impresa o il singolo individuo andrà a localizzarsi.Il 1° modello formulato agli inizi dell’800, per le attività agricole, è di Von Thunen (negli anni ’60 Alonso riformula il modello in un contesto urbano) nel quale non è più la scelta della singola impresa o del singolo individuo ad interessare, ma la definizione della dimensione e della densità della città e dei costi del suolo.
La localizzazione delle attività agricole: il modello di Von Thunen

Si tratta del primo modello di localizzazione urbana delle attività economiche, seguendo le seguenti ipotesi:1) Spazio omogeneo (isotropo), sia in termini di fertilità delle terre sia di infrastrutture di trasporto.2) Unico centro: il borgo medievale.3) Domanda illimitata.4) Perfetta distribuzione dei fattori produttivi nello spazio.5) Rendimenti di scala costanti.6) Condizioni di concorrenza perfetta.7) Costi di trasporto unitari costanti: il costo totale di trasporto dipende dalla distanza tra la produzione e il
borgo.Il problema che affronta Von Thunen è quello di individuare la suddivisione delle terre tra i coltivatori. Il prezzo al quale il coltivatore è disposto a pagare la terra è ottenuto in modo residuale, una volta sottratti ai ricavi i costi di trasporto e produzione. Una minor distanza unitaria dal centro genera un risparmio pari all’incremento di rendita che richiedono le localizzazioni più centrali. Il modello di Von Thunen riesce a individuare nella semplice distanza o accessibilità al borgo (costi di trasporto) la ragione della diversa rendita del suolo e a discostarsi dalla visione ricardiana che attribuiva alla diversa fertilità il differenziale di redditività.
Gerarchia, localizzazione e sistemi urbaniLa teoria delle località centrali ha l’obiettivo di individuare una regola che interpreti la gerarchia urbana e, dunque, la distribuzione geografica di tutti i centri. Inoltre il nuovo paradigma delle reti di città è stato formulato per superare i limiti di tale teoria. Finora si sono analizzate le scelte localizzative prescindendo dall’esistenza di altre città, altri soggetti e dalla possibilità di localizzazioni in centri urbani alternativi. L’equilibrio, infatti, presuppone che le città siano tutte identiche. L’introduzione della gerarchia urbana ha l’obiettivo di spiegare:
La dimensione e la frequenza dei centri urbani di ciascun livello gerarchico, e pertanto l’idea di mercato di ognuno.
La distanza tra un centro e un altro, dunque la distribuzione geografica.I padri fondatori di questa corrente di pensiero, che va sotto il nome di “teoria delle località centrali” (central place theory), sono il geografo Walter Christaller e l’economista August Losch.
L’approccio geografico: il modello di ChristallerSi basa sull’assunzione che esista un centro urbano o località centrale che offre beni e servizi su un territorio omogeneo e isotropo. L’obiettivo è comprendere la gerarchia urbana. A differenza del modello di Von Thunen, l’offerta è puntiforme e la domanda omogeneamente distribuita nello spazio, secondo una logica simile a quella della suddivisione delle aree di mercato tra produttori. Christaller introduce i concetti di:
Soglia (threshold): delimita un’area circolare nella quale è compresa la quantità di popolazione minima sufficiente a garantire un livello di domanda tale per cui il servizio è prodotto in modo efficiente.
Portata (range): definisce la distanza massima oltre la quale il consumatore non è disposto ad affrontare i costi di trasporto.
Ogni servizio è prodotto solo se la portata supera la soglia. Le aree di mercato hanno forma esagonale. Ipotesi:1) Minimizzazione dei costi di trasporto: è la località centrale che la permette.2) Equità distributiva: non esistono zone non servite.3) Concorrenza tra produttori: le aree non sono sovrapposte.
Si delinea così una struttura a favo. I servizi di qualità superiore hanno una portata maggiore, che giustifica un’area di mercato più grande. Christaller ipotizza che i produttori vadano a localizzarsi nel centro degli esagoni, in maniera da godere di economie di agglomerazione. Poiché la portata del servizio inferiore è per definizione minore di quella del servizio superiore, l’area di mercato servita dalle unità di produzione localizzate nel centro è inferiore all’esagono stesso e lascia parte del territorio non coperto. Nuove unità di produzione saranno così attratte dalla domanda inevasa. I principi organizzatori delle aree di mercato sono:
1) Principio del mercato: la minimizzazione del numero di centri in grado di coprire tutto il territorio (prevede 3 centri di ordine inferiore).
2) Principio del trasporto: minimizza i costi di trasporto (ne risultano 4 centri di ordine inferiore).3) Principio amministrativo: cerca di evitare i conflitti di competenze (tutti i centri di ordine inferiore, 7,
appartengono ad un unico centro di ordine superiore).Ogni centro maggiore produce i beni/servizi relativi al suo livello gerarchico e tutti quelli di ordine inferiore.I postulati economici che caratterizzano questo modello sono quindi:
1) Ottimalità nel comportamento dei consumatori, che minimizzano i costi di trasporto.2) Spazio geografico omogeneo, in cui l’agglomerazione nasce per ragioni economiche e non geografiche.3) Costo di trasporto proporzionale alla distanza.4) Economie di scala (implicite nel concetto di soglia).

5) Equità dell’offerta (copertura di tutto il territorio).Analizzando la struttura della Germania meridionale, Christaller trova una corrispondenza impressionante con la realtà.
L’approccio economico: il modello di LoschNel 1940, Losch cerca di superare le ipotesi di proporzionalità costante lungo la gerarchia urbana, ottenendo anch’egli una struttura esagonale, ma dovuta a motivi economici:
La competizione che non permette l’esistenza di aree di mercato non coperte. I consumatori si rivolgono al produttore in grado di offrire il bene a prezzi più bassi, ossia al più vicino.
L’equilibrio spaziale del settore è raggiunto facendo riferimento al mercato di concorrenza monopolistica di Chamberlin, raggiunto quando non esistono più incentivi ad entrare nel mercato.A differenza di Christaller, Losch evidenzia diversi fattori di proporzionalità detti coefficienti di annidamento: egli suppone che ad ogni bene o servizio corrisponda una diversa dimensione di mercato. I coefficienti di Losch sono multipli geografici di quelli di Christaller (3,4,7). L’abbandono dell’ipotesi del fattore di proporzionalità permette di considerare la diversa specializzazione dei centri delle stesse dimensioni: ogni centro può ospitare anche una sola funzione e non tutte le altre. Il modo in cui Losch arriva alla strutturazione complessiva del territorio risponde ad un principio di efficienza del sistema di trasporto che ammette soluzioni più realistiche di quelle di Christaller. Anche Losch riesce a dimostrare empiricamente la validità del suo modello, applicandolo al territorio dell’Iowa (USA).Il modello di Losch è più adatto a descrivere il settore industriale, quello di Christaller i sistemi basati sui servizi.
Valutazione critica dei due modelliSulla base dell’esistenza delle forze che spiegano le scelte localizzative (economie di agglomerazione e costi di trasporto), l’equilibrio emerge attraverso una logica di ottimizzazione del profitto per le imprese e di utilità per i consumatori. Fin qui tutto ok. Limiti:
Domanda omogenea e immobile (si considera solo il lato della produzione). La mancanza di interindipendenza dei produttori: si ignorano le relazioni I-O che potrebbero favorire scelte
localizzative dettate dalla prossimità con altri fornitori). La natura statica dei modelli.
Sviluppi recentiIl modello di Beckmann & McPherson ipotizza un diverso fattore di proporzionalità a seconda del livello gerarchico e del servizio offerto: assume non più un significato geografico, ma economico e indica il numero di residenti necessario per fornire il servizio a ciascun abitante di un’area. Beguin ha inserito nel modello di Beckmann & McPherson la produttività del lavoro e la quantità del bene domandata, dimostrando che la gerarchia urbana dipende da:
Rendimenti crescenti, decrescenti, costanti del fattore lavoro. Distribuzione della domanda. Elasticità rispetto al reddito.
Long introduce in un modello christalleriano l’interindipendenza tra i beni, ipotizzando che la quantità acquistata non diminuisca necessariamente con la distanza dal centro, perché può aumentare a mano a mano che ci si avvicina ad altri centri. Inoltre afferma che la portata può cambiare per la presenza di beni succedanei. Il modello di Long è matematicamente troppo complesso.Parr analizza l’evoluzione dinamica della gerarchia urbana ipotizzando:
La formazione di livelli successivi di gerarchia. Il mutamento nell’allocazione delle funzioni economiche. Modificazioni nella struttura gerarchica.
Il risultato è che le aree si possono eventualmente trasformare in rettangoli o triangoli.Le reti di città
Definizione: insieme di rapporti, orizzontali e non gerarchici, fra centri complementari o similari, che realizzano la formazione di economie o esternalità di specializzazione, sinergia, cooperazione, innovazione.In anni recenti si è assistito ad un’evoluzione dei sistemi urbani nei paesi di medie dimensioni (40.000-200.000 abitanti), caratterizzata da:
Forti interdipendenze tra centri dello stesso ordine. Specializzazione. Mancanza di rapporti gerarchici. Mix di funzioni incompleto in ogni città. Funzioni di rango elevato in centri di ordine inferiore. Legami orizzontali e di sinergia.
Il modello christalleriano tradizionale è incapace di spiegare questi fenomeni. È possibile identificare due tipi di reti:

1) Reti di complementarità (integrazione verticale e orizzontale): la specializzazione garantisce il raggiungimento di economie di scala e di agglomerazione anche in centri di dimensioni non rilevanti.
2) Reti di sinergia: piazze mondiali, mercati integrati grazie a telecomunicazioni avanzate. I vantaggi sono costituiti dalle cosiddette “esternalità di rete” (esempio: centri finanziari virtuali).
3) Reti di innovazione: su specifici progetti con rapporti su lunga distanza, tra città a “vocazione funzionale” simile.
Si abbandonano la minimizzazione dei costi di trasporto e la massimizzazione dell’area di mercato; i legami cooperativi sono alla base delle relazioni economiche.
Teorie della crescita e dello sviluppo regionale: lo spazio uniforme-astrattoLe teorie della crescita regionale, sviluppate negli anni ’50 e ’60, individuano lo sviluppo locale attraverso la crescita del prodotto o del reddito pro-capite, cercando di identificare gli elementi che possono dare ragione del sentiero di sviluppo sia in un’ottica di efficiente allocazione delle risorse locali (convergenza o divergenza nei tassi di crescita), sia in un’ottica di equità distributiva. Si occupano della capacità di un sistema locale di sviluppare attività o attrarne di nuove attraverso l’uso efficiente e creativo delle risorse.Quando, invece, le teorie si occupano del benessere sociale, siamo di fronte a teorie dello sviluppo locale.Affronteremo 3 grandi filosofie:
1) Classici e neoclassici (‘700/’800): interpretano il processo di crescita in chiave di efficienza produttiva. L’obiettivo risiede nell’individuazione delle determinanti che generano occupazione e reddito nel breve periodo.
2) Visione congiunturale di breve periodo: risorse date e inutilizzate. L’interesse è quello di evidenziare i meccanismi che permettono di uscire dalla povertà e di garantire un certo livello di benessere.
a. Chiave moderna: crescita come problema di competitività di lungo periodo, per la quale diviene essenziale l’innovazione.
In una concezione di breve periodo, un aumento delle esportazioni oppure dei processi migratori rappresenta un meccanismo di sviluppo, in un’ottica di benessere individuale, lo stesso fenomeno è concepito come una sottrazione di beni al consumo finale.Un aumento del reddito di breve periodo è raggiungibile attraverso una crescita della domanda attraverso effetti moltiplicativi di stampo keynesiano. In un’ottica attenta al benessere e alla competitività di lungo periodo, il motore dello sviluppo deve necessariamente spostarsi su elementi di offerta (lavoro, capitale, imprenditorialità). In comune c’è sempre un’ottica dinamica.
Concezioni di spazioLe prime teorie dello sviluppo regionale sono teorie della crescita, volte a spiegare l’andamento del reddito e dell’occupazione. Per farlo, adottano una concezione di spazio uniforme-astratto con offerta e domanda ovunque identiche, ipotizzando un territorio uniforme, privo di sinergie e agglomerazione. Si tratta di teorie della crescita regionale, con l’inevitabile perdita di informazioni qualitative ma con il pregio di una modellizzazione analitica. Regioni deboli si contrappongono a regioni a forte dotazione di capitale, di tecnologie e di Know-how. Un secondo modo di interpretare lo spazio è contenuto nella concezione di spazio diversificato-relazionale, che ipotizza rapporti tra individui, società e territorio. Questa concezione richiede un approccio micro territoriale che rientra nelle teorie dello sviluppo (analisi delle multinazionali, innovazione, cause esogene di sviluppo). Questa interpretazione di spazio trova la sua massima espressione nelle teorie dei distretti industriali, con rendimenti crescenti che permettono un circolo virtuoso di sviluppo; ma lo sviluppo avviene in aree di efficienza dei processi produttivi. Lo spazio diviene fattore produttivo.
La teoria degli stadi e le pre-condizioni dello sviluppoLa semplicità della teoria degli stadi (cfr. Hoover & Fisher) è al tempo stesso la sua forza e la sua debolezza: lo sviluppo regionale è rappresentato come un susseguirsi di fasi, una successiva all’altra con capitali e lavoro crescenti. La sequenza prevede:
1) Fase di autarchia: economia di sussistenza.2) Fase di specializzazione: si mette in moto grazie alla creazione di alcune infrastrutture di trasporto, che
danno luogo a scambio di beni agricoli.3) Fase di trasformazione da economia agricola a industriale.4) Fase di diversificazione dell’attività manifatturiera.5) Fase di terziarizzazione: la specializzazione diventa fonte di produttività.
Questa teoria sottolinea l’importanza di una crescita contemporanea di diversi settori. Le forze motrici della crescita regionale sono:
Esternalità derivanti da meccanismi di interindipendenza tra diversi settori. Esternalità nei meccanismi di interindipendenza tra domanda e offerta.

Esternalità che nascono dalla presenza di investimenti in infrastrutture differenti.Il sottosviluppo è interpretato come la permanenza forzata all’interno di una fase. Qualora non esistesse sufficiente dimensione di mercato o investimenti in capitale o in infrastrutture. Il rischio è che le dispersioni verso aree esterne più avanzate siano talmente forti da limitare un’espansione della domanda. Il suggerimento è che nelle prime fasi dello sviluppo si debbano incanalare investimenti pubblici in pochi, grandi e diversificati settori forti. Tuttavia, risulta alquanto difficile poter accettare l’idea che il processo di sviluppo possa avvenire seguendo fasi necessariamente identiche in tutte le regioni.
Fasi di sviluppo e disparitàWilliamson sostiene che lo sviluppo si presenta concentrato e polarizzato nelle aree centrali e successivamente si diffonde alle periferie e ai settori più deboli. La conseguenza è che nelle prime fasi il divario regionale cresce. Motivi:
Emigrazione. Flussi di capitali. Investimenti pubblici nelle aree forti. Limitati scambi interregionali, fino a che non entrano in gioco meccanismi opposti.
L’evidenza empirica dà ragione di una crescita dei differenziali; non altrettanto si può sostenere per gli effetti opposti.
La domanda e la crescita regionaleIn un’ottica tipicamente keynesiana, che si pone come obiettivo quello di ovviare ad un elevato livello di disoccupazione, esaminiamo le teorie che, negli anni ’50 e ’60 individuano lo sviluppo attraverso la crescita del prodotto o del reddito pro-capite, con la necessaria assunzione di uno spazio uniforme-astratto e omogeneo. Anche qui le condizioni di offerta e di domanda sono ovunque identiche. Gli elementi che innestano un processo di sviluppo sono:
1) Espansione della domanda.2) Crescita della capacità produttiva.3) Maggiori risorse a disposizione.4) Investimenti.
Dall’aumento della domanda dipende non solo l’occupazione e il reddito del settore, ma anche, per effetto di meccanismi di interindipendenza a monte e a valle della produzione, dell’intera area. La domanda è dunque in questi modelli il motore dello sviluppo. Quanto si produce spesso va al di là delle esigenze della domanda locale. La domanda è, infatti, spesso esterna e, in quest’ottica, la crescita dipende dal grado di specializzazione. Ogni spesa addizionale si trasforma in reddito, il cui aumento a sua volta torna ad incrementare la spesa, ad ogni passaggio con incrementi via via più limitati. Siamo nel breve periodo, quindi privo di considerazioni riguardo al benessere individuale e alla competitività, che sono dati per scontati.
La bilancia dei pagamenti regionaliLe regioni si presentano come sistemi di piccole dimensioni che producono in eccesso il bene di specializzazione e non sono in grado di fornire un’ampia gamma di risorse, che devono essere acquistate dall’esterno. La bilancia dei pagamenti rappresenta lo strumento contabile, a livello aggregato, di tutte le transazioni che un sistema regionale intrattiene con il resto del mondo in un periodo di tempo (annuale).
È suddivisa in 3 parti:
1) Partite correnti:a. Bilancia dei servizi:
ENTRATE USCITESpese effettuate dai non residenti Spese dei residenti per servizi ottenuti all’esterno
b. Bilancia commerciale:ATTIVO PASSIVOMerci esportate Merci importate
c. Trasferimenti unilaterali:ENTRATE USCITETrasferimenti del Governo alla Regione Rimesse degli immigrati verso altre regioniLa somma dà luogo al saldo delle partite correnti, ossia il saldo di tutte le transazioni reali.
2) Movimenti di capitale: registra le transazioni finanziarie.3) Movimenti monetari: entrate e uscite di moneta per transazioni di merci o capitali.

Il metodo è quello della partita doppia, quindi il bilancio risulta sempre in pareggio. Nel conto delle risorse e degli impieghi sono registrati in attivo le risorse e in passivo i modi di impiego di esse (consumi, investimenti, esportazioni). Se la regione registra un saldo positivo nella bilancia commerciale e in quella dei servizi, significa che una parte della produzione interna è effettuata per rispondere all’esigenza di un mercato esterno. Il secondo quadro è quello del reddito regionale e del suo utilizzo, utilizzato per consumi e risparmi. Il terzo quadro è quello del conto della formazione del capitale: registra risparmi, contributi e investimenti non finanziari. Il saldo registra le risorse interne a disposizione o mancanti. Il saldo delle partite correnti uguaglia sempre il saldo del conto della formazione del capitale.
Le condizioni macroeconomiche nelle relazioni interregionaliLa crescita può essere il risultato di:
Esportazioni elevate (positivo). Cospicui trasferimenti pubblici (negativo che indica ridotta competitività, stagnazione e disoccupazione). Acquisti di beni patrimoniali (negativo: anche in questo caso può celare disoccupazione e squilibrio). Movimenti di capitali in entrata per investimenti (positivo: stimola l’occupazione e la capacità produttiva). Importazioni (crediti commerciali). Elemento “neutro”.
La regione esportatrice: il modello della base d’esportazioneIl modello di Hoyt degli anni ’30 è orientato all’identificazione del ruolo della domanda nei meccanismi di crescita e di sviluppo. L’idea di base è che i sistemi di piccola entità non possono affidarsi esclusivamente alle capacità endogene di sviluppo: la crescita resta condizionata da elementi esterni. Hoyt distingue l’occupazione del settore di base dall’occupazione del settore dei servizi. L’occupazione nel settore di base è esogena. All’aumentare dell’occupazione nel settore di base, l’occupazione totale aumenta di una quantità più che proporzionale (definita moltiplicatore urbano): 1 / (1 – occupazione nei servizi) con 0 < a < 1.
Il modello keynesiano export-ledNegli anni cinquanta viene formulata una versione a livello regionale del modello della base d’esportazione di natura economica, che si basa su un modello tradizionale di domanda aggregata keynesiana: Y = C + I + G + (X – M).La conclusione è analoga al modello precedente: la domanda esterna, misurata in termini di esportazioni, genera sviluppo locale, attraverso gli effetti moltiplicativi che provoca sul reddito e sull’occupazione. Le regioni a più rapido sviluppo sono quelle che riescono a mantenere nel tempo un surplus di esportazioni.
Valutazioni critiche del modelloPregi:
analizza il problema dello sviluppo dal punto di vista di un sistema di piccole dimensioni, in una logica keynesiana ed evidenzia il ruolo delle relazioni interregionali.
Ricorda l’importanza della specializzazione e riesce a mettere sull’avviso circa il rischio di un’accentuata specializzazione nel lungo periodo: se diminuisce la domanda di un determinato bene e la regione è specializzata nella sola produzione di quel bene, ci sarà recessione.
Si adatta a descrivere lo sviluppo nei cosiddetti ricardian goods, ossia beni connessi con la disponibilità di risorse naturali.
Difetti: Non considera la struttura e la dinamica dell’offerta locale. Non esiste distinzione tra attività produttive e tra specializzazioni industriali differenti. Gli effetti moltiplicativi delle esportazioni sul reddito hanno sempre la stessa portata, indipendentemente dal
settore. Non vi è nessun ostacolo all’ampliamento dell’offerta: il sistema ha le risorse per aumentare la produzione a
costo nullo. Se così non fosse, l’aumento della domanda si scaricherebbe nel breve in aumento dei prezzi. Stabilità dei moltiplicatori: nel lungo sono facilmente ipotizzabili processi di diversificazione produttiva. Non
sono previsti cambiamenti produttivi. Ignora il settore residenziale e dei servizi.
La stima della base economicaL’interesse ad applicare il modello della base d’esportazione ha spinto all’individuazione di metodi per distinguere i settori. Il più comune è quello del quoziente di localizzazione, con il quale si distinguono i settori in base alla quota occupazionale del settore a livello regionale rispetto alla quota dello stesso settore a livello nazionale: è il rapporto tra la percentuale di occupati della regione e la percentuale di occupati della nazione in un settore. Qualora il rapporto tra le quote sia maggiore di 1, si considera che la proporzione eccedente sia espressiva di un surplus di produzione rispetto alle esigenze della domanda locale e, quindi, di esportazioni nette. Stabilito in questo modo quali sono i settori che esportano, sommandone l’occupazione si ottiene la stima dell’occupazione nel settore di base.Limiti:
1) Assume uguali preferenze dei consumatori nello spazio nazionale o regionale.

2) È una logica di economia chiusa: si ipotizza che la nazione non esporti e che le esigenze siano al massimo rappresentate dalla domanda nazionale.
3) Ipotizza uguali livelli di produttività nello spazio.Un altro metodo è quello della tecnica dei requisiti minimi, che parte dal presupposto che la quota di occupati più bassa sia la quota minima per soddisfare le necessità di una regione e che una quota più elevata sia espressiva di una capacità produttiva eccessiva per la regione. La somma dell’occupazione dei settori con una quota superiore alla minima determina l’occupazione nel settore di base. Anche questo modello ha più o meno gli stessi limiti.
La stima del moltiplicatore regionaleEsistono almeno due metodi in grado di stimare il moltiplicatore regionale:
1) Metodo di Archibald: stima la propensione ad acquistare beni localmente.2) Metodo di Allen: considera come proxy l’inverso della quota di dispersione (leakages) sul PIL di una regione.
L’analisi I-OÈ una tecnica che permette di considerare l’impatto che la crescita di un settore genera sulla produzione di ogni altro settore dell’economia locale. È basata sul modello delle interdipendenze settoriali di Wassily Leontief: è una metodologia di previsione che si basa sulla costruzione di una matrice quadrata n x n nella quale vengono registrate le vendite sulle righe e gli acquisti sulle colonne. La matrice è completata da una serie di colonne nelle quali si registrano consumi, investimenti ed esportazioni e da una serie di righe, nelle quali si inseriscono salari e profitti e acquisti dall’esterno. La somma di ogni riga rappresenta i ricavi di ogni settore, mentre la somma di ogni riga i suoi costi. I valori per riga uguagliano i valori per colonna. La matrice inversa di Leontief o “matrice dei moltiplicatori” permette di calcolare il valore della produzione di ogni settore attivata direttamente e indirettamente da un euro di domanda finale che si rivolge a ciascun settore. Il moltiplicatore keynesiano è disaggregato in settori.Limiti:
1) Rendimenti costanti.2) Assenza di progresso tecnico.3) Se la si utilizza a livello regionale la matrice deve essere suddivisa in flussi intra e interregionali.
La dotazione fattorialeLe teorie neoclassiche di crescita locale e le teorie del commercio interregionale concepiscono l’offerta come motore dello sviluppo e la dotazione fattoriale come fonte della competitività. Introduciamo il lungo periodo. Per esportare si deve godere di qualche vantaggio competitivo: prezzi bassi, qualità elevata o beni nuovi. La crescita non è più intesa come aumento dell’occupazione e del reddito ma come benessere individuale, raggiunto grazie ad incrementi della produttività fattoriale o alla specializzazione. Ancora una volta, dunque, ci confrontiamo con approcci ala crescita regionale, attenti a concepire uno spazio uniforme-astratto, che garantisce condizioni economiche identiche ovunque.
Crescita regionale e mobilità fattoriale: modello a un solo settore produttivoFormulato da Borts & Stein, questo modello presenta le tradizionali ipotesi di un modello di crescita neoclassico: perfetta concorrenza, piena occupazione, perfetta mobilità dei fattori produttivi, immobilità dei beni, sostituibilità tra capitale e lavoro. Attraverso la funzione Cobb-Douglas a rendimenti costanti, la possibilità per il reddito di crescere dipende dalla crescita del progresso tecnico e dalla crescita del capitale e del lavoro. In assenza di progresso tecnico, la produttività del lavoro può solo aumentare se la crescita del capitale la eccede. Lo stato stazionario è garantito quando il tasso di crescita del capitale uguaglia quello del lavoro. Secondo i neoclassici, la crescita è una questione di ottima allocazione delle risorse: data la perfetta mobilità dei fattori produttivi, essi si spostano dove è più elevata la loro produttività, attratti da maggiori remunerazioni. Data una regione ricca (nord) e una povera (sud), il lavoro si sposterà dalla regione povera a quella ricca e il capitale farà il contrario, sino a far uguagliare la ricchezza delle due regioni: l’equilibrio coincide con il punto in cui il tasso di crescita del rapporto capitale/lavoro è nullo.
Il modello a due settori
L’evidenza empirica sembra non confermare la precedente conclusione. Si passa così a ipotesi più realistiche: Esistenza di due regioni, in ognuna delle quali sono presenti due settori:
o Manifatturiero, ad alta produttività che esporta.o Agricolo, a bassa produttività che non esporta.
Esistenza di squilibri nella bilancia commerciale. Concorrenza perfetta. Rendimenti costanti. Remunerazione alla produttività marginale.

Massimizzazione del profitto.Partendo da una situazione di equilibrio iniziale, il modello mostra le variazioni nei tassi di crescita delle due regioni, qualora sia ipotizzato uno shock esogeno (ricorda la teoria della base d’esportazione: una domanda esterna è fonte di crescita):
Lo stock di capitale nel settore che produce per l’esportazione aumenta. La domanda di lavoro aumenta e attrae lavoratori sia dal settore agricolo sia dall’altra regione. Il settore agricolo registra un aumento della domanda del bene e, di conseguenza, della produzione e
dell’occupazione.La crescita della produzione in questo modello appare dunque come il risultato di un’allocazione delle risorse più efficiente verso il settore manifatturiero, a maggior produttività.Conclusioni:
1) La mobilità di entrambi i fattori produttivi avviene verso la stessa regione.2) C’è divergenza nei tassi di crescita del reddito tra regioni.
Considerazioni critiche sull’approccio neoclassicoLe regioni ricche hanno forte capacità di attrarre lavoro, ma al contempo rischiano di perdere competitività a causa dei rendimenti decrescenti che accompagnano un utilizzo intensivo delle risorse. Le regioni deboli hanno vantaggi localizzativi nel salario relativo e nel costo del lavoro. Tuttavia, la persistenza di forti squilibri lascia intendere che questi vantaggi non siano sufficienti: le aree forti trovano il modo di superare i rendimenti decrescenti. L’ostacolo più appariscente risiede nei costi economici e psicologici che accompagnano la mobilità delle risorse, ipotizzati nulli.Le economie di agglomerazione giustificano la tendenza delle imprese ad investire sempre nelle regioni ricche, già dotate di capitale. Inoltre, la migrazione risulta spesso selettiva: coinvolge i lavoratori più qualificati e ciò priva l’area debole delle risorse più efficienti. Secondo Vera Lutz, aumenti salariali concentrati in aree forti, imposti dal sindacato, creano un dualismo salariale. L’area forte reagisce riducendo i lavoratori e facendo ricorso a tecnologie più avanzate. La persistenza in fasi di sottosviluppo può essere ben spiegata dalla presenza di elementi istituzionali e sociali che limitano la mobilità delle risorse. Infine, in presenza di tecnologie differenti, un uguale rapporto capitale/prodotto tra regioni non è garanzia di un uguale livello di produzione.
Specializzazione e vantaggio comparato: il modello classico di RicardoBisogna stare attenti a considerare la specializzazione quale determinante dello sviluppo di una regione, confrontando considerazioni a livello nazionale e regionale. Le regioni (e le nazioni) scambiano tra loro i beni sulla base di un vantaggio comparato e non di un vantaggio assoluto: una regione può essere inefficiente nella produzione di tutti i beni rispetto al resto del Paese, ma può comunque essere relativamente meno inefficiente nella produzione di un bene rispetto agli altri beni, specializzandosi in quella produzione.Questo risultato è noto come il paradosso di Torrens-Ricardo, derivante dalle assunzioni del modello David-Ricardo:
2 regioni 2 beni. 1 solo fattore produttivo con produttività differenti in differenti regioni. Assenza di rendimenti crescenti o decrescenti: costi marginali costanti. Perfetta mobilità interna, immobilità esterna. Baratto.
Il Sud produce in maniera inefficiente. In una logica di vantaggio assoluto, non esisterebbe ragione per la quale il nord debba procedere a scambi di beni più cari con il sud. Ricardo, però, confronta i costi comparati o costi opportunità e così ogni regione è portata a produrre un unico bene: quello nel quale gode di un vantaggio comparato. Il risultato è che le regioni sono in grado, indipendentemente dalla loro reale capacità produttiva, di ottenere sempre un ruolo nel mercato. Si tratta, infatti, di un risultato paradossale e, come vedremo, le regioni competono sul vantaggio assoluto. Il risultato di Ricardo era talmente ridicolo che subito fu accettato e inserito tra le teorie regionali.
La teoria delle dotazioni fattoriali: il modello neoclassico di Heckscher-OhlinNel 1933, Ohlin formula un modello sulla base dell’immobilità dei fattori produttivi (opposto al modello neoclassico), evidenziando le fonti delle diverse produttività fattoriali delle regioni, date per esogene nel modello ricardiano. Il modello dimostra che ad ogni regione converrà specializzarsi nelle produzioni che fanno più intenso uso del fattore produttivo più abbondante nell’area, perché generano costi inferiori.Ipotesi:
2 regioni 2 beni 2 soli fattori (capitale e lavoro). Ogni bene richiede una diversa intensità fattoriale. I fattori produttivi sono qualitativamente identici, ma presenti in quantità differenti. Le funzioni di produzione sono uguali nelle 2 regioni (per evitare il paradosso di Ricardo).

Concorrenza perfetta. Stesse condizioni di domanda. Immobilità dei fattori produttivi. Economia aperta e commercio libero.
Al Nord manca il lavoro e abbonda il capitale (viceversa al Sud), quindi si produrrà facendo più ricorso al secondo. Al Sud conviene specializzarsi nella produzione del grano (labour intensive), al Nord nell’acciaio (capital intensive). Si assiste così ad un processo di aggiustamento e riallocazione dei fattori produttivi: il Nord sposterà risorse dalla produzione del grano a quella dell’acciaio (viceversa al Sud). Il risultato è l’uguaglianza dei prezzi relativi dei beni.Ciò viene confutato da Leontief (poi anche Moroney & Walker) negli anni ’50, dimostrando che i settori di esportazione degli USA, Paese a maggior intensità di capitale, hanno in realtà un’elevata intensità di lavoro. Anche la realtà empirica italiana degli anni ’60-’90 dimostra il contrario.Spiegazioni del paradosso:
1) La prima spiegazione dei paradossi di Ohlin risiede nel fatto che, come Leontief stesso fece notare, non si può considerare il fattore lavoro come omogeneo (il lavoro qualificato giustifica la specializzazione).
2) Non considera il progresso tecnico: le innovazioni possono generare ampi vantaggi.3) Infine, con riferimento al caso italiano, vanno ricordati gli investimenti pubblici al Sud.
Il modello, concludendo, così come formulato, anche se spiega il benessere derivante dalla specializzazione, non è in grado di definire un processo di crescita regionale.
Vantaggio assoluto e vantaggio comparatoNella regione con produttività più elevata è logico attendersi che i salari siano più elevati, generando un divario con l’altra regione. Anche ipotizzando che il salario monetario sia mantenuto artificialmente alto al Sud, il Nord produrrebbe tutto e si troverebbe in più che piena occupazione, mentre il Sud non produrrebbe niente, e avrebbe problemi di disoccupazione e un deficit continuo nella bilancia dei pagamenti. La conclusione è che, in presenza di regioni più efficienti in assoluto di altre, le condizioni di squilibrio sono destinate a perdurare nel tempo, in quanto i puri meccanismi riequilibratori macroeconomici, che a livello nazionale sembrano tutelare la competitività relativa dei territori, a livello regionale o non esistono o non funzionano.