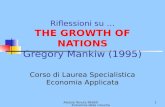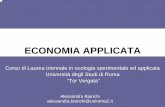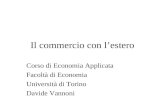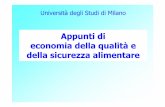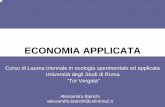economia applicata - users.unimi.itusers.unimi.it/banterle/pdf/economia_applicata.pdf ·...
Transcript of economia applicata - users.unimi.itusers.unimi.it/banterle/pdf/economia_applicata.pdf ·...

1
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Economia applicata
Appunti delle lezioni a cura di A. Banterle
Laurea in Dietistica
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Prof. Alessandro Banterle
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi – DEMM
Università degli Studi di Milanovia Celoria 2 - 20133 [email protected]
02-50316482orario ricevimento: martedì dalle 15 alle 18
Milano2012

2
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Programma del corsoObiettivi• apprendere i principali elementi di teoria economica per l’analisi del
mercato alimentare• conoscere alcune problematiche attuali dei consumi alimentari
Articolazione
• definizione di economia e classificazione della scienza economica• i principi base della teoria della domanda• l’evoluzione della teoria dei consumi (modelli di Lancaster, Becker e
Grossman)• i principi base della teoria dell’impresa• ricavi, costi fissi e variabili, profitto• le principali forme di mercato e le strategie di differenziazione• l’analisi economica dei consumi alimentari• aspetti economici dell’obesità
TestoMariani A. e Viganò E. (a cura di) (2002): Il sistema agroalimentare
dell’Unione europea, Carocci, Roma (cap. 1 -
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• La scienza economica si occupa del modo in cui la società umana affronta il problema della scarsità delle risorse scelte efficienti in relazione alle scarse risorse di individui e società nel loro complesso (Begg, Fischer, Dornbusch, 2001)
• L’economia è lo studio del modo in cui le societàutilizzano risorse scarse per produrre beni utili e di come tali beni vengono distribuiti tra i diversi soggetti (Samuelson, Nordhaus, 2002)
Oggetto dell’Economia

3
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Scienza economica ed economia agro-alimentare
economia politica
bilancioeconomia aziendale organizzazione
strategia --> marketing
teoria della domandamicroeconomia teoria dell’offerta
teoria dei mercati
macroeconomia
economia applicataagraria, agro-alimentare, industriale, ambientale, regionale, del turismo, degli intermediari finanziari, ecc.
politica economica
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

4
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
I principi base della teoria della domanda
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Domanda individualeyi = f (pi, pj, R, pr)
doveyi = quantità domandata del bene i; pi = prezzo del bene i; pj = prezzo di beni sostituti; R = reddito del consumatore; pr = preferenze qualitative
yi = f (pi)
variazione % della quantità domandata dy p• elasticità = = *
variazione % del prezzo dp y• i prodotti alimentari sono beni di prima necessità• per i prodotti alimentari generalmente l’elasticità è bassa (<1,
domanda rigida) alla diminuzione del prezzo la quantitàaumenta in modo meno che proporzionale
• la domanda è più rigida per i prodotti prossimi al livello di saturazione

5
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Domanda individualeyi = f (R)
variazione % della quantità domandata• elasticità al reddito =
variazione % del reddito
• per i prodotti alimentari (beni di prima necessità) l’elasticitàrispetto al reddito è bassa all’aumento del reddito la quantità aumenta in modo meno che proporzionale
• all’aumento del reddito cresce la domanda di beni non alimentari si riduce l’incidenza percentuale dei consumi alimentari sui consumi complessivi
• con lo sviluppo economico si riduce negli anni il peso percentuale dei consumi alimentari, ma cresce il valore assoluto
• la rigidità della domanda rispetto al reddito comporta una stabilità dei consumi nel medio periodo
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Domanda individualeRelazione quantità domandata di un bene - prezzo del
bene
Relazione quantità domandata di un bene - reddito del consumatore
y
p
p2
p1
y1 y2
R
y
Curva di Engel
y
p

6
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Teoria della domanda
Domanda individuale− yi = f (pi, pj, R, pr)− yi = f (pi) --> elasticità− yi = f (pj)− yi = f (R) --> R = p1 * y1 + p2 * y2
− yi = f (pr) --> qualità del prodotto --> attributi del prodotto
Domanda aggregata− domanda individuale --> Σ yi
− caratteristiche socio-demografiche
y
p
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
L’evoluzione della teoria dei consumi

7
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Razionalità del consumatore Il consumatore è un individuo razionale e quindi cerca di massimizzare la sua utilità; ciò significa che in base al reddito a disposizione egli sceglie il bene che gli fornisce la massima utilità.
Nel modello neoclassico, il reddito è considerato come unico vincolo all’attività di consumo e, in generale, le variabili economiche tradizionali (prezzo e reddito) rappresentano i fattori determinanti nella struttura decisionale del processo di acquisto.
Trasparenza del mercato Il consumatore è perfettamente in grado di riconoscere l’utilità che un determinato prodotto genera e, inoltre, conosce esattamente tutte le possibili alternative di scelta; conosce quindi chi produce tale bene e a che prezzo (perfetta conoscenza della domanda e dell’offerta). Questo è un presupposto fondamentale perché il consumatore possa essere razionale nelle sue scelte.
I principi fondamentali della TEORIA NEOCLASSICA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Principio dell’utilità marginale decrescente Nel consumo di una unità in più del prodotto, aumenta l’utilità totale. Tuttavia, l’utilitàmarginale dell’ultima dose è inferiore dell’utilità marginale fornita dal consumo della penultima dose. All’aumentare del consumo l’utilità aumenta sempre, però con incrementi sempre minori (es. il consumo del secondo panino aumenta la mia utilità, ma in misura inferiore dell’aumento di utilitàottenuto con il consumo del primo panino). Quindi, all’aumentare della quantità: => aumenta l’utilità totale (con incrementi sempre minori);
=> diminuisce l’utilità marginale.
Omogeneità Tutti i consumatori sono uguali (stessi gusti), quindi si comportano nel medesimo modo (comprano le stesse cose), e non ci sono differenze di qualità tra i prodotti.
I principi fondamentali della TEORIA NEOCLASSICA

8
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Questo approccio è valido anche per il consumatore di prodotti alimentari?
Il consumatore è poco razionale Non necessariamente egli massimizza il suo budget iniziale acquistando il prodotto che gli conferisce la massima utilità. Molte volte non viene acquistato il prodotto per lui più conveniente, ma la scelta può essere influenzata da altri fattori (gusto, aspetto nutrizionale, convenienza)
Il prodotto alimentare è un prodotto composito Contiene una moltitudine di servizi (proprietà/caratteristiche) e il consumatore non ha la piena conoscenza di tutte le alternative possibili. Possiamo parlare di un prodotto la cui utilità possiamo valutarla a pieno solo dopo il consumo. Quelle che vengono acquistate sono aspettative o informazioni.
I principi fondamentali della TEORIA NEOCLASSICA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il principio dell’utilità marginale decrescente Il concetto che all’aumentare della quantità diminuisce l’utilità marginale vale anche per il consumatore di prodotti alimentari
Il principio dell’omogeneità Questo principio non vale per il mercato di prodotti alimentari. Innanzitutto non è vero che non esistono differenze qualitative tra i diversi prodotti ed in secondo luogo i consumatori non si comportano tutti nel medesimo modo. Proprio perché si tratta di prodotti compositi ogni consumatore può scegliersi il prodotto con sotto caratteristiche che piùmassimizzano la sua utilità.
I principi fondamentali della TEORIA NEOCLASSICA

9
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Modern Consumer Theory
Abbiamo visto che uno dei principali motivi per cui la teoria neoclassicanon è applicabile alla realtà dei prodotti alimentari è dato dal fatto che il principio dell’omogeneità, secondo il quale tutti i consumatori si comportano nel medesimo modo e non ci sono differenze qualitative tra i prodotti, non trova una conferma pratica.
Kelvin John Lancastereconomista inglese degli anni ’60, ha rielaborato il modello neoclassico del consumo, cercando di introdurre le differenze di qualità fra i prodotti introduce quindi la eterogeneità dei prodotti.
L’utilità non si esprime in termini di quantità di prodotto, bensì in termini di quantità di caratteristiche del prodotto.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Teoria neoclassica: il consumatore massimizza la quantità di prodottoacquistabile con il proprio reddito
Modello di Lancaster
il consumatore massimizza la quantità di caratteristiche che egli è in grado di acquistare con il proprio reddito. Ciò significa che il consumatore per massimizzare la sua utilità non valuta i beni, ma le singole caratteristiche degli stessi, scegliendo quel prodotto che presenta la combinazione di attributi che gli fornisce la maggiore soddisfazione.
Nonostante l’estensione della teoria, l’analisi del consumo rimane comunque d’impronta neoclassica: massimizzare l’utilità sotto un certo vincolo di bilancio.
Modern Consumer Theory

10
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
New household Economics
Gary Becker per primo sviluppò un approccio teorico per lo studio dell’unità familiare noto come la New Household Economics(NEH).
Secondo tale approccio, il soggetto non agisce individualmente ma collettivamente, nella comunità familiare. In questa teoria il
nucleo familiare è considerato una ‘small factory':
Trasforma input output (paniere finale di beni – beni Z) in grado di max l’utilità di tutti i soggetti
I beni, singoli o combinati, sono gli input e le loro caratteristiche o combinazioni di caratteristiche sono gli output
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Cosa sono gli INPUT:•numero di beni acquistati sul mercato, (la cui quantità/qualità è decisa in funzione del reddito,•tecnologie (gli strumenti che la famiglia ha a disposizione per il proprio lavoro), •capitale umano (inteso in termini di risorse non economiche), •non-working time, ovvero il tempo che resta a disposizione escludendo le ore di lavoro.Cosa sono gli OUTPUT: ‘commodities’ - rappresentano le preferenze dei
componenti della famiglia e sono il mezzo per il raggiungimento dell’utilità.
Un bene in quanto tale non produce utilità: sono le sue caratteristiche, una volta che siano valorizzate, o espresse, attraverso la tecnologia di consumo, a produrre l’utilità. Negli esempi fatti da Becker, i beni Z sono beni non commerciabili che includono i bambini, il dormire, la salute, attività ricreative ecc. La famiglia sceglierà poi la migliore combinazione di allocazione delle risorse per produrre nel miglior modo possibile tali beni.
New household Economics

11
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Esempio funzione produttiva fasi di preparazione di un pasto.
INPUT materie prime alimentari acquistate dalla famiglia (compatibilmente con il proprio reddito)
trasformate tramite l’uso dei vari utensili da cucina a disposizione della famiglia (che rappresentano le tecnologie).
OUTPUT pasto preparato - bene Z
Per la preparazione però, è necessario che la famiglia disponga di un altro input TEMPO
New household Economics
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il tempo costituisce un input fondamentale, e prende parte in diversi modi alla funzione di produzione:
Nella household economics le attività produttive sono influenzate principalmente da due fattori:
il vincolo di bilancio e il vincolo di tempo.
risorsa necessaria al
momento dell’acquisto
materie prima durante la
preparazione
consumo del pasto
reddito della famiglia che inevitabilmente condiziona sia la tipologia che la quantità dei beni
acquistabili
il tempo è inteso come “non-working time”, ovvero il tempo
di non- lavoro.
New household Economics

12
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Becker affida al TEMPO un ruolo determinante all’interno del suo modello produttivo, infatti considera contemporaneamente il tempo
come un input per la household production e come un limite alle attività che la famiglia può svolgere.
In altri termini, se da un lato il tempo è un fattore di produzioneindispensabile per qualsiasi attività produttiva, dall’altro (essendo una
risorsa scarsa), costituisce un vincolo, poiché il tempo destinato ad un’attività viene indirettamente sottratto allo svolgimento di un’altra
che potrebbe ugualmente accrescere l’utilità finale della famiglia.
Ad esempio in presenza di un vincolo di tempo la famiglia potrebbe essere portata a scegliere di preparare pietanze poco elaborate o addirittura a consumare prodotti già pronti in modo da risparmiare
giornalmente delle ore che potrebbero essere dedicate ad altre attività.
New household Economics
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Fino ad ora si è parlato della household production come di una funzione di utilità comune, senza però tenere conto del fatto che le caratteristiche individuali e le differenti preferenze dei vari componenti della famiglia potrebbero generare dei conflitti di
interesse.
Se così fosse il modello della household economy avrebbe dei risvolti fallimentari, dal momento che ognuno sarebbe portato ad
agire in maniera opportunistica per massimizzare la propria soddisfazione a discapito dell’utilità collettiva. Per questa ragione Becker immagina che all’interno della famiglia vi sia un soggetto in grado di gestire autonomamente le risorse della collettività e di
ridistribuirle con lo scopo di appagare le esigenze di ognuno.
New household Economics

13
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Unico agente con obiettivo comune
La famiglia viene considerata come se fosse un unico agente in cui tutti i suoi membri prendono congiuntamente le decisioni e
massimizzano la stessa funzione di utilità.
Formalmente, preferenze differenti ed un complesso apparato di relazioni e scambi all’interno delle unità familiari vengono unificate
in una funzione obiettivo comune (o funzione della famiglia), analoga a quella di un responsabile unico delle decisioni.
Poiché l’aggregazione di preferenze e di gusti individuali in un’unica funzione di utilità è problematica dal punto di vista della teoria neoclassica, Becker la giustifica assumendo che l’unità familiare sia gestita da una sorta di “capo benevolo” che opera nell’interesse di tutti.
New household Economics
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Allocazione delle risorse
Un’altra ipotesi scaturisce dal processo decisionale di allocazionedelle risorse. Secondo tale ipotesi, tutte le risorse della famiglia (reddito, capitale, lavoro, terra, ecc) entrano a far parte di un fondo comune che, il “capo benevolo” dovrà allocare tra i componenti della famiglia al fine di massimizzare una funzione obiettivo comune.
Formalmente, le decisioni di consumo e di spesa sono prese sullabase di un singolo vincolo di bilancio e di tempo, e la soluzione del problema di ottimizzazione darà luogo a funzioni di domanda che dipendono unicamente da variabili esogene come i prezzi ed il reddito totale della famiglia.
New household Economics

14
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
L’aspetto innovativo di Becker è quello di aver inserito la variabile tempotra i fattori esplicativi della domanda.
Il tempo e il capitale rappresentano per Becker i fattori di produzione.
Secondo Becker, beni e servizi acquistati al mercato sono combinati con gli input domestici, principalmente il tempo di lavoro, per produrre un paniere di beni di base, detti beni Z.
Il vantaggio principale che, secondo questa teoria, si ottiene dalla household production è, appunto, la soddisfazione di tutti i componenti della famiglia, che stando insieme possono produrre in maniera piùefficiente ed avere così un maggior guadagno individuale (Becker, 1965).
New household Economics
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Modello di Grossman
hanno come scopo comune quello di raggiungere o mantenere un buono stato di salute
A partire da tali considerazioni, Michael Grossman nel 1972 utilizzò la funzione di produzione alla base della household economy per studiare la domanda di salute e le variabili in grado di influenzarla. Grossman considera la salute come un bene di cui ciascun individuo è dotato alla nascita e che è soggetto ad un inevitabile deprezzamento nel tempo a causa dell’età e dello stile di vita. Tale deprezzamento può essere compensato o ripristinato attraverso opportuni investimenti ed in particolare tramite l’acquisto di prestazioni sanitarie.
Molte delle decisioni prese all’interno di una famiglia, ed in particolare la scelta del regime alimentare, il tempo da dedicare all’attività fisica, alla preparazione dei pasti, alle cure personali, e le risorse da destinare alle spese mediche…

15
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Grossman analizza la salute al pari di una semplice variabile economica che nella funzione di produzione della famiglia rappresenta l’utilità comune dei singoli componenti.
utilizzato in modo generico e non si riferisce esclusivamente all’acquisto di cure mediche (quali ad esempio medicinali o interventi chirurgici), ma anche all’investimento del proprio non-workingtime a tutte quelle attività che, come l’esercizio fisico, hanno un impatto positivo sulla salute.
Il termine SALUTE
Modello di Grossman
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
In questo modello, come nella household economy di Becker, il raggiungimento dell’utilità è subordinato alle risorse materiali disponibili, e al tempo di non lavoro investito per la sua produzione.
Lo stock di salute di cui un individuo dispone in un determinato momento può quindi essere visto come l’output di una funzione di produzione, i cui input sono rappresentati, ad esempio, dal tempo investito in cure mediche, dal tipo di alimentazione, dallo stile di vita e dal tempo dedicato all’attività fisica.
La morte secondo Grossman, sopraggiunge quando lo stock si deprezza tanto da scendere al di sotto di un limite soglia. Per questa ragione ogni individuo deve amministrare le proprie risorse in modo da poter mantenere la salute ad un livello adeguato e secondo questa logica ognuno è in grado di determinare autonomamente la lunghezza della propria vita.
Modello di Grossman

16
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Da un punto di vista economico, la salute per il consumatore ha una duplice valenza.
•bene di consumo utilità diretta poiché permette di dedicarsi a diverse attività produttive, •bene di investimento utilità è di tipo indiretto e deriva dalla diminuzione dei giorni di malattia che riducono le giornate lavorative e di conseguenza generano disutilità.
Essere in salute trarre la massima soddisfazione da tutte le attivitàproduttive: avere energie sufficienti per lavorare e dalle ore di lavoro dipende l’ammontare del reddito; essere maggiormente efficienti nelle attività domestiche, apprendere con maggiore profitto, godersi a pieno tutte le attività ricreative e così via.
Modello di Grossman
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un’altra attività che, secondo Grossman, è in grado di influenzare la domanda di salute è l’informazione. Una persona informata conosce, ad esempio, gli effetti che l’alimentazione ha sulla salute, e può compiere scelte alimentari più salutari e ridurre il rischio di malattia.
Per raggiungere tale obiettivo è necessario che l’individuo investa il proprio tempo di non lavoro nell’attività di ricerca delle informazioni e nel caso dei prodotti alimentari alla lettura delle etichette. L’etichettatura può infatti essere considerata come lo strumento adatto ad apprendere le caratteristiche degli alimenti, ma la sua efficacia èsubordinata al tempo dedicato alla lettura.
Il tempo dedicato ad arricchire la propria knowledge nutrizionale Grossman lo investe come un vero e proprio investimento in salute e a partire da tale considerazione è facile comprendere quale sia l’importanza del tempo nel determinare il comportamento di acquisto.
Modello di Grossman

17
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il comportamento di acquisto
Il consumatore può massimizzare la propria utilità scegliendo i prodotti che maggiormente rispecchiano le sue preferenze, compatibilmente con il proprio reddito e il vincolo di tempo.
2°consumatore la soddisfazione è data da una dieta sana che consenta di mantenersi in salute
non si sofferma a valutare le caratteristiche nutrizionali di ciò che compra, piuttosto sceglie utilizzando le sue preferenze sensoriali come unico criterio, il consumatore non ha bisogno di fare altre valutazioni riguardo al prodotto e il tempo necessario per la scelta è minimo.
1°consumatore l’utilità finale èdata dalla gratificazione diretta che si ottiene dal consumo di un alimento e quindi connessa principalmente al suo sapore
forte attenzione nei confronti della dieta, legge le informazioni riportate in etichetta, queste considerazioni implicano un maggior dispendio di tempo per poter decidere quale prodotto tra quelli accessibili è il più adatto al raggiungimento della propria soddisfazione.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Questi due modelli di comportamento sono determinati da un personale criterio di preferenza che
in letteratura viene definito “time preference”
Tale espressione si riferisce alla misura in cui una persona è disposta a sostituire un’attività che comporta un immediato beneficio con un’altra, che invece comporterebbe un beneficio per il futuro. Il consumatore disposto ad impegnare parte del suo tempo per la lettura delle etichette non trae un vantaggio immediato dall’acquisizione di informazioni, ma il suo comportamento gli sarà utile in futuro per compiere scelte alimentari più salutari e mantenersi in buona salute. Al contrario, l’acquisto di un alimento in base alle sue caratteristiche sensoriali comporta un’utilità immediata, ma non tiene conto delle conseguenze negative che un’alimentazione poco equilibrata potrebbe avere alla lunga sullo stato di salute.
Il comportamento di acquisto

18
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Nell’ultimo decennio ritmi imposti dal lavoro e dai sempre piùnumerosi impegni della vita quotidiana, hanno contribuito ad
accrescere notevolmente il valore del tempo.
Per andare incontro alle esigenze dei consumatori il progresso tecnologico ha messo a disposizione molti strumenti in grado di facilitare le attività domestiche e ridurre il tempo necessario alla cura della casa e alla preparazione dei pasti, e in modo parallelo si è assistito ad una progressiva riduzione del dispendio energetico giornaliero.
Proprio questo viene considerato uno dei fattori che può spiegare in chiave economica l’ aumento dei tassi di sovrappeso e obesità.
Il comportamento di acquisto
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il problema dell’allocazione del tempo è determinante non soltanto nella scelta dei prodotti da acquistare, ma in modo indiretto, anche sullo stato di salute. Il tempo è un input fondamentale in tutti i momenti connessi all’acquisto e anche al consumo di cibo: serve tempo per fare la spesa, per scegliere con criterio un alimento invece di un altro, per cercare e leggere le informazioni in etichetta, per comprenderle e rielaborarle,
per preparare il pasto e infine anche per consumarlo.
Il consumatore è obbligato a dedicare il proprio non-working timesoltanto ad alcune di queste attività, sacrificandone altre che potrebbero potenzialmente contribuire alla sua funzione di utilità.
E’ stato dimostrato che generalmente i consumatori reagiscono allostress dovuto alla mancanza di tempo mettendo in atto alcune strategie per ridurre il costo delle attività in termini di ore e riallocare il tempo in modo da poter comunque raggiungere la soddisfazione.
Il comportamento di acquisto

19
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
I principi base della teoria dell’impresa
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Concetto di impresaimpresa
processoinput output
fattori di produzione produttivo prodotticreazione di valore
input• capitale fisso
– macchine– impianti
• capitale circolante --> MP– cereali– latte– carne– olive– uva– ecc.
• lavoro
processo
produttivo
output
• pane, prodotti dolciari, pasta
• prodotti lattiero-caseari
• carne, salumi, conserve di carne
• olio• vino• ecc.

20
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Richiami di teoria dell’offerta(teoria dell’impresa)
Offerta individuale− produzione della singola impresa− obiettivo economico dell’impresa
--> max profittoricavi RT
Π
costi CTOfferta aggregata
− offerta individuale --> Σ qi
− numero delle imprese del settore e loro dimensione
q
p
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Obiettivo economico dell'impresa
• Teoria economica massimizzazione del profitto
max Π = RT - CT
max RT = p * q min CT = CF + CMeV * q
• p CF• q CMeV• mix produttivo
differenti strategie
• teoria aziendalistica max valore
• teoria manageriale max fatturato public company

21
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• MERCATOMERCATO - assenza di fallimenti
- unica forma di coordinamento (coordinamento gestito dal sistema dei prezzi)
• AGENTI AGENTI della filiera comportamento ideale
• IMPRESAIMPRESA mera funzione di produzione.““black box” (scatola nera) contenente tecnologie
atte a trasformare le risorse in output.
Approccio neoclassico
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Approccio neoistituzionale
••MERCATOMERCATO presenza di fallimenti
• AGENTIAGENTI della filiera - razionalità limitata
- conoscenza imperfetta
- comportamento opportunistico
• IMPRESAIMPRESA struttura coordinativa di governo“Il funzionamento del mercato comporta un certo costo e, formando
un’organizzazione e permettendo a un’autorità (imprenditore) di dirigere le risorse, possono essere risparmiati taluni costi di contrattazione”(Coase, 1973)
Costi di transazione
Incompletezza dei contratti

22
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Le principali forme di mercato
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il mercato
− libera concorrenza o concorrenza perfetta− monopolio− oligopolio concorrenza− concorrenza monopolistica imperfetta
qe
pIncontro tra domanda e offerta (tra consumo e produzione) nello spazio e nel tempo, reale e virtuale
pe
q

23
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Libera concorrenza
• Tipo di prodotto: omogeneo o non differenziato• numero di imprese: molto elevato --> struttura
atomistica• dimensioni delle imprese: piccole• influenza sulla quantità del mercato: no• influenza sul prezzo: no --> price taker• barriere all’entrata: basse• ruolo della pubblicità: molto limitato• condizioni di max Π --> RMa = CMa = p• variabile di decisione --> q• conoscenza perfetta
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Libera concorrenza
Nel modello di concorrenza perfetta non vengono considerati:
– la differenziazione– la concentrazione– l’innovazione fenomeno esterno
all’economia– la strategia d’impresa– l’asimmetria informativa fra produttore e
consumatore

24
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Libera concorrenza
P, CMa, CMe
q
CMa
CF
CVCTCT, RTRicavi RT
q1
p1
CMeT
CMeV
RT
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Monopolio
• Tipo di prodotto: omogeneo o non differenziato• numero di imprese: una• dimensioni delle imprese: molto grande• influenza sulla quantità del mercato: si• influenza sul prezzo: si --> price maker• barriere all’entrata: molto alte• ruolo della pubblicità: limitato• condizioni di max Π --> RMa = CMa• variabile di decisione --> q e p• inefficiente --> combattuto dalle leggi antitrust• esistono monopoli legali

25
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Oligopolio• Tipo di prodotto: omogeneo e differenziato• numero di imprese: molto poche • dimensioni delle imprese: grandi• influenza sulla quantità del mercato: si• influenza sul prezzo: si --> price maker• barriere all’entrata: alte• ruolo della pubblicità: importante• condizioni di max Π --> RMa = CMa• variabile di decisione --> q e p• quota di mercato QM = qi / QT * 100• teoria dei giochi• oligopolio omogeneo e differenziato• oligopolio collusivo
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Concorrenza monopolistica
• Tipo di prodotto: differenziato• numero di imprese: elevato• dimensioni delle imprese: piccole e grandi• influenza sulla quantità del mercato: si• influenza sul prezzo: si --> price maker• barriere all’entrata: medie• ruolo della pubblicità: molto importante• condizioni di max Π --> RMa = CMa• variabile di decisione --> q e p

26
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• caratteristiche intrinseche attributi qualitativi del prodotto• caratteristiche estrinseche etichetta, certificazione, ecc.• marchio
industriale• marchio inviduale
commerciale (private label)• marchio collettivo (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc.)
• pubblicità
fedeltà del consumatorepremium price
Differenziazione del prodotto
• prezzo• caratteristiche qualitative• costi di produzione CMeT• prezzo dei prodotti concorrenti• disponibilità a pagare del consumatore
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

27
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
L’analisi economica dei consumi alimentari
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Domanda aggregata• Domanda individuale --> Σ yi
• incremento demografico• distribuzione del reddito nella popolazione• distribuzione della popolazione per classi di età
domanda di beni alimentari
consumi extra domestici• risorazione commerciale -->
canale Horeca• ristorazione collettiva
consumi domestici• acquisto di prodotti
alimentari per uso domestico
caratteristiche• molto dinamici• in aumento rispetto al totale
dei consumi• elevata elasticità al reddito
caratteristiche• stabili in termini fisici• in calo rispetto al totale dei
consumi• ridotta elasticità al reddito

28
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
0
50000
100000
150000
200000
250000
Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati ISTAT
Consumi finali delle famiglie 1970‐2008 (mio euro a valori correnti)
Consumi delle famiglie domestici ed extradomestici 232,9 miliardiConsumi extradomestici 71,0 miliardi
Bevande e tabacco 33,7 miliardi
Generi alimentari 128,2 miliardi
La dinamica dei consumi alimentari
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
La dinamica reale dei consumi
‐
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Fonte: elaborazioni DEPAAA su dati ISTAT
Dinamica delle componenti dei consumi finali 1970‐2008 (mio euro concatenati 2000)
Consumi delle famiglie domestici ed extradomestici
Consumi extradomestici
Bevande e tabacco
Generi alimentari
+37%
+29%
+163%
+59%

29
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Dinamica relativa dei consumi
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
% s
ulla
spe
sa d
elle
fam
iglie
% di spesa delle famiglie per alimentazione
% Servizi di ristorazione
% Bevande
% Alimentari
45% -
40% -
35% -
30% -
25% -
20% -
15% -
10% -
5% -
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Fonte: INEA 2011

30
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Fonte: INEA 2011
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
CONSUMI ITALIANI DEI PRINCIPALI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI (Kg/anno per persona)
1951 1961 1971 1981 1990 2000Frumento 161,2 159,6 174,2 168,7 160 162,3Risone 7,8 8 6 6,8 7,2 8,8Frutta fresca 56,7 90,3 119,3 110,7 132,1 152,7Ortaggi 106,6 169 192,6 204 218,4 215,3Carni 16,5 30,7 66,8 74 83,3 79,8 -bovine 6,6 14 25,2 25,2 26,2 - -suine 4,4 6,4 11,9 21,2 26,9 -Latte 48,1 61,6 69,5 83,5 79,4 82,9Formaggi 6,4 9 10,6 14,5 16,1 18,6Grassi vegeta 7 13,2 21,5 21,1 25,6 27Olio d'oliva 5 9 11,2 10,6 12,1 -Olio di semi 2 4,2 10,3 10,5 13,5 -Vino (000 hl) 141,6 108,2 112,4 92,5 60,5 55,1Birra (000 hl) 3 6,1 12,1 17,6 23,5 25fonte: Istat, Annuario Statistico
Dipartimento di Economia e Politica Agraria,Agro-alimentare e Ambientale

31
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Aspetti economici dell’obesità
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
IntroduzioneL’obesità viene oggi descritta da diversi autori come un
fenomeno di carattere epidemico.
Negli ultimi venti anni si è verificato un rapido aumento del numero degli individui in sovrappeso o obesi determinando un nuovo grave problema di
salute pubblica dei nostri tempi.
La gravità del problema è destinata a peggiorare sia nei paesi industrializzati (Nord America ed Europa), che in quelli in via di sviluppo
(Cina, India, Sud America), con importanti conseguenze in termini di politica economica e sanitaria.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che, nel 2015, le persone in sovrappeso saranno 2,3 miliardi, ed oltre 700 milioni quelle obese.
Misura dell’OBESITÀ Livelli di BMI (Peso/Altezza 2)

32
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
La prevalenza obesità e grande obesità appare piùcontenuta nella nostra popolazione nei confronti di
Paesi ad analogo sviluppo economico.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un pò di dati..... nel Mondo
300 milioni di obesi e 1 miliardo di persone in sovrappeso

33
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un pò di dati..... in UE
0
5
10
15
20
25
30
Austria
Belgium
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
FranceGermany
Greece
Hungary
Ireland
ItalyLatvia
Lithuania
Luxembourg
MaltaNetherlands
PolandPortugal
Slovakia
Slovenia
SpainSweden
Great Britain
UE-15UE- 25
(%) 1997
2004
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un pò di dati..... in Italia
• Le statistiche indicano in Italia un tasso di obesità in etàadulta di circa il 10%.
• Il dato italiano inferiore rispetto a quello di altri paesi europei.
• Dualismo geografico fra i tassi di obesità nelle regioni meridionali, i più elevati, e quelli delle regioni settentrionali.

34
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
La problematica
In Italia l’obesità ha un costo sociale annuo di 23 miliardi euro
OBESITÁè un problema individuale frutto di una scelta razionale (MODELLO NEOCLASSICO)
è il risultato di scelte di consumatori scarsamente informati e ignari di quelle che potrebbero essere le conseguenze di scelte errate sulla loro salute (MODELLO NEOISTITUZIONALE)
COSTI DIRETTI
gravano sulla società e sono conseguenti alla richiesta di risorse necessarie per la diagnosi e la cura dell’obesità e delle malattie correlate all’obesità (2 – 8% della spesa sanitaria complessiva).
COSTI INDIRETTI
sono determinati dalle perdite di produttività (minore capacitàlavorativa, maggiore assenteismo sul lavoro, pensioni di invalidità, morte prematura) (3-4% sui costi sanitari complessivi).
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un fallimento del mercato
raccordo tra la domanda e l’offerta
L’intervento pubblico in situazioni di possibili fallimenti del mercato è di norma vantaggioso, proprio al fine di eliminare questo divario tra costo privato e costo sociale e riportare il mercato all’equilibrio
L’equilibrio del mercato
se il soggetto in soprappeso o l’obeso determina una spesa sanitaria per la società, e se questa spesa sanitaria non è pagata dal soggetto, questo implica un’ esternalità negativa, ossia delle disutilità che il soggetto procura a terzi.
FALLIMENTO DEL MERCATO

35
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Quali le possibili cause?Predisposizioni costituzionali che facilitano l'aumento di peso.In seguito ai cambiamenti delle società da rurali a urbane il dispendio energetico è in costante calo a causa dell’innovazione tecnologica che ha profondamente modificato le caratteristiche (e il costo energetico) dell’attività lavorativa e degli spostamenti.La rivoluzione tecnologica nella preparazione di cibi su scala industriale (il sottovuoto, congelamento) un abbassamento della qualità.
Come risultato di queste innovazioni tecnologiche, allora la convenienza e i cibi pre- cotti sono cresciuti: questi prodotti presentano un’elevata densità calorica e non saziano l’appetito, inducendo a mangiare maggiori quantità e introdurre più calorie
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Informazione e conoscenza. Gli individui dovrebbero fare le loro scelte a proposito del consumo tenendo conto di massimizzare la loro utilità a lungo termine. C’è incertezza, invece, a proposito di quelli che sono i risultati a lungo termine rispetto a quelli che sono i sacrifici a breve termine: gusto, costi e convenienza. I consumatori che non si sanno limitare agiscono in maniera miope non tenendo conto del lungo termine.
Cause psicologiche. Si può affermare che il soggetto obeso ha sviluppato una dipendenza da cibo, per molti aspetti (anche fisiologici) simile ad altri tipi di dipendenza come l'alcolismo o il tabagismo. La dipendenza da cibo può essere ancora più difficile da affrontare rispetto alle dipendenze "classiche", e non vi è alcuna difficoltà nell'approvvigionamento di tale sostanza. Il "motore" psicologico può essere più o meno determinante nell'origine della malattia, mentre è quasi sempre la causa principale della sua cronicizzazione

36
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Recentemente l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha fissato i nuovi criteri che permettono di classificare l’obesità in base al BMI (body mass index o Indice di Massa Corporea).
Come misurare i tassi di obesità
Situazione peso BMI
sottopeso < 18,5
normopeso Da 18,5 a 24,9
sovrapeso Da 25 a 29,9
obeso Da 30 a 34,9
gravemente obeso Da 35 a 39,9
patologicamente obeso >40
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Diverse sono le variabili che vengono analizzate in letteratura:il genere, l’età, il reddito, il titolo di studi, occupazione,numero dei componenti familiari,dieta,fumo,attività fisica,la distribuzione geografica,
……e molte altre che sembrano essere correlate con questa patologia.
Quali sono le variabili socio-economiche che incidono su questa patologia

37
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un’indagine in Lombardia
Analisi mediante questionario telefonico realizzato ad hoc;Campione formato da circa 1000 consumatori lombardi statisticamente
significativo;Modello econometrico utilizzato: BINARY LOGISTIC REGRESSIONBINARY LOGISTIC REGRESSIONVariabile dipendente BMI variabile binaria (assume valori 0 e 1)
- sovrappeso grave e obesi (BMI >27) valore 1- normopeso (18,5 < BMI > 25) valore 0
∑+=⎟⎟⎠
⎞⎜⎜⎝
⎛−
=j
jiji
ii X
pp
plogit βα1
ln)(
Dipartimento di Economia e Politica Agraria,Agro-alimentare e Ambientale
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Il 58,16 % delle persone è in una condizione di normopeso, ben un adulto su tre ( 29,63 %) risulta in sovrappeso, il 7,81 % è obeso e il restante 4,3 % è sottopeso
I risultati mostrano che la condizione di sovrappeso e obesità aumenta con l’età, specialmente tra la persone con più di 65 anni.
Anche il genere è correlato con questa patologia: i tassi maggiori si registrano fra il genere maschile piuttosto che tra il genere femminile.
Una relazione inversa emerge tra eccesso di peso e livelli di istruzione. Tra gli adulti con titolo di studio medio-alto (diploma o laurea) la percentuale degli obesi è piuttosto bassa, mentre sale la percentuale tra gli adulti con la licenza elementare o privi di titolo.
Interessante è come esiste un inversa relazione tra i livelli di Knowledge alimentare e obesità. Sottolineando l’importanza di programmi di educazione alimentare per contrastare l’obesità.
Un po’ di risultati

38
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Per quanto riguarda i claims nutrizionali, come “light”, “basso contenuto energetico”, “elevato tenore in fibra”, “povero di grassi”, “povero di sodio”, non sono state trovate relazioni significative.
Il claim “povero in zuccheri” mostra una relazione positiva e significativa con questa patologia. Probabilmente dovuto alla percezione del consumatore del link tra contenuto in zucchero dei cibi e obesità.
Tra le variabili che riguardano i comportamenti d’acquisto, un’inversa e significativa relazione appare nei confronti del sapore e delle proprietà nutrizionali, sottolineando il basso interesse del consumatore obeso per questi attributi qualitativi dei prodotti alimentari.
Reddito e occupazione non hanno mostrato coefficienti statisticamente significativi.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Relativamente alle risorse economiche della famiglia: possiamo notare come la percentuale maggiore, sia per quanto riguarda gliobesi, sia per i sovrappeso si colloca in una posizione in cui il bilancio delle risorse economiche della famiglia è negativo arrivando a stento alla fine del mese o comunque facendo attenzione alle spese, mentre le percentuali dei soggetti in eccesso di peso diminuisce se le disponibilità economiche della famiglia sono ritenute ottime o adeguate anche se questo tipo di discorso non èstato poi confermato da un punto di vista statistico.
ANALISI DESCRITTIVA

39
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Un’indagine in Italia
L’indagine ha coinvolto 300 consumatori provenienti da Lombardia e Puglia.Le unità dove compiere le interviste sono rappresentate dai luoghi di acquisto, suddivisi in dettaglio tradizionale e grandedistribuzione. Per ciascuna tipologia di questi punti vendita sono state estratte dal sito delle pagine gialle le liste dei relativi esercizi commerciali con l’ubicazione di ognuno. Il questionario è composto da circa 80 domande separate per aree.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• Mediamente importante è il ruolo che il consumatore attribuisce all’informazione sui prodotti alimentari nel processo di allocazionedel tempo libero.
• Relazione diretta fra flessibilità del lavoro, knowledge nutrizionale e stock di informazioni con la propensione del consumatore a dedicare tempo alla ricerca di informazioni.
• La persona in sovrappeso o obesa risulta, invece, allocare poco tempo a questo tipo di attività.
• In linea con i dati ISTAT, l’analisi ha messo in luce una differente distribuzione tra la Puglia e la Lombardia in termini di BMI. Infatti, nella regione meridionale si riscontrano tassi di obesità piùelevati.
Un po’ di risultati

40
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• Gli individui obesi del campione considerato rappresentino una fascia della popolazione socialmente svantaggiata in cui prevalgono oltre alle persone anziane, quelle con modesti livelli di istruzione, basso reddito, inadeguata qualità della dieta e scarsa knowledge.
• La qualità della dieta, e i livelli di knowledge rappresentano delle determinanti fondamentali nello spiegare una condizione di sovrappeso grave e obesità.
• Importanza attribuita dal consumatore a qualità dei prodotti e prezzo di acquisto sono le determinanti principali nella scelta del punto vendita.
Un po’ di risultati
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Linee di policy RUOLO INFORMAZIONE
L’informazione gioca un ruolo importante nelle scelte del consumatore, aiutandolo a prendere decisioni circa le sue scelte dietetiche in maniera più consapevole
Attraverso quali mezzi informare?
Messaggi chiari, semplici e di facile comprensione
Permettere l’accesso ai meno istruiti e con un basso livello di knowledge
Permettere l’accesso a chi ha poco tempo da dedicare a questo tipo di attività

41
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Linee di policy DISEGUAGLIANZE SOCIALI
Questa considerazione trova ragione economica nel fatto che gli alimenti ad alto contenuto calorico sono in linea di massima disponibili a prezzi nettamente inferiori rispetto ad alimenti più healthy, quali frutta e verdura chi dovrebbe consumare tali prodotti non andrebbe a farlo a causa di prezzi troppo elevati, ripiegando su alimenti dieteticamente meno sani, ma con prezzi più bassi.
Tra l’informazione e l’adozione di un regime alimentare sano
Per quale motivo, ad esempio, l’obesità tende ad essere più elevata nelle aree meridionali, dove peraltro l’aderenza alla dieta mediterranea è maggiore? Non si tratta solo di un problema nutrizionale, ma c’è anche una ragione economica da
tenere in considerazione: le famiglie più povere sono quelle con tassi di obesità piùmarcati.
Agire in modo tale da favorire una riduzione dei prezzi di tali alimenti.
I consumatori a reddito più basso sono quelli più sensibili e che più facilmente modificano le loro abitudini, quindi, il beneficio in termini di salute e riduzione di rischio sarà maggiore per le fasce sociali più deboli.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Secondo le linee guida promosse dall'OMS
Cosa fare?
Per contrastare la tendenza all'obesità
“correggere le diete caratterizzate da un eccessiva componente energetica rispetto ai fabbisogni, in particolare il consumo eccessivo di grassi saturi, sale e zucchero e l'insufficiente consumo di frutta, ortaggi e alimenti ricchi di fibre. “

42
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
I potenziali strumenti di politica nutrizionale
Lo spettro delle misure adottabili è molto ampio e sempre più spesso si discute su strumenti più controversi:
l'introduzione di tasse o sussidi sui nutrienti contenuti nei prodotti alimentari,
campagne d’informazione per aumentare la conoscenza e la consapevolezza del consumatore,
regolamenti pubblicitari per limitare la pubblicità di cibi insalubri specialmente quando riguardano i bambini,
programmi di educazione nutrizionale nelle scuole,regolamenti di etichettatura specificando i livelli nutrizionali e
segnalare nutrienti sani e non sani, informazioni nutrizionali sui menu, regolamentare gli Health claims, finanziare le ricerche epidemiologiche, comportamentali e cliniche,regolare la responsabilità delle aziende alimentari, fissare degli standards.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
L'applicazione del regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, che ha permesso ai consumatori di disporre di informazioni affidabili, veritiere e coerenti sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari, dovrebbe avvenire in modo tale da stimolare l'industria alimentare a rinnovare e a migliorare i propri prodotti
Una politica di incentivi, riduzione dei prezzi, alleggerimento fiscale e altri tipi di sovvenzioni, potrebbero essere preferibili ad un sistema di tassazione maggiorata dei prodotti calorici ("fat tax") che, in ultima analisi, penalizzerebbe le famiglie europee a più basso reddito. La cosiddetta “fat tax”, infatti, calibrata per aumentare il prezzo degli alimenti con contenuto eccessivo di grassi saturi o altri nutrienti dannosi, discussa soprattutto negli Stati Uniti e in Inghilterra, rischia di essere uno strumento iniquo e di difficile implementazione. Uno strumento iniquo, perché andrebbe ad incidere maggiormente sulle fasce più povere della popolazione, per le quali la quota di spesa destinata all'alimentazione è più rilevante.

43
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Alternative più interessanti, ma di difficile introduzione per la potenziale reazione dell'industria agro-alimentare, sono la tassazione a livello di input produttivi. Questo per forzare le aziende trasformatrici ad utilizzare in misura minore gli ingredienti meno sani o per fare introdurre sussidi a livello di commercio al dettaglio, per rendere meno costosi prodotti, quali frutta e verdura.
Provocatoria potrebbe sembrare la proposta di introdurre una “tassa sull'obesità”. In un certo senso questa esiste già in alcuni paesi, dove le compagnie di assicurazione impongono premi più alti ad individui in sovrappeso, essendo questi considerati maggiormente a rischio per certi tipi di patologie. In una prospettiva analoga alcuni studiosi hanno proposto l'introduzione di incentivi e sgravi fiscali per gli individui, che dimostrano di intraprendere attività e spese mirate alla riduzione del proprio peso.
La lista di potenziali interventi politici è comunque nutrita e include misure di vario genere.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
In generale, i paesi del Nord-Europa sono quelli più avanzati nell'adozione di politiche nutrizionali, anche perché il problema dell'obesità è emerso anteriormente rispetto ai paesi mediterranei.
In Inghilterra, dove il tasso di obesità nel 2010 era al 24%, •massicce campagne di informazione per aumentare il consumo di frutta e verdura e ridurre quello di sale, oltre a misure per migliorare l'alimentazione nelle mense scolastiche e a piani locali per promuovere l'attività fisica•fine del 2004 è stato pubblicato un Libro Bianco che mira ad estendere l'intervento politico fino all'adozione di standard nutrizionali per i prodotti trasformati •schema di etichettatura che prevede una segnalazione “a semaforo”, con etichette rosse per i cibi nutrizionalmente inadeguati, verdi per quelli più salutari e gialle per quelli a rischio.
La situazione reale

44
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
In Italia l'intervento politico rimane limitato.
Il Piano Sanitario Nazionale prevede azioni informative e il monitoraggio dell'obesità.
Sono state inoltre pubblicate e distribuite linee guida per un'alimentazione più sana, mentre altre misure provvedono a finanziare campagne informative televisive e a promuovere una serie di iniziative educative nelle scuole, con distribuzione di pacchetti informativi e l'organizzazione di una competizione a livello scolastico.
Programma Frutta nelle Scuole è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari. Interessa scuole secondarie di 1 e 2 grado e installazione di distributori automatici di frutta e verdura di IV gamma
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Gli attributi qualitativi dei prodotti alimentari

45
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Attributi del prodotto alimentare
Sicurezza alimentarePatogeniMetalli pesanti e tossinePesticidi e residui di medicinaliContaminanti di acque e terreniAdditivi e conservantiBotulismo e altre sporeIrradiazioni e fumigazioniGeni di altra specie
Attributi nutrizionaliCalorieGrassi e colesteroloSodio e altri mineraliCarboidrati e fibreProteineVitamine
Attributi intrinseci di qualitàAttributi organolettici/sensoriali
GustoColoreFreschezzaMorbidezzaOdore/aroma
Attributi di funzioneIntegrità della confezioneDimensioneStileFacilità di preparazioneMateriali di confezionamentoConservabilità
Attributi di processoBenessere degli animaliAutenticità del processo/origine del prodottoRintracciabilitàBiotecnologie/biochimiciImpatto ambientale/biologicoSicurezza dei lavoratori
Fonte: Caswell, Noelke, Mojduszka(2002); Mariani e Viganò (2002)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Attributi del prodotto alimentareAttributi estrinseci di qualità
IndicatoriSistemi di gestione di qualitàCertificazioneEtichettaturaStandard minimi
SegnaliPrezzoMarcaNome del produttore Nome del distributoreConfezionamentoPubblicitàPaese di origineAssortimentoGaranzie ReputazioneEsperienze di acquisto passateAltre informazioni disponibiliFonte: Caswell, Noelke, Mojduszka
(2002); Mariani e Viganò (2002)

46
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Attributi del prodotto
asimmetria informativa --> ricerca di informazioni svolta dal consumatore sulle caratteristiche qualitative di un prodotto --> costo-beneficio (Stigler, 1961)
classificazione degli attributi del prodotto sulla base della ricerca di informazioni e delle caratteristiche qualitative:
− attributi search/ricerca --> si possono rilevare prima dell’acquisto
− attributi experience/esperienza --> si possono rilevare dopo il consumo
− attributi credeance/fiducia --> non si possono rilevare anche dopo il consumo
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Attributi del prodottoProdotti ‘ricerca’
Le caratteristiche del prodotto sono note ai consumatori prima della decisione di acquisto (simmetria informativa): i consumatori, dati i prezzi, scelgono la qualità che preferiscono
-> non esiste alcun problema.
Prodotti ‘esperienza’Le caratteristiche del prodotto sono note ai consumatori solo dopo il consumo: se si tratta di prodotti ad acquisto ripetuto, le imprese hanno un incentivo ad offrire beni di buona qualità ad un prezzo adeguato alla qualità ed a fornire ai consumatori informazioni corrette circa le caratteristiche del prodotto
-> poiché i consumatori, dopo il consumo, acquisiscono piena informazione sulle caratteristiche del prodotto, si può creare una “reputazione” del prodotto

47
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Prodotti ‘fiducia’Le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione non sono note ai consumatori neanche dopo il consumo: i produttori conoscono tutte le caratteristiche di ciò che offrono, i consumatori neanche dopo il consumo caratteristiche legate al processo di produzione-> esempi di caratteristiche qualitative dei prodotti agro-
alimentari che li rendono beni ‘fiducia’- prodotto a “denominazione di origine controllata e protetta”- prodotto da “agricoltura biologica”- prodotto “rispettando la natura”- prodotto “senza impiego di bambini”- prodotto “rispettando il benessere animale”
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Prodotti ‘fiducia’Alcuni consumatori saranno disponibili a pagare di più un prodotto che abbia una o più di queste caratteristiche.-> l’asimmetria informativa, in presenza di differenze
qualitative del prodotto, nei costi di produzione e di una disponibilità a pagare dei consumatori per caratteristiche non osservabili, determina un forte incentivo per le imprese ad offrire ai consumatori prodotti di qualitàinferiore come prodotti di più alta qualità
Il mercato per un prodotto ‘fiducia’ può svilupparsi:- sulla base di un atto di fiducia del consumatore (nel
produttore) marchio- grazie ad una ‘garanzia’ fornita da terzi sulle caratteristiche
del prodotto o del processo che il consumatore non è in grado di verificare da sé certificazione

48
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Politiche agro-alimentari ed intervento pubblico
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Classificazione delle politicheagro-alimentari
per il sistema e le filiere
politiche agro-alimentari
per i singoli settori
– politiche di food safety (sicurezza alimentare) --> etichettatura, standard, HACCP, rintracciabilità
– politiche di food quality --> denominazioni di origine, agricoltura biologica, rintracciabilità, certificazione
– politiche di food security --> crescita dell’offerta nei paesi in via di sviluppo
– politiche per le relazioni verticali --> chain management, cooperative
– politiche per il commercio internazionale– politiche alimentari per fasce più povere
– per il settore agricolo --> Pac– per l’industria alimentare --> es. antritrust– per la distribuzione --> es. licenze

49
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Problematica generale per l’intervento pubblico: è meglio lasciare libere le imprese, dare precise indicazioni o rendere obbligatorie determinate misure
Ruolo dell’intervento pubblico
private standards or public intervention?
Da: M. Garcia Martinez, A. Fearne, J.A. Caswell, S. Henson “Co-regulationas a possible model forfood safety governance: Opportunities for public-private partnerships”, Food Polocy 32 (2007).
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

50
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Problematiche economiche dell’etichettatura nutrizionale
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
è meglio lasciare libere le imprese, dare precise indicazioni o rendere obbligatoria l’etichettatura?
Caratteristiche economiche dell’etichettatura nutrizionale
l’etichettatura nutrizionale come intervento nel mercato l’informazione nell’etichetta rappresenta un mezzo per • nel caso dell’impresa strategia di differenziazione
comunicare al consumatore le caratteristiche del prodotto (attributi nutrizionali) attributi search
• nel caso di intervento pubblico politica comunitariagarantire che non ci siano comportamenti opportunistici e ristabilire l’efficienza del mercato
ATTRIBUTI NUTRIZIONALI
Sicurezza alimentare Qualità

51
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Caratteristiche economiche dell’etichettatura nutrizionale
Nei paesi industrializzati le regolamentazioni sull’etichettatura nutrizionale sono differenziatenegli USA l’applicazione del National Labelling and EducationAct nel 1994 ha reso l’etichettatura nutrizionale obbligatoriaper quasi tutti i prodotti alimentari confezionati, stabilendo specifici standards per la formulazione di queste informazioni (Golan et al., 2000; Nayga, 1996). nell’UE solo con il regolamento 1169/2011 viene prevista l’obbligatorietà della tabella nutrizionale, mentre le indicazioni nutrizionali sono ancora volontarie; ma dal 1990 in accordo con la Direttiva 90/496 se un’indicazione nutrizionale compare sull’etichetta o nella pubblicità la tabella nutrizionale diviene obbligatoria; la Direttiva 90/496 stabilisce alcune regole per la standardizzazione delle tabelle nutrizionali, ma le imprese sono piuttosto libere su come formulare queste informazioni.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Caratteristiche economiche dell’etichettatura nutrizionale
Nell’UE l’etichettatura nutrizionale è divenuta obbligatoria con il reg. 1169/2011.i nutritional claims possono trasformare attributi credencein attributi search il consumatore può fare scelte piùveloci e scegliere prodotti che più corrispondono alle sue preferenze qualitative (Hooker and Caswell, 1996)in etichetta possono esserci tante informazioni èimportante capire a quale tipo di informazioni il consumatore è realmente interessato quando sceglie un prodotto.l’introduzione di nutritional claims potrebbe determinare alcuni cambiamenti nel comportamento d’acquisto se l’informazione nutrizionale riportata in etichetta è chiara, concisa, e comprensibile.

52
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Politica comunitaria per leproblematiche nutrizionali
• Regolamento 1924/2006 obiettivo garantire un alto livello di tutela dei consumatori, stabilendo un quadro giuridico nell’UE per i nutrition e gli health claimsassicurare la diffusione di una corretta informazione ai consumatori facilitando le scelte dei consumatori per i prodotti alimentari.
• se si vogliono inserire in etichetta specifiche indicazioni nutrizionali è necessario riferirsi agli standards previsti per i nutritional claims standard pubblici di riferimento.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Nutritional claims previsti dal Reg. 1924/2006
• L’allegato del reg. 1924/2006 stabilisce una lista dei nutritional claims permessi e le relative condizioni che devono essere seguite per utilizzare queste indicazioni
• le indicazioni nutrizionali introdotte dal regolamento sono 24, che possono essere raggruppate in 9 categorie:
• calorie (basso contenuto calorico, ridotto contenuto calorico, senza calorie low energy, energy-reduced, energy-free);
• grassi ( a basso contenuto di grassi, senza grassi, a basso contenuto di grassi saturi, senza grassi saturi low-fat, fat-free, low-saturated fat, saturated fat-free);
• zucchero (a basso contenuto in zuccheri, senza zuccheri, senza zuccheri aggiunti low sugar, sugar-free, with no added sugar);

53
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Nutritional claims previsti dal Reg. 1924/2006• sodio (a basso contenuto di sodio/sale, a bassissimo
contenuto di sodio/sale, senza sodio o senza sale low sodium/salt, very low sodium/salt, sodium-free or salt-free);
• fibre (fonte di fibre, ad alto contenuto in fibre source of fibre, high fibre);
• proteine ( fonte di proteine, ad alto contenuto di proteine source of protein, high protein);
• vitamine (fonte di vitamine e/o minerali, ad alto contenuto di vitamine e/o minerali, contiene... source of vitaminsand/or minerals, high vitamins and/or minerals);
• nutrienti (contiene ..., a tasso accresciuto di ..., a tasso ridotto di ... contains nutrients or other substances, increased nutrients, reduced nutrients);
• leggero/light• naturalmente/naturale naturally/natural.
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
• Tali fattori determinanti dell’interesse e della lettura delle informazioni nutrizionali da parte del consumatore sono raggruppabili in 5 categorie:
• caratteristiche socio-demografiche e individuali includono variabili come l’età, sesso, educazione, reddito, BMI, etc;
• attributi che riguardano il comportamento d’acquistoincludono variabili come prezzo, marca, sapore, origine del prodotto, tracciabilità, certificazione di qualità;
• attitudine ad una vita sana rappresenta variabili come dieta equilibrata, sport, fumo, malattie connesse all’alimentazione;
• conoscenza nutrizionale e risorse informative includono variabili come il livello di conoscenza e fonti d’informazione;
• attitudine ad un’alimentazione sicura rappresenta variabili come l’attenzione ad un’alimentazione sicura, condizioni del packaging, l’attenzione agli ingredienti.
I fattori determinanti dell’interesse del consumatore verso le informazioni nutrizionali

54
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
I risultati di un’indagine diretta
• analisi mediante questionario telefonico realizzato ad hoc• campione formato da 1025 consumatori lombardi statisticamente significativo
• obiettivi:– esaminare il grado di interesse e di attenzione dei
consumatori nei confronti della salubrità degli alimenti e delle problematiche nutrizionali
– valutare in tale ambito i comportamenti dei consumatori
– valutare la percezione dei consumatori sui nutritionalclaims
• l’indagine è stata finanziata dalla Regione Lombardia (IReR)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Scopo analizzare l’attitudine del consumatore verso l’etichetta nutrizionale e i “nutritional claims” e identificare le principali variabili di decisione
NIj= f (IC, PBF, HLA, NKS, FSA)L’informazione nutrizionale (NIj) è rappresentata da variabili dipendenti
come : • l’importanza dell’etichetta nutrizionale (NI1), • l’uso dell’etichetta (NI2), • le principali categorie di nutritional claims fornite del Reg.
1924/2006: basso contenuto energetico (NI3), basso tenore in grassi o senza grassi (NI4), basso tenore in zuccheri o senza zuccheri (NI5), basso sodio/sale o senza sodio (NI6), alto contenuto in fibre e vitamine (NI7), light (NI8).
I risultati di un’indagine diretta
NI: Nutrition Information,IC: Socio-demographic and
indiv.characteristicsPBF: Purchasing behaviour
HLA: Healthy life attitudeNKS: Nutritional knowledge
and source of informationFSA: Food safety attitute

55
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Attributi che influiscono sull’acquisto di un prodotto
0
10
20
30
40
50
60
70
prezzo
marca
sapore
propr.n
utriz
.
origine
tracciab
ilità
cert.
qualità tot.d'accordo
moltoabbast.pocoper nullanon sa
- Alto interesse del consumatore per gli attributi nutrizionali- sapore (87%), segnali di qualità (80%) e origine (74%)
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
05
1015202530354045
valori nutrizionali
totalmente molto abbastanzapoco per nulla non sa
Importanza della presenza della tabella nutrizionale
L’analisi ha rilevato un alto interesse del consumatore per la tabellanutrizionale, dato che la maggior parte dei consumatori considera la presenzadi tale tabella un elemento importante per la scelta di un prodotto alimentare.

56
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Elementi controllati nella scelta di un prodottoalimentare
- L’importanza data dagli intervistati alla tabella nutrizionale non determina che il consumatore legga tali informazioni
- altri elementi come le condizioni di freschezza e la data discadenza sono controllati da la gran parte degli intervistati
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Freshness control of foodproducts
expiry date ingredients nutritional information
Dipartimento di Economia e Politica Agraria,Agro-alimentare e Ambientale
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Importanza dei nutritional claims
- Alto interesse degli intervistati verso i nutritional claims stabiliti dalReg. 1924/2006
- differenti livelli di importanza fra le categorie dei nutritional claims- grande interesse per i claims “high fibre/vitamin” e “low fat”- il consumers rivela scarso interesse per i claims “light”, “low energy”
and “low sodium/salt”.
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
low energy low fat low sugar low sodium/ salt high fibre/ vitamin "light"
totally agree agree neutral not agree totally disagree don't know
Dipartimento di Economia e Politica Agraria,Agro-alimentare e Ambientale

57
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Considerazioni di sintesi• regolamento 1924/2006 oltre alla tabella nutrizionale, se si vogliono
inserire in etichetta specifiche indicazioni nutrizionali è necessario riferirsi agli standards previsti per i nutritional claims standard pubblici di riferimento
• significativa influenza sulle strategie di differenziazione e considerevoli costi di adeguamento per le imprese, con la necessità di disporre di competenze legislative
• il consumatore percepisce le informazioni nutrizionali come di rilevante interesse per la scelta di un prodotto alimentare
• si nota una differenza fra la percezione e il reale comportamento (lettura delle informazioni nutrizionali)
• i nutrional claims vengono ritenuti importanti con una particolare rilevanza per quelli relativi alle vitamine e grassi
• i consumatori che utilizzano la tabella nutrizionale presentano differenti caratteristiche da quelli che preferiscono i claims si nota una particolare categoria che è interessa alla tabella nutrizionale e a una serie di altri fattori legati alla food safety
• riduzione dell’assimetria informativa