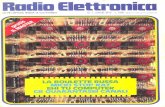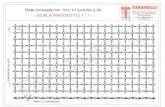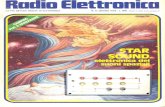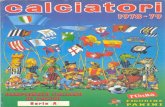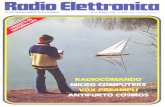E. Guidubaldi (Ed.) - Dal «De Luce» Di R. Grossatesta All'Islamico «Libro Della Scala» (1978)
-
Upload
booksocialist -
Category
Documents
-
view
109 -
download
3
description
Transcript of E. Guidubaldi (Ed.) - Dal «De Luce» Di R. Grossatesta All'Islamico «Libro Della Scala» (1978)
-
TESTI MEDIEVALI DI INTERESSE DANTESCO ~~~~~~~-2~~~~~~~-
DAL
-
TESTI MEDIEVALI DI INTERESSE DANTESCO ~--~~~~~-2~~~~~~~~
DAL
-
PREMESSA
DALL'INTESA ARABO-OXFORDIANA CONFLUITA NEL POEMA SACRO COME PROFEZIA PER I NOSTRI GIORNI AI COLLOQUI EUROARABO E CRISTIANO ISLAMICO
D'OGGI
Nel lungo titolo che introduce questa premessa vorrei su-bito bloccare l'attenzione del lettore sulle parole profezia per i nostri giorni ; onde prevenire il pericolo dei metaforismi soliti a caratterizzare, per tradizione tristemente secolare, la prophetia Dan-tis ; col conseguente svuotamento lessicale atto ad annullare anche l'auspicata incidenza politica per la collana che, con questo mio con-tributo, passa dal primo al secondo volume.
Profezia in che senso? Lo capiremo richiamandoci all'altro ter-mine che qui funge da correlato d'obbligo: visione; essa pure secolarmente succube di metaforismi riusciti ad eliminare ogni trac-cia d'esperienzialit, previo relegamento (di tutti i rei di un simile approccio al Poema Sacro) nel dimenticatoio pi invalicabile.
Non credo di dire alcunch di presuntuoso, segnalando, in que-sto settore, l'avvenuto approdo nel regno della sperimentalit pi totale; s da potersi additare, senza timore di confutazioni, la piena rispondenza tra i sogni del Poema Sacro e quanto di pi tecnico v' nella scienza onirica odierna; come anche ravvisare nel linguag-gio di Dante il timbro d'una conduzione inconscia agevolmente ri-portabile ai pili centrali canoni dell' criture automatica.
Traguardo analogo, senza la minima rinuncia, perseguiamo an-che qui; ai sensi, cio, volendo essere totalmente precisi, che, mentre aggiudicano a Dante quanto di pi accettato v' nella feno-menologia profetica d'ispirazione divina, per essa anche reclamano quell'altro, particolarissimo, timbro esperienziale del metro socioana-
-1-
-
litico della time span of discretion di cui ci occuperemo al ter-mine di questo volume.
Valida, infatti, la prima dimensione nell'ambito di un discorso che, come or ora ricordato, ha gi percorso l'intero raggio d'argo-menti relativi alla visio su cui poggia l'ofE.ciatura profetica, non stenta a suffragarsi con altrettanta spontaneit anche la seconda dimensione in un contesto espressivo che tutto ha giocato agli effetti dei segni da cui far riconoscere, in noi uomini del secolo ven-tesimo, i veri destinatari del messaggio profetico.
quanto vedremo nel capitolo finale commisurando il profe-tismo dantesco sui due canoni pi centrali della scienza che consacra i profeti dell'odierna era industriale; coloro, cio, cui spetta di intuire il futuro cui adeguare i piani di sviluppo sia l dove tutto procede lungo il tracciato del guadagno crescente, sia l dove c-' invece da attraversare l'incomodo, a volte gravissimo, mare delle perdite.
Cos' la Commedia? uno strano, ma genialissimo, esempio di programmazione passato, su diretta conduzione del Dittatore di-vino, proprio attraverso questo secondo (scomodissimo, nel caso di Dante) itinerario, ubicandovisi come il pi oculato rapporto ptoftti-perdite che la storia conosca.
Sconfinato guadagno, da una parte, ravvisabile soprattutto nel dato d'una emblematicit unitario-politica riuscita addirittura a coin-volgere gli stessi operatori meno disponibili per le pure commozioni letterarie; ma dolorosamente passato attraverso un mare di perdite mai verificatosi in proporzioni cosl colossali: ben cinque secoli bui dovuti da Dante affrontare prima che la riaccesa emblematicit politica desse il via al progressivo riaccendersi di tutte le sintonie di gusto: modernit lirica, dimensione-teatro nel quadro d'una spetta-colarit non meno aperta verso le conquiste cinematografiche odier-ne, genuinit musicale, gusto figurativo tra l'astrattismo d'un Kan-dinski e l' art brut d'un Dubuffet, espressivit da romanzo; le sintonie di gusto che prima erano rimaste non solo inavvertite, ma addirittura esposte al ridicolo pi totale.
Resta da precisare, a questo punto, il nucleo pi autentico di questo messaggio profetico. il nucleo maturato da ultimo con l'organica conclusione dell'arco politico servito da avvio; oggi riuscito a sostituire con prospettiva marcatamente euromediterranea l'emble-
-2-
-
maticit nazionalistica simultaneamente esplosa aali inizi del secolo scorso, in pi Stati d'Europa. ' 0
. i~ . nu.cleo portato a schiuderci nel miracoloso quanto insta-bile eqmhbrio cantato da Dante (con lirismo da tramonto atto a tran:utarsi per tal via anche in lirismo da ripresa) non gi il dissol-versi della sola Respublica Christiana identificabile con la Zona-Carlomagno , ma il pieno esaurirsi del pi vasto ambito arabo-oxfor-diano rivelatosi, in questi ultimi tempi, vero tessuto strutturale del Poema Sacro; il pieno esaurirsi, cio, della stessa zona Maometto .
Di qui lo spontaneo congiungersi di tale tessuto con la ripresa che simili istanze hanno nel mondo d'oggi come inevitabile traguardo d'integrazione europea. Mi riferisco al colloquio euro-arabo in crescente sviluppo dopo l'avvio avuto lo scorso anno a Firenze e pi ancora, a quel colloquio cristiano-islamico in cui dato ravvisare un autentico ritorno aIIe origini della bimiilenaria parabola culturale europea fondata, al suo inizio, proprio sull'incontro tra le culture cristiana ed islamica.
* * *
Con ci s' anche dato il perch d'un accoppiamento di testi fatti apposta per rendere omaggio l'uno (il De luce di R. Grossatesta) al Dante interprete dell'Europa di Carlo Magno, l'altro (l'islamico Libro della Scala) al Dante interprete delI'Europa di Maometto; accoppiamento pienamente giustificato, del resto, dall'intimit di nes-so (d'autori, quando non addirittura di codici) che legava nell'oriz-zonte culturale dantesco tematiche perspectivistiche e tematiche esca-tologiche d'indubbia provenienza araba in ambedue i casi. Una volta, infatti, accettate in sede dantesca quelle (e col calore d'accoglienza loro riservato su diretta iniziativa-Contini in Studi Danteschi ) non ha davvero pi alcun significato espungere queste, trasmesseci (ripeto ancora) dagli stessi autori (penso soprattutto a R. Bacone e Tommaso di York). Ma aIIora (ecco il vero asse portante dell'acco-stamento di testi qui praticato) molto meglio l'accoglierle, tali tematiche escatologiche, per la via deIIa porta rappresentata dal Libro deIIa Scala , anzich per la via deIIa finestra rappre-sentata dalle sillogi, assai meno autorevoli in questo caso, prove-nienti da Oxford; stante anche la possibilit che oggi abbiamo, grazie
-3-
-
ai noti versi di Fazio degli Uberti, di poter ritener circolante tale Libro nel clima della Toscana predantesca.
Tanto pi ci apparir ragionevole se si riflette sul fatto che con le recenti indicazioni junghiane sull' inconscio collettivo viene assolutamente a svuotarsi l'arduo problema delle possibili trasmi-grazioni culturali che ha fatto via via cadere la proposta-Asin Pala-cios. Non ha alcun bisogno di trasmigrare ci che gi non solo in tutti noi (quale che sia l'area geografica in cui ci troviamo a stare), ma anche in ogni tempo con identici depositi immaginistici fatti di terrificanti abissi (al momento dell'inconscio d'espiazione), di monta-gne o scale ascensionali (quando in noi subentra l'istanza di purifica-zione) o di suggestivi geometrismi (come nomina Dei atti a signi-ficare il nostro incontro col divino). Niente di strano che chi per divino intervento (e proprio questa la prospettiva in cui si lascia qui ripro-porre la linea-Asin Palacios) rivive simili, del tutto eccezionali, espe-rienze sia portato a corroborarle col ricorso a resoconti analoghi: in alcuni casi come esplicita ricerca d'autenticazione grazie al cifrario interpretativo desumibile da tali esperienze analoghe; in altri casi come normale appello (per niente fatto alla chetichella, anzi volonta-riamente contando sulla spontanea associazione fantasmatica in chi le conosce) al modo oggi descrittoci da T.S. Eliot.
E. G.
Cagliari, giugno '78
-4-
-
I
LA LEZIONE OXFORDIANA IN R. GROSSATESTA
-
IL PERCHE' D'UNA SCELTA
Un'adeguata illustrazione dei testi, qui appresso leggibili, diffi-cilmente potrebbe effettuarsi senza due premesse concernenti l'una l'apparente timbro estremistico che Dante riceve gi con il solo ve-nire a tali testi accostato e l'altra lo specifico incontro con essi che a Dante si intende attribuire.
Mi riferisco (per quanto riguarda il primo punto) soprattutto al contenuto di un De Intelligentiis che, non a caso, protegge con volontario 1 anonimato, asserti nei quali la gi sospetta atmosfera ema-natistica di R. Grossatesta :.? raggiunge compiacenze luministiche ren-denti assai fragile lo stesso finale argine tra le creature e Dio.
Baster, a tal proposito, rievocare la vigorosa piattaforma me-diana 3 da cui Dante prende il via per poi dirigersi, con altrettanto entusiasmo, verso i due opposti estremismi in cui si lasciava reperire il meglio dei patrimoni estetici offertigli dalla cultura del suo tempo: metafisica della luce (nucleo vitale della lezione estetica neoplato-nica) e psicologia di libert (nucleo dell'opposta lezione aristotelico-tomista, artisticamente fertilissimo esso pure).
Fisionomia estremistica, d'accordo, quella che allo stesso Dante qui verremo ad attribuire, sostituendo agli spunti bonaventuriani
1 Le esatte parole con cui tal volontario anonimato viene introdotto, cosi suo-nano: Procul igitur omnis invidiae livor absistat, ne statim cognito auctore quod labore acquisitum est vilescat, sed quae dicantur lector diligenter inspiciat, ut quae bene dieta sunt memoriae commendans et quae minus bene dieta corrigens ad ve-ritatis cognitionem perveniat . Vedasi il significato di questo passo nel contesto laggibile a p. 117.
2 Qui pure (per una pi vasta giustificazione di quanto asserito in merito alle tracce emanatistiche individuabili nel Grossatesta) rinvio ai dettagli che verranno spe-cificati a p. 46.
3 Previo richiamo sin d'ora alla sintesi figurale che tra questi due passi addi-teremo in Par. XXVIII ( cfr. p. 57) invito a confrontare i racconti creazionistici da Dante trasmessici in Par. XIII e in Par. XXIX. Piu suffragata non potrebbe,
-7-
-
(che fungono da abituale riscontro per il luminismo paradisiaco) le ben pi audaci. prospettive metodologiche del Grossa testa e del De Intelligentiis; ma lo nel felice bilanciarsi di due opposte tensioni che, mentre si aggiudicano il tipico fascino delle posizioni di punta, trovano poi modo (proprio per il loro reciproco stemprarsi) di va-nificarne le possibili escrescenze negative, con ci approdando ad un vicendevole arricchimento. Questo ci ha gi detto in nota la spon-taneit con cui (su esatta contrapposizione platonico-aristotelica) re-ciprocamente si chiamano i due racconti creazionistici di Par. XIII e di Par. XXIX; questo, in seguito, ci diranno i vari punti del Poema Sacro in cui metafisica della luce e psicologia di libert vengono da Dante simultaneamente chiamate a dare il meglio delle loro possi-
dayvero,. riuscirne la vigorosa piattaforma mediana da cui. Dante parte per poi sp1:gers1 . verso le pili audaci punte estetiche del neoplatonismo e del neoaristo telismo Slillultaneamente vissute:
Ci eh~ non more e ci che pu morire non e se non splendor di quella idea :he partorisce, amando, il nostro Sire:
che quella viva luce che si mea dal s:io lucente, che non si disuna da lm n da l'amor ch'a lor s'intrea
per s~a bontate il suo raggiare adu~a quasi specchiato, in nove sussistenze '
e~ter:almente rimanendosi una. ' Q'-:1~di, disce~de a l'ultime potenze
gm d atto m atto tanto divenendo che p'' f h' ' iu non a e e brevi contingenze.
(Par. XIII, vv. 52-63)
Non per aver a s di bene acquisto, ch'esser non pu, ma perch suo splendore potesse, risplendendo, dir 'Subsisto',
in sua etternit di tempo fore, fuor d'ogne altro comprender, come i
[piacque, s'aperse in nuovi amor l'etterno amore.
N prima quasi t;>rpent~ si giacque; ch n prima ne poscia procedette lo discorrer di Dio sovra quest'acque.
Forma e materia, congiunte e purette, usciro ad esser che non avfa fallo, come d'arco tricordo tre saette.
(Par. XXIX, vv. 13-24). . Si ?a qui a che fare con due moduli creazionistici apparentemente impron-
tati a rispondenza totale come deducibile in ambedue i casi sia da quel Cristo splend~r Patri? che ci viene presentato quale idea-archetipa da cui tutte le. crea-tur: der~vano sta dall'agilit con cui queste medesime cre~ture vengono .per rifles~o a. s.1tuar~1, esse pure, quale splendida catena di splendori conclamanti la propria ?IOta ~ls~enziale. ~e palese, per, il precisarsi delle rispondenze, altretta,?to lo ~ 11. d~~1rs1 de~e differenziazioni. In forza di queste Par. ~I}I non stentera ad . es1-
b~r~isi come discorso neoplatonico vissuto sino all'ossequio pm totale; l:ir;igo un g.ioco d1 mtonazioni, cio, che pur partendo da mero motivo pseudoareopag1tl~o, vogliono beneficiare il pili possibile del fascino estetico insito n~lla .con.catenaz1one causale cara al neoplatonismo emanatista. Non meno deciso (ma m. d1rez1one completamente opposta) ci apparir in Par. XXIX un riecheggiamento tomista ~he, pur. non smen-tendo il precedente motivo neoplatonico, tutto pervas
-
bilit espressive; come, ad esempio, ci accadr di constatare analiz-~ando il pal~se incoraggiamento che, nel cielo di Giove, l'impulso Innovatore di Dante trae dalla duttilit d'una materia-luce da lui plasmabile in libert assoluta.
Nel giro dei dettagli esplicativi postulati dalla seconda pre-messa (il tipo di contatto qui presupposto tra Dante e i testi che ci accingiamo ad illustrare) il dato-base sar costituito dalla necessit di dissipare al pi presto i sospetti causati da questa ripresa del mo-tivo oxfordiano, forse associabile (nella mente di qualche lettore) alle tante peregrinazioni extra-italiche spesso a Dante attribuite, ma poi sempre risultate indocumentabili, soprattutto quando effettiva-mente indirizzate oltre Manica 1
A scanso di perplessit qui pure in tal senso originabili m'af-fretto a precisare subito che, pur con tutta l'intensit di riecheg-giamento appresso documentato, il contatto qui presupposto non solo non intende ricalcare la via delle indocumentabili peregrinazioni europee:!' ma restringe al massimo, nella stessa Italia, la sfera dei materiali soggiorni di Dante all'uopo necessari. Le sole Firenze e Bologna appariranno pi che sufficienti, solo che ci si premuri di ri-flettere sui dati emersi in questi ultimi decenni 3 sia quanto a dimen-sione filosofica in Dante globalmente riscontrabile sia quanto a spe-cifiche conoscenze luministiche a lui fondatamente attribuibili.
1 In merito alle ipotetiche peregrinazioni dantesche formulatesi in senso oxfordiano basti una testimonianza di G. Serravalle, inserito quasi furtivamente nel precedente tracciato di Benvenuto da Imola dal Serravalle fedelmente ricalcato, come deducibile attraverso il confronto fattone dal Barbi. Iste auctor Dantes se in iuventute dedit omnibus artibus liberalibus, studens eas Padue, Bononie, demum Oxoniis et Pari-siis ... . (Cfr. M. BARBI, La lettura di Benvenuto da Imola e i suoi rapporti con altri commenti, in Studi Danteschi, voi. XVIII, 1934, p. 79 ss.).
2 Superfluo il dire che, se assai problematica la dimostrabilit d'un Dante oxfor-diano, non altrettanto Io il fatto del ventilato soggiorno francese di Dante, per il quale (oltre alle molteplici ragioni di buon senso) ci fanno fede testimonianze di per-sone al poeta vicinissime. Si pensi al Villani e al Boccaccio che sulla cosa non una sola volta ritornano.
3 Su di un piano alquanto pi integrale questa sistematica riscoperta di dati concernenti l'impegno filosofico di Dante stata bene trattata da G. G. MEERSSE-MANN in Dante come teologo, leggibile in Atti del Congresso Internazionale di Studi Danteschi, G. C Sansoni Editore, Firenze, 1965, pp. 177-196. Del resto il solo ricordo di apporti quali quelli di G. Busnelli, B. Nardi o E. Gilson gi piu che sufficiente.
-9-
-
Ai sensi che ci interessano indubbiamente utile gi il primo di questi due dettagli. Grazie ad esso, infatti, il Dante filosofica-mente impegnato veniva per forza di cose ad imbattersi con meto-dologie luministiche significanti (rispetto alle polemiche che vivifi-cano il Medioevo) non gi un fatto puramente marginale, ma qual-cosa di intimamente connesso con i pi centrali problemi agitati 1 Ancor pi utile, per, il secondo dettaglio, fatalmente destinato ad immetterci nella tipica atmosfera risalente, come sue iniziali fonti ispirative, proprio ai teorici di cui ci stiamo occupando 2 , come tra poco ci dir lo stesso S. Bonaventura.
Vorremmo con ci parlare di diretto incontro, da Dante sicura-mente avuto con gli specifici testi qui riportati, di ci forse ten-tando riprova in base al metro dei riscontri verbali solitamente pra-ticati? Non ce ne sar alcun bisogno, stante l'assoluta centralit che tali formulazioni primordiali detenevano nell'atmosfera estetica del tempo e la conseguente possibilit di incontrarsi con esse che Dante veniva ad avere per vie pressoch infinite. Quel che, invece, faremo, sar il servirci di questi testi come ideali avvii ad una pienezza di intenzioni espressive altrimenti inafferrabili in Dante; in ci, del resto, incoraggiati da un gioco di rispondenze percepibili al livello di precisione con cui il purgatoriale E una melodia dolce correva -per l'aere luminoso 3 ci si lascer commisurare sul principio gros-satestiano della luce che diventa suono mediandosi attraverso I' aria o a quello con cui il vitalismo luministico del De I ntelli-gentiis 4 ci si tradurr in esatto metro con cui riconoscere l'interiore struttura del Poema Sacro.
1 Ad attestarla, tale centralit. interverr tra poco la stessa esegesi dei primi versetti biblici. '
3
Appena necessario il rievocare il nesso in ci significato dal tema perspet-tlvtstlco , soprattutto attraverso due capisaldi della sua fortuna in Italia: Witelo e G. Peckam. Sul primo (autore come noto della Perspectiva commissionatagli nel 12_70. da Guglielmo di Moe~beka) pili che 'probanti sono i nessi ~i. derivazione oxfordiam fissati da A. C. CROMBIE nel suo R. Grosseteste and the ortgzns of expe-rimental science, Oxford at the Glarendon Press II ed. 1962. (Cfr. cap. VIII, Gros-seteste, Oxford and European Sdence , pp. 218-219). Sul .sec~:mdo, poi, del tutto superflua ogni bench minima volont di prova, trattandosi. d1 p~nsatore ?~ Oxfo~d proveniente ed in Inghilterra nuovamente ritornato dopo gli anm trascorsi m Italia, quale Lector Sacri Palatii .
:! Purg. XXIX, vv. 22-23. 4 Il punto sar a lungo trattato appresso in sede di concreta lettura.
- 10 -
-
Dissipate in tal maniera (almeno in via introduttoria) le due pi inevitabili pregiudiziali, l'ordine logico con cui ora procederemo ci porter prima a documentare l'innegabile incidenza che queste te-matiche luministiche operavano anche qui in Italia (cap. I). In se-condo luogo ci impegner in una accurata rassegna dei pi importanti canoni cui si affida la metafisica della luce oxfordianamente con-formata (cap. II). Infine (cap. III) ci condurr di fronte al luminismo dantesco per una concreta prova della lectio plenior per tal via conseguibile.
- 11 -
-
R. GROSSATESTA E LA SUA INCIDENZA NELLE POLEMICHE MEDIEVALI
Lo specifico tema con cui qui veniamo alle prese ben si lascia avviare con una puntualizzazione di E. Gilson 1 particolarmente adatta a svelarci il vero contesto in cui nel Medioevo si sviluppava il discorso luministico col quale Dante non poteva non venire a contatto. Mi riferisco alla fine indagine dal Gilson condotta sul-l'apparente~ equidistanza detenuta da S. Bonaventura tra la pienezza di compiacenze luministiche riscontrabili in R. Grossa testa (o R. Ba-cone) e l'atteggiamento drasticamente ostile sempre, invece, assunto da S. Tommaso 3
Ripercorrendo di tal puntualizzazione gli aspetti salienti av-vertiremo forse un po' troppo, in un primo momento, il disagio d'una lettura pi filosofica che letteraria, ma ne ritrarremo vantaggi tut-t'altro che indifferenti; primo fra questi la vigorosa iniziazione oxfor-diana per Dante rappresentata proprio dal pensatore al quale pi si soliti accostare il suo luminismo.
Lo spunto al quale il Gilson fa, anzitutto, capo come indicazione di bonaventuriana equidistanza concerne l'origine stessa del discorso luministico: l'antefatto biblico servito da stimolo a tal discorso at-traverso il misterioso fiat lux da Dio pronunciato in principio ; con forte anticipo, cio, su quel dies quartus in cui, a seguito
1 E. GILSON, La philosophie de Saint Bonaventure, Parigi, Vrin, 1924, Cap. IX Les corps inanims. La lumire , p. 217-235.
2 Come esaurientemente ci diranno i testi qui direttamente riportati, tale equi-distanza esplicitamente voluta dallo stesso S. Bonaventura, senza per con ci impedire un preciso affiorare delle sue preferenze oxfordiane.
:i Di tal drastico atteggiamento la riprova pi evidente l'avremo attraverso i sui interventi sul De fotelligentiis (cfr. testi qui riportati a p. 106).
- 13 -
-
del fant luminaria in firmamento coeli 1 , avrebbe avuto inizio la luce del sole.
Sull'argomento S. Tommaso cosi s1 pronuncia: Illa lux fuit lux solis, sed adhuc informis quantum ad hoc quod iam erat substantia solis et habebat virtutem illuminativam in communi; sed postmodum data est specialis et determinata virtus ad particulares ef-fectus 2
Cosa ci voglia dire con esattezza lo capiremo riportandoci al creazionismo totale 3 da S. Tommaso in Dio ravvisato sin dal primo momento, anche se estrinsecatosi limitatamente ai quattro elementi primigenii (terra, acqua, fuoco, aria) al cui particolare status di quel momento primordiale andrebbe fatta risalire la terra inanis et vacua di cui ci parla la Bibbia.
Ben diversa la posizione di S. Bonaventura che in questa terra inanis et vacua ravvisa una fisica materia informis t munita, s, d:una sua forma prima , ma ancora bisognosa di successive spe-cificazioni formali: quelle per cui da semplice corpo sarebbe pas-
1 In tal cronologia gli esatti termini cosl suonano: In principio creavit Deus caelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua et tenebrae erant super faciem f~~ssi et .sJ:?iritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus ~at lux .. Et facta. e~t
x. _Et v1d1t Deus quod esset bona et divisit lucem a tcnebns ... . S1 ha, qumd1, c~nsistenza luministica totale gi in principio; cui solo nel dies quartus terr dietr? _la luminosit solare, Dixit autem Deus: :fiant luminaria in firmamento coeli ~t dividant diem et noctem et sint in signa et tempora et dies et annos ut luceant in firmamento coeli et illuminent terram. Fecitque Deus duo luminaria magna ... Et factum t d s . .es . vespe.re et mane, dies quartus . Guardan o con attei:z1one 1 prinn .ve_r-etu 9u1 riportati dal Genesi non si avr difficolt ad ammettere il fondato appiglio
che ci poteva costituire per i teorici del luminismo. Sulla cosa torner a riflet-t~re ~nche Cartesio, facendone parte integrante del piano che sarebbe dovuto sfo-cia~e in Le Trait du monde (mai in effetti potuto arrivare alla sua piena realiz zazione). Gi negli accenni per ~he di qu~sto piano, egli ci fa nel suo Discours
l , h d ' ' , sur a met o e assai chiara anche in lui l'idea di dimostrare che nel mondo tutto proce?e dalla. luce. Sull'argomento, cfr. G. FEDERICI VESCOVINI, St:1di sulla pro-spettiva, medievale, G. Giappichelli Editore, Torino, 1964, Introduzione.
2 S. Th. I, Qu. LXVII, art. IV :i Per un confronto tra il creazionismo totale postulato da S. Tommaso e
l'adesione. percepibile (o meno) in Dante, cfr. B. NARDI, Dante e la cultura. me_dio-evale, Bari, Laterza, 211 ed. 1949. Particolare importanza, da questo punto d1 vista, hanno i saggi Se la prima materia era da Dio intesa {p. 248) e Tutto il frutto ricolto del girar di queste spese (p. 309). '
4 Assai felice la presentazione che di questa ~onaventuriana materia in-form1s ci offre E. BETTONI, in s. Bonaventura, Brescia, .La Scuola Ed., 1945, dove (a p. 94) del tutto esplicita l'interpretazione fisica data a questo pre-supposto bonaventuriano.
- 14 -
-
sata ad essere il tale o tal'altro corpo. Materia informis come qualcosa di simile (ci precisa ancora E. Gilson sul filo d'un imma-ginismo particolarmente felice) la masse de chair encore indif-f.renci~ qui ~onstitue l'embryon ; da vedere in quel suggestivo clima di grandiosa attente universelle de Dieu cui chiaramente allude lo stesso Bonaventura: Materia in diversis suis partibus quamdam diversitatem imperfectam ha-bebat, non ex diversis actibus completis, sed magis ex appetitibus ad diversa 1
Che sul piano estetico tutto qui fili alla perfezione sarebbe in-giusto non ammetterlo; il campo, per, entro il quale ci stiamo muovendo ha anche una sua logica strettamente metafisica; e da que-st'angolo visuale l'apparente equidistanza di S. Bonaventura non tarda a rivelare la vera meta verso la quale essa tende per una sua finale giustificazione metodologica. In cosa, infatti, verr a precisarsi lo specifico dinamismo da cui tale attente universelle sar soddi-sfatta? Si tratter di vero intervento divino esplicato nel pieno respiro d'un creazionismo totale o si tratter d'un primo saggio di esplosivit energetica praticamente controllata dalle leggi del lumi-nismo grossatestiano? Ben riflettendoci non tarderemo ad optare per questa seconda ipotesi verso la quale il Gilson ci spinge con chia-rezza estrema, segnalandoci nelle premesse scientifiche oxfordiane il vero sostegno della lux corporalis ~ in cui si concreta l'inter-pretazione da S. Bonaventura data al fiat lux . Solo, infatti, con tali premesse (essenzialmente basate sul concetto della vis multi-plicativa lucis ) diverr pienamente giustificabile il caposaldo me-tafisico che S. Bonaventura cos ci precisa: Duplex est informatio materiae corporalis, quaedam generalis, quaedam specialis; genernlis per formam communem omnibus corporalibus, et haec est forma lucis; specialis vero per alias formas ... :i.
C' proprio molto spazio tra questa duplicit di formae da S. Bonaventura sostenuta e il preciso' tracciato scientifico su cui poggiava il luminismo grossatestiano? Tutt'altro!
1 In lib. II.ttm Sent. 12, 1, 3, concl. t. II, p. 300. '.! Secundum hanc igitur positionem ( quella cui S. Bonaventura aderisce) est~ quod Scriptura per lucem illam, quam dicit prima esse factam, corporalem lucem insinuant . In lib. Il.ttm Sent. 13, 1, 1, p. 313.
3 In lib. II.wn Sent., 13, divis. Textus, t. II, p. 31.
-15-
-
Ancor pi chiaro ci diverr col passaggio immediatamente se-guente. Stimolata, infatti, dal misterioso spunto biblico, la polemica luministica trovava modo d'alimentarsi ulteriormente subito dopo, approfondendo il presupposto su cui la prima conclusione si basava; affrontando, cio, il problema dell'ubicazione da dare alla lux entro l'ambito delle formae che dinamizzano la materia . Sar vera realt di forma substantialis , come senza esitazione alcuna aveva affermato il Grossatesta o, al contrario, sar semplice forma accidentalis , come vuole S. Tommaso?
Il punto particolarmente adatto per ben cogliere l'esatta por-tata dello spazio polemico che si schiude di fronte a noi; e lo (non sar male precisarlo sin d'ora) per un primo precisarsi di riflessi che toccano la stessa sfera psicologica prima ancora che quella sem-plicemente logica. Accostiamoci ad esso prendendo prima atto della meticolosit con cui S. Bonaventura fissa l'ambito raziocinativo in cui collocare la sua posizione mediana: Q~idam (, per l'esattezza, il punto di vista cui aderisce S. Tommaso) enim dicere voluerunt, quod lux est accidens corpori luminoso, sicut sa-pientia sive scientia, quae est lux spiritualis, est accidens ipsi animae, et sicut color est accidens corpori terminato, et sicut calar est accidens corpori calido. Dixerunt enim, quod sic se habet corpus luminosum ad lucem, sicut anima ad cognitionem, et sicut corpus terminatum ad co-lorem, et sicut corpus calidum ad calorem, quoniam per ipsam decoratur,
P~: ipsam sentitur et per ipsam operatur; et ideo, si dicatur forma no-bihs, hoc non intelligitur quantum ad esse primum, sed quantum ad esse secundum; sicut scientia et gratia nobilissimae formae ponuntur, quamvis accidentia esse dicantur. Et sic pro magna parte rationes evadunt 1
In senso diametralmente opposto suoner il punto di vista ri-portabile invece aila scuola oxfordiana: est alia positio, quod lux est forma substantialis corporum, secun-dum. ~ius maiorem et minorem participationem corpora ha ben t verius et d1gmus esse in genere entium. Unde nobilissimum corporum, sicut est empyreum illud, est praecipue luminosum, infmum vero, sicut terra, maxime est opacum, intermedia vero, secundum quod sunt magis et minus nobiliora, participant plus et minus. Et quod omnia corpora na-turam lucis participent, hoc satis de plano ostendunt, quia vix est corpus
1 In lib. II.um Sent., 13, t. II, p. 320.
- 16 --
-
opacum, quin per multam tensionem et politionem possit e.ffici lumino-sum, sicut pater, cum de cinere fit vitrum, et de terra carbunculus i.
In questo schermo polemico come si preciser il tentativo di mediazione nuovamente praticato da S. Bonaventura? V, erum es: ... qu~d lux, cum sit forma nobilissima inter corporalia, sicut di~unt philosoph1 et Sancti, secundum cuius participationem maiorem et mmorem s~nt corpora magis et minus entia, est substantialis forma. Ve-rum est etrnm, quod cum lux sit per se sensibilis, sit etiam instrumen-tum operandi, sit etiam augmentabilis et minuibilis, salva forma substan-tiali, quod ipsa habet naturam formae accidentalis '.!.
Equidistanza perfetta, apparentemente. Non cos, per, andranno le cose sul piano dei riscontri pratici, dove ben presto verremo a tro-varci nuovamente in vera anticamera oxfordiana, come ci fa rilevare il Gilson con un deciso Il n'y a pas de media via entre les deux opinions 3
Il ragionamento, ovviamente, qui rischierebbe di vanificarsi nel-l'equivoco pi deteriore qualora fosse avulso dall'esatto contesto lo-gico in cui il concetto di forma 1 viene a situarsi nei rispettivi sistemi e dalle conseguenti, pressoch infinite, sfumature interpreta~ tive di cui esso era passibile. Fuor di dubbio , per, la possibilit che qui pure si ha di stabilire un comune punto di riferimento nei cui confronti veder poi automaticamente precisarsi gli atteggiamenti
1 In lib. II.um Se11t., 13, v. II, p. 320. :2 I bidcm, p. 321. Particolarmente significativa (nel giro delle precisazioni che
troviamo effetttrnte) quella cosl leggibile: non sentitur: (soggetto, naturalmente, la luce) ratione suae essentiae, sed ratione fulgoris vel coloris cam inseparabiliter concomitantis, maxime ubi est vehementia lucis .
3 L'expression dcs scoliastes (quella leggibile, esattamente, al termine della Quaestio dedicata al problema di cui ci stiamo occupando) S. Bonav. pro more suo viam mediam inter utramque opinionem aggreditur , n'cst pas tout fait exacte, car, en acceptant la deuximc thse pour la lumire et la premire pour le rayon 1umineux, Saint Bonaventure passe par-dessus l'objection fondamentale dc Saint Thomas: Impossibile est ut id quod est forma substantialis in uno sit forma accidentalis in alio . Si d'ailleurs tous Ics corps participent la meme forme substantielle, la Iumire, il faut admettre la pluralit es formes. Il n'y a pas de media via cntre les deux opinions .
-i Tale discorso sulla diversa interpretabilit del termine forma viene, na-turalmente, ad acutizzarsi con il pensiero moderno, tanto da una parte portato ad accentuare la centralit tematica detenuta da questo termine quanto a diversificarne le possibili accezioni. Si pensi ad un Kant o, meglio ancora, alle varie forme dello Spirito emerse in sede idealistica.
- 17 -
-
pi diametralmente opposti; come, ad esempio, qui ci dato nuo-vamente riscontrare con un S. Tommaso per il quale la luce non solo non forma substantialis universalmente concomitante la materia, man stesso dove essa costituisce un nobilissimo fatto di pre-senza (nel sole, cio) si lascia agevolmente relegare a semplice ruolo di qualitas activa appoggiata ad un'altra forma substantialis del tutto autonoma ed indipendente: quella del sole, esattamente, ri-spetto alla quale la luce forma accidentalis nel senso pi espli-cito della parola 1
La rassegna delle apparenti equidistanze potrebbe continuare ancora; ad esempio, seguendo il propagarsi della luce lungo la qua-dripartizione (lux - lumen - radius - splender) che tanta incidenza ha gi nello stesso Dante del Convivio 2 ; ma punto troppo connesso con i presupposti gi visti per poter comportare vere differenziazioni rispetto al gi detto. Pi utile ci sar fissare un'attenzione conclu-siva sul problema non meno dibattuto e col quale dovremo per forza incontrarci nell'esaminare il luminismo dantesco: l'entit celeste fun-gente da involucro al restante universo.
I termini della polemica questa volta cosl si lasciano riassumere: semplice primo mobile fatto di luce come vorrebbe la tesi scien-tifica sostenuta dagli oxfordiani, o cristallino acqueo , come in-vece vorrebbe la tesi tomista qui pure ligia al biblico fiat frma-
~entum in medio aquarum, et dividat aquas ab aquis ? Ascol-tiamo nuovamente S. Bonaventura:
aliqui (gli oxfordiani) sequentes viam rationis et mundanae philo-sophiae, dixerunt, quod supra firmamentum, quod est caelum sidereum, nu.ll~e sunt aquae corporales, et Scriptura sacra intelligi debet de aquis spmtualibus ... alii (posizione tomista) innitentes textui sacrae Scripturae, secundum quod videtur sanare, dixerunt, quod aliquod caelum sursum est, quod est aquae naturae, quod divina dispositio sursum posuit ad refrigerandum ardorem aetheris ... est tertius modus dicendi (quello di
1 Cfr. testo qui riportato a p. 106. '.! H testo del Convivio cui qui subito dat? ~ensa.re quello leggibile al
Tr. III, XIV, 5-6: Dico che l'usanza de' filosofi e di ch1am~re
-
S. Bonaventura aderisce) quod supra frmamentum, sicut dicit Scriptura, sunt aquae, guae tamen non habent naturam et speciem aquae elementi. censentur tamen aquae nomine propter convenientiam in aliqua pro: prietate 1.
Ancora una volta: c' molta differenza tra queste aquae bonaventuriane che censentur aquae nomine propter convenientiam in aliqua proprietate e le aquae spirituales di cui poco prima ci ha parlato la scuola oxfordiana? Scorrendo le ulteriori delucida-zioni che subito dopo ci vengono da S. Bonaventura offerte non lo si direbbe davvero; donde il nuovo suffragio che per tal via viene ad avere l'incidenza oxfordiana di cui ci stiamo occupando e con la quale non pu non esser venuto a contatto un Dante che, oltre a sorprenderci gi nel Convivio ~ con qualche omissione troppo sco-pertamente intenzionale, poi tutto intento nel Paradiso a delineare i dettagli dai quali ogni traccia di spunti acquei sar completamente assente 3
Con ci, beninteso, ci si guarda bene dallo sminuire il diretto influsso esercitato su Dante in chiave luministica da S. Bonaventura, del quale perfettamente valida resta l'intera incidenza solitamente ammessa; e, prima ancora, ci si guarda dal ridurre a mero collezio-natore d'insostenibili posizioni mediane un pensatore alla cui origi-nalit rende fortemente omaggio, attraverso le pericolose conse-guenze estreme tirate dal De Intelligentiis, proprio l'instabilit di posizione subito avvertibile non appena usciti dal dosatissimo equi-librio che S. Bonaventura ha sempre cercato in tutte le maniere. Ci di cui unicamente ci si preoccupa l'evitare che la lezione bonaven-turiana continui ad ergersi, per nostro mancato approfondimento di prospettive, quale argine negativo dolorosamente destinato a pre-cludere un completo incontro col vero luminismo dantesco. Il S. Bo-
i In lib. II.1m1 Sent., dist. XIV, Art. I, Quest. I, Conclusio, p. 337. ~Mi riferisco sin d'ora alla specificazione acquea che vedremo soppressa
in un dettato dantesco totalmente ricalcante il precedente dettato tomista dove essa, invece, era chiaramente leggibile. Per il confronto tra i due testi dr. quanto verr detto a p.
3 Anche per questo dettaglio rimando a ci che verr pi ampiamente illu-strato appresso.
-19-
-
naventura pi autentico (quello, per intenderci, del luminismo bea-tificante 1 , suggestivamente disteso tra lo splendore delle bianche stole '.! e la refulgentia exstatica del Cristo glorioso 3 ) rester sempre, per di pi arricchendosi d'un merito forse a tutt'oggi scar-samente attribuitogli in critica dantesca: il merito, cio, d'aver allar-gato la lezione direttamente esercitata spingendo gi lui stesso le attenzioni di Dante verso quella dimensione metafisico-scientifica che questi, grazie ad un'eredit tomista altrettanto fervidamente accettata, avrebbe poi saputo assorbire previa neutralizzazione delle sue conseguenze estreme, come gi potutosi rilevare I.
Discorso del tutto identico quello che ora ci suggerir S. Tom-maso, sul quale, dopo le chiamate in causa gi avvenute nelle pagine precedenti, pochi rilievi potranno bastare.
Si , per caso, voluto far di lui un retrogrado esibendolo, ri-spetto al progressismo oxfordiano, in posizione ancora pi distan-ziata che non lo stesso S. Bonaventura? Tutt'altro! Se ne sempli-cemente voluto fare l'autorevole interprete di un'altra esigenza este-tica non meno necessaria per la comprensione d'un respiro poetico che svela la sua vera portata solo allorch si riusciti a sostituire l'in-
1 Per un completo raffronto della lezione bonaventuriana riflessasi in Dante . sempre utilmente consultabile L. CICCHITTO, Postille bonaventuriano-dantesche, I\.:ilano, .1.940. Sullo specifico tema del luminismo beatificante sono, ovviamente ..
ripens~b1h con estrema utilit tutti i dettagli da S. Bonaventura offertici a questo proposito. n~ll' fo quartum librum sententiarum; sia nella parte I (Art. un. De .beatztudme) che nella parte II (Sectio I: De gloria corporis in generali e Sect10 II: De gloria corporis in speciali).
'.! Si ripensino, su questo tema, le felici annotazioni che cosl frequentemente S. Bon~ventu~a ci offr.e nei suoi Opuscula mystica: O anima, cogita, qualis tibi tunc. ent gloria, cum mduta fueris illa stola nova et splendida, ornata omni lapide pret10so, et est c.orpore glorificato, in quo tot fulgebunt gemmae pretiosissimae, quod modo sunt virtutes in mente. Cfr. Seraphici Doctoris S. Bonaventurae Decem Opuscula ad Theologiam mysticam spectantia. Ad claras aquas 1896, p. 157.
1 L'o~era ~eglio i~dicata. per questo motivo della rcfulgentia exstatica del
Cristo glorioso e Collatzones m Hexaemeron edita nel 1934 da F. DELORME. So-prattutto la visio IV ci ofire spunti particolarmente suggestivi quali: Prima ergo consideratio caelestis Monarchae comparatur luci solari propter tria, scilicet propter fulgorem puritatis praecipuae, propter fulgorem limpiditatis praeclarae, propter ful-gorem inflammationis vivifcativae (p. 224 ).
1 Cfr. quanto gi documentato alla n. 3 di p. 7-8.
- 20
-
dole eclettica, tante volte in Dante ravvisatasi, con la cosciente sintesi da lui praticata tra quanto di meglio era percepibile in chiave estetica nei due mondi in contrasto 1
Qualche accenno in chiave di libert S. Tommaso ha gi saputo offrircelo, oltre che con lo splendido come i piacque di Par. XXIX, con quanto potutosi riscontrare agli inizi della polemica luministica; laddove, cio, all'embrionale materia luce (cosl vicina alle istanze emanatistiche di platonica origine) lo vedevamo opporre un libero creazionismo divino gi estrinsecantesi in maniera integrale.
Se, dopo questa prima rivendicazione di libert da lui effettuata a livello divino, noi potessimo seguirlo lungo l'intero discorso poi svi-luppato in termini di libert, non stenteremmo a veder confermata questa medesima linea, trasformantesi ad un certo punto da prero-gativa di Dio in sacro retaggio dell'uomo, libero lui pure non gi nell'evanescente misura consentita dall'indirizzo neoplatonico:!, ma nel ben diverso clima emerso con S. Tommaso sia sul piano della dignit individuale sia su completa prospettiva sociale. N gran ch ci vorrebbe per vedere come tutto questo abbia potuto risolversi per Dante in fonte di suggestioni estetiche altrettanto fertili di quanto, su opposto registro, veniva per lui ad essere l'universo di luce schiusogli innanzi dalle metodologie oxfordiane verso le quali la lezione bonaventuriana lo spingeva.
Se a ci rinunciamo per non allontanarci troppo dal centrale tracciato in cui ci stiamo muovendo, inevitabile, per, verr ad essere il far leva sui suoi accalorati interventi polemici come spie d'una presenza oxfordiana che, riconoscibile ancor oggi, tanto pi lo era ai tempi di Dante.
1 Il tema del Dante
-
Ne vogliamo la prova? Baster ripercorrere i passi tomisti dei quali, occupandoci di S. Bonaventura, abbiamo appreso solo in via indiretta il contenuto. In essi, anche in atmosfera culturale ormai lontanissima da quella in cui visse Dante, tutt'altro che difficile sar individuare i pi autorevoli rappresentanti del pensiero oxfordiano dietro gli a1ii ivi esibiti (pur in clima di pieno anonimato, come voleva l'uso del tempo) sul banco degli accusati: Alii ... dixerunt, quod lux est forma substantialis Solis. Sed hoc etiam apparet impossibile propter duo. Primo quidem quia nulla forma sub-stantialis est per se sensibilis: quia quod quid est est obiectum intel-lectus ut dicitur in III de Anima lux autem est secundum se visibilis. Secundo quia impossibile est ut id quod est forma substantialis in uno, sit forma accidentalis in alio: quia formae substantiali per se convenit constituere in specie: unde semper, et in omnibus adest ei. Lux autem non est forma substantialis aeris: alioquin, ea recedente, corrumperetur. Unde non potest esse forma substantialis Solis. Dicendum est ergo, quod sicut calar est qualitas activa consequens formam substantialem ignis; ita lux est qualitas activa consequens formam substantialem Solis, vel cuius-cumque alterius corporis a se lucentis, si aliquod aliud tale est 1
Non solo i maestri oxfordiani saranno sempre presenti, in forma ben riconoscibile, ma addirittura verranno fatti bersaglio di un calore polemico che non esita perfino a tacciarli di ridicolo.
Si... lumen esset corpus, quando aer obtenebrescit per absentiam lumi-n~ris, sequeretur quod corpus luminis corrumperetur, et quod materia ems acciperet aliam formam; quod non apparet, nisi aliquis dicat, etiam tenebras esse corpus. Nec etiam apparet, ex qua materia tantum corpus,
q~od re?let medium hemisphaerium quotidie generetur. Ridiculum est etiam d1cere, quod ad solam absentiam Iuminaris tantum corpus corrum-pat~r. Si quis etiam dicat, quod non corrumpitur, sed simul cum Sole ac-
c~d1t.' et circumfertur, quid dici poterit de hoc quod ad interpositionem alicums corporis circa candelam tota domus obscuratur 2 ?
Di ci potremo ancor meglio prendere atto con il De I ntelli-gentiis, altro documento al cui proposito (nonostante gli accosta-menti gi tante volte avutisi in pi che autorevoli settori dell'ese-
1 S. Th. I, qu. LXVII, art. III. 2 S. Th. I, qu. LXVII, art. II.
22 -
-
gesi dantesca 1 ), c' pure da faticare non poco per infrangere lo scet-ticismo tutt'ora esistente agli effetti della diretta conoscenza potu-tasene avere da parte di Dante.
Sull'argomento faranno luce in seguito vari elementi, tra i quali lo stesso dettato poetico, destinato a rivelarci coincidenze troppo sco-perte per non doversi parlare di precisi echi in Dante avvertibili. Qui giover, invece, il rilevare riverberi incidenziali trasmessici da S. Tommaso in termini che questa volta trasbordano completamente il metodo dell'anonimato solitamente risoltosi in un generico alii . Della precedente prassi polemica tomista rester ancora il calore, o, per essere pi precisi, il tipico linguaggio da battaglia risoltosi in chiara denuncia di nessuna autorit ( non.... auctoritatis ali-cuius ); del tutto esplicito, per, verr ad essere il riferimento: Contrarium concedimus, quamvis Liber de intelligentiis non sit auctoritatis alicuius, nec etiam verum sit quod omnis influxus sit ratione lucis, nisi lux metophorice accipiatur pro omni actu ... 2
Nei concreti sfondi polemici qui ricostruiti tutt'altro che in-giustificata verr ad apparirci, penso, l' incidenza di cui stiamo parlando.
Estranei al discorso dantesco il Grossatesta e gli altri oxfordiani potranno forse apparire a noi, lontanissimi da un clima nel quale la schermaglia polemica soggiaceva ad identificabilit di bersagli faci-litata dalle stesse ufficiali censure che con tanta frequenza a tali scher-maglie so levano tener dietro sia di qua che di l della Manica; estranei non apparivano affatto ad un Dante che (grazie, ripeto an-cora, all'intimo nesso corrente tra i pi centrali canoni luministici e la pi determinante tematica filosofica) se li vedeva comparire innanzi continuamente anche soffermandosi sui manuali scolastici di pi ine-vitabile accesso; talch, se volessimo esprimerci per via di parad~~si, dovremmo parlare di conoscenza con essi da Dante fatta non gia a
1 Mi limiter a ricordare gli accenni gi in tal senso fatti vari dece~ni. or sono da B. NARDI (cfr., ad esempio, Intorno al tomismo di Dante e alla qmstron~ di Sigeri, Leo S. Olschki Editore, Firenze, Lungarno Acciaioli, 4, p. 8) e quelli pi recenti effettuati da R. GUARDINI nel suo Landschaft der Ewigkeit, Kosel Verla~, Mi.inchen, 1958 (cfr. p. 40) o da J. A. MAZZEO nel suo Structure and Thought m the Paradiso, Comell University, Ithaca, New York, 1958.
2 Questiones quodlibetales VI, 11, 19.
- 23
-
seguito dei trenta mesi trascorsi m assiduo studio nelle scuole dei religiosi, ma a seguito dei primi giorni appena.
.... ;'( ;':
Un terzo elementQ su cm e dato far leva come riprova dell'in-cidenza oxfordiana da Dante avvertibile restringe ancor pi (come gi precisato) l'ambito geografico doverosamente esplorabile. Dallo schermo polemico parigino, in cui per lo pi ebbero a verificarsi le dispute sin qui ricordate, c' da portarsi in zone sulle quali ogni pos-sibile divergenza (rispetto all'avvenuto soggiorno di Dante e ai con-nessi contatti culturali) cessa nella maniera pi assoluta 1 : Firenze e Bologna, ambedue analizzabili sia come centri di studio neoplato-nicamente improntati sia come cenacoli francescani ovunque caratte-rizzati da ampie tracce dell'appoggio che l'Ordine aveva ricevuto in Oxford da R. Grossatesta 2
Per quanto riguarda Firenze, il primo e principale aspetto su cui fissare la nostra attenzione concerne, ovviamente, la Biblio-teca di S. Croce ch' punto agevolmente verificabile grazie ai risul-tati ottenibili integrando le indicazioni dell'inventario-Mazzi 3 con
1 ! dati relativi all'accoglienza fatta in Inghilterra dal Grossatesta ai france-scani c1 vengono trasmessi da T. EccLESTON (Fratris Thomae vulgo dicti de Ec-cleston Tractatus de adventu Fratrum Minorum in Angliam). Per quel che poi ri-guarda la ricca schiera di maestri francescani usciti dalla scuola del Grossatesta n?n si stenta a ravvisare in essi il fior fiore dell'intellettualismo minorita: Adamo d1 Marsh, Riccardo Rufo Tommaso di York Bartolomeo Anglico, Ruggero Bacone cd altri. ' '
:.? Molto a proposito qui interviene un ricordo delle prescrizioni piuttosto ri-gide che (a differenza di quanto praticato gi in questo campo dai Domenicani) c~ntroll~vano gli sviluppi delle biblioteche francescane, visibilmente jmprontatc al clima di austerit che regnava in tutta l'atmosfera dell'Ordine. Sull'argomento mi sembra opportuno anticipare questi rilievi dal saggio di F. Mattesmi cui tra non mol.to faremo abbondante ricorso. Per l'ordine domenicano noto che fino dal capitolo della Provincia romana tenuto a Perugia nel 1261 i frati potevano, priva-ta~en~e, ritenere danaro per l'acquisto di libri... Le Costituzioni provinciali dc:i frati mmon ?ella Toscana promulgate subito dopo il 1316 mentre contemplano 11 caso ~el sacnsta .che senza licenza del superiore non poteva ven
-
glyi apporti recentemente offertici da F. Mattesini 1 e, pi ancora, da Ch. T. Davis 2
Scorrendo l'inventario-Mazzi, registrante lo status di biblio-teca esistente verso la met del sec. XV, non si tarda affatto a coaliere l'impronta marcatamente oxfordiana che caratterizza l'intera biblio-teca, centralmente strutturata in Firenze nell'esatta maniera in cui avrebbe potuto esserlo in Oxford; come, anzitutto, attestatoci dalla compatta presenza di tutti i maestri che oltre Manica avevano pi cooperato al successo dello studium poi servito da rifornimen-to a tutti gli altri centri dell'Ordine.
Vediamone alcuni di questi maestri, senza lasciarci troppo im-pressionare dalla difficolt insita nel non trattarsi (per il Grossatesta) degli specifici testi qui appresso leggibili o, nel caso degli altri mae-stri, d' opere prevalentemente impegnate su argomento lumini-stico. Vale, infatti (qui assai pi che altrove), quanto abbiamo gi detto circa l'assoluta centralit detenuta dal problema luministico nell'intera tematica del tempo. Qui si ha, per di pi, a che fare pro-prio con la scuola che dalla luce faceva partire l'intero suo ragio-namento filosofico. Per quanto poi riguarda il Grossatesta, il conte-nuto luministico percepibile attraverso i suoi commenti 3 aIIo pseudo-Dionigi non ha proprio nulla da invidiare ai trattatelli esplicitamente impegnati su tal tema.
Ci premesso, accostiamoci agli autori maggiormente connessi con il nostro assunto cominciando ovviamente dal Grossatesta soli-
' tamente qualificato con l'epiteto episcopale di lincolniensis . Di lui abbiamo: 1) Computus lincolniensis: invent. n. 109. (In decimo bancho ex
parte ecclesie). 1 F. MATTESINI, La biblioteca francescana di S. Croce e Fra Tebaldo della
Casa, in Studi Francescani, Anno 57, Luglio-Dicembre 1960, n. 3-4. :! CH. T. DAvrs, lo studioso al quale si devono i contribut_i maggiort?ente d_e-
cisivi su questo argomento. Ai due saggi cui faremo tra poco ricorso aggmngo s111 d'ora il Dante and the Idea o/ Rome, Oxford, At the Clarendon Press, 1957.
:i A volte tale fertilit metodoloo'ica Iuministicamente conformata potrebbe apparire meno evidente nel Grossatesta~ traduttore dello pseudo-Dionigi. presso il quale fortemente operante il puro rigore filologico; sl da trovarcisi assai spesso di fronte ad espressioni assai meno esuberanti di quelle che in simili casi ci danno altri traduttori. (Vedasi, ad esempio, il confronto fattibile attraverso il cap. III del De coelesti hierarchia). Non cosl accade nel Grossatesta commentatore, portato a riversarsi sugli originari spunti pseudo-aeropagitici con impegno luministico age-volmente riscontrabile.
-25-
-
2) Dyonisius, de ecclesiastica ierarchia, cum commento lincolniensi: invent. n. 130.
3) Dyonisius aeropagita, de angelica ierarchia et De mistica theologia cum commento lincolniensi: invent. n. 131.
4) Dyonisius, de divinis nominibus cum commento licolniensi (sic) Dyonisius, de divinis nominibus: invent. n. 132-133. (43).
5) De mistica theologia 1 : invent. n. 141. Il Baldini glossa questo manoscritto con le parole interprete anonymo, ut in Cod. II huius plutei supra pag. 427 che corrisponde, precisamente, al n. 131 qui sopra riportato.
6) Kalendarium linconiensis: invent. n. 593.
Con il caposcuola troviamo, uno dopo l'altro, tutti gli esponenti pi significativi, spesso addirittura accompagnati da un gioco di vici-nanze legato in Firenze al nesso logico tipicamente neoplatonico con cui gi Oxford si giungeva a tali autori 2
Tra questi esponenti particolare importanza per noi rappresen-teranno:
1) BARTHOLOMAEUS ANGLICUS , qui pure presente con l'abbon-danza riscontrabile in tutta Italia 3 : a) Liber de proprietatibus rerum. Invent. 598 (in XVI bancho
ex parte ecclesie). b) Liber de proprietatibus rerum. Invent. 621 (in XVIII bancho
ex parte claustri). c) De proprietatibus rerum. Invent. n. 6222 (ibidem).
1 il codice al .quale U. GAMBA si rif per il suo Il com11_1ento .di R. Gros-satesta .al De mystzca theologia dello Pseudo-Dionigi Areopagita, Milano, Vita e Pensiero, 1942.
2 ~rte presenz~ arabe, ad es. (tra cui l'Algazel frequentement~ ricorrente nelle opere d: Tomn;iaso di .York) 0 certe altre appartenenti alla Scuola d1 .Chartr~s (co~e, ad es., il Guglielmo d1 Conches ricordato al n. 561 con un Dragmatzon phzlosophze) soggiacciono, con ogni probabilit, proprio a questo criterio.
3 A parte la concreta documentabilit offribile sul piano dei codici, ci di ci spia qualche volgarizzamento del suo pensiero avutosi anche in lin!?Da italiana, quale quello che il notaio mantovano Messer di Vivaldo Belcazer fece m onore di Guido Bonaccolsi.
- 26 -
-
2) GIOVANNI PECKAM: 1 a) Formula confessionis fratris iohannis de pecciano. Invent.
n. 444 (in tertio bancho ex parte claustri). b) Scriptum ethicorum fratris iohannis de picchiano. Invent.
533 (in undecimo bancho ex parte claustri). Nonch (sicuramente a lui attribuibile nonostante l'ancor pi grave deformazione nominale):
c) Primus iohannis de parciano. Invent. 395 (in XXXIV bancho ex parte ecclesie).
3) TOMMASO DI YoRK 2: Scriptum methaphisica fratris thome de eboraco. Invent. n. 552 (in XIII bancho ex parte ecclesie). Doverosamente commemorabile poi il nome che per noi riveste
speciale importanza agli effetti dell'indagine che appresso faremo come ipotesi attribuzionale sul De intelligentiis: Adamo di Buck-field 3, riccamente rappresentato lui pure con un duplicato completo di tutte le sue opere pi importanti, come avremo modo di vedere appresso.
Sorpresa particolarmente gradita abbiamo al plut. XIII Dext. Cod. XI dove, sotto il generico titolo Dionysi Aeropagitae opera, Hugonis postilla in caelestem hierarchiam et Aristotelis quaedam) ci imbattiamo in una dicitura cosl concepita: VI. pag. 92, Ano-nymi de Intelligentia Liber cum expositione. Inc. summa in hoc Ca-pitulo nostrae intentionis est . Des. inter species quantitatis non est enumerata .
, esattamente, il De Intelligentiis del quale ci stiamo qui occu-pando e, per di pi, proprio nel manoscritto-archetipo che tanto il Bandini quanto il Baeumker 4 fanno risalire al sec. XIII.
1 Ce ne occuperemo ampiamente nelle derivazioni perspectivistiche che con-cludono questo volume.
2 A Tommaso di York dato pensare come approfonditore d'un aspetto che le pagine seguenti ci mostreranno assai centrale nella metafisica della luce: la dimensione musicale, vista soprattutto come fatto cosmico.
3 Sin d'ora rinvio a quanto (come diretta analisi di questo manoscritto-archetipo) verr presto detto in sede di ipotesi attribuzionale per la paternit del De I ntelligentiis.
1 II discorso (su queste indicazioni cronologiche del Baeumker) verr approfon-
dito appresso in sede d'esame di manoscritti.
- 27 -
-
Un problema, ovviamente, subito si presenta alla cui soluzion~ difficilmente potrebbe bastare il puro fatto dell'intrinseca datab1hta dei singoli codici (tutti, per lo pi, risalenti al sec. XIII) e ci per la piena possibilit che essi siano giunti a Firenze dopo il soggiorno di Pante. Tal problema, per, anche a prescindere dai preziosi schia-rimenti che tra non molto ci verranno attraverso i contributi del Mattesini e del Davis, tutt'altro che insolubile. Stante, infatti, la marcatissima centralit strutturale oxfordiana individuabile nella bi-blioteca trasmessaci dall'inventario-Mazzi, non si cade davvero in errore facendo risalire tale impronta sino ai primordi della biblio-teca stessa. E in tal senso palesemente incoraggia sia il trattarsi di testi significanti, per i francescani di tutto il mondo, u nautentico pn-trimonio domestico 1 (quindi raggiungibile con particolare facilit rispetto ad ogni altro fondo di biblioteca) sia il trattarsi di manuali scolastici che gli stessi professori inviati ad insegnare da Oxford in Firenze portavano con s 2 (Non si dimentichi tra l'altro che, come fondi di biblioteca sicuramente addebitabili ai tempi posteriori, ci sono varie altre zone totalizzanti numerose di codici assai cospicuo
3)
Se, di conseguenza, biblioteca c'era ai tempi di Dante (n di questo potremo in alcun modo dubitare), essa non poteva gi non rispondere all'impronta documentataci dall'inventario-Mazzi; quale equipaggia-tissima piattaforma francescano-oxfordiana in tutto corrispondente, come sua centrale fisionomia, a ci che, in senso diametralmente opposto, stava a significare S. Maria Novella 1 totalmente struttu-
~ Particolarmente documentato, in tal senso, lo stesso studio del Mattesini
-
rata, a .su~ volta, lungo. l'indirizzo aristotelico-tomista (a punto tale da sen.tlr~1, non .s?lo spmt~ all'ostracismo pi completo per tutti i maestn pm esplicitamente impegnati in senso oxfordiano, ma per lo stesso S. Bonaventura, rappresentato in forma del tutto insignificante se a verit risponde il quadro contemplabile nell'inventario illustra-toci da St. Orlandi 1 ).
Su ci si aggiunga ora quanto il Mattesini si premurato di do-cumentarci relativamente allo slancio con cui sin dal 1246 (data del-1' acquisto del primo libro) subito ci si impegn per il rifornimento d'uno studium chiaramente destinato, nelle prospettive dell'Or-dine, a raggiungere posizione di primissimo piano ~. Molto, pur-troppo, rimane ancora nell'oscurit sulla rigogliosa vita della S. Croce primitiva; da ci che, per, siamo in grado di conoscere, del tutto indubbio risulta il fatto dell'assoluto primato subito detenuto, tra i problemi di sviluppo, dalla biblioteca, cui effettivamente si pens con forte anticipo sulle preoccupazioni dirette in senso edilizio 3
Con tali premesse ci si porti al periodo che qui ci interessa per il contatto che con S. Croce poteva avere un Dante ormai maturo alla vita intellettuale. , esattamente, il momento in cui imponenza mon-dana (poggiante soprattutto sull'iniziativa di Matteo d'Acquasparta, ministro generale deII'Ordine nel 1287 e Cardinale di S. Romana
sine mora priori provinciali studeant nuntiare . Contro tale atteggiamento viene, invece, a situarsi un dato francescano (riferentesi a questo medesimo tempo) ua smessoci da P. N. Papini nel suo elenco dei primi lectores in fiorentina Unlvc:i: sitate : AccuRSIUS BoNFANTINI. .. Sacrae Theologie Doctor et Lcctor Regens in Coenobio S. Crucis anno 1318, necnon humanioribus cxcultus litteris, edidit, teste viro erudito Laurentio Mehus, in Vita B. Ambrosii Camaldulensis, Expositionem Commcdiae Dantis Aligherii... Hunc puto primum delectum fuisse a Florentinis ad explanandam diebus dominicis Sacram Commediam Dantis in Cathedrali . Cfr. (per questo dato concernente l'ordine francescano) Miscellanea Francescana di Storia, lettere cd arti edita dal Collegio Serafico Internazionale dei Frati Minori Conven-tuali, Roma, 1933, n. s., voi. XXXIII, p. 383. Per il dato, invece, concernente l'or-dine domenicano cfr. Monumenta et antiquitates Romanae Provinciae O.P.I., Romae, 1864, p. 128 dove esso stato per la prima volta pubblicato da P. MASETTI.
1 ST. 0RLANDI O. P., La Biblioteca di S. Maria Novella in Firenze dal sec. XIV al sec. XIX, Firenze, Ed. Il Rosario, 1952. Nell'inventario ivi leggibile l'unico testo bonaventuriano ,registratoci il Sermo11es Bo11ave11ture per anni circulum, non certo sufficiente a colmare la compatta assenza delle altre e ben pit1 importanti opere bonaven turi.me.
2 La geografia scolastica francescana ricordataci dal Davidsohn colloca Firenze, unitamente a Bologna, Tolosa e Colonia, al secondo posto subito dopo i tre studia principalia di Parigi, Oxford e Cambridge.
3 Per Ja storia edilizia di S. Croce: P. S. MENCHERINI, Santa Croce di Fi-renze (memorie e documenti), Tip. Fiorenza, Firenze, 1929.
- 29 -
-
Chiesa nel 1288 1 ) e potere intellettuale (imperniato soprattutto sulla presenza di Pier Giovanni Olivi 2 ) si danno cordialmente la mano attorno ad una linea di studio di cui piuttosto facile definire l'indirizzo. Stenteremo, con ci, a veder confermata gi su mera chiave storica la fisionomia che ci preme fissare per la primitiva atmosfera culturale da Dante respirabile in S. Croce?
Interviene a questo punto il prezioso contributo di Ch. J. Davis del quale segnalo soprattutto due studi: The Early Collection of Books of S. Croce in Florence 3 ed Education in Dante}s Florence 4 Dal suffragio storico qui passiamo a quello del paziente ricamo sui singoli codici dal Davis analizzati con diligenza infinita onde coglier-ne, attraverso le annotazioni spesso fattevi dai rispettivi proprietari 5 , le possibili databilit di introitus .
Agli effetti nostri, purtroppo, un dato riesce particolarmente nocivo: il senso gerarchico che caratterizzava queste annotazioni, tanto facili ad intervenire l dove si trattava di importanti testi scrit-turistici o di auctores d'ormai secolare prestigio quanto, invece, scarse l dove si trattava di puri fatti manualistici nel senso poco fa ricordato proprio nei confronti dei maestri francescani pi frequen-temente ritenuti patrimonio domestico. Ci, per, non impedisce allo stesso Davis, mentre ci segnala le annotazioni che danno ormai per avvenuto il pi massiccio introito di testi aristotelico-tomisti, di riscontrare ancora una marcata impronta neo-platonica; e siamo, si noti bene, gi nei primi decenni del sec. XIV, posteriormente cio al soggiorno fiorentino di Dante.
Dopo quanto rilevato sull'atmosfera neoplatonica respirabile in S. Croce da un Dante sulla cui stessa persona, tra l'altro, gravavano
1 ~ due mansio?i qui rievocate per il D' Acquasparta si fasciano ravvisare gi m. mumo nesso c?n il personaggio qui ricordato subito dopo: P. G. Olivi che pro-prio nel . passaggi~ del D'Acquasparta dalla prima alla seconda mansione vede co~c:e!ars1 a~che il proprio passaggio dal clima di protezione (e quindi di tran quilhta) al rmovato accendersi delle sue precedenti traversie.
2 in Firenze tra il 1287 e il 1289 unitamente all'Ubertino da Casale che tanto gli assomiglia sia come linea ideologi~a che come traversie da lui pure subite.
3 CH. T. DAvrs, The Early collection of books of S. Croce in Florence in Pro-credings of the American Philosophical Society Vol. 107, N. 5, Ottobre, 1963.
1 Education in Dante's Florence in Speculum luglio 1965. 5 Ne ricorder, a puro titolo indicativo, una sola prelevata dal primo dei saggi
del Davis or ora indicati: Iste liber fuit Fratris Phylippi de Sancta Trinitate, quod dedit armario Florentini Conventus .
- 30
-
ipoteche francescane 1 tendenti a rivelarsi sempre pi fondate, c10 che si rende doverosamente segnalabile per Bologna pu ben ridursi a pura postilla passante attraverso la concorde indicazione fornitaci da L. Olschki 2 e da C. Piana 3
Mi riferisco a Bartolomeo da Bologna, sicuramente vissuto in questa citt lungo Pintero arco temporale da tener presente per il sog-g.iorno quivi avuto da. Dante. (I documenti chiamabili in causa ci attestano questa presenza di Bartolomeo da Bologna dall'anno 1282, 7 ottobre, all'anno 1294, 12 luglio). N si tratta di presenza in ruolo di second'ordine, ma in posizione inevitabilmente avvertibile; in qualit, cio, di rinomato professore nello studio qui pure tenuto dai francescani e, pi ancora, in qualit di pi autorevole gerarchia dell'Ordine in forza della sua nomina a Ministro Provinciale avve-nuta nel 1285 e poi protrattasi sino al 1289.
Faremo qui pure leva, per un possibile contatto di Dante con lui, sulle or ora ricordate ipoteche francescane ravvisabili nella stessa persona di Dante? Le segnalazioni dell'Olschki e del Piana ci offrono qualche altro argomento ancor pi confortevole dal punto di vista filologico: le tracce di Bartolomeo da Bologna rilevabili nella strut-tura luministica del Convivio 4 e quelle non meno evidenti perce-pibili nella configurazione della candida rosa .
Ci premesso, non resterebbe, se lo spazio ce lo consentisse, che aprire il Tractatus de luce in cui Bartolomeo da Bologna con-densa il suo luminismo con un'apertura di respiro che dalle pure premesse teoriche si porta alle ultime derivazioni mistiche. Tutto questo accade (e con ci rientriamo sul nostro itinerario logico) con un'incidenza grossatestiana che non solo fatto di spunti teorici ininterrottamente assorbiti, ma esplicito richiamo alla autorit d'un
i Di queste "'
-
,
Commentator 1 nel quale si lascia ravvisare esattamente R. Gros-satesta, dal Maestro bolognese riverito all'interno d'un rispetto subito dopo professato verso gli altri pensatori oxfordiani al Grossatesta maggiormente uniti.
Un ultimo dettaglio vorrei ancora evidenziare a riprova della qui asserita centralit grossatestiana: il suffragio che la cornice sto-rica medievale viene in tal senso a stabilire attorno alla statura umana di R. Grossatesta sia come energico animatore di studi, sia come in-defesso riformatore ecclesiastico. Il primo dato, dopo le fruttuose attenzioni ad esso dedicate da E. Franceschini 2, ormai di pubblico dominio. Per renderci, invece, conto di ci che concretamente signi-ficasse il secondo aspetto, giover collocarsi di fronte ad uno dei Papi che maggiormente hanno dominato l'orizzonte storico cui Dante appoggia il suo sogno politico: Innocenzo IV (il Papa che ha trion-fato su due imperatori l'uno pi terribile dell'altro: Federico II da lui scomunicato al Concilio di Lione e Corrado IV, ridottosi, dopo una tenace lotta, ad affidare al Papa, la tutela del proprio figlio Cor-radina). , tra l'altro, la scena in cui si ambientano le figure di Co-stanza da Dante immortalata fra i tre venti di Soave , del Manfredi biondo .... e bello e di gentile aspetto nonch, su ver-sante oltre-Manica, dell'inetto Arrigo ricordato nel Purg. VII e dell' Inghilese folle commemorato nel Par. XIX.
1 Dell'argomento si gi occupato L. Olschki nel saggio gi rievocato in nota. . ~Ricorder, tra gli altri contributi di E. FRANCESCHINI, R. Grossatesta, Vescovo
dt Lmcoln e le sue tradizioni latine in Atti del R. Istituto Veneto di scienze, let-te:c e? ~rti , XCIII, 1933; Intorno ad alcune opere di R. Grossatesta, Vescovo di Lmcotn m Aevum , l\1ilano VIII, 1934, pp. 529 sgg.
- 32 -
-
LA METAFISICA DELLA LUCE NEI SUOI CANONI ESSENZIALI
In materia notevolmente complessa qual' quella in cui ci stiamo introducendo non sapr, spero, d'eccessivo rigore scolastico il ricor-rere a schematizzazione ben precisa, anticipandone gi in apertura i punti essenziali. Dieci per l'esattezza: sei facenti capo alla metodo-logia grossatestiana, quattro al pi che sospetto (ma, peraltro, coe-rentissimo) sconfinamento che l'autore del De Intelligentiis non a caso proteggeva, come gi visto, col velo dell'anonimato.
I sei punti in cui si lascia raccogliere l'apporto metodologico di R. Grossatesta sono i seguenti:
1) luce come essenza metafisica
2) luce come fatto dinamico
3) luce come impulso sferico
4) luce come gioco coloristico
5) luce come coronamento musicale
6) luce come imperiosit ritmica.
I quattro punti nei quali, invece, condensabile il nucleo este-tico del De Intelligentiis (a cominciare proprio da quello su cui pi si fonda la sospetta atmosfera di panteismo luministico) cosl si la-
- 33 -
-
sciano precisare alla luce del confronto dantesco 1 che ci funge da meta:
1) luce divinizzata 2) luce spazializzata 3) luce principium motus et vitae 4) luce fonte di cognitio e causa di delectatio .
E. De Bruyne \ cui, credo, va riconosciuto il merito di aver n:e-glio puntualizzato il significato estetico del luminismo grossatesua-no, d il via alle sue considerazioni premurandosi, come prima cosa, di mettere bene a fuoco le due eredit che in R. Grossatesta vanno a confluire: la tradizione di Chartres 3 (vista soprattutto nei suoi presupposti neoplatonici) e la tradizione araba 1 (vista soprat-tutto nella sua dimensione luministica).
Con tale patrimonio portiamoci nuovamente alle origini bibli-che dalle quali, nell'occuparci di S. Bonaventura, abbiamo visto par-tire l'intero discorso luministico. Nel connubio tra lo specifico im-pegno che il Grossatesta attinge dalla sua indole di pensatore cri-stiano e la pienezza consentita da queste due eredit culturali cosa verr ad essere il primo frutto della creazione divina?
1 Ad allargamento di quanto qui dichiarato circa la libert con cu~ pr~le-v~amo dal De Intelligentiis i canoni maggiormente atti a lasciarsi ripensare m dtr~zione dantesca, rinvio sin d'ora allo schema che appresso verr dato dell'intero svi-luppo tematico cui tale trattato soggiace.
2 Mi riferisco (per la fondatezza di questo giudizio sulla felicit dei rilievi
fatti da . E. ~e Bruyne in merito all'estetica grossatestiana) a quanto leggibile nel terzo. dei suoi Etudes d'esthtique mdivale, ed. cit., da p. 121 a p. 152. Di tal contributo beneficeremo spesso in queste pagine.
:i Su di una possibile geografia strutturale della scuola di Chartres ho gi avuto m?
-
. Non_ sa~ certo la realt illustrataci da S. Tommaso in quel clima d1 creaz10msmo totale sul quale ci siamo gi soffermati e nemmeno (anche se qui siamo gi assai pi vicini) la pura materia informis fisicamente concepita che soggiace ali' attesa universale descrittaci da S. Bonaventura; ma un qualcosa di essenzialmente metafisico ri-sultante dalla fusione di tre elementi: 1) la sacralit d'un indirizzo biblico (la terra inanis et vacua
gi contraddistinta di lux ). 2) l'autorit di un'indicazione :filosofica (la materia prima neo-
pla tonicamen te concepita). 3) il fascino d'un suggerimento scientifico (l'esplosivit radiante della
luce fisicamente intesa).
Esimendoci dal sottolineare ancora il primo elemento, proviamo ad occuparci del secondo ricorrendo a testo indubbiamente ideale per noi che di esso beneficiamo, ma agevolmente sostituibile 1 con spunti analoghi al Grossatesta sicuramente noti. Si tratta d'un brano di Porfirio ::! nel quale troviamo perfettamente resa l'evanescenza d'una materia prima del tutto disponibile per l'innesto con una lux in direzione radiante:
~ I ,f.' \ ) t;"~ ~) ( I vouc;, OU't'S 't'UX"I), ou sC'J X(X1.T S(XU't'O &'JdEO, &\o':oc;, &m:Lpo, &v(Xoc;. L o: ov, &' &1J~hvv ~ ov, Etwov X(X. Cf>OCV't'XCJ(X oyxou O't'L
' ' ' ,, '~' 't'O 7tpC't'C EV oyxcp, 't'O (X.OU'Jaov,
Materiae proprietates secundum an-tiquos hae sunt: quod sit incorporea; diversa enim a corporibus est: quod vitae expers; neque enim intellectus, nec anima, nec aliquid per se vivens: anima, nec aliquid per se vivens: quod informis, variabilis, infinita, impotens. Propterea neque ens,_ se~ non ens. Neque ita non ens, s1cut1 motus sed verum non ens. Simu-lachru:U et panthasma molle; quia id est, quod primo subest moli: i.m-potens, et appetitio subsistenua:
1 Altro riferimento d'obbligo , a questo proposito, Proda sul quale, tr~ l'altro, oggi piuttosto facile far luce (come gioco di dati ~ultura~mente operan~1 nel Medioevo) grazie agli acuti raffronti fissati dal Pera tra. ~li assc~t~ del De
-
Nel contesto qui delineatosi il primo dei ca.noni in cui ci parso di poter riassumere l'apporto metodologico di R. Grossatesta non stenta a chiarirci il suo vero significato:
Formam primam corporalem, quam quidam corporeitatem vocant, lucem esse arbitrar. Lux enim per se in omnem partem se ipsam diffundit, ita ut a puncto lucis sphaera lucis quamvis magna subito generetur, nisi ob-sistat umbrosum. Corporeitas vero est, quam de necessitate consequitur extensio materiae secundum tres dimensiones, cum tamen utraque, corpo-reitas scilicet et materia, sit substantia in se ipsa simplex, omni carens dimensione. Formam vero in se ipsa simplicem et dimensione caren-tem dimensionem in omnem partem inducete fuit impossibile, nisi se-ipsam multiplicando et in omnem partem subito se diffondendo et in sui diffusione materiam extendendo, cum non possit ipsa forma materiam derelinquere, quia non est separabilis, nec potest ipsa materia a forma eva-cuati. Atqui lucem esse proposui, cuius per se est haec operatio, scilicet se ipsam multiplicare et in omnem partem subito diffundere. Quicquid igitur hoc opus facit, aut est ipsa lux, aut est hoc opus faciens in quantum participans ipsam lucem, guae hoc facit per se. Corporeitas ergo aut est ipsa lux, aut est dictum opus faciens et in materiam dimensiones inducens, in quantum participat ipsam lucem et agit per virtutem ipsius lucis. At vero formam primam in materiam dimensiones inducete per virtutem for-mae consequentis ipsam est impossibile. Non est ergo lux forma conse quens ipsam corporeitatem, sed est ipsa corporeitas 1
Vogliamo ben capire cos' la luce per il Grossatesta? Fissiamo lo sguardo su quest'ultima espressione all'uopo evidenziata in co:-sivo. ci che, fondendosi a livello di forma con una materia prima in tutto identica a quella poco fa descrittaci da Porfirio, crea la corporei tas in s presa o, con altro termine, l' extensum .
Nell'atto, per, in cui ci definisce la lux in senso gen~mamente metafisico, il passo qui riportato ci spinge anche verso il se-condo dei canoni che sopra c' parso di dover evidenziare: la luce afferrata nel suo volto dinamico; nel suo esibirsi, cio, come origine dello stesso movimento universale (alla luce effettivamente sempre
1 De motu corporali et luce, ed. cit., p. 92.
- 37 -
-
riportabile q~alunque sia lo specifi~o tipo di movimento cu1 nei sin-goli casi dato assistere).
Anche da questo punto di vista non potrebbe davvero essere pi completa la casistica dal Grossatesta fissata al momento in cui analizza il passaggio dalla fase strettamente metafisica (la lux-forma prima corporeitatis ) alla susseguente fase dinamica (la lux-primum motivum corporale ): Dico enim quod forma prima corporalis est primum motivum corporale. Illa autem est lux, quae cum se multiplicat et expandit absque hoc, quod corpulentiam materiae secum moveat, eius pertransitio per diaphanum ft subito et non est motus, sed mutatio. Quando vero est lux expandens se in partes diversas, ista incorporatur materiae, si corpulentiam materiae secum extendit, et ft rarefactio materiae vel augmentum. Quando vero congregatur lux in se um corpulentia materiae, fi.t condensatio vel di-minutio. Cum vero lux secundum unam viam se generat secum trahens materiam, ft motus localis. Cum vero lux, aquae est intra materiam, mit-tatur foras et quod foris est, immittit intus, :ft alteratio. Et in hoc patet, quod motio corporalis est vis multiplicativa lucis. Et hoc idem est appeti-tus corporalis et naturalis 1
Giungiamo con ci all'aspetto sul quale lo stesso E. De Bruyne pi concentra la sua attenzione invitandoci a contemplare l'universo d:scritto dal Grossatesta nel suggestivo volto di immense enche-
vetr~ment de sphres et de cones, de lignes et de plans, de courbes et d angles 2
1 De luce seu de inchoatione formarum, ed cit., p. 51.
2,Val la pena di ripercorrerselo tale testo, di E. De Bruyne, particolarmente
espressivo da questo punto di vista: En ce qui concerne les figures, rappelons-nous qu' l'exemple de la sphre universellc forme par la diffusion de la lumire, ~ous les volumes sont conus (dal Grossatesta evidentemente) comme des champs de clirces .. La proprit fondamentale de la corporit est de s'tendre dans les trois mension~,de l'espace. Or, le principe de cette extension ne peut tre que Ja force de la lumiere ou une autre nergie qui participe de son pouvoir. Les volumes nais-sent clone .?e l'expansion d'une nergie fondamentale qui vainc diversement l'inertie de la matiere, se diffusant plus facilement un endroit, se ramassant davantage un autre. Si la farce lumineuse suit des lois mcaniques simples, il va de soi que tous les volumes se rduisent des structures gomtriques lmentaires. Sur la ~onfiguration des volumes influent, d'autre part, les forces cosmiques qui agissent a travers l'atmosphre. Le rayonnement de la matire produit, en effet, les sphres celestes et par leur intermdiaire, les formes terrestres qui, leur tour, ragissent les unes sur les autres. Toute action exprime l'nergie totale ou partielle de l'agent. Lorsque l'agent n'engage qu'une partie de la farce, son mouvement s'exprime par
- 38 -
-
Luce come propagarsi sferico, anzitutto. l'autentico leit-motiv dell'intero De Luce che su di esso (all'interno del primo te-sto riportato) ci ha gi regalato un prezioso dettaglio agevolmente impegnabile in senso dantesco come fondamento dei rapporti che tante volte vedremo da Dante evidenziati tra centrale punto lumi-noso e sfera attorno ad esso generatasi:
Lux enim per se in omnem partem se ipsam diffundit, ita ut a puncto lu-cis sphaera lucis quamvis magna subito generetur, nisi obsistat umbrosum 1
ma spunto altrettanto ritornante nei seguenti trattati dove esso viene sottoposto ad approfondimenti sempre pi ricchi:
Omne enim agens multiplicat suam virtutem sphaerice, quoniam undique, et in omnes diametros: sursum deorsum, ante retro, dextrorsum sini-strorsum. Quod patet per hoc, quod qua ratione ab agente posito loco centri contingit protrahere lineam in unam partem et in omnem secun d d h
. 2 um omnes differentias positionis: quapropter oportet, quo sp aence
e soprattutto tema destinato a schiuderci prospettive di suggestion~ immensa, come ad esempio constatabile con le grandiose c~scate ~t luce cui ben si lascia accostare il formarsi delle sfere celesti descrit-toci dal Grossatesta in base al principio della luce che incessa~te~ mente si raref e poi si condensa in sfere minori per tornare quindi a rarefarsi subito dopo:
S. I I h am secun-tcut autem umen genitum a corpore primo comp ev1t sp aer, dam et intra secundam sphaeram molem densiorem reliquit, sic lumen ge-nitum ex sphaera secunda sphaeram tertiam perfcit et infra ipsam sphae-d
i Atque a ram terttam molem adhuc densiorem congregauone re 1quit. h d . . . . d' donec complerentur une or mem processlt 1psa congregat10 1sgregans, . f novem sphaerae caelests et congregaretur inter sphaeram nonam in mam
d I. d , ' d' 'flchies perpendicu-es 1gnes ro1tes ou courbes directes ou bnsees, e est-a- tre re ' , , laires ou obliques. Lorsque l:aoent agit de toutes ses nergies, le. mouvement sex-prime par une sphre d'action I:> s'il ne vise pas un point particuher - ouLpa~ un
' e rmzvers eone ou une pyramide s'il concentra sa force totale sur un pomt umqu d
' d ' h .. d he'res et de cones. PS se presente onc comme un 1mmense enc cvetrement e s , l d lignes et de plans, de cottrbes et d' angles, qui en dernire ,a?alyse resu trt u rayonnement incessant de la lumire, diversifi d'aprs les reststences de a ma-tire (Op. cit., Vol. III, p. 143).
1 Dettaglio interno dal passo del De luce citato da ultimo. ~De lineis angulis et figuris seu de fractionibus et refiexionibus radiorum, ed. cit., p. 64.
- 39 -
-
moles densata, quae esset quattuor elcmentorum materia. Sphaera autem infima, quae est sphaera lunae, ex se etiam lumen gignens, lumine suo et molem infra se contentam congregavit et congregando partes eius extimas subtiliavit et disgregavit 1
Nient'affatto minore sar la compiacenza con cui il Grossatesta da questo primo trionfo geometrico sfericamente concretatosi passa a ragguagliarci su aspetti affini traducentisi, ad un certo punto, in un autentico cubismo energetico 2 gi denso di tonalit del tutto in linea con esperienze artistiche a noi vicinissime. Materialmente presa, l'espressione cubismo energetico ancora del De Bruyne; ma il contenuto ad essa rispondente grossatestiano nel senso pi genuino, fin a livello di conferme lessicali d'evidenza estrema: Si enim lux multiplicatione sui infinita extendit materiam in dimensionem bicubitam, eadem infinita multiplicatione duplicata extendit eam in di-n:ensionem tetracubitam, et eadem subduplicata extendit eam in dimen-sionem monocubitam; et sic secundum ceteras proportiones numerales et non numerales 3
Tale sbizzarrimento geometrico dal Grossatesta ripercorso lungo tu~te .~e possibili componenti di forza (si ricordi l'accentuazione con cui gia sopra ci ha scandito il sursum deorsum, ante retro, dextror-
su~. sinistrorsum ) avr ancora qualche immagine da offrirci? (Diciamo immagine , perch a questo punto impossibile sarebbe non cogliere l'automatico riverbero artistico). la piramide i o me-
1 De luce seu de inchoatio11e formarum, ed. cit., p. 51.
1 : Cosl, ancora, E. De Bruyne nel preparare la felice espressione che qui da lui pre eviamo: . alors que tous les autres auteurs se bornent la "composition" ou se contentent d'affirmer simultanment la "proportion" et la "couleur", Grossa-
~ste est le seul raliser d'une certaine manire l'unification de ces deux concepts. ien ~lus, au lieu de se contenter de dcrire la "composition colore" telle qu'elle a~parau. au regard, il s'efforce de la rduire scientifiquement un cubisme lmen-taire qm en dernire analyse n'est pas d'ordre spatial mais nergtique . (Op. cit, vol. III, p. 148-149).
3 De luce seu de inchoatione formarum, ed. cit., p. 53.
1 1:utt'altro che inopportuno mi sembra qui il richiamare sin d'ora l'attenzione sm .fervidi rjfless! che questa specifica eredit immaginistica grossatestiana . (!a pi-rarmde, precisamente) determiner in Bartolomeo da Bologna, come deducibile da P.assi di questo genere: Immaginemur etiam pyramidem i~tam intus concav~m ~e
s~ ess~t una pyramis cristallina splendidissima in modm:i u?ms camerae pyram1.d~hs, siv:e 1ll ~odum unius papillionis imperialis et pyramidalis, recta arte ~c. divma, cums lat1tudo in inferiori parte tanta esset ut totam spheram firmamenti cum om
- 40 -
-
glia, come subito vedremo, ad ennesima conferma dello sbizzarri-mento di cui ci occupiamo, le infinitae pyramides : Alia autem figura exigitur ad actionem naturalem, scilicet pyramidalis: quoniam si virtus veniat ab una parte agentis et terminetur ad aliam pattern patientis et sic de omnibus, ita quod semper veniat vittus ab una parte agentis ad unam solam pattern patientis, numquam erit fottis actio sive bona. Sed completa est actio, quando ab omnibus punctis agentis sive a tota superficie eius veniet virtus agentis ad quemlibet punctum patientis. Hoc autem est impossibile, nisi sub figura pyramidali, quoniam virtutes venientes a singulis partibus agentis concurrunt in cono pyramidis et con-gtegantur et ideo omnes fortiter possunt agere in partem patientis con-currentem. Possunt ergo infnitae pytamides exire ab una superficie a.gentis, quarum omnium una est basis, scilicet superfcies agentis, et coni sunt tot, quot sunt pyramides, et cadunt in diversa puncta medii seu patientis un-dique; et ad unam pattern possunt infnitae exire, quarum una est brevior et alia Iongior 1
A questo punto non c' che da esplicitare il titolo del tratta-tello cui quest'ultima citazione risale: De lineis angulis et figuris seu de fractionibus et reflexionibus radiorum 2 Il compiaciuto gusto geo-metrico non potrebbe rivelarcisi con maggiore evidenza.
Dal mondo della dinamica e della geometria passiamo, col quarto canone sopra anticipato, al regno delle suggestioni coloristiche, cui il Grossatesta ci si rivela sensibile sino, addirittura, a finezza d'anno-tazioni liriche che non possono non sorprenderci in un pensatore cosl rigidamente metafisico.
Idea matrice sat ancora una volta la definizione che gi in par-tenza ci viene fornita in immediato nesso con quella lux che sempre funger da soggetto principale dell'intero discorso. Colore,
nibus, quae infra fumamentum continentur, capere se faciliter posset; et imm~ginemur basim eius esse superficicm circularem quasi inferiore longitudinis et latitu dinis et esse supra convexum coeli cristallini et altitudincm eius erigi usque ad summum coeli empirei, et immaginemur pyramidem istam lucidissimam ... . Il passo preso dalle Quaestiones disputatae in una trascrizione gentilmente messami a di-sposizione da C. Piana.
1 De lineis, angulis et figuris seu de fractio11ibus et refiexionibus radiomm, ed. cit., p. 64.
2 L'intero trattatello leggibile in ed. cit., da p. 59 a p. 65.
- 41 -
-
vale a dire, lux incorporata perspicuo o anche lumen admixtum cum diaphano ; dove assai facile scorgere l'automatico proten-dersi di quello che abbiamo or ora definito soggetto principale. Solo, infatti, che si esca dalla sfera dell'invisibile, la lux-forma prima corporeitatis non tarda a precisarsi in veste coloristica all'interno della ripartizione che il Grossatesta ci precisa subito dopo: Lux autem quadri/arie partitur: quia aut est lux clara vel obscura, pauca vel multa 1
Ancor pi feconda ci apparir, a questo proposito, la lezione grossatestiana se dal De colore ci si porta simultaneamente ai vari spunti su tal tema reperibili nel De iride seu de iride et speculo 2
al quale dovremo appresso far ricorso come embrionale nucleo di tematica perspettivistica. La quadruplicit gi posta dal De colore alla base del nuovo discorso che ci viene offerto condurr a dettagli ancora esteticamente pi fertili: Cum autem color sit lumen admixtum cum diaphano, diaphanum vero diversifcetur secundum puritatem et impuritatem, lumen autem quadri-farie dividatur, secundum claritatem scilicet et obscuritatem et nmc se-cundum multitudinem et paucitatem, et secundum harum sex differentia-rum connumerationes sint omnium colorum generationes et divertitates, varietas coloris in diversis partibus unius et eiusdem iridis maxime eccidit propter multitudinem et paucitatem radiorum solis. Ubi enim est maior ra?iorum multiplicatio, apparet color magis clarus et luminosus; ub~ v~ro mmor est radiorum multiplicatio, apparet color magis attinens hyazmtmo et obscuro 3
. . Il termine di confronto cui qui stato fatto ricorso come pos-sibile esemplificazione coloristica (l'iride) particolarmente fecondo. Suo tramite non ci sar affatto difficile pervenire col Grossatesta prima alla ricca catalogazione sfociante nei sedecim colores : Erunt ergo in universo colores sedecim: duo scilicet extremi et hinc inde septem extremis annexi hinc per intensionem ascendentes illinc per re-missionem descendentes ac in medio in idem consurrentes 1
1 De colore, ed. cit., p. 78. 2 il trattato che appresso riporteremo come legame con le derivazioni per-
-;pectivistiche . :i De iride, seu de iride et speculo, ed. cit., p. 77. 1 De colore, ed. cit., p. 79.
- 42 -
-
e poi ( vision presa delle innumeri sfumature percepibili nell'interno dei singoli colori) al totale rifiuto d'ogni argine numerico, decisa-mente infranto dalla nota d'infinit che finisce per contraddistinguere la gamma coloristica sulla quale il Grossatesta ci invita a riflettere: In quolibet autem colorum mediorum gradus intensionis et remissionis sunt infiniti. l!nde qui per numerationem et combinationem eorum, quae intenduntur et remittuntur, multitudinis scilicet et claritatis luminis et etiam puritatis perspicui et oppositorum his, fiunt colores novero, per numerationem graduum intensionis et remissionis erunt infiniti 1
* * ~:
Nel giro degli ulteriori arricchimenti al Grossatesta consentiti dalla duttilit della sua iniziale premessa metafisica vengono ora a profilarcisi due altri canoni alla cui simultanea assunzione (insieme all'elemento-poesia) ci porta lo stesso De luce come suo coerente sviluppo 2 : la luce-suono e la luce-danza.
Essenziale, per il primo di questi due canoni, il ruolo eserci-tato dall'aria. Di ci veniamo avvertiti non solo dall'esplicita defini-zione che nell'opera In analytica posteriora ci prospetta il suono come luce incorporata nell'aria pi sottile 3, ma, in pari tempo e con egua~e precisione tecnica, anche dal gioco dei richiami ovunque ritornanti; come ci accadrebbe di riscontrare senza ombra di dubbio allargando la motio sonativa secundum extensionem et contractionem in par-tibus minu tis , di cui ci parla il De generatione sonorum, con lo spunto chiarificatore che di esso ci viene offerto nel poco fa ricordato In anatytica posteriora: Hic motus itaque extensionis et constrictionis in eodem secundum ~i~e~sos diametros, cum pervenerit ad naturam luminis incorporati in subtthssimo aere quod est sonativum, sonatio est