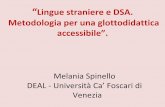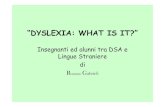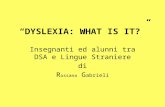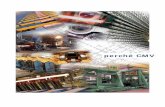DSA E LINGUE STRANIERE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI...
-
Upload
trinhkhanh -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of DSA E LINGUE STRANIERE - ISTITUTO COMPRENSIVO DI...
DEFINIZIONE:
Con la sigla DSA si intendono i Disturbi Specifici di Apprendimento, definiti
anche con la sigla F81 nella Classificazione Internazionale ICD-10
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, compresi nel capitolo 315 del DSM-IV
americano e annoverati dalla Legge 8 ottobre 2010, n. 170: "Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010. Fanno parte della famiglia dei
Disturbi Evolutivi Specifici. Si tratta di disturbi nell'acquisizione di alcune abilità
specifiche che non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento
poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della
cultura, come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto. I disturbi specifici
di apprendimento si verificano in soggetti che hanno intelligenza almeno nella norma,
con caratteristiche fisiche e mentali nella norma, e la capacità di imparare.
Nei paesi anglosassoni in genere si considerano disortografia e
disgrafia come tipi di dislessia, anche per la forte comorbidità.
Si includono però nei DSA anche:
disturbo specifico del linguaggio (F80.0-F80.2/315.3)
disprassia
disturbo dell'elaborazione auditiva
disturbo dell'apprendimento non verbale
Tutti questi disturbi, colpendo direttamente
o indirettamente l‟area linguistica, per lo
meno nella sua forma scritta, sono di
ostacolo all‟apprendimento di una lingua
straniera (o ALS), come e più che non nel
caso della lingua materna o di una lingua
seconda.
Infatti, l‟apprendimento di una lingua straniera in un ambiente guidato presenta di per sé numerosi svantaggi rispetto all‟apprendimento di una lingua acquisita in modo naturale e spontaneo, perché:
1.L‟ambiente è artificiale e poco motivante
2.Gli scopi di utilizzo sono in genere deboli
3.Il tempo di esposizione e di elaborazione della lingua è limitato
4.Il docente, fonte principale di input linguistico, è spesso non-madrelingua
LA DISLESSIA:
E‟ il DSA più diffuso e più studiato, e anche il più
pervasivo. E‟ una difficoltà tipicamente associata
con l‟apprendimento e la conoscenza linguistica, che
può colpire l‟abilità dell‟apprendente nella lettura, nella
scrittura e/o nell‟ortografia. Più che a problemi di
identificazione grafica, è dovuta principalmente a
difficoltà di decodifica fonologica (v. sotto).
TEORIE EZIOLOGICHE:
1. Teoria fonologica: nel soggetto dislessico, le rappresentazioni mentali
dei fonemi sono degradate o difficilmente accessibili (Snowling 2000)
2. Teoria magnocellulare o sensomotoria: la dislessia è dovuta ad un
insieme di disturbi di tipo visivo, uditivo e motorio (Stein 1991)
3. Teoria del doppio deficit: esistono due tipi di lettori dislessici: i primi con
un problema puramente fonologico, gli altri con entrambi i problemi
(Wolf e Bowers 1999)
4. Teoria multicausale: si tratta di una combinazione di fattori biologici,
cognitivi, comportamentali, ambientali
IMPLICAZIONI PER L‟ALS:
Le implicazioni per l‟apprendimento della LS sono molteplici:
Difficoltà di memorizzazione dei vocaboli
Difficoltà di analisi grammaticale
Difficoltà di pronuncia
Difficoltà di lettura (lentezza, confusione tra diverse parole,
mancata comprensione del testo, ecc.)
Difficoltà di scrittura (soprattutto nell‟ortografia)
LA DISGRAFIA:
E‟ un disturbo specifico della scrittura nella riproduzione di
segni alfabetici e numerici; può essere legata ad un quadro
di disprassia, può essere secondaria ad una lateralizzazione
incompleta, è caratterizzata dalla difficoltà a riprodurre segni
alfabetici e numerici e infine riguarda esclusivamente il
grafismo. Potrebbe essere collegata ad un‟anomalia
cerebellare che colpisce la motilità fine.
IMPLICAZIONI PER L‟ALS:
Chiaramente incide sull‟apprendimento di
una LS, ma soltanto nella resa dei segni
della L1, rimangono solo le difficoltà
generali già riscontrate riguardo a
quest‟ultima.
LA DISORTOGRAFIA:
La disortografia è la difficoltà a tradurre correttamente i suoni che compongono le parole in simboli grafici. Può derivare da una difficoltà di linguaggio, da scarse capacità di percezione visiva e uditiva, da un‟ organizzazione spazio-temporale non ancora sufficientemente acquisita, da un processo lento nella simbolizzazione grafica. Essa si presenta con errori sistematici che possono essere così distinti:
1. Confusione tra fonemi simili (es. /f/ e /v/, /l/ e /r/, /t/ e /d/)
2. Confusione tra grafemi simili (es. /b/ e /d/, /q/ e /p/, /C/ e /G/) 3. Omissioni (es. di un segmento delle doppie (leto per letto) , di una parte di un dittongo (ovo per uovo) , di parte di un gruppo consonantico (catare per cantare) 4. Inversioni (es. Gevona per Genova, sefamoro per semaforo)
IMPLICAZIONI PER L‟ALS:
Come la dislessia (con cui presenta una forte
comorbidità), può avere gravi conseguenze
sull‟apprendimento di una LS, specialmente se
essa ha una grafia opaca, cioè se la
corrispondenza grafema/ fonema presenta forti
irregolarità (v. sotto).
IL DISTURBO SPECIFICO DELLA COMPITAZIONE:
E‟ una difficoltà nello sviluppo delle abilità di
compitazione, cioè di suddivisione in sillabe delle
parole; solitamente è associato a problemi di
disgrafia ma non fonetici. Le abilità di pronunciare
e scrivere correttamente le parole sono entrambe
compromesse.
IMPLICAZIONI PER L‟ ALS:
Il disturbo della compitazione, compromettendo le
capacità di pronunciare e di scrivere
correttamente le parole, va a colpire sia la
produzione orale che quella scritta della LS,
soprattutto per quanto riguarda la combinazione e
sequenziazione dei grafemi e dei fonemi.
LA DISCALCULIA:
E‟ una difficoltà specifica nell‟apprendimento del
calcolo che si manifesta nel riconoscimento e
nella denominazione dei simboli numerici, nella
scrittura dei numeri, nell‟associazione del simbolo
numerico alla quantità corrispondente, nella
numerazione in ordine crescente e decrescente, nella
risoluzione di situazioni problematiche.
IMPLICAZIONI PER L‟ ALS:
L‟influsso sull‟apprendimento di una LS non è
diretto, ma molte delle funzioni linguistiche di
base implicano l‟uso dei numeri e del calcolo
numerico (es. denaro, ora e data, età, pesi e
misure, quantità, distanze, direzioni, destra e
sinistra).
CI CONCENTRIAMO SOPRATTUTTO SULLA DISLESSIA,
PERCHÉ:
A. E‟ il disturbo più comune
B.E‟ anche il più rappresentativo
C. E‟ quello che crea maggiori difficoltà nell‟ALS
D. E‟ pertanto il più studiato in generale
E. C‟è spesso comorbidità tra gli altri disturbi e la dislessia
LA COMPETENZA FONOLOGICA
La competenza fonologica, o coscienza fonemica, è l‟abilità
metalinguistica che permette all‟individuo di analizzare il parlato in
unità sonore dal valore distintivo (e cioè, in ultima analisi, semantico),
che chiamiamo fonemi (es. essere consci che le due parole sole e sale
si distinguono soltanto per il primo suono vocalico, e cioè per la
sostituzione del fonema /o/ con il fonema /a/).
Lo sviluppo della competenza fonologica è strettamente legato alla
letto-scrittura, in quanto il linguaggio scritto può essere compreso
solamente se si parte dal rapporto esistente tra il segno sonoro (il
fonema o, in una scrittura sillabica come quella giapponese, la sillaba) e
quello grafico (il grafema).
Si possono identificare due processi di lettura:
1. La lettura decifrativa o strumentale, che implica la mera transcodifica grafema/ fonema.
2. La comprensione del testo, che richiede una più ampia consapevolezza dell‟organizzazione dei grafemi e dei lessemi in unità più grandi e della coerenza tematica di queste ultime.
Si può inoltre procedere in due modi:
-Bottom-up, cioè partendo dalla decodifica delle unità più piccole per poi combinarle in unità sempre più grandi fino alla comprensione dell‟intero testo.
-Top-down, cioè basandosi su una più generale conoscenza del mondo e del contesto per giungere alla decifrazione delle singole parole.
Un buon lettore, naturalmente, utilizza entrambi i procedimenti (procedimento interattivo).
MODELLO A DUE VIE O STANDARD (COLTHEART 1978):
Codifica fonologica accesso al sistema semantico (accesso lessicale) identificazione
recupero o attivazione del significato (via fonologica)
Oppure accesso diretto, senza passare per la mediazione fonologica (via visiva, per le parole più note e prevedibili)
TRE MODI PER OTTENERE LA STRUTTURA FONETICA DI UNA PAROLA
SCRITTA:
1.Via fonologica prelessicale: si accede al suono della parola tramite le
regole di conversione grafema-fonema; da qui si può accedere al
significato della parola
2.Via visiva semantica: si passa dal lessico visivo di input al sistema
semantico e poi al lessico fonologico
3. Via visiva diretta: si connette direttamente il lessico visivo di input al
lessico fonologico di output, ma non al significato
SECONDO FRITH (1985), SI POSSONO DISTINGUERE QUATTRO FASI:
1.Stadio logografico: si riconoscono alcune parole a livello globale, senza conoscerne l‟ortografia né la struttura fonologica.
2.Stadio alfabetico: si discriminano le varie lettere, stabilendo una conversione grafema-fonema.
3.Stadio ortografico: si imparano le regolarità e le irregolarità della lingua letta.
4.Stadio lessicale: si riconoscono le parole in modo diretto, senza dover recuperare il fonema associato ad ogni grafema.
Si possono riconoscere diversi tipi di dislessia evolutiva,
che riguardano diversi aspetti del processo di decodifica/
codifica fonologica e grafemica:
a. Dislessia fonologica
b. b. Dislessia superficiale
c. c. Dislessia mista
d. d. Iperlessia
La dislessia fonologica inibisce la „via fonologica‟ alla
lettura, cioè va a colpire il processo di conversione grafema-
fonema, corrispondendo ad un arresto dello sviluppo dei
processi di lettura a livello del passaggio tra lo stadio
alfabetico e quello ortografico. I lettori affetti da questo tipo di
dislessia, avendo un basso grado di consapevolezza
fonologica, trovano maggior difficoltà nel decifrare le parole
sconosciute e le non-parole, ma riconoscono più facilmente le parole
frequenti e quelle che sono state prese in considerazione perché
costituiscono eccezioni di pronuncia.
La dislessia superficiale colpisce invece la „via lessico-semantica‟,
ossia la capacità di stabilire una connessione tra forma grafica,
forma fonologica e significato dei lessemi. Il blocco avviene
pertanto a livello dello stadio ortografico, per cui il lettore non ha
problemi a compiere la conversione grafema-fonema ma non ha
costruito il vocabolario necessario ad automatizzare e velocizzare
la lettura. Infatti, egli risulta particolarmente lento nella lettura e
incontra problemi nella decifrazione di parole contenenti eccezioni di
pronuncia o accentate in modo irregolare, mentre non incontra
problemi a leggere le non-parole.
La dislessia mista o profonda, che purtroppo rappresenta il
tipo più frequente, presenta sintomi tipici di entrambe le
forme di dislessia precedentemente citate. Il lettore affetto
da questo tipo di dislessia commette errori strettamente
semantici, leggendo una parola alposto di un‟altra anche
molto diversa fonologicamente, quando tra le due sussista un
legame di tipo semantico (es. contento anziché felice). Secondo
il modello della Frith, in questo caso l‟arresto sarebbe avvenuto
a livello delle prime fasi dello stadio alfabetico.
Esistono inoltre casi di iperlessia evolutiva, in cui
il lettore, avendo un‟ottima memoria visiva e
uditiva, dimostra grandi e precoci abilità nel
decifrare le strutture linguistiche a livello fonologico,
ma ha difficoltà di comprensione dei significati ad
esse connessi. In questo caso, delle due vie di
Coltheart, soltanto la via fonologica viene utilizzata, e
non quella semantica.
Secondo l‟ “ipotesi delle differenze di codifica linguistica” di Ganschow et
al. (1998), c‟è una forte correlazione tra le abilità (e quindi le difficoltà)
riscontrate da un individuo nell‟acquisizione della lingua materna (LM) e quelle
riscontrate nell‟apprendimento di una lingua straniera o seconda (v. anche il
modello dell‟Iceberg di J. Cummins, 1979). Pertanto, un ragazzo dislessico o
disortografico tenderà ad incontrare nell‟apprendimento della LS ostacoli
analoghi a quelli incontrati nella LM (es. difficoltà nella lettura di numeri e ore, di
riconoscimento della destra dalla sinistra, di ricerca dei vocaboli nel dizionario,
di riconoscimento e categorizzazione grammaticale, di memorizzazione di parole
irregolari e della loro ortografia, di produzione dei suoni), con l‟ulteriore svantaggio di
chi si trova a dover fronteggiare una lingua non familiare, in un ambiente artificiale,
con scarsissima esposizione e stimolo motivazionale e in età più avanzata.
IL „MAPPING DILEMMA‟:
Le difficoltà aumentano con la lontananza della lingua target dalla
lingua materna, ma anche a seconda della marcatezza
grammaticale e/o ortografica della stessa. Il grado di complessità
del processo di transcodifica tra parlato e scritto - tra fonemi (o altre
unità fonologiche come le sillabe) e grafemi - varia infatti da lingua a
lingua (mapping dilemma, Ziegler & Goswami 2005). In particolare,
esistono lingue che, a differenza dell‟italiano, presentano una scarsa
corrispondenza tra i suoni parlati e i grafemi scritti: sono cioè lingue
opache o profonde. Tra queste, alcune delle lingue a noi più vicine e
più spesso studiate, come l‟inglese e il francese.
In inglese, ad esempio, gli stessi grafemi possono corrispondere a molti
fonemi diversi (es. ea può essere letto /i:/ come in peace, / / come in bread,
/ / come in bear, /e / come in steak); allo stesso tempo, lo stesso suono
può essere reso graficamente in modi diversi (es. /i:/ può essere scritto ee
come in peel, ea come in peace, ie come in piece, i come in pizza, e come in
equinox).
L‟alfabeto inglese, infatti, è costituito da 26 lettere e 45 suoni diversi, che si
possono scrivere in oltre 200 modi differenti (l‟italiano ha soltanto 21 lettere, 28
suoni e 30 possibili grafie). Inoltre, spesso certi grafemi non corrispondono a nessun
suono, come la w in wrist, la p in psychology, la n in column, la e in plane.
A questo tipo di lessemi si addice certamente più un metodo di lettura
„globale‟ che non uno di tipo analitico o anche sillabico, oppure, a livello
ortografico, vanno introdotte regole flessibili e molto complesse. Questo
rappresenta un ulteriore problema per l‟alunno con DSA, che generalmente
presenta difficoltà di memorizzazione e/o assimilazione delle
corrispondenze grafema-fonema, soprattutto quando egli abbia imparato o
stia imparando a leggere una lingua madre che presenta corrispondenze
differenti e molto più trasparenti, come l‟italiano. Questo vale soprattutto per i
dislessici di tipo „superficiale‟, che usano prevalentemente la via fonologica per
decifrare la lingua scritta, ma anche, naturalmente, per chi soffre di dislessia
mista, e abbiamo visto come questi siano la maggioranza.
La maggior parte degli studiosi (es. Daloiso, Stella, Kvilekval), tuttavia, non sono di
questo parere. Nonostante tutte le difficoltà sopra riportate, è importante dare agli
studenti affetti da DSA la possibilità di studiare una LS, per le seguenti ragioni:
Conoscere altre lingue è indispensabile per comunicare in ambienti eterolinguistici, anche non all‟estero
Da‟ accesso ad una più vasta gamma di professioni
Da‟ accesso ad una più vasta gamma di fonti di informazione
E‟ utile anche al fine dello sviluppo cognitivo generale
Aumenta la capacità di comunicare, anche nella L1
Aiuta a migliorare le abilità e le caratteristiche comuni con la L1 (punti di convergenza)
Può aumentare la coscienza metalinguistica
Può migliorare l‟alfabetizzazione
Porta a contatto con altre culture e aiuta a sviluppare un atteggiamento positivo verso di esse
Aiuta a stabilire legami con altre culture
Aiuta a capire testi e ipertesti nella vita di tutti i giorni e nello studio delle discipline
I ragazzi affetti da DSA possono sentirsi umiliati se li si esclude da certe attività educative
L‟ALS può anzi accrescere l‟autostima del soggetto con DSA, se le attività vengono opportunamente calibrate e il feedback è positivo
L‟ALS è insomma un‟abilità chiave che tutti dovrebbero poter acquisire: è una vera e propria questione di pari opportunità (Mc Keown 2004)
POSSIBILI SOLUZIONI:
Insegnare agli alunni affetti da DSA una lingua trasparente, con
un‟ortografia poco profonda, e possibilmente anche vicina alla L1 (es.
lo spagnolo)
Dispensarli dall‟apprendimento della forma scritta di una lingua opaca
MA:
•L‟inglese in particolare è molto richiesto ed è decisamente la lingua che
apre più orizzonti sul piano lavorativo e comunicativo.
•In alcune situazioni, ad esempio di confine, anche altre lingue opache,
come il francese, possono essere molto utili.
•La lingua scritta, in una società alfabetizzata come la nostra, è presente
nella maggioranza delle situazioni comunicative.
Per questo è necessario ridurre la portata degli strumenti dispensativi
(cioè, non eliminare del tutto
l‟insegnamento di una lingua o della scrittura in LS tout court) e introdurne
di compensativi.
SOLUZIONI ALTERNATIVE:
Assegnare compiti diversi, sia quantitativamente che qualitativamente
Valutare il contenuto e le competenze comunicative piuttosto che quelle linguistico-strutturali
Dare maggiore importanza alla produzione orale piuttosto che a quella scritta
Dimostrare che si comprendono le difficoltà dell‟alunno senza farlo sentire compatito
Utilizzare tecniche di rilassamento e costruire un ambiente positivo in modo da aumentare la motivazione e l‟autostima
Permettere all‟allievo di registrare le lezioni
Dilatare i tempi di consegna e di risposta
Fornire appunti o schemi degli argomenti che si affronteranno
Utilizzare particolari tecniche di insegnamento:
Utilizzare particolari strumenti compensativi (software, libri parlati, sussidi audiovisivi, ecc.)
Favorire il lavoro di gruppo distribuendo adeguatamente i compiti
Scrivere alla lavagna in stampatello maiuscolo
Eliminare il co-testo in eccesso (es. coprire tutte le linee del foglio sotto quella che lo studente sta leggendo)
Scrivere il più possibile al computer e con caratteri più facili da distinguere (es. Arial, Verdana o Comic Sans piuttosto che Times New Roman, senza giustificare il testo)
Intensificare le attività che aiutino a sviluppare la coscienza fonologica dell‟allievo
Abbinare la memorizzazione linguistica ad attività senso-motorie
TECNICHE DI INSEGNAMENTO PARTICOLARMENTE UTILI:
Tecniche per allenare la memoria (giochi di parole, bingo, flashcards,
ecc.)
Tecniche di overlearning e ripetizione automatica (drills contestualizzati e
significativi)
Annotazione sistematica di schemi linguistici, mappe semantiche e regole
grammaticali
Incoraggiamento all‟autocorrezione
Tecniche di ascolto (parole-chiave, contorni intonativi, indizi contestuali)
Attività di skimming o scanning per una lettura più rapida ed efficiente
Nello studio delle lingue straniere esiste un affective filter( Krashen:1985)
che spesso impedisce ad allievi introversi di esprimersi in L2 a causa di
ansia e demotivazione. Nel caso dei ragazzi DSA, già talvolta emotivamente
frustrati da esperienze fallimentari in L1, questo filtro affettivo diventa una
barriera insormontabile. Pertanto, è auspicabile che l‟ alunno DSA possa
avere:
• una situazione sistematica, ben strutturata dall„ insegnante che possa
renderlo sicuro perché graduata sulle sue reali abilità. L‟ insegnante
dovrebbe fornire ai ragazzi non solo una lezione frontale ma utilizzare
tecniche quali il noticing ( Scmidt:1990) che permette ai ragazzi di
notare la regola per poi lavoraci attivamente ed interiorizzarla.
Daloiso ( 2012) sottolinea l‟ importanza di favorire:
• una riflessione metacognitiva a mappatura, dove gli alunni possano schematizzare gli obiettivi, i contenuti e le attività svolte durante la lezione o la UDA.
• Un approccio multisensoriale ( Reid:2006) che permetta a studenti con stili cognitivi diversi di acquisire o rinforzare le proprie abilità in modo autentico ed efficace.
• Tecniche di ridondanza, segmentazione e semplificazione delle attività possono supportare l‟ apprendimento della lingua straniera in modo efficace.
• Verifiche strutturate con criteri accessibili quali griglie immagini/parole,
• versioni facilitate di cloze, , vero/falso con supporto semiotico.
• Attività orali su topics conosciuti e elaborati con mappe o prompts
TECNICHE DI AIUTO ALLA LETTURA:
Tecniche sublessicali (Tressoldi et al. 2003): 5-6 ore al mese, 6 fasi:
a. Pa-ro-la: suddivisione e fusione della parola in unità sublessicali
b. Sillaba: ripetizione delle sillabe per memorizzarle
c. Composizione di parole: partendo dalla sillaba, formare le parole
d. Gruppi ortografici „dispettosi‟: esercizi che si concentrano sul riconoscimento
di gruppi ortografici problematici (es. It. gn, ch, ingl. ght, aw)
e. Riconoscimento veloce di parti di parola (es. desinenze, gruppi consonantici)
f. Giochi con le parole: per rendere più automatica l‟identificazione delle parole
in modo rapido e globale e giungere all‟autocorrezione
ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELLA COSCIENZA FONEMICA:
1. riconoscimento del suono iniziale delle singole parole
2. riconoscimento di analogie tra le lettere iniziali di parole diverse
3. suddivisione della sequenza costitutiva delle parole in fonemi isolati
4. suddivisione in sillabe
5. riconoscimento e formazione di rime
6. sostituzione di fonemi per formare parole nuove
7. riconoscimento di (gruppi di) grafemi omofoni ma non omografi
8. riconoscimento di (gruppi di) grafemi omografi ma non omofoni
ABBINAMENTO CON ATTIVITÀ SENSO-MOTORIE:
1.Total Physical Response (TPR): ideato negli anni ‟60 da James
J.Asher, è un metodo che abbina risposte non-verbali, soprattutto
di tipo motorio, agli input verbali in LS. Adatto soprattutto ad
apprendenti molto giovani e nelle prime fasi dell‟ALS, può essere però
esteso ad un pubblico di età più avanzata e a concetti più complessi
(es. la morfologia o le espressioni idiomatiche). L‟enfasi sull‟ascolto e
la comprensione, l‟interiorizzazione inconscia delle strutture
linguistiche, l‟aspetto ludico e creativo e la memorizzazione
contestualizzata alle azioni compiute lo rendono particolarmente
adatto a soggetti affetti da DSA.
2. Sviluppo delle abilità sensoriali: secondo Carola
Robinson-Tait, l‟ALS può essere reso più accessibile e i
concetti ad esso legati più facilmente memorizzabili se si
abbinano gli stimoli linguistici a stimoli sensoriali,
attraverso l‟uso di gestualità, disegno, flashcards,
canzoni e filastrocche, oggetti reali, codifica tramite i
colori, giochi di manipolazione degli elementi linguistici
(es. acronimi, rime, puzzle, indovinelli, bingo), giochi di
ruolo e di mimica (http://www.dyslexia-
parent.com/mag46s.html).
STRUMENTI COMPENSATIVI (VA SEMPRE TENUTO PRESENTE CHE NON TUTTI
SARANNO UTILI A TUTTI GLI STUDENTI CON DSA INDISTINTAMENTE):
•Computer (aspetto ludico, motivante, promuove l‟autostima) con videoscrittura e correttore automatico, sintesi vocale, scanner
•Software interattivi (es. Study Buddy, Personal Reader, SuperQuaderno e SuperMappe di Anastasis……)
•Siti internet (es. per ascoltare i suoni, per praticare attività interattive supplementari)
•Audiolibri
•Lavagne interattive
•Schede con particolari trascrizioni, figure, simboli pittografici ecc. (promozione del visual thinking)
•Mappe concettuali, es. per la grammatica (cfr. ad es. http://www.ademario-lobrano.it)
•Audioregistratore
•Fotocopie e copie di supporto digitale
•Esercizi supplementari (e.g. drills, dettati, schemi..)
STRUMENTI DISPENSATIVI (RIDIMENSIONATI):
•Dispensa dalla lettura ad alta voce
•Dispensa dal prendere appunti
•Dispensa dalla dettatura veloce
•Dispensa dall‟uso di dizionari cartacei
•Dispensa da verifiche puramente grammaticali
•Dispensa da interrogazioni non programmate
•Evitamento di caratteri piccoli o fancy
•Evitamento di testi lunghi e densi
•Evitamento di presentazioni con sfondi bianchi o vivacemente colorati, sottofondi musicali e parole in movimento
Questo tipo di dispense può facilmente passare inosservato e persino essere esteso
A tutta la classe, evitando così che l‟alunno con DSA si senta emarginato.
LE VERIFICHE:
Le verifiche vanno differenziate con discrezione e somministrate con
naturalezza. Esistono diversi tipi di intervento (anche questi possono spesso essere estesi a tutta la classe):
1.Intervento sui contenuti della verifica (es. testi più brevi, incremento della parte orale, compiti più semplici, informazioni supplementari…)
2.Intervento sulla forma (es. forma e grandezza dei caratteri, utilizzo di uno strumento compensativo, maggior uso di figure…)
3.Allungamento dei tempi di consegna o di risposta
4.Simulazioni di verifica in preparazione alla verifica vera e propria
5.Monotematicità della verifica
6.Esplicitazione degli obiettivi della stessa
7.Spiegazione a voce delle consegne
8.Intervento sui modi di correzione (maggiore importanza data al parlato piuttosto che allo scritto, ai contenuti piuttosto che alla forma, al progresso fatto piuttosto che ai risultati assoluti)
POSSIBILI PROBLEMI:
L‟alunno affetto da DSA potrebbe non accettare con facilità gli
strumenti dispensativi e compensativi perché non vuole sentirsi
diverso e si vergogna
I compagni possono vedere l‟attenzione data all‟alunno con DSA
come un favoritismo
I docenti possono non essere in grado di utilizzare determinati
strumenti compensativi
POSSIBILI SOLUZIONI:
Individualizzare i compiti anche per gli altri alunni (ogni apprendente è
unico e nessuno è migliore o peggiore)
Permettere anche agli altri alunni di accedere almeno in parte agli
strumenti compensativi e/o far loro capire perché non ne hanno (o ne
hanno meno) bisogno
Lavorare sull‟autonomizzazione dell‟alunno con DSA
Incoraggiare la cooperazione e lo spirito di gruppo
Fornire costanti possibilità di aggiornamento per gli insegnanti
Favorire la collaborazione con altri insegnanti con abilità diverse
BIBLIOGRAFIA:
Asher, J.J. (1969) "The Total Physical Response Approach to Second Language Learning". The Modern Language Journal, Vol. 53, No. 1, pp. 3-17.
Balboni, P. e Luise, M. C. (1994) Interdisciplinarità e continuità nell’educazione linguistica, Roma, Armando.
Belz, J.A. (2002) Social dimensions of telecollaborative foreign language study. Language learning and technology, 6.1, pp. 60-81.
Bloomfield, L. e Barnhart, C. (1961) Let's read, a linguistic approach, Detroit (Mich), Wayne State University Press.
Borello, E. e Luise, M. C. (2007) L’offerta linguistica in Italia, Torino, Utet Università.
Brown, H.D. (2000) Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. 2Ns ed White Plains, NY, Longman.
Bull, R., Johnson, R.S. e Ro, J.A. 1999, . Exploring the roles of the visual-spatial sketch pad and central executive in children‟s arithmetical skills: Views from cognition and developmental neuropsychology. Developmental Neuropsychology, 15, 421-442.
Campanini S., Battafarano R., Iozzino R. 2010, Evoluzione naturale della lettura del brano, delle liste di parole e non parole e della comprensione del testo in dislessici mai trattati. Dislessia, 7, 165-179.
Celce-Murcia, M. (2001) Teaching English as a second or foreign language, 3rd edition, Boston: Heinle & Heinle.
Chapelle, C.A. (2001) Computer applications in second language, Cambridge: CUP.
BIBLIOGRAFIA:
Chiappe P., Hasher L., Siegel L.S. (2000) Working memory, inhibitory control, and
reading disability. Memory and Cognition, 28, 8-17.
Coltheart, M. (1978) Lexical access in simple reading tasks. In G. Underwood (ed.)
Strategies of Information Processing , New York: Academic Press.
Crombie M. e McColl H. (2000) Dyslexia and the teaching of modern foreign languages,
David Fulton Publishers, London.
Crombie M. e McColl H. (2000) Multilingualism, literacy and Dyslexia, David Fulton
Publishers, London.
Cunningham, A.E. e Stanovich K.E. (1997) Earl reading acquisition and its relation to
reading experience and ability 10 years later. Developmental Psychology, 33, 934–
945, 1997
Cummins, J. (1979) Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in Crossfire
(Bilingual Education and Bilingualism). Multilingual Matters.
De Luca, K. e Papalia, F. (2006) Dislessia e lingue straniere, Edizioni Dr Antonio
Sfanemi, Messina.
Daloiso, M. (2009) la dislessia evolutiva: un quadro linguistico, psicolinguistico e
glottodidattico, Studi di Glottodidattica 2009, 3, 25-43.
Frith U. (1985) Beneath the surface of developmental dyslexia. In K. Patterson, J.
Marshall e M. Coltheart (a cura di), Surface dyslexia, Hillsdale, N.Y., Erlbaum, pp.
302-330.
Ganschow, L., Sparks, R. e Schneider E. (1995) Learning a foreign language:
challanges for students with language learning difficulties., Dyslexia: International
Journal of Research and Practice (2), 75-95.
Ganschow, L., Sparks, R.L. e Javorsky, J. (1998) Foreign language learning difficulties: an historical perspective. Journal of Learning Disabilities, 31.1, pp. 248-258.
Gyarmathy E., Mahlerbe C., Pichel P., Stoyanov B. e Tartari T. (2009) Dyslexic Students and Second Language Learning A study on the learning needs - European review, Education and Culture LifeLong Learning Programme LEONARDO DA VINCI, Novembre 2009.
Harrington, M. Levy M. (2001) CALL begins with a “C”: interaction in computer-mediated lanuage learning, System 29, 15-26.
Kvilekval P. (2007) Insegnare l'inglese ai bambini dislessici – un metodo sicuro per tutti, Libriliberi: Firenze.
Mc Keown, S. (2004) Meeting SEN in the Curriculum: Modern Foreign Languages, Manchester: David Fulton Publishing.
Melioni M., Galvan N., Sponza N. e Sola D. (Comitato scuola A.I.D., 2004) Dislessia: strumenti compensativi, Libriliberi, Firenze.
Moats, L. (1994). Issues in researching the link between phonological awareness, learning disabilities, and spelling. In G. R. Lyon (Ed.). Frames of reference for the assessment of learning disabilities: New views on measurement issues (pp. 333-349). Baltimore: Paul H. Brookes.
Morad, T. (2010) Unmasking Dyslexia on the Bumping Road to Bilingualism, Haaretz.com, 17 Dicembre 2010.
Schneider, E. e Crombie, M. (2003) Dyslexia and foreign language learning, London: David Fulton Publisher.
Shankweiler, D., Crain, S., Katz, L., Fowler, A. E., Liberman, A. M., Brady, S. A., Thornton, R., Lundquist, E., Dreyer, L., Fletcher, J. M., Stuebing, K. K., Shaywitz, S. E. e Shaywitz, P. A. (1995). Cognitive profiles of reading-disabled children: Comparison of language skills in phonology, morphology, and syntax. Psychological Science, 6, 149-156.
Serragiotto G. (a cura di, 2004) Le lingue straniere nella scuola. Nuovi percorsi, nuovi ambienti,nuovi docenti, Torino: Utet Libreria.
Sisti F. e Taylor J. (1995) Il video nell'insegnamento delle lingue straniere, Torino: S.E.I.
Snowling, M.J. (2000) Dyslexia, Oxford: Blackwell Publishing
Stein, J. (1991) Vision and Visual Dyslexia, Boca Raton: CRC Press.
Stein, J. e Walsh, V. (1997) To see but not to read: The magnocellular theory of dyslexia. Trends in Neurosciences, 20(4), 147-152.
Stella, G. (2004) “ La Dislessia evolutiva in Italia”. Dislessia, giornale italiano di ricerca clinica ed applicativa, Marzo 2004
Taeschner T. (1993) Insegnare la lingua straniera con il format, Roma: Anicia.
Titone R. (1995) Imparare le lingue giocando, Recanati: ELI.
Tressoldi P.E., Vio C., Lo Russo M.L., Facoetti A. e Iozzino R. (2003) «Confronto di efficacia ed efficienza tra trattamenti per il miglioramento della lettura in soggetti dislessici». Psicologia clinica dello sviluppo, vol. 7, pp. 481-493.
Wolf, M. e Bowers, P. (1999). The "Double-Deficit Hypothesis" for the developmental dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91, 1-24.
Wolf, M., Bowers, P. G. e Biddle, K. (2001) Naming speed processes, timing, and reading: A conceptual review. Journal of Learning Disabilities, 33, 387-407.
Ziegler, J. C. e Goswami, U. C. (2005) Reading acquisition, developmental dyslexia and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. Psychological Bulletin, 131(1), 3-29.
SITOGRAFIA:
Dyslexia Online Magazine: http://www.dyslexia-parent.com/magazine.html
Consigli di un esperto per migliorare il metodo di studio: http://www.ademario-lobrano.it/
Software per la dislessia: http://www.dyslexia-parent.com/software.html
Consigli per migliorare le strategie di apprendimento: http://www.clifton-partnership.org.uk/prod-learn-skills-curriculum.asp
Sintetizzatore vocale per varie lingue straniere: http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal
Documenti legislativi sulle lingue: http://ec.europa.eu/education/policies/lang/key/legislation_en.html
Pubblicazioni europee sull‟insegnamento delle lingue: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/multiling_en.html
Nota n. 4674 del 10/5/2007: http://www.aiditalia.org/it/nota_ministeriale_4674_del_10_maggio_2007.html
DDL del 29/09/2010: http://www.agiad.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=118
Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/217240f2-6e0e-4b5f-8231-a2489da4b1f5/Legge18-10-10_170.pdf