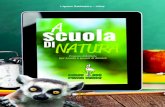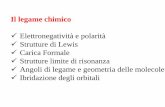Documento di programmazione annuale del Consiglio della ... · 1 Abanico Josh Van Edward Dima 23...
Transcript of Documento di programmazione annuale del Consiglio della ... · 1 Abanico Josh Van Edward Dima 23...
Anno scolastico 2018/2019
Liceo Scientifico Statale
A. Avogadro
Documento di programmazione annuale
del Consiglio della Classe IV B
Docente Coordinatore
prof. Alessandro Capata
2
Alunni frequenanti la IV B
1 Abanico Josh Van Edward Dima 23 Sofo Alessandra
2 Di Palma Lorenzo 24 Valenti Giulio
3 Guiducci Julia
4 Lunardi Alessio
5 Mancini Chiara
6 Mancini Filippo
7 Mandiello Alberto
8 Marini Giovanni
9 Molajoni Olimpia
10 Mucci Luigi
11 Ninapaytan Lazaro Andrea
12 Onesti Matteo
13 Papa Pierluigi
14 Pasquali Emma
15 Peguri Matteo
16 Perna Dal Miglio Giorgio
17 Pesiri Francesco
18 Poreba Daniele
19 Pozio Martina
20 Rodio Costanza
21 Serena De Maria Riccardo
22 Severini Giacomo
3
Composizione del consiglio di classe della IV B
Materia Peso orario
settimanale
Monte ore
annuo Docente
Orario ricevimento
docenti
Lingua e letteratura italiana 4 132 Capata
Martedì 11-12
Lingua e letteratura latina 3 99 Capata
Filosofia 3 99 Dotto
Giovedì 9-10
Storia 2 66 Dotto
Lingua e letteratura Inglese 3 99 Barbieri Venerdì 9-10
Matematica 4 132 Pinelli
Martedì 11-12
Fisica 3 99 Pinelli
Scienze naturali 3 99 Ruscitto Giovedì 11-12
Disegno e storia dell'arte 2 66 Caneppele Venerdì 11-12
Scienze Motorie e sportive 2 66 Paolucci Martedì 11-12
IRC 1 33 Avellino
Martedì 9-10
Lunedì 9-10 M.A. Diritto 1 33 Leuzzi
4
Situazione iniziale
La classe ė composta da 27 elementi di cui 3 frequentano il quarto anno all’estero (Maggiora Vergaro
Adriana, Michieletto Marzia, Pinto Francesco). I rimanenti 24 alunni si suddividono in 17 ragazzi e 7 ragazze.
La classe appare coesa, attiva e propositiva sul piano didattico, con una soddisfacente tenuta disciplinare. La
preparazione di partenza tuttavia non è omogenea in tutte le materie e richiederà un graduale lavoro di
riallineamento agli obiettivi prefissati nelle singole programmazioni disciplinari. Il clima nella classe è
collaborativo e dinamico pur nella difformità del rendimento con alcuni alunni brillanti e competenti ed altri
meno attivi e meno motivati.
Obiettivi generali comuni
Educativi generali e comportamentali
Educare al rispetto delle persone, delle regole, delle idee altrui, delle diversità, dell'ambiente e delle cose;
Sviluppare la capacità di concentrazione, discussione e argomentazione;
Acquisizione del senso di responsabilità e dello spirito di collaborazione.
Formativi aspecifici (trasversali a tutte le discipline)
Promozione di un atteggiamento di apertura nei confronti del “nuovo”;
Promozione dell'interesse verso problematiche culturali letterarie, scientifiche ed artistiche.
Didattici generali
Obiettivi minimi
Padronanza della lingua, corretta esposizione e competenza lessicale;
Interpretare un testo;
Comprendere ed applicare le conoscenze acquisite;
Dedurre conseguenze logiche da determinate premesse con ragionamenti completi e coerenti.
Obiettivi di livello tassonomico superiore
Approfondire in modo autonomo i temi trattati;
Utilizzare e collegare conoscenze e competenze in ambiti disciplinari diversi;
Analisi, sintesi e rielaborazione critica;
Giudizio autonomo.
Didattici specifici
Sono esplicitati nelle programmazioni individuali allegate al presente documento
Progetti e attività disciplinari e interdisciplinari
ll C.d.C. si propone, se ciò sarà possibile, di approfittare delle occasioni offerte dalla città (mostre,
convegni, spettacoli e manifestazioni culturali) che risultino attinenti ai programmi curricolari o siano occasione
di arricchimento culturale ed umano. Il C.d.C. avrà cura di non concentrare le uscite in prossimità delle
verifiche di fine periodo e di non superare il numero massimo di sei nell’anno.
La classe potrà aderire ai progetti previsti dal PTOF, quali: le Olimpiadi di Matematica, di Fisica e di Filosofia,
il Piano Lauree Scientifiche per Matematica e Fisica, olimpiadi di Italiano, progetto Einaudi.
5
Alcuni della classe aderiscono anche quest’anno al progetto IGCSE, con lezioni integrate di fisica e inglese.
Valutazione: criteri minimi per il passaggio alla classe successiva (V. PTOF)
Ciascun Dipartimento fornisce i parametri di valutazione, relativamente alle attività degli studenti, in
base alle conoscenze, alle capacità ed ai comportamenti. A tali parametri si riferiscono i Docenti di questo
Consiglio di Classe.
La valutazione finale rappresenterà un giudizio complessivo sullo studente secondo un’ottica globale e
non limitata alle singole discipline.
Il Consiglio di Classe, nel determinare gli esiti di fine anno scolastico per ogni singolo alunno, terrà
presente i seguenti elementi di valutazione:
- il livello e la qualità delle conoscenze maturate
- la capacità di padroneggiare e utilizzare le conoscenze acquisite
- l’impegno nel lavoro: in classe e nello svolgimento dei compiti assegnati
- la partecipazione attiva alla vita della scuola.
Metodologie e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi
Organizzazione del tempo-scuola: lezioni frontali, discussioni guidate, confronti sulla interpretazione di testi
umanistici e scientifici, relazioni individuali e di gruppo, attività multidisciplinari, attività di laboratorio.
Lavoro a casa: relazioni orali e scritte, esercizi di competenza linguistica, risoluzione di problemi, risposte a quesiti,
soluzioni di test in ambito umanistico e scientifico.
Comportamenti nell’ambito del c.d.c.: confronto continuo tra i Docenti, per equilibrare il carico di lavoro a casa ed
evitare, possibilmente, il condensarsi di verifiche in classe, specialmente quelle scritte; ricerca di un
rapporto sereno e produttivo con la componente genitori; approfondimento delle esigenze e curiosità
culturali degli allievi, in un rapporto di fiducia e rispetto reciproco.
Numero e tipologia delleProve scritte
Per quanto riguarda il numero delle verifiche scritte e delle verifiche orali si fa riferimento alle
programmazioni di Dipartimento, in sintesi si fa riferimento alla seguente tabella:
Materia Trimestre Pentamestre Italiano 3 5 Latino 3 5 Storia 3 3 Filosofia 3 3 Inglese 3 5 Matematica 3 5 Fisica 3 4 Scienze 2 3 Arte 2 3
6
Scienze Motorie 2 3 Religione /MA 2 3
Le tipologie di prove sono riportate nella tabella sottostante
Disciplina
Italiano Temi di ordine generale/testo argomentativo/ analisi del testo poetico e
narrativo
Latino Questionari di letteratura/traduzione di testi non noti /traduzione di testi noti
con domande a margine
Storia Prove semistrutturate /testo argomentativo
Filosofia Analisi del testo/prove semistrutturate/ testo argomentativo
Matematica Risoluzione di esercizi e problemi/questionari/prove strutturate e
semistrutturate
Fisica Risoluzione di esercizi e problemi/prove semistrutturate/relazioni di
laboratorio
Inglese
Domande a risposta aperta sui temi trattati/analisi del testo letterario/ prove
strutturate/relazioni/questionari di letteratura su autori e contesto storico-
culturale
Scienze Test strutturati e semi-strutturati/questionari/relazioni di
laboratorio/risoluzione di esercizi e problemi applicativi
Disegno e Storia dell'Arte Prove grafiche in laboratorio/test di riconoscimento
Scienze motorie e sportive Domande a risposta breve
IRC Prove strutturate/tema/test a risposta multipla
Per la valutazione orale si prevede anche la somministrazione di questionari e/o test.
Infine, il Corpo Docente sottolinea che la verifica, utile per rilevare dati oggettivi, è elemento necessario ma
certamente non sufficiente per esprimere un giudizio finale, tale da consentire l’ammissione alla classe successiva.
Per procedere ad una corretta e completa valutazione, elemento fondamentale nel processo apprendimento-
insegnamento, concorreranno quindi altri parametri quali: interesse, partecipazione, ritmi di apprendimento,
motivazione, assiduità nello studio, sostanziali miglioramenti rispetto ai livelli di partenza.
7
Attività di sostegno e di recupero
Le attività di recupero, sostegno, approfondimento, qualora vengano ritenute necessarie, saranno volte
non solo a favorire il profitto, ma anche la motivazione allo studio e all’apprendimento, adottando di volta in
volta le strategie ritenute più opportune; in particolare il recupero curricolare avrà come scopo principale il
consolidamento di un metodo di studio efficace. I tempi e i modi saranno quelli stabiliti dal Collegio dei
Docenti.
Alternanza Scuola-Lavoro
Come da documentazione consegnata dalla prof.ssa Caioli, ora in quiescenza, coordinatrice della III B nel
precedente anno scolastico, la classe risulta nella sua interezza aver svolto 101 ore di ASL (Corso sulla sicurezza 4h;
Corso Eni 15 h; FEDUF 8 h in sede + 22 in piattaforma; Viaggio a Malta Linguatime 52h). In attesa di conscere nel
dettaglio i nuovi provvedimenti legislativi in materia, il Consiglio di Classe e il tutor dell’ASL prof. Capata si
rimetteranno alle offerte predisposte dalla Funzione Strumentale ASL prof. ssa Leuzzi.
Roma, 24/10/2018
Prof. Andrea Avellino
Prof.ssa Rita Barbieri
Prof. Alessandro Caneppele
Prof. Alessandro Capata
Prof.ssa Paola Dotto
Prof. Daniela Leuzzi
Prof. Gabriele Paolucci
Prof.ssa Serena Pinelli
Prof.ssa Graziella Ruscitto
Si allegano i piani di lavoro individuali dei singoli Docenti.
8
Anno scolastico 2018/2019
Liceo Scientifico Statale
Amedeo Avogadro
Allegati
Piani di lavoro individuali
Liceo Scientifico “Avogadro”
Classe IV B
Programmazione Lingua e Letteratura Italiana
Prof. Alessandro Capata
Competenze Abilità dello studente Conoscenze linguistiche
A Conoscere et utilizzare gli strumenti espressivi della lingua italiana nei diversi contesti comunicativi
1. Acquisire I principali termini specifici del linguaggio letterario e dimostrare
consapevolezza della convenzionalità di alcuni.
2. Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e
collegamenti tra i contenuti.
Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale
3. Pianificare ed organizzare il proprio discorso in base al destinatario, alla
situazione comunicativa , allo scopo del messaggio e del tempo a disposizione
Esporre oralmente in modo chiaro e formalmente corretto.
Parlare nelle situazioni
programmate: il colloquio orale – la
relazione – il dibattito – la
presentazione.
B Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
Effettuare una lettura autonoma del testo come prima forma di comprensione globale
dei suoi contenuti
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuandone natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed espressivi.
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo; Cogliere le relazioni tra
forma e contenuto.
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera
appartiene.
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando
analogie e differenze.
Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme.
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi relativamente a forma e
contenuto.
Cogliere l’intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali del testo
Imparare a dialogare con le opere di un autore, confrontandosi con più
interpretazionicritiche; Motivare le proprie scelte e interpretazioni (dal
secondo anno)
C Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
1. Produrre autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia;
2. Elaborare diverse tipologie di testi in rapporto all’uso, alle funzioni, alla
situazione comunicativa (testi espositivi-argomentativi, articoli di giornale, saggi
brevi)
Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica di un testo
Il testo espositivo- argomentativo
Il saggio breve
L’articolo di giornale
L’analisi di un testo
Costruire schemi o mappe concettuali efficaci
Tipologie della terza prova di Esame
Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e
collegamenti tra i contenuti.
La recensione (di un testo letterario – rappresentazione teatrale – film )
D Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura
1. Collocare singoli testi nella tradizione letteraria, mettendo in relazione uso del
volgare, produzione letteraria e contesto storico sociale.
2. Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel contesto storico-
politico e culturale di riferimento, cogliendo l’influenza che esso esercita su
autori e testi.
3. Cogliere I rapporti tra i fenomeni linguistici e i processi culturali e storici
in cui I testi sono inseriti
Confrontarsi con autori di epoche diverse, riconoscendone le diverse prospettive
rispetto a un medesimo nucleo tematico.
Contestualizzare gli eventi letterari più rilevanti.
4.
E Attualizzare le tematiche letterarie per interpretare la reltà presente
Riconoscere gli elementi innovativi ed universali dell’opera e del pensiero
di un autore collegando le tematiche letterarie ai fenomeni della
contemporaneità.
F Stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline o domini espressivi.
Confrontare il linguaggio letterario con altre linguaggi artistici riconoscendo
temi comuni come espressione dell’immaginario collettivo di un’epoca
G Confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere
Individuare e riconoscere nei testi delle diverse letterature sia tematiche e
soluzioni formali affini sia specificità e differenze
H Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale
Conoscere gli aspetti specifici della comunicazione audiovisiva
Progettare percorsi multimediali
Organizzare un percorso argomentativo attraverso mappe concettuali con
l'ausilio delle tecnologie della comunicazione audiovisiva
Presentazione di percorsi in
Power Point o altro supporto
digitale.
Conoscenze letterarie – classe IV B
CONTESTI E CORRENTI PERCORSI TEMATICI
AUTORI e OPERE
• ETA’ DELLA CONTRORIFORMA Manierismo
LUDOVICO ARIOSTO
Vita, opere, poetica. Olando Furioso
BALDASSARRE CASTIGLIONE
Vita, opere, Il Cortegiano
GIOVANNI DELLA CASA
Vita, Rime e Galateo
FRANCESCO GUICCIARDINI
Vita e Opere
TORQUATO TASSO
Vita, opere, poetica. Gerusalemme Liberata
GALILEO GALILEI
Vita, opere, poetica. Passi scelti dalle opere
CARLO GOLDONI
Vita, opere, poetica. Una commedia e/o passi
scelti dalle opere
GIUSEPPE PARINI
Vita, opere, poetica. Passi scelti da “Il Giorno
UGO FOSCOLO
Vita,opere, poetica. Scelta di opere
DANTE: scelta di 10 canti dal Purgatorio
► Condizione e ruolo dell’intellettuale
• SEICENTO. Barocco
► Legami fra scienza e letteratura: la Nuova Scienza e il Barocco
• SETTECENTO Illuminismo – Neoclassicismo – Preromanticismo
►Figure sociali e rappresentazioni dell’uomo
► Il teatro : dalla Commedia dell’arte al teatro moderno
• • OTTOCENTO* Romanticismo
► La nascita del romanzo moderno: Romanzo e Realismo*
Liceo Scientifico "Amedeo Avogadro"
Programmazione - lingua e cultura latina
classe IV B
Prof. Alessandro Capata
Competenze asse
linguaggi
A Padroneggiare gli strumenti espressivi
B Leggere, comprendere ed interpretare i testi della civiltà latina – Abilità linguistiche
C Leggere, comprendere ed interpretare i testi della civiltà latina – Abilità letterarie
D Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi
E
Dimostrare consapevolezza della storicità dei fenomeni letterari e attualizzare le tematiche
Abilità dello studente
Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario
Comprendere il messaggio contenuto in un testo d’autore
Organizzare il proprio discorso ed esporlo in modo chiaro e formalmente corretto
Analizzare le strutture morfo-sintattiche di un testo per comprenderne almeno il senso generale
Individuare il lessico specifico e i procedimenti stilistici di un determinato autore o genere letterario
Riconoscere i legami tra le scelte linguistiche/ espressive ed il messaggio
Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e civiltà latina
Cogliere i caratteri specifici dei diversi testi, individuandone, funzione e scopi comunicativi
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene
Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e differenze
Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo genere
Tradurre in Italiano corretto e attuale un testo latino, rispettandone l’integrità del messaggio.
Sintetizzare (anche secondo le tipologie previste per la terza prova dell’Esame di Stato) gli elementi essenziali dei temi trattati, effettuando collegamenti tra contenuti e cogliendo l’intenzionalità dell’autore
Elaborare analisi linguistiche, stilistiche e retoriche di un testo.
Collocare il testo nel suo contesto storico culturale e sociale
Cogliere le relazioni esistenti tra contesto e produzione letteraria e tra pubblico ed autore.
Saper individuare sia il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea sia gli elementi di discontinuità
Utilizzare criticamente le opere del mondo classico come strumento di interpretazione del mondo moderno
Riconoscere il contributo del latino alla formazione del lessico intellettuale
Competenza non
Livello base
Livello intermedio
Livello avanzato
Descrizione
livelli di competenza
raggiunta
Non si orienta rispetto al significato generale di un testo e non ne individua le strutture morfosintattiche di base
È in grado di leggere un testo latino, di comprenderne il significato generale, individuando il lessico latino di base e le fondamentali strutture morfosintattiche; ne rende il senso in italiano in modo semplice, inserendolo in modo essenziale nel contesto di riferimento
Legge correttamente un testo latino comprendendone il significato e individuandone le strutture morfosintattiche; ne rende correttamente il senso in italiano, inserendolo in modo appropriato nel contesto di riferimento, anche attraverso un’adeguata riflessione lessicale
Legge scorrevolmente un testo latino comprendendone pienamente il significato e padroneggiandone le strutture morfosintattiche; ne rende il senso in italiano in modo completo e appropriato, inserendolo in modo puntuale nel contesto di riferimento e approfondendo la riflessione lessicale
CONOSCENZE LINGUISTICHE
CONOSCENZE LETTERARIE
CONTESTI PERCORSI (tematici e/o generi letterari) AUTORI E OPERE
Sintassi del periodo: consolidamento della sintassi del periodo e costrutti notevoli (ad es. relative improprie, usi del congiuntivo, periodo ipotetico)
La crisi della res publica
La retorica: importanza della retorica, le scuole di retorica, i generi dell’oratoria.
Cicerone Cesare
Consolidamento del lessico della lingua latina in relazione agli intenti espressivi
Le guerre civili La storiografia
La filosofia
Sallustio
La poesia
Il principato di Augusto
Il ruolo del letterato Virgilio
La poesia: il genere lirico, l’elegia, il poema epico
La guerra, la pace,
la missione di Roma
Livio Orazio Ovidio Properzio
1
PROGRAMMAZIONE MATEMATICA CLASSE QUARTA B
CONTENUTI ED OBIETTIVI
La seguente programmazione parte dalle indicazioni nazionali ministeriali per il nuovo Liceo
Scientifico e specifica il percorso per la classe quarta. I contenuti presentati sono stati organizzati
per temi, talvolta articolati in unità didattiche. La trattazione di alcuni di questi temi è stata antici-
pata l’anno scorso ma verrà approfondita. In particolare per le unità didattiche dei primi due Temi
(goniometria e trigonometria), la trattazione potrà prevedere dei semplici richiami o uno
svolgimento dettagliato e approfondito in funzione del programma svolto nel precedente anno
scolastico.
Nella programmazione sono indicate con C1, C2,..C6 le competenze di base che ciascun te-
ma/unità didattica concorre a sviluppare, secondo la legenda riportata di seguito.
C1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
C2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
C3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
C4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con
l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le poten-
zialità offerte da applicazioni di tipo informatico.
C5. Utilizzare gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici
C6. Saper costruire ed analizzare di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche
utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo.
Primo periodo
Contenuti Obiettivi minimi/capacità operative
Competen-
ze
Tema 1
Goniometria
-----
--
Unità 1.1
Richiami sulle
funzioni
goniometriche e
relative
proprietà
Richiami su: funzioni go-
niometriche e f. goniome-
triche inverse, archi asso-
ciati, addizione e sottra-
zione, duplicazione, bise-
zione, prostaferesi
• Conoscere le caratteristiche delle funzioni seno e coseno
tangente e cotangente
• Saper rappresentare graficamente le funzioni goniometriche
• Conoscere i valori delle funzioni goniometriche di angoli particolari
• Determinare il coefficiente angolare di una retta e l’angolo tra due rette
• Conoscere le funzioni goniometriche inverse e la loro rap- presentazione grafica
• Operare con le formule goniometriche
C1, C2,
C3
2
Tema 3 (*) Numeri complessi: la trattazione di questo tema è da considerarsi opzionale.
Primo periodo
Contenuti Obiettivi minimi/capacità operative
Competen-
ze
Tema 1
Goniometria
-------
Unità 1.2
Equazioni e dise-
quazioni goniome-
triche
Tecniche risolutive per
equazioni e disequazioni
goniometriche: elementari
o ad esse riconducibili,
lineari, omogenee.
• Risolvere semplici equazioni goniometriche
• Risolvere semplici disequazioni goniometriche
C1
Tema 2
Trigonometria
Teoremi sui triangoli ret-
tangoli (richiami)
Teoremi sui triangoli qua-
lunque
Applicazioni dei teoremi
sui triangoli
• Conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli
• Risolvere triangoli rettangoli
• Calcolare l’area di un triangolo
• Conoscere e saper applicare il teoremi: della corda, dei seni, di Carnot
• Risolvere un triangolo qualunque
• Saper applicare le conoscenze sopra specificate alla risolu- zione di problemi di geometria di vario tipo
• Saper utilizzare le conoscenze sopra specificate alla risolu- zione di problemi che possono presentarsi in campi diversi (fisica, topografia…)
C1, C2, C3, C5,
C6
Tema 3 *
Numeri Complessi
Numeri immaginari, nu-
meri complessi: rappre-
sentazione algebrica, ge-
ometrica, trigonometrica
e operazioni
• Utilizzare la rappresentazione cartesiana dei numeri com-
plessi
• Operare con i numeri complessi
• Utilizzare la rappresentazione trigonometrica per calcolare prodotti e quozienti
• Conoscere ed utilizzare la formula di De Moivre
• Risolvere equazioni nel campo complesso
C1, C2
3
Secondo periodo
Tema 4
-------
Unità 4.1
Esponenziali
Funzioni esponenziali ,
equazioni e disequazioni
esponenziali, curve e fe-
nomeni
Il numero di Nepero e
Conoscere le caratteristiche generali della funzione esponenziale
Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e lo- garitmiche
Trasformare geometricamente il grafico di una fun- zione esponenziale
Conoscere e applicare le proprietà delle potenze a e- sponente reale
Risolvere equazioni e disequazioni esponenziali
Applicare le nozioni acquisite a vari fenomeni (deca-
dimento, leggi di crescita,…)
C1, C2, C5,
C6
Tema 4
-------
Unità 4.2
Logaritmi
Funzioni logaritmiche,
equazioni e disequazioni
logaritmiche, curve e fe-
nomeni
• Conoscere le caratteristiche generali della funzione loga- ritmica
• Rappresentare il grafico di funzioni esponenziali e logarit- miche
• Trasformare geometricamente il grafico di una funzione lo- garitmica
• Conoscere e applicare le proprietà dei logaritmi
• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche
• Applicare le nozioni acquisite a vari fenomeni (decadimen- to, leggi di crescita,…)
C1, C2, C5,
C6
4
Secondo periodo
Tema 5
Geometria
solida
Poliedri, Solidi rotondi
• Definire e conoscere le proprietà di alcuni solidi (prismi, piramidi, poliedri regolari, cilindro, cono, sfera)
• Conoscere ed utilizzare le formule per il calcolo di superfici e di volumi
C1, C2,
C3, C5
Tema 6
Dati e previsioni
-------
Unità 6.1
Calcolo combina-
torio
disposizioni, permutazio-
ni, combinazioni e coeffi-
cienti binomiali
• Calcolare disposizioni semplici e permutazioni
• Calcolare combinazioni semplici
• Conoscere i coefficienti binomiali e le loro proprietà
• Determinare la potenza di un binomio
C1,C3,C
6
Tema 6
Dati e previsioni
-------
Unità 6.2
Calcolo delle pro-
babilità
Probabilità semplici, com-
poste, condizionate, teo-
rema di Bayes
• Calcolare la probabilità come misura
• Applicare il calcolo combinatorio alla probabilità
• Determinare le estrazioni da un’urna
• Calcolare probabilità composte
• Calcolare probabilità condizionate, utilizzare la formula di Bayes
C1,C3,C
6
Tema 6
Dati e previsioni
-------
Unità 6.3
Elementi di stati-
stica descrittiva
Statistica descrittiva, me-
die, frequenze, grafici
• Rappresentazione dei dati
• Determinare frequenze statistiche
• Rappresentare graficamente una distribuzione
• Calcolare e utilizzare indici di media: media aritmetica, a- ritmetica ponderata, geometrica, armonica, quadratica, mo- da e mediana.
• Calcolare e utilizzare indici di variabilità: varianza, devia- zione standard
• Determinare l’indipendenza statistica
• Calcolare la correlazione
• Determinare la retta di regressione lineare
C1, C4, C6
5
La programmazione potrebbe subire modifiche in base all’andamento didattico della singola clas-
se.
Strumenti di verifica
Negli scrutini del primo trimestre come in quelli finali, la valutazione dei risultati raggiunti è formu-
lata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico che, secondo le indicazioni ministeriali, deve
fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strate-
gie metodologico-didattiche adottate dai docenti e volte ad accertare conoscenze, capacità e
competenze specifiche; si stabilisce che il numero minimo di prove da svolgere sono:
trimestre (primo periodo): tre (di cui almeno una orale)
pentamestre (secondo periodo): quattro (di cui almeno una orale)
Le prove scritte potranno essere potranno essere strutturate come esercizi o problemi.
Nelle interrogazioni si darà peso all'esposizione che dovrà essere scorrevole ed organica.
Criteri di valutazione delle prove
Si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:
- conoscenza e comprensione degli argomenti
- capacità di applicare quanto appreso
- logicità dell’elaborato o dell’esposizione
- uso del linguaggio specifico.
Criteri di valutazione finali
Si prenderanno in considerazione i seguenti elementi:
- situazione di partenza
- grado di progressione del processo di apprendimento
- raggiungimento degli obiettivi
- continuità nell’impegno a scuola e a casa
- partecipazione al dialogo educativo.
Criteri di sufficienza (standard minimo)
- Conoscere e comprendere la trattazione teorica dei nuclei fondanti del programma.
- Esporre in modo corretto quanto appreso.
- Applicare, in contesti algebricamente e concettualmente semplici, i contenuti appre-
si, con pochi errori e, comunque, di calcolo.
settembre 2018 Dipartimento di Matematica
Liceo scientifico Avogadro Roma
Programmazione di STORIA
Docente: Paola Dotto
A.S. 2018/2019
Classe 4° B
La classe si compone di 27 allievi, di cui 9 studentesse e 18 studenti; aperta al dialogo educativo -
didattico, si mostra attenta alle lezioni e interessata agli argomenti svolti. Non sempre, tuttavia,
risponde in modo costante all’impegno domestico. L’insegnante promuoverà nel suo
insegnamento la curiosità verso gli argomenti proposti cercando di impostare la didattica
attraverso la conoscenza degli argomenti proposti, l’approfondimento, facendo ricorso alla
storiografia delle fonti primarie e secondarie, insegnando il metodo storico di ricostruzione dei
contenuti, partendo dai dati e dalla narrazione di essi, interpretandoli. L’insegnamento della storia
mirerà all’acquisizione delle categorie interpretative fondamentali, all’apprendimento del lessico
specifico di disciplina, all’attenzione al Diritto nelle Costituzioni, per intraprendere un cammino di
comprensione verso i concetti di democrazia e modernità. Durante l’anno scolastico, l’insegnante
proporrà la lettura di romanzi storici o saggi in base all’interesse dimostrato dalla classe.
Obiettivi Didattici:
nel corso dell'anno scolastico oltre a perseguire gli obiettivi generali, individuati dai singoli
Dipartimenti, e quelli trasversali specificati nella Programmazione del Consiglio di classe, saranno
perseguiti i seguenti obiettivi formativi disciplinari:
Conoscenze : Conoscere il linguaggio specifico della disciplina, Conoscere i fatti storici
Capacità: Collocare nello Spazio-Tempo i fatti storici. Cogliere le connessioni dei vari fatti storici nelle loro interrelazioni struttura-sovrastruttura: aspetto politico (istituzioni, principi e metodi dell’esercizio del potere), aspetto economico (metodi, strumenti e rapporti di produzione, distribuzione della ricchezza, lavoro e classi sociali), aspetto culturale/scientifico (ideologia, valori, sistemi e religione). Identificare le principali cause e conseguenze degli eventi considerati. Riconoscere, selezionare e interpretare le fonti. Utilizzare diversi strumenti interpretativi come Storiografia, Atlanti, Tavole, Cronologie, Grafici
Competenze: Utilizzare lo studio della Storia al fine di operare collegamenti trasversali
tra le diverse discipline. Comprendere il presente alla luce del passato
Metodi: momento esplicativo da parte del docente, coinvolgimento e partecipazione
della classe nella dibattito e confronto sul tema proposto.
Strumenti di lavoro: libro di testo, dispense e sussidi audiovisivi e multimediali (filmati -
CD)
Strumenti di verifica e criteri di valutazione: sondaggi dal posto, esercitazioni in classe
e/o a casa, questionari, prove scritte (elaborati di filosofia, problemi, relazioni etc.) e
prove orali
Numero di verifiche: almeno due nel trimestre e pentamestre
Criteri di valutazione: si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di
Dipartimento e al PTOF
Programma:
Due modelli di monarchia Francia e Inghilterra
La Francia di luigi XIV: l’assolutismo, la persecuzione delle minoranze religiose,
mercantilismo e politica estera. L’Inghilterra la rivoluzione politica del 1642 e la
“Gloriosa rivoluzione” ; la guerra di successione spagnola e il nuovo assetto italiano.
L’età delle rivoluzioni
La nascita degli Stati Uniti: Il significato di una rivoluzione, le tredici colonie, il contrasto
con la madrepatria, la guerra e l’intervento europeo, la costituzione degli Stai Uniti.
La rivoluzione francese: crisi e mobilitazione politica, 1789 il rovesciamento dell’ancien
régime, la rivoluzione borghese 1790-91, la rivoluzione popolare, la Repubblica e la
guerra rivoluzionaria 1791-93; la dittatura giacobina e il Terrore 1793-94, la continuità
rivoluzionaria e tentativi di stabilizzazione, la rivoluzione francese e l’Europa.
Napoleone e l’Italia: Bonaparte e la campagna in Italia 1796-97, le Repubbliche giacobine
in Italia, la spedizione in Egitto e il colpo di stato 1798-99, modello politico e tradizione
rivoluzionaria.
Napoleone e l’Europa: il consolato pacificazione interna e internazionale, l’Impero e le
guerre, trasformazioni e contrasti nell’Europa napoleonica, la campagna in Russia e il
crollo dell’impero.
Le lotte per la libertà: restaurazione e rivoluzioni (1815-1848)
La Restaurazione e i suoi limiti, il Congresso di Vienna e il nuovo assetto europeo, la
restaurazione politica, gli aspetti sociali della Restaurazione, cospirazioni e società
segrete, i moti del 20-21 in Spagna e in Italia, l’indipendenza greca. I moti del ’31.
Il Risorgimento italiano:
Mazzini e la giovine Italia.
Le nuove correnti politiche: moderatismo, neoguelfismo, federalismo.
L’elezione di Pio IX, il biennio delle riforme 1846-1848. Le rivoluzioni del 1848, la
prima guerra di indipendenza.
Il pensiero liberale, Cavour il governo e la politica estera, la guerra di Crimea e gli accordi
di Plombiers
La seconda guerra di Indipendenza e il compimento dell’unità
La Destra storica e la Sinistra storica
Il difficile compimento dell’Unità, il brigantaggio la presa di Roma e la legge delle
Guarentigie.
Il Trasformismo di Depretis, Crispi, la politica coloniale e i governi di fine secolo.
Testo in adozione: Antonio Desideri e Giovanni Codovini Storia e Storiografia vol. 2A-2B D’anna
editore
Liceo scientifico Avogadro Roma
Programmazione di FILOSOFIA
Docente: Paola Dotto
A.S. 2018/2019
Classe 4° B
La classe si compone di 27 allievi, di cui 9 studentesse e 18 studenti; aperta al dialogo educativo e
didattico, si mostra attenta alle lezioni e interessata agli argomenti svolti. Risponde in modo
costante all’impegno domestico. L’insegnante promuoverà nel suo insegnamento la curiosità verso
gli argomenti proposti cercando di impostare l’insegnamento attraverso il confronto e il dibattito
dialettico -argomentativo, muovendo la sensibilità verso i contenuti di tipo etico morale, leggendo
i testi antologici, commentando i testi degli autori proposti dal manuale in adozione e la lettura
integrale di opere filosofiche del periodo illuminista o moderno in base all’interesse e al grado di
coinvolgimento del gruppo classe.
Obiettivi didattici: si rimanda alla programmazione di Dipartimento
Conoscenze
Conoscere temi e problemi della filosofia
Comprendere e saper utilizzare il lessico proprio della disciplina Abilità
Enucleare le idee centrali di un brano filosofico. Individuare le argomentazioni utilizzate a sostegno di una tesi. Riassumere le tesi fondamentali. Saper rilevare analogie e differenze tra filosofi di diversa impostazione.
Competenze
Saper ripercorrere diacronicamente l’evoluzione di un concetto e saperne individuare sincronicamente i rimandi all’autore. Individuare il rapporto tra le posizioni filosofiche oggetto di studio e le situazioni storiche in cui emergono, individuare e analizzare problemi significativi della realtà contemporanea, considerati nella loro complessità.
Metodi: momento esplicativo da parte del docente, coinvolgimento e partecipazione della
classe nella dibattito e confronto sul tema proposto.
Strumenti di lavoro: libro di testo, dispense e sussidi audiovisivi e multimediali (filmati -
CD)
Strumenti di verifica e criteri di valutazione: sondaggi dal posto, esercitazioni in classe e/o
a casa, questionari, prove scritte (elaborati di filosofia, problemi, relazioni etc.) e prove
orali
Numero di verifiche: almeno due nel trimestre e nel pentamestre
Criteri di valutazione: si fa riferimento a quanto stabilito nella Programmazione di
Dipartimento e al PTOF
Programma
1)L’Età tardo- antica e medievale:
La Patristica: caratteri generali. S. Agostino: l’uomo il pensatore, il cristiano. I tratti del
pensiero agostiniano, ragione e fede, dal dubbio alla verità. Dio come Essere Verità e
Amore. La struttura trinitaria del peccato. La polemica contro il manicheismo e il problema
del male, la polemica contro il donatismo, la polemica contro il pelagianesimo. Libertà
grazia e predestinazione.
2)La Scolastica:
Filosofia e scholae: S. Anselmo e la prova dell’esistenza di Dio, argomento a posteriori,
l’argomento ontologico
La disputa sugli universali: Realismo VS Nominalismo
3)La rivoluzione scientifica:
La nascita della scienza moderna, il nuovo modo di vedere la natura, il nuovo modo di
concepire la scienza, l’universo degli antichi e dei medievali, dal geocentrismo
all’eliocentrismo, dal mondo chiuso all’universo aperto.
Galilei: una vita consacrata alla scienza, la battaglia per l’autonomia della scienza, e il
rifiuto del principio di autorità. Le scoperte scientifiche ed astronomiche. Il metodo della
scienza: sensata esperienza e necessarie dimostrazioni. Metodo e filosofia: presupposti e
giustificazioni filosofiche del metodo, il realismo. Il processo.
6)La ragione e il suo metodo: Cartesio e il razionalismo
Cartesio: la vita e gli scritti, il metodo, il dubbio e il cogito, Dio come giustificazione
metafisica delle certezze umane. Il dualismo cartesiano.
Pascal: vita e opere e difesa del giansenismo. Il problema del senso della vita, il
divertissement. I limiti del pensiero scientifico: esprit de geometrie e esprit de finesse. Il
limiti della filosofia: i filosofi e il problema di Dio, i filosofi e la condizione umana, i filosofi e
i principi pratici. La meta filosofia di Pascal.
7) Ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese:
Locke: empirismo inglese e il suo fondatore, vita e opere, ragione ed esperienza, le
idee semplici, l’attività della mente, la conoscenza e le sue forme.
Hume: scetticismo gnoseologico, il concetto di causa, di abitudine, la critica alla
metafisica
8) Il pensiero politico nell’età moderna:
Hobbes: la politica, la condizione presociale e il diritto di natura. La ragione
calcolatrice e la legge naturale. Lo stato e l’assolutismo.
Rousseau: vita e opere, l’uomo nello stato di natura, allo stato di natura alla società
civile. Rousseau e l’illuminismo, il Contratto sociale : la struttura del patto, la sovranità
e il governo.
9)Kant : La Critica della Ragion Pura
Testo in adozione: Abbagnano Fornero La ricerca del pensiero voll. 2A/2B Paravia
PROGRAMMAZIONE ANNUALE INDIVIDUALE 2018 - 2019
Prof.ssa Rita Barbieri
Disciplina: INGLESE Classe IV B Testi in adozione: - Spicci/ Shaw : Amazing Minds 1 , Pearson Longman - Minardi/Jones : Go Live English Grammar, De Agostini ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE
La classe ha un atteggiamento corretto, positivo e collaborativo nei confronti dell’insegnante e manifesta la volontà di migliorare. La partecipazione è di solito ordinata e fattiva per i più, non sempre attiva per altri. Le competenze linguistiche possono definirsi al momento mediamente più che sufficienti, con diversi casi di ottima preparazione ma anche alcuni di generalizzata fragilità. La socializzazione tra i ragazzi sembra buona e l’atmosfera di lavoro è serena e produttiva.
OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA - Riconoscere la tipologia di testo analizzato e il suo registro linguistico - decodificare e riutilizzare i linguaggi specifici - comprendere il senso generale e/o individuare informazioni richieste - riassumere i contenuti - argomentare le proprie opinioni in modo completo, chiaro e coerente - discutere sequenze di film o articoli di giornali e riviste con lessico adeguato - organizzare le conoscenze in mappe concettuali/percorsi personali OBIETTIVI DIDATTICI Obiettivi didattici minimi
capacità di orientarsi nell’analisi di un testo
comprensione del senso generale del testo
conoscenza degli argomenti di letteratura e di attualità trattati
capacità di riferire in modo coerente, coeso e con lessico adeguato Obiettivi didattici superiori
migliore conoscenza della lingua sia dal punto di vista morfo-sintattico che lessicale
acquisizione dei linguaggi specifici
acquisizioni di informazioni e dati utili ad effettuare validi collegamenti e confronti con altre discipline
acquisizione di “socializing and presentation skills”
consolidamento dell’uso dell’inglese come lingua veicolar CONTENUTI
A. Letteratura
Section 2: THE RENAISSANCE AND THE AGE OF SHAKESPEARE - W. Shakespeare: “Hamlet”: To be or not to Be; “Macbeth”: The Dagger Scene; Sonnets 18 e 130;
- Cross-cultural Perspectives: Shakespeare in Refugee Camps; - Critical Perspectives: V. Woolf on Shakespeare: Shakespeare’s Sister;
Section 3: “FROM THE PURITAN AGE TO THE AUGUSTAN AGE” - Historical and Social Background - Literary Background - Movers and Shakers: Isaac Newton
- J. Donne’s sonnets : “Death be not proud”; “Batter my Heart”; “No Man is an
Island”
- J. Milton: “Paradise Lost”: Satan’s Speech
- Cross-cultural Perspectives: Is America Still Puritan?
- The Rise of the Novel: What are Novels?; What made Novels Possible?; A Versitile Genre
- D. Defoe:” Robinson Crusoe”: Robinson wants to leave England; Robinson’s first
day o the Island;
- J. Swift: “Gulliver’s Travels”; The Academy of Lagado;
Active investigation: Satire; “A Modest Proposal”
- S. Richardson: “Pamela”.
- Section 4 : The Romantic Age (1760-1837) - Historical and Social Background - Literary Background - The Declaration of American Independence - E-. Burke: A Philisophical Enquiry - W. Blake: The Lamb; The Tyger” “The Chimney Sweeper “ (2 vesrsions) - W. Wordsworth: “Preface to the Lyrical Ballads; “I wandered lonely as a cloud”; “My
Heart Leaps up”;
- S. T. Coleridge: “The Rime of the Ancient Mariner”
B. U.D.A. “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” Si approfondiranno le tematiche relative alla nascita dei partiti politici e del parlamentarismo in Gran Bretagna nel corso del XVII e XVIII secolo e la Dichiarazione di Indipendenza Americana.
METODOLOGIE L’approccio metodologico sarà prioritariamente di tipo comunicativo, privilegiando lo sviluppo della competenza linguistica rispetto alla conoscenza morfosintattica della lingua. Lo studente non si limiterà a “conoscere”, ma imparerà a “saper fare”, acquisendo conoscenze e competenze attraverso attività da cui estrapolare e stabilire regole e modelli che saranno poi strutturati in un adeguato quadro di riferimento. L'approccio comunicativo: a) è basato sull’uso della lingua come strumento per il raggiungimento di obiettivi extralinguistici; b) è basato su diversi tipi di interazione: tra mente e linguaggio, tra studente e insegnante, tra studente e studente, tra studente e testi; c) tende a valorizzare il contributo dello studente al processo educativo attraverso diversi tipi di interazione; d) stimola un atteggiamento attivo da parte degli studenti, ponendoli in situazioni in cui è necessario comunicare. L'approccio partecipativo: In questa prospettiva la classe viene vissuta come una comunità interdipendente. Le attività potranno svolgersi: a) attraverso un'interazione diretta/frontale tra docente e studenti nella fase dell’unità didattica in cui è necessario un input diretto da parte dell’insegnante, una discussione o una verifica da parte del docente o della classe stessa; b) mediante l'interazione tra piccoli gruppi di studenti nella fase di ampliamento e consolidamento dell’input attraverso la condivisione di attività, la presentazione di esperienze individuali, discussioni e confronti su tematiche diverse, al fine di moltiplicare il tempo di impegno attivo e di pratica linguistica da parte degli studenti; c) proponendo attività da svolgersi in coppia quando sarà necessaria una breve chiarificazione e/o un confronto, come nel caso della verifica della correttezza dei compiti assegnati per casa; d) con attività individuali quando si chiede allo studente una riflessione sulle proprie esperienze e/o di produrre un testo scritto. STRUMENTI DIDATTICI
Libri di testo, giornali, riviste, film e documenti in lingua originale, internet, presentazioni in Power Point e dvd. MODALITA’ E NUMERO DI VERIFICHE : si fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e alla programmazione del Dipartimento di lingua Inglese. In particolare, si prevedono almeno 3 verifiche, tra scritto e orale, nel trimestre e 5 nel pentamestre. VERIFICHE ORALI: Conversazione interventi dal posto Colloqui orali su temi definiti Presentazioni orali riguardanti anche ricerche e approfondimenti individuali o di gruppo Riassunti
Analisi del testo con contestualizzazione storica e rielaborazione personale VERIFICHE SCRITTE: Prove a risposta aperta Prove a risposta chiusa Analisi di testi Scrittura di brevi relazioni e commenti su tematiche trattate (gli elaborati verranno di tanto in
tanto raccolti dall’insegnante, corretti, valutati come produzione scritta e restituiti agli studenti)
MODALITA’ DI RECUPERO Corsi di recupero e corsi di sostegno in itinere saranno attivati secondo le necessità e le indicazioni fornite dal Collegio dei docenti. Roma, 20 ottobre 2018 Prof.ssa Rita Barbieri
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA e PIANO DI LAVORO INDIVIDUALE
per l’insegnamento di SCIENZE nella CLASSE IV sez. B Anno scolastico 2018/2019
Insegnante: Prof.ssa Graziella RUSCITTO
SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE La classe, nella quale insegno dal secondo anno di corso , ha affrontato con profitto nel complesso discreto (nessuna sospensione di giudizio ,e diverse buone valutazioni ) il programma di Biologia e di Chimica del terzo anno ;è formata da diversi elementi interessati alla disciplina e molto disponibili al coinvolgimento e all’approfondimento, e da altri che partecipano in maniera più discontinua, applicandosi con superficialità nello studio, mostrando impegno ed attenzione non sempre pienamente sufficienti. Negli anni precedenti il lavoro è stato impostato soprattutto sull’acquisizione di un corretto metodo di lavoro, oltre che dei contenuti di base delle discipline scientifiche, ed i risultati ottenuti sono stati molto positivi (soprattutto se valutati con riferimento ai prerequisiti ed alla situazione di partenza del secondo anno); già dal terzo anno ,infatti la classe appariva, in tutto il suo complesso, più matura, consapevole e disponibile all’apprendimento; rispetto allo scorso anno, inoltre , sembra avere in parte superato il timore della partecipazione attiva ,la cui iniziativa era lasciata e demandata a pochi, lasciandosi coinvolgere maggiormente ; anche se la partecipazione della classe nell'insieme , in questa fase iniziale, non sempre appare coordinata e costruttiva, probabilmente per la necessità di acquisire un buon ritmo di lavoro . Permane, in diversi elementi , la “resistenza” o il rifiuto al prendere appunti ,che non aiuta nè la rielaborazione dei contenuti né la precisione nell'uso del linguaggio specifico. Il comportamento disciplinare è corretto.
Particolare attenzione sarà dedicata , come avviene da due anni nelle lezioni da me svolte in questa classe, nel fornire agli studenti gli strumenti scientifici necessari per orientarsi nella realtà e tra le informazioni cui attingono quotidianamente , in modo che possano effettuare scelte consapevoli e sappiano districarsi tra le varie fonti con coscienza civile, competenza e capacità critica. OBIETTIVI DIDATTICI e OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA Lo studio delle Scienze Naturali si compone di discipline distinte, Biologia, Chimica e Scienze della Terra, caratterizzate da contenuti concettuali e metodologie di lavoro differenziate. Esiste però un aspetto essenziale comune alle tre discipline: la medesima strategia di indagine: sono infatti materie fondate sul metodo scientifico – sperimentale, un sistema di ricerca basato sull’osservazione, la sperimentazione, l‘elaborazione di ipotesi , leggi e teorie. L’acquisizione di questo metodo, declinato nei diversi ambiti, costituisce l’aspetto formativo dell’insegnamento delle Scienze, prima ancora del possesso dei contenuti disciplinari specifici. Lo studio della Chimica in particolare si propone diverse finalità: concorre in modo fondamentale alla formazione dello studente, in quanto fornisce strumenti essenziali per orientarsi nella complessa realtà scientifica e tecnologica; costituisce una delle premesse per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile; contribuisce a sviluppare le capacità di osservazione; contribuisce alla genesi di una coscienza naturalistica che maturi nello studente il senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle sue risorse; consente di interpretare leggi naturali e fenomeni legati all’attività scientifica e tecnologica. FINALITA’ dell’insegnamento scientifico :
Fornire agli studenti gli strumenti essenziali per orientarsi nella complessa realtà scientifica. Sviluppare le capacità di osservazione. Porsi in modo razionale di fronte ala realtà ed in modo critico rispetto alle informazioni , valutando
correttamente l’affidabilità delle fonti. Sviluppare consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali, dei sistemi materiali e viventi e delle
relazioni interne ad essi. Saper comprendere ed utilizzare un linguaggio appropriato e corretto dal punto di vista scientifico per
comunicare e sintetizzare informazioni , spiegare fenomeni , partecipare a discussioni esprimendo le proprie idee.
Prendere coscienza della continua evoluzione del pensiero scientifico. Costituire una delle premesse per la costruzione di una professionalità polivalente e flessibile. Contribuire alla genesi di una coscienza naturalistica che maturi nello studente il senso di responsabilità nei
confronti della conservazione degli equilibri e nella gestione dell’ambiente e delle sue risorse. Fornire le basi di una corretta educazione alla salute.
Per raggiungere queste finalità sono programmati i seguenti obiettivi specifici, comportamenti ed azioni misurabili e valutabili , punti di riferimento in termini di conoscenze ed abilità: OBIETTIVI SPECIFICI (con l’asterisco* sono contrassegnati gli standard minimi):
Acquisire conoscenze e competenze*. Acquisire capacità critiche, intese come riflessione e valutazione personale. Acquisire capacità di sintesi e d’analisi*. Saper organizzare le conoscenze acquisite*. Risolvere problemi. Saper effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni*. Comprendere ed avere padronanza del linguaggio specifico*. Individuare le correlazioni tra i fenomeni*. Classificare, formulare ipotesi, trarre conclusioni*. Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale. Esaminare le caratteristiche della materia*. Comprendere le leggi che regolano le trasformazioni della materia*. Analizzare le relazioni tra le diverse trasformazioni*. Conoscere il comportamento della materia nei tre stati fisici. Saper rappresentare una reazione chimica* Definire il controllo delle reazioni chimiche Analizzare le relazioni tra le diverse componenti biologiche*. Conoscere gli aspetti dell’anabolismo e del catabolismo degli esseri umani e le caratteristiche delle funzioni
che sono collegate a questi aspetti* Educare alla Salute*. Partecipare al dialogo educativo*.
CONTENUTI Per poter comprendere il significato dei fenomeni scientifici, dei processi vitali e degli interventi sull’ambiente è necessario interpretare correttamente i meccanismi fisici e chimici e biologici che ne sono alla base; occorre guidare gli allievi all’osservazione ed alla comprensione dei fenomeni ed all’educazione ai processi logico – causali, anche per poter stabilire le relazioni che intercorrono tra i diversi processi naturali. Si partirà dall’osservazione macroscopica dei corpi, delle sostanze e dei fenomeni per arrivare in modo graduale all’aspetto particellare della materia, ed infine offrire spunti di connessione tra conoscenze scientifiche ed applicazioni tecnologiche. Nell’insegnamento delle Scienze Naturali del primo biennio del liceo scientifico riformato l’ approccio alla disciplina è stato di tipo fenomenologico e osservativo – descrittivo. Nel secondo biennio sono stati e verranno ampliati, consolidati e posti in relazione i contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli ed il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. Biologia Si porrà l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra le componenti di tali sistemi e tra i diversi sistemi e sulle basi fisiologiche dei sistemi stessi. Lo studio riguarderà la forma e le funzioni dell’ organismo umano, trattandone sia gli aspetti anatomici che le funzioni metaboliche di base. Verranno inoltre considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la nutrizione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento costante e continuo agli aspetti di Educazione alla Salute. Chimica Si riprenderà la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si approfondiranno lo studio della struttura della materia e delle relazioni tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura dei composti, il sistema periodico, le proprietà periodiche ed i legami chimici. Si proseguirà con lo studio delle seguenti unità didattiche: le caratteristiche dei composti chimici; .le soluzioni; le reazioni chimiche, la stechiometria delle reazioni; il controllo delle reazioni chimiche; l’energia; la velocità delle reazioni; l’equilibrio chimico; le reazioni di ossido – riduzione; la chimica degli elementi. Si darà adeguato spazio agli aspetti quantitativi, e quindi ai calcoli relativi ed alle applicazioni. Scienze della Terra Si riprende il concetto di Sistema Integrato Terra e si cominciano ad analizzare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera, biosfera).
Si studieranno la struttura interna della Terra, la composizione della litosfera , e si inizierà a catalogare , classificare e riconoscere minerali e rocce, dopo aver approfondito in Chimica le caratteristiche della materia e dei materiali allo stato solido. METODOLOGIE DI LAVORO - STRUMENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI Nel presentare i contenuti, e per la loro acquisizione, si ritiene fondamentale ricercare la partecipazione attiva degli allievi, cercando di stimolare l’interesse allo studio e, per quanto possibile, il coinvolgimento personale. Si ricorrerà pertanto a lezioni frontali e a lezioni partecipate; le prime saranno costituite dalle introduzioni di carattere generale, dall’esposizione di concetti, dalla costruzione di mappe concettuali, dalla sistematizzazione dei risultati emersi, dagli approfondimenti. Nelle lezioni partecipate si utilizzeranno, soprattutto, domande -stimolo e modi di risoluzione di casi o problemi specifici mediante applicazione concrete delle conoscenze acquisite. Si organizzeranno, se e quando possibile, lavori di gruppo per raccogliere ed esaminare materiale, per redigere e presentare relazioni. Si cercherà, inoltre, di approfondire tematiche specifiche per realizzare progetti che abbiano una ricaduta sul mondo esterno. Come strumenti di lavoro si utilizzeranno libri di testo, sussidi quali enciclopedie e dizionari(anche multimediali) materiale di documentazione (libri, articoli di quotidiani e di riviste specializzate, siti web specialistici), materiale didattico come schede di lavoro, schemi riepilogativi e riassuntivi, presentazioni in PowerPoint, LIM, mezzo informatico, audiovisivi. Si utilizzerà il laboratorio di Scienze per esperienze e lezioni. Sono previste uscite didattiche brevi con visite a mostre e partecipazione a convegni ed incontri presso Enti scientifici. Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche valore orientativo al proseguimento degli studi. Per questo motivo si cercherà di attivare, ove possibile, collaborazioni con Università, Enti di Ricerca, Musei della Scienza e mondo del lavoro. VERIFICA DEL LAVORO SVOLTO E METODOLOGIE DI VALUTAZIONE
Sono necessarie verifiche periodiche delle abilità conseguite dagli allievi in corrispondenza degli obiettivi prefissati. Il raggiungimento degli obiettivi va accertato rilevando: il livello di conoscenza; il livello di comprensione; il livello di applicazione. La verifica formativa sarà effettuata, pertanto, per conoscere grado e stile d’apprendimento da parte degli allievi e per individuare eventuali lacune (in modo da programmare interventi di recupero); gli alunni potranno così rendersi conto dei risultati ottenuti, rispetto all’impegno, e dell’efficacia del metodo di studio. Per ciascuna unità didattica è previsto un momento di riflessione in classe; qualora i risultati raggiunti non fossero soddisfacenti, si potrà impostare un eventuale itinerario didattico correttivo od alternativo. Oltre alle verifiche formative in itinere, si ricorrerà alle interrogazioni con cui far emergere la capacità di impostare i problemi in modo personale, la logica che guida l’esposizione, la quantità di nozioni assimilate e la loro rielaborazione originale, la precisione del linguaggio. Si prevede un congruo numero di verifiche orali supportato da prove scritte di diverso tipo ( domande a risposta aperta , quesiti a risposta chiusa, test strutturati e semi - strutturati, relazioni, esercizi ed applicazione delle conoscenze). In particolare, per far emergere le capacità sintetiche e per quantificare in modo generale la preparazione dell’allievo o la parte compiuta del programma, si utilizzeranno questionari che consentiranno di accertare il livello d’acquisizione delle nozioni Saranno anche svolte esercitazioni ,suscettibili o meno di valutazione, a seconda delle condizioni della classe e delle esigenze didattiche del momento . Per le verifiche orali ci si baserà anche sull’organizzazione del tempo-scuola e sulle necessità individuali. Le verifiche orali potranno quindi essere sostituite e/o integrate con test, strutturati o semi-strutturati,
questionari e quesiti, a risposta singola o multipla, trattazioni sintetiche di argomento,relazioni di laboratorio, lavori di
approfondimento, esercizi e problemi ,sia per motivazioni di ordine didattico ( sono tipi di verifica che garantiscono
un’applicazione più oggettiva dei criteri di valutazione) che di ordine pratico (se ne possono realizzare diverse, e in un’
ottica di più ampio respiro, anticipano l’impostazione delle prove di ammissione alle facoltà universitarie e preparano
allo svolgimento di concorsi, gare studentesche ed esami vari).
Le verifiche orali saranno continue ed in itinere, per consentire il monitoraggio dell’apprendimento e del profitto lezione per lezione. Le verifiche scritte saranno di tipo sommativo, e pertanto, comprensive di più unità didattiche, moduli o segmenti curricolari, sia per consentire una valutazione più oggettiva, sia per adeguarle alle modalità dei futuri test di ammissione e/o valutazione, nonché per favorire impegno, attenzione e apprendimento continui e costanti, indispensabili per ottenere le basi di una preparazione completa. Il numero minimo di verifiche previsto dal Dipartimento di Scienze è due nel trimestre e tre nel pentamestre.
La metodologia da seguire nella valutazione sarà basata sui diversi tipi prove, con modalità diversificate a seconda
degli argomenti oggetto delle verifiche. Tutte le prove contribuiranno, con pesi anche differenziati, alla
determinazione della valutazione finale. N.B: l'interrogazione scritta equivale alla verifica orale e ne segue le regole: (
1) è prevista per ogni lezione, sugli argomenti svolti nelle lezioni precedenti e/o assegnati come compiti a casa, 2) non
ammette giustificazioni, se non per motivi documentati di eccezionale gravità, 3) non rientra nel monte giornaliero
dei compiti scritti della classe. Le verifiche orali , inoltre, non sono “programmabili”.,in modo da favorire negli
studenti lo studio continuativo e l'attenzione costante al percorso didattico; si prevedono eccezioni di
verifiche”concordate “ o “su base volontaria” solo in presenza di BES o motivi contingenti di particolare gravità.
La verifica/valutazione sommativa sarà impostata sui seguenti criteri : risultati conseguiti preparazione di base progressi manifestati in rapporto al livello di partenza potenzialità degli allievi interesse e partecipazione al dialogo educativo comportamento impegno
in relazione al raggiungimento degli obiettivi. Per le valutazioni , adattando all’insegnamento delle Scienze Naturali i parametri di voto considerati nella programmazione collegiale, si utilizzerà la seguente TABELLA DOCIMOLOGICA di riferimento, in decimi: Voto Motivazione
1 Rifiuto di partecipazione al dialogo educativo. Rifiuto di acquisire conoscenze 2 Consegna di foglio bianco o rifiuto di interrogazione. Ritiro di un compito svolto con l’ausilio di supporti
non previsti dal Regolamento disciplinare. 3 Mancanza di contenuti specifici. 4 Risposte frammentarie che denotano mancanza di conoscenze o conoscenza parziale dei contenuti
essenziali; linguaggio improprio; esposizione incerta e limitata 5 Espressioni inadeguate dovute a studio mnemonico o superficiale che determina insufficiente capacità a
collegare gli argomenti 6 L’alunno conosce, comprende, ma non collega adeguatamente i diversi argomenti; la capacità di
rielaborazione autonoma è modesta; il linguaggio sufficientemente appropriato 7 L’alunno conosce, comprende e sa inquadrare il problema proposto usando un linguaggio concreto e
corretto; sa impiegare autonomamente le conoscenze acquisite 8 L’alunno conosce , approfondisce, rielabora i contenuti e risolve i problemi analizzando e sintetizzando;
l’espressione è corretta e sicura 9-10 L’alunno rielabora autonomamente , collega ed approfondisce con ricerche personali; la preparazione è ampia ed approfondita; c’è ricchezza e proprietà di linguaggio; i problemi sono affrontati con visione critica e personale.
I voti più alti deriveranno da una somma di abilità acquisite con continuità di impegno e ricerca autonoma. I voti allo scrutinio verranno espressi con numeri interi e rappresenteranno il risultato di verifiche e valutazione basati sui criteri sopra indicati con relativo arrotondamento . Nel registro elettronico i voti saranno invece trascritti integralmente, con l’uso di decimali, se necessario, per cogliere e marcare le differenze all’interno della banda di oscillazione docimologica.
N. B.: durante le lezioni e le verifiche non è consentito l'uso di cellulari, tablet e altri dispositivi elettronici; l'uso di
questi strumenti è sanzionabile e , durante i compiti scritti, comporterà l'annullamento del compito e la conseguente
attribuzione del voto 2.
MODALITÀ DI RECUPERO Il recupero verrà effettuato prevalentemente in itinere, al termine dello svolgimento di unità o moduli; al termine del primo trimestre, non essendo possibile attivare corsi di Scienze nell’Istituto, il recupero delle carenze ,per gli allievi che presentino insufficienze alla valutazione del primo periodo, sarà basato sullo studio individuale, con verifica nel secondo pentamestre.
Roma, 12 ottobre 2018 L’INSEGNANTE
Prof.ssa Graziella RUSCITTO
LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
1
Liceo Scientifico AVOGADRO via Cirenaica e Via Brenta (Roma)
PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 4B Anno scolastico 2018-2019
PREMESSA.
L’insegnamento dell’ Educazione Fisica , tende al motivato coinvolgimento degli alunni e delle alunne; le svariate attività proposte, saranno rivolte a tutti anche ai meno dotati e a coloro che manifestano
gravi carenze e lacune. Gli esonerati nella parte pratica, infine, oltre ad avere un programma teorico più approfondito, saranno coinvolti con compiti di organizzazione, assistenza e arbitraggio. L' attività pratica varierà , per intensità e durata di lavoro durante il corso dell’anno.
Sarà dato largo spazio alle metodiche valide per prevenire eventuali distonie e paramorfismi. E’ prevista la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi,in previsione dei quali saranno organizzati corsi di avviamento e approfondimento tecnico tattico in orario extracurriculare.
REGOLAMENTO DELLA PALESTRA. 1. Per svolgere le attività pratiche di Educazione Fisica è assolutamente indispensabile indossare tuta o pantaloncini e scarpe da ginnastica idonee. 2. Le classi che hanno Ed. Fisica si recano rapidamente in Palestra, senza soste e tenendo un comportamento corretto.
3. L’accesso agli spogliatoi è consentito solo alle classi che hanno lezione di
Educazione Fisica, per cambiarsi e depositare gli oggetti personali. Gli oggetti di valore vanno custoditi negli armadietti che si trovano in Palestra. 4. Ogni lezione è preceduta dall’appello.
5. Gli alunni che non hanno il materiale occorrente sono tenuti a rimanere seduti nei luoghi previsti per l’attività, a non disturbare lo svolgimento delle lezioni, a seguire eventuali spiegazioni e le attività in corso o dedicarsi all’arbitraggio. Per gli alunni che si ostinano a non portare il materiale occorrente verranno prese misure disciplinari. 6. E’ obbligo rispettare il materiale sportivo, fare attenzione all’uso della palla nei giochi sportivi, utilizzare i piccoli attrezzi e i tavoli da tennis-tavolo in maniera corretta e solo in presenza degli insegnanti. Tutto il materiale utilizzato, al termine della lezione deve essere riposto nei luoghi indicati dagli insegnanti.
7. N o n è consentito praticare il calcetto in palestra.
8. E’ vietato consumare cibo e bevande in palestra.
Per quanto non specificato si confida nel senso civico e la buona educazione di tutti.
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 1. Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale.
LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
2
Liceo Scientifico AVOGADRO via Cirenaica e Via Brenta (Roma)
2. Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo. 3. Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni. 4. Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al miglioramento dell’autostima.
5. Includere e consolidare un’equilibrata coscienza sociale basata sulla
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza concreta di contatto socio-relazionali soddisfacenti. 6. Trasmettere informazioni e stimoli affinchè l’attività motoria e sportiva diventi uno stile di vita.
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA.
Per l’individuazione degli obiettivi specifici, bisognerà valutare i livelli cognitivi e psicomotori dei ragazzi. Allo scopo appaiono opportuni sia un iniziale colloquio con la classe per vagliare le conoscenze specifiche della materia sia la somministrazione di stimoli condizionali e coordinativi, al fine di conoscere il vissuto motorio e le potenzialità di ogni singolo alunno.
Successivamente si tenderà ad accrescere nello studente la coscienza del proprio corpo, attraverso il movimento guidato.
OBIETTIVI SPECIFICI
1. Potenziamento fisiologico. 2. Rielaborazione degli schemi motori di base. 3. Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 4. Conoscenza e pratica delle attività sportive.
5. Studio di argomenti teorici, tratti dal libro di testo “In Movimento”. CONTENUTI.
1-POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. Saranno attivate tutte quelle attività che coinvolgeranno le qualità condizionali quali:
RESISTENZA FORZA VELOCITA’ O RAPIDITA’
MOBILITA’ ARTICOLARE. 2-RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE. Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato del corpo, attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie, si pensa necessario lavorare sulla coordinazione, con particolare riguardo all’ampliamento delle
esperienze motorie ed alla conseguente varietà delle risposte che devono essere sempre
più precise e raffinate. Coordinazione dinamica generale Equilibrio
Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica Ideogrammi motori
3-CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO
LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
3
Liceo Scientifico AVOGADRO via Cirenaica e Via Brenta (Roma)
CIVICO. Al fine di conseguire tale obiettivo si propongono:
Vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica Esercizi con attrezzi, percorsi e circuiti Partecipazione all’organizzazione delle varie attività e arbitraggio di gare
Concetti generali di sicurezza e primo soccorso. 4- CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE. In base alla situazione delle strutture utilizzate e in una certa misura, agli interessi degli allievi e alle loro capacità verranno praticate le seguenti discipline:
Giochi sportivi - pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo e altre attività in base alla richiesta della classe.
Atletica – corsa di mezzofondo , velocità.
Ginnastica – progressioni semplici a corpo libero e con piccoli attrezzi, individuali, a coppie e in gruppo anche preparate autonomamente.
Per la pratica di altri sport inerenti i Giochi Sportivi Studenteschi saranno selezionati quegli alunni che hanno già una preparazione specifica per quelle discipline. Al termine dell’anno l’alunno dovrà aver sviluppato le competenze relative ad uno dei livelli sotto descritti: Livello base (voto 6/10): lo studente effettua esercizi ginnici semplici e la pratica di alcuni fondamentali individuali di un gioco sportivo, in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali. Conosce schematicamente gli argomenti teorici del programma.
Livello intermedio (7-8/10): lo studente effettua esercitazioni ginnico- sportive adattandosi al meglio in situazioni motorie complesse anche non note, compie scelte appropriate, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. Oltre a conoscere gli argomenti teorici del programma riesce ad approfondirli. Livello avanzato (9-10/10): lo studente effettua esercitazioni ginnico- sportive adattandosi al meglio in situazioni motorie non note, pratica almeno uno sport a livello agonistico, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Nella teoria conosce perfettamente gli argomenti trattati e sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.
LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
4
Liceo Scientifico AVOGADRO via Cirenaica e Via Brenta (Roma)
ATTIVITA’ DI RECUPERO. Sarà effettuata in itinere per coloro che presentano difficoltà motorie di base. Si interverrà durante lo svolgimento delle lezioni attraverso attività individualizzate o di gruppo, applicando anche la flessibilità per quegli studenti che fanno parte di classi parallele.
METODO D’INSEGNAMENTO.
La lezione tipo di Educazione Fisica sarà strutturata nel modo seguente: prima parte, rilevamento delle assenze degli alunni e della loro partecipazione attiva o non alle lezioni; seconda parte, esercizi di riscaldamento e attività ginnica-motoria come previsto dal programma; terza parte, pratica di un gioco sportivo (pallavolo, pallacanestro,calcio
tennis-tavolo). Nello svolgimento di questa terza parte spesso saranno assecondate le
preferenze e le predisposizioni degli alunni ed essendoci nella stessa ora la presenza contemporanea di altre classi, si formeranno gruppi di lavoro per classi di sezioni diverse, soprattutto quando queste saranno parallele o almeno contigue. In questa fase i docenti si organizzeranno per seguire non la propria classe ma i gruppi di lavoro costituitisi che ovviamente dovranno essere pari al numero dei docenti presenti in quell'ora. La durata delle singole fasi sono a discrezione del docente. Per quanto riguarda gli argomenti teorici si prevedono lezioni in classe. Nello svolgimento delle lezioni si cercherà di coinvolgere attivamente tutta la classe, l’Insegnante valuterà se guidare ogni attività riducendo gli spazi liberi degli allievi oppure se operare riservandosi il compito d’intervenire per stimolare correzioni, analisi di problemi per ottenere risposte motorie adeguate in modo che ogni esperienza diventi uno stimolo per l’attività autonoma. Lo spirito competitivo dovrà essere contenuto nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al superamento di quelle dei compagni. Si fa presente, inoltre, che l’attività pratica sarà supportata contestualmente da informazioni teoriche secondo il programma stabilito e si terranno, inoltre lezioni in classe per approfondire gli argomenti. Gli esonerati alle lezioni pratiche saranno valutati non solo nella parte teorica del programma ma anche dalla loro collaborazione nelle attività organizzative di arbitraggio.
METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE.
La valutazione formativa sarà utilizzata in itinere per evidenziare eventuali lacune ed apportare in tempo procedure didattiche compensative. La valutazione terrà conto del miglioramento delle capacità condizionali e coordinative, del comportamento mostrato nel corso delle varie attività svolte e dell’acquisizione dei contenuti teorici trattati. L’impegno, l’interesse, la regolarità di applicazione, il rispetto delle regole e del materiale sportivo e,infine, la frequenza sono elementi basilari per la valutazione. Per la valutazione degli argomenti teorici saranno effettuati colloqui con gli alunni. Le verifiche per la valutazione delle capacità condizionali e coordinative e la valutazione dell’apprendimento tecnico delle discipline proposte, saranno simultanee al lavoro svolto e basate su prove e attenta osservazione dell’alunno da parte dell’insegnante.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE.
In riferimento ai criteri di valutazione del Liceo, gli insegnanti di Educazione fisica concordano la seguente griglia di valutazione:
Il voto 9/10 sarà dato agli alunni che
A – mostrano notevole interesse e predisposizione per la disciplina B – rispettano le regole e il materiale della palestra C – portano sempre l’abbigliamento adatto per svolgere le attività pratiche
LICEO SCIENTIFICO AVOGADRO DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE FISICA
5
Liceo Scientifico AVOGADRO via Cirenaica e Via Brenta (Roma)
D –acquisiscono movimenti complessi e li esprimono in maniera raffinata in tutte le attività E – organizzano le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati
F – eccellono in una disciplina sportiva che praticano ad un livello buono.
G - Nella teoria conoscono perfettamente tutti gli argomenti trattati e sa proporre e
sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. Il voto 8 sarà dato agli alunni che:
a – mostrano interesse costante, portano il materiale occorrente e rispettano le regole b – mostrano capacità coordinative e condizionali abbastanza sviluppate nelle varie discipline sportive. c – Conoscono gli argomenti teorici trattati in maniera approfondita ed esauriente.
Il voto 7 sarà dato agli alunni che: a – partecipano assiduamente e mostrano interesse per la disciplina
b – migliorano in maniera significativa le capacità condizionali e coordinative anche se commettono delle imprecisioni nell’espressione di qualche gesto motorio di difficoltà medio-alta. c – conoscono quasi tutti gli argomenti teorici trattati in maniera esauriente.
Il voto 6 sarà dato agli alunni che: a – partecipano in maniera non sempre costante
b – elaborano gli schemi motori in maniera semplice c – oppure pur mostrando qualche difficoltà nell’apprendimento motorio si applicano con impegno e costanza d – oppure possiedono buone qualità motorie che non usano e non sfruttano in maniera adeguata. e – Conoscono buona parte, anche se in maniera schematica, gli argomenti teorici trattati.
Il voto 5 sarà dato agli alunni che:
a – partecipano e s’impegnano in maniera saltuaria nonostante le continue sollecitazioni da parte del docente b – mostrano difficoltà ad incrementare le capacità condizionale e coordinative
c – conoscono in maniera superficiale e con qualche lacuna una parte degli argomenti teorici trattati.
Il voto 4 sarà dato agli alunni che:
a – mostrano una scarsa partecipazione ed un impegno molto superficiale
b – conoscono appena qualche argomento teorico trattato e con molte lacune nella esposizione.
I voti 1/2/3 saranno dati agli alunni che:
a – hanno un rifiuto totale per le attività motorie e sportive, e una conoscenza nulla degli argomenti teorici trattati.
Prof.Gabriele Paolucci
Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro”
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Materia: INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. Andrea Avellino
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
Profilo generale:
L’insegnamento della Religione cattolica, nel biennio, e ancor più nel triennio, concorre a promuo-
vere il pieno sviluppo della personalità degli alunni.
Tale insegnamento concorre, inoltre, a promuovere negli alunni l'acquisizione della cultura religiosa
in senso universale ed offre contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-
culturale in cui essi vivono; viene incontro ad esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita;
contribuisce alla formazione della coscienza morale ed offre elementi per scelte consapevoli e
responsabili di fronte ai vari problemi religiosi e civili odierni.
Obiettivi formativi:
La disciplina promuove l'acquisizione della cultura religiosa secondo il più alto livello di conoscen-
ze e di capacità critiche proprio di questo grado di scuola, offrendo contenuti e strumenti che aiutino
lo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano della società italiana ed europea; con-
corre ad arricchire - insieme alle altre discipline - la formazione globale della persona e del cittadi-
no, in vista di un efficace inserimento nel mondo civile, universitario e professionale e di una parte-
cipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana.
Poiché la scuola fornisce chiavi di lettura per la comprensione della realtà italiana, europea, occi-
dentale e – nei limiti del possibile – mondiale, l’insegnamento della religione promuove anzitutto la
conoscenza oggettiva e sistematica della Tradizione cristiana (in specie cattolica) e della Bibbia, in
quanto parti rilevanti del patrimonio storico-culturale italiano ed europeo. Per lo stesso motivo, la
disciplina abbraccia lo studio delle differenti confessioni cristiane e delle principali Tradizioni reli-
giose mondiali (ebraismo, islam, induismo, buddismo) con i loro Testi Sacri, che in epoche e con
peso diverso hanno influenzato la cultura e lo sviluppo del pensiero occidentale. In tal modo parte-
cipa – specie nell’attuale contesto multiculturale della società italiana ed europea -
al dialogo e al confronto tra tradizioni culturali e religiose diverse.
Come ogni disciplina curricolare all’interno del proprio sapere, l’insegnamento della religione viene
incontro alle esigenze di a-letheia e di ricerca degli studenti, soprattutto in relazione alle domande
di senso che essi si pongono; contribuisce all’informazione circa gli aspetti spirituali ed etici
dell’esistenza e concorre a formare una coscienza etica e una propria spiritualità (credente, atea o
agnostica); offre elementi per scelte consapevoli di fronte al problema religioso.
Obiettivi di apprendimento – Triennio
Conoscenze Abilità Competenze Nuclei tematici essenziali
1) Gesù della fede:
l’incarnazione
Il mistero della Trinità
- imposta criticamente la
riflessione su Dio nelle sue
dimensioni storiche, filoso-
fiche e
teologiche;
- Delineare i tratti
fondamentali della
rivelazione di Dio in Gesù
Cristo.
- Strutturazione e
comprensione del Credo
- Elementi fondamentali di
cristologia e teologia
trinitaria
2) Lo sviluppo del
cristianesimo nel tempo - Riconoscere la tensione tra
realtà e ideali, tra limiti
dell’uomo e azione dello
Spirito nella vita ecclesiale
- Affrontare il rapporto del
messaggio cristiano
universale con le culture
particolari e con gli effetti
storici che esso ha prodotto
nei vari contesti sociali e
culturali
- Individuare le cause delle
divisioni tra i cristiani e
valutare i tentativi operati
per la riunificazione della
Chiesa
- Conoscere la
comprensione che la Chiesa
ha di sé, sapendo
distinguere gli elementi
misterici e storici,
istituzionali e carismatici;
- Conoscere lo sviluppo
storico della Chiesa nell’età
antica, medievale, moderna
e contemporanea cogliendo
i motivi storici delle
divisioni ma anche le
tensioni unitarie in
prospettiva ecumenica;
- Tappe fondamentali della
Storia della Chiesa e
questioni rilevanti di
ecclesiologia
- Confronto con le
principali tradizioni
religiose orientali.
- Analisi filosofica,
religiosa, storica,
strutturale delle principali
religioni orientali
3) Relazione tra fede e
razionalità scientifica - Riconoscere differenze e
complementarità tra fede e
ragione e tra fede e scienza
- Prosegue il confronto
critico sulle questioni di
senso più rilevanti, dando
loro un Inquadra- mento
sistematico;
- Studiare la relazione della
fede cristiana con la
razionalità umana e con il
progresso
scientifico-tecnologico
studiando alcuni casi
specifici attraverso testi
specifici
- Elementi e personaggi
fondamentali del rapporto
fede e ragione
4) Conoscenze
fondamentali della morale
cristiana.
Bioetica ed etica sociale
- Saper riconoscere la
serietà di alcune tematiche
morali e confrontarsi con
chi fa scelte morali
differenti
- Riconoscere le linee di
fondo della dottrina sociale
della Chiesa e gli impegni
per la pace, la giustizia e la
salvaguardia del creato
- Prosegue il confronto
critico sulle questioni di
senso più rilevanti, dando
loro un inquadramento
sistematico;
- Approfondire la
concezione cristiano-
cattolica della famiglia e del
matrimonio;
- Elementi di teologia
morale fondamentale e
speciale
Metodologia: - Lezione frontale
- Lezione partecipata
- Lezione multimediale
- Ricerca individuale
- Metodo induttivo
- Lavoro di gruppo
- Discussione
- Simulazioni
Valutazione:
In rapporto agli obiettivi didattici e disciplinari si osserverà, negli alunni, il loro interesse alle
attività della disciplina, le conoscenze acquisite, gli atteggiamenti maturi. Ciò potrà essere verificato
a un ritmo mensile, quadrimestrale e finale, con verifiche scritte, questionari, interviste su
specifiche tematiche, conversazioni ed interrogazioni. Oltre al raggiungimento degli obiettivi, delle
competenze e delle capacità sopra esposte, vengono valutate positivamente anche la disponibilità al
lavoro, all’attività didattica e al confronto; la presenza alle lezioni; la buona conduzione delle
relazioni interpersonali; la capacità di realizzare lavori in collaborazione; la capacità di
rielaborazione creativa e critica delle tematiche trattate.
La valutazione saprà comunque andare al di là della semplice quantificazione e cogliere il prodotto
finale del processo educativo e formativo promosso non solo dall’I.R.C., ma altresì dalle restanti
discipline in connessione tra loro.
Prof. Andrea Avellino
LICEO SCIENTIFICO STATALE “ A. AVOGADRO” - ROMA
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISEGNO E STORIA DELL’ARTE PROF .ALESSANDRO CANEPPELE Classe 4 Sez. B Anno scolastico 2018/19 LIVELLI DI PARTENZA La classe dimostra un discreto interesse per la materia con una attiva partecipazione alle
lezioni. Il corso è iniziato con lezioni sulla storia dell’arte del Rinascimento del ‘400. Si è
proseguita la progettazione architettonica lasciata al termine dell’anno precedente.Presto si
imposteranno le tavole grafiche per il disegno tecnico e quello artistico, per i quali gli studenti
hanno dimostrato interesse negli anni precedenti. Non si hanno ancora sufficienti elementi per valutare la conoscenza della Storia dell’Arte, ma considerando l'interesse e la
preparazione riportata l'anno scorso la si può stimare buona. OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI (conoscenza e capacità ) Conoscenze conoscenza degli argomenti trattati nel corso dell’anno scolastico come da
programma - conoscenza dei principali movimenti artistici ed autori (pur se in forma sintetica
ed attraverso una selezione mirata delle opere, dovuta ai problemi oggettivi delle ore
curricolari)che hanno caratterizzato la storia artistica occidentale, con gli opportuni
collegamenti ai principali avvenimenti storici e culturali delle epoche prese in esame. - Conoscenza dei principali sistemi di rappresentazione grafica e della relativa semantica del
segno Capacità capacità di saper leggere ed interpretare il libro di testo - capacità nell’utilizzo del
linguaggio specifico della disciplina - capacità di raccordare diversi ambiti disciplinari,
rilevando come nell’opera d’arte confluiscano aspetti e componenti de diversi campi del
sapere (umanistico, scientifico, tecnologico) - raggiungere buone capacità di analisi e di
sintesi – capacità di utilizzare i sistemi di rappresentazione grafica appresi, non come
applicazione meccanica di regole , ma come conseguenza di un processo logico spaziale
compreso, quantomeno, a livello intuitivo - autonomia di lavoro e capacità organizzativa sia
individuale che di gruppo. OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI Serietà e puntualità nel mantenere gli impegni, nella buona conservazione del materiale di
studio, nell’esecuzione dei compiti assegnati - partecipazione ed attenzione al lavoro di
CONTENUTI : sequenze organizzazione e tempi
classe e di gruppo – motivare lo studente allo studio e al valore della cultura intesa come
processo di evoluzione - rispetto reciproco, verso gli insegnanti e il personale della scuola -
senso di responsabilità - disponibilità e collaborazione
I contenuti programmatici, che saranno suddivisi in quadrimestre, compatibilmente
all’impegno degli allievi ed al livello di apprendimento raggiunto , riguarderà i seguenti
argomenti: - Geometria descrittiva : Esercitazioni sulla rappresentazione in proiezione ortogonale e visione assonometrica di solidi sovrapposti e incastrati. Studio di composizioni architettoniche e conseguente proposta progettuale. Teoria delle ombre in assonometria e relative applicazioni. Cenni sulla rappresentazione prospettica Analisi di strutture architettoniche e rappresentazione in disegno ornato delle opere
significative inerenti gli argomenti di storia dell’arte
Trimestre
IL SEICENTO : Caravaggio - Artemisia – Bernini – Borromini - P. da Cortona - G.Reni - i maestri fiamminghi. Pentamestre : IL SETTECENTO : Il Vedutismo : A. Canaletto e F. Guardi - IL NEOCLASSICISMO : A.Canova – J.L. David. IL ROMANTICISMO: T.Gericault – E. Delacroix – F. Hayez – G. Fattori e i Macchiaioli. - L’IMPRESSIONISMO: E.Manet – C. Monet – E. Degas – A. Renoir. - IL POSTIMPRESSIONISMO: P. Cézanne – P. Gauguin – V. van Gogh
METODOLOGIE OPERATIVE, RISORSE E STRUMENTI, USO DI SUSSIDI
E LABORATORI
Metodi : Lezione frontale – discussioni guidate – questionari – materiale audiovisivo in
dotazione della scuola – per lo svolgimento del programma di disegno, che comprende
l’esecuzione grafica di elaborati , con il materiale in dotazione a ciascuno degli studenti.
Il corso sarà integrato, quando possibile, da visite didattiche in luoghi di interesse artistico e
architettonico, come chiese, palazzi storici e mostre allestite nella nostra città.
RECUPERO
Per chi evidenzierà carenze durante il corso del programma si ritiene di operare con un
recupero in classe, sospendendo le lezioni per brevissimi periodi, se necessario,
VALUTAZIONE, CRITERI, MODI DI VERIFICA
La valutazione, benché espressa con un unico voto in decimi, tiene conto del raggiungimento
di più obiettivi, individuati da definizioni legate alla disciplina. In tal modo si pensa di poter
descrivere con oggettività il comportamento scolastico complessivo dell’alunno.Le voci che
verranno prese in considerazione per la valutazione di ciascun allievo e i criteri
e modi utilizzati per la loro valutazione vengono qui di seguito espresse:
1. Impegno e partecipazione
Evidente nella partecipazione alle lezioni, all’impegno dimostrato nello studio e legato
anche al rapporto ore di assenza/ore di lezione 2. Acquisizione dei contenuti
Prove scritte : test a risposta chiusa e/o aperta, saggi brevi – Prove orali : interventi, lezioni/relazioni, interrogazioni tradizionali - Prove grafiche: risoluzione di problemi grafico - rappresentativi 3. Acquisizione di un linguaggio specifico . Prove scritte : test a completamento – Prove orali :
lettura di opere d’arte – lettura di piante, prospetti e sezioni architettoniche – lettura degli
elementi che compongono il disegno geometrico degli elaborati svolti.
4. Metodo di lavoro
Evidenziabile nel metodo acquisito nella lettura del testo artistico e nell’acquisizione di
criteri di lavoro razionali e rigorosi nella realizzazione degli elaborati grafici assegnati.
Criteri di valutazione :
Le valutazioni intermedie e conclusive deriveranno dalle verifiche di cui al punto precedente
secondo i seguenti parametri
1-4 G r a v e m e n t e Gli elaborati risultano molto incompleti o fuori tema e risulta insufficiente chiara l’incapacità di sviluppare un qualsiasi argomento
artistico
5 Insufficiente Gli elaborati presentano carenze teorico-grafiche tali che risulta fortemente ridotta la comprensione dell’argomento assegnato; la preparazione dei temi di storia dell’arte, pur se
pertinente, è scoordinata o fortemente frammentaria.
6 Sufficiente Gli elaborati risultano sostanzialmente corretti sia nella teoria che nella risoluzione grafica; la conoscenza degli argomenti di storia dell’arte deve sfociare in una adeguata capacità di
sintesi.
7-8 Buono La prova grafica risulta completa, esatta e pienamente valida nella tecnica applicata; buona conoscenza degli argomenti di storia dell’arte associata ad una buona capacità di
rielaborazione interdisciplinare.
8 - 1 Ottimo o Gli elaborati si presentano completi, esatti, molto validi 0 Eccellente tecnicamente; la trattazione degli argomenti di storia dell’arte
deve evidenziare, oltre alle capacità sopra indicate, una
pertinente analisi critica.
L’Insegnante Prof. Alessandro Caneppele






















































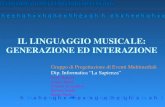







![µ Ì ] } v ] v } u ] o · txdqwlwj vlpphwulfd n vxffhvvl 2 : g l x j l s r á l l r ä w ; l s r h {h z h y h x h w h v h u h t x h w h v h u h t h v h u h t ® r ä w 5 4 l r ä](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5f143fd7e52ca628f67db95b/-oe-v-v-u-o-txdqwlwj-vlpphwulfd-n-vxffhvvl-2-g-l-x-j-l-s-r-l-l.jpg)