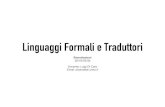DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V sez. H ......forme del sapere, di sviluppare la padronanza dei...
Transcript of DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V sez. H ......forme del sapere, di sviluppare la padronanza dei...

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ,
RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE
”BERTRAND RUSSELL” Via Tuscolana, 208 – 00182 Roma Tel. 06/121123005– Fax 06/7023714 Succursale:Via La Spezia 21 Tel. 06/121122140 - C.F. 80213970587 -
Sito web: www.liceorussellroma.it
E-mail: [email protected] – Pec: [email protected]
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI
CLASSE
V sez. H
Indirizzo Scientifico
Anno Scolastico 2018/19

1. Presentazione della scuola
L’Istituto, al termine del ciclo di studi di cinque anni, conferisce il diploma di scuola secondaria
superiore ad indirizzo classico, scientifico o linguistico valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o
diploma universitario e ai concorsi della pubblica amministrazione.
Elemento fondante del nostro Liceo è l’unità dei saperi, ossia lo sviluppo e l’armonica interazione di
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, quali:
▪ Saperi linguistico-letterari, storico-filosofici e artistico–espressivi in grado di sviluppare lo
spirito critico del giovane e di fornirgli una solida base culturale come strumento per
orientarsi nella società dell’informazione, per essere capace di situare, decodificare e
rielaborare autonomamente immagini e dati provenienti da molteplici fonti.
▪ Saperi matematici e scientifici in grado di sviluppare nel giovane competenze metodologiche
e professionali che gli permettano di seguire consapevolmente e criticamente le fasi dello
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, di individuare le interazione tra le diverse
forme del sapere, di sviluppare la padronanza dei linguaggi e delle tecniche e delle relative
metodologie.
▪ Capacità di porsi in relazione positiva con gli altri, di comprenderne i bisogni e di accettarne
le diversità.
▪ Capacità di progettare autonomamente e responsabilmente il proprio percorso di formazione culturale e professionale, discernendo e coltivando attitudini e interessi personali.
Al termine del percorso liceale per gli studenti è previsto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Conoscenze
▪ linguistico-letterarie, storico-filosofiche
▪ matematiche e scientifiche (teorico-empiriche)
▪ artistico–espressive
Abilità e competenze
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative metodologie relative alle varie discipline
comprensione, interpretazione e produzione di testi di varia tipologia e relativi a vari
ambiti disciplinari
comprensione e rielaborazione dei nodi concettuali relativi ai diversi statuti disciplinari
uso di schemi procedurali e tecniche di calcolo
elaborazione dei dati dell’osservazione
organizzazione critica delle conoscenze
analisi e sintesi
2

2. Profilo dell’indirizzo scientifico
Le conoscenze, abilità e competenze, secondo quanto indicato nel PTOF, vengono di seguito
sintetizzate:
BIENNIO
Conoscenze
▪ Possesso della struttura morfo-sintattica della lingua italiana
▪ Possesso di un lessico di base articolato
▪ Padronanza adeguata della terminologia specifica delle discipline
▪ Utilizzazione di base degli strumenti relativi ai vari ambiti disciplinari
Abilità e competenze
▪ Comprensione della struttura morfosintattica e concettuale di un testo orale e scritto
▪ Esposizione chiara e corretta, orale e scritta, dei contenuti appresi
▪ Applicazione in contesti noti delle conoscenze acquisite
▪ Individuazione dei nessi essenziali tra contesto storico-sociale e produzione culturale ed
artistica
▪ Sviluppo di attitudine alla sintesi di un discorso e di un testo
▪ Formulazione di giudizi personali argomentati e motivati
▪ Riferimento alla propria esperienza personale degli argomenti studiati
TRIENNIO
Conoscenze
▪ Contenuti delle varie discipline
▪ Padronanza del linguaggio specifico delle discipline
▪ Panorama storico-culturale italiano ed europeo
Abilità e competenze
▪ Corretto utilizzo del linguaggio scientifico
▪ Analisi di un testo scritto e di un problema scientifico nelle sue componenti concettuali ed espressive
▪ Identificazione e contestualizzazione, all’interno di un testo di riferimento, di termini e
concetti che rivestano un carattere paradigmatico
▪ Confronto fra eventi, fenomeni e testi di uno stesso ambito disciplinare e di diversi ambiti
disciplinari.
▪ Collocazione in chiave diacronica di eventi e processi storico-culturali e delle varie
problematiche loro collegate
▪ Capacità di astrazione e sistemazione logica e comparativa delle conoscenze,
relativamente ai vari linguaggi e discipline
▪ Rielaborazione critica e problematizzazione delle conoscenze
▪ Piena padronanza del metodo scientifico
▪ Produzione di testi di varia tipologia, in forma scritta e orale, secondo differenti contenuti, contesti e scopi comunicativi
▪ Comprensione e valutazione delle problematiche e delle relative scelte scientifiche e
tecnologiche che interessano la società
▪ Costruzione autonoma di un percorso di lavoro e di approfondimento
▪ Formalizzazione di problemi relativi alla realtà circostante
▪ Osservazione di fenomeni, semplificazione e modellizzazione di situazioni reali
▪ Capacità creative e strategiche nell’affrontare e risolvere problemi (problemsolving)
3

QUADRO ORARIO DELL’ INDIRIZZO SCIENTIFICO
1°biennio 2° biennio 5° anno
1° anno 2° anno 3° anno 4°anno
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e cultura letteratura latina
3 3 3 3 3
Lingua e cultura straniera (Inglese)
3 3 3 3 3
Storia e Geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica* 5 5 4 4 4
Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali** 2 2 3 3 3
Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Totale ore 27 27 30 30 30
* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. AL BIENNIO DEGLI INDIRIZZI CLASSICO E SCIENTIFICO E’ PREVISTA
L’INTEGRAZIONE OPZIONALE DEL CURRICULUM DI 2 ORE SETTIMANALI DI
SECONDA LINGUA (FRANCESE e SPAGNOLO) AFFIDATA A DOCENTI INTERNI , AL
FINE DEL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE EUROPEA DI
COMPETENZA LINGUISTICA. LE ORE SI SVOLGERANNO IN ORARIO
ANTIMERIDIANO
4

3. Profilo della classe
1° biennio
1^ anno
1° biennio
2^ anno
2° biennio
3^ anno
2° biennio
4^ anno
5^ anno
N° alunni
iniziale 24 24 28 22 22
Ritirati e/o non
promossi 4 7 7 1 1
Nuovi
Iscritti
5 11 2 1
N° alunni totale
fine a.s. 20 17 21 21 21
N° alunni
DSA/BES
La classe V H ad indirizzo scientifico consta attualmente di 21 studenti complessivamente, di
cui 11 maschi e 10 femmine.
Continuità didattica
DISCIPLINE 1
ANNO
2
ANNO
3
ANNO
4
ANNO
5
ANNO
Italiano Adornato Adornato Adornato Adornato Adornato
Latino Foti Tavano Adornato Adornato Adornato
Storia/geogr. Foti Tavano
Inglese Scarano Scarano Scarano Scarano Scarano
Storia Cimarelli Cimarelli Cimarelli
Filosofia Cimarelli Cimarelli Cimarelli
Matematica Iannicelli Iannicelli Iannicelli Tommasi Tommasi
Fisica Casale Casale Burgos Santo Inglese
Scienze natur. Amatruda Amatruda Amatruda Amatruda Amatruda
Dis. St.Arte Grassini Grassini Tittarelli Tittarelli Tittarelli
Scienze motorie Urtone Boncoraglio Mongelli Mongelli Polese
Religione Di Marco Magnano Magnano Magnano Magnano
5

Profilo della classe ( attitudini, comportamenti, rapporti scuola-famiglia, partecipazione alle
attività extracurricolari ecc
La classe 5° H è composta da ventuno studenti provenienti da contesti socio-culturali piuttosto
omogenei e zone abitative che vanno dalle immediate vicinanze alla sede scolastica a luoghi più
lontani.
Come frequentemente accade il gruppo classe ha caratteristiche eterogenee in relazione all’impegno
profuso, alla partecipazione alle attività didattiche e alla frequenza scolastica, nonché al bagaglio
culturale maturato, soprattutto in relazione alle abilità, competenze e conoscenze acquisite a partire
dal terzo anno. A tale eterogeneità hanno sicuramente contribuito gli inserimenti di alunni nel corso
del triennio, provenienti da un ‘altra sezione dell’Istituto o da altre realtà scolastiche nonché la non
promozione di alcuni studenti o il cambiamento di scuola da parte di altri.
Si riscontra negli studenti. un evidente rallentamento nel processo di maturazione culturale causato,
senza dubbio, da una significativa demotivazione allo studio. Tutti i docenti, oltre a svolgere
interventi didattici mirati, si sono attivati per individuare e condividere strategie utili al recupero
della motivazione, prerequisito indispensabile per poter costruire un progetto educativo efficace ma i
diversificati tentativi di coinvolgimento messi in atto non hanno fatto registrare, per la maggior parte
degli alunni, cambiamenti degni di nota. Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di classe
hanno cercato di stimolare costantemente le alunne e gli alunni ad una maggiore assiduità, alla
frequenza scolastica, alla puntualità nell’adempimento degli impegni, alla partecipazione costruttiva
al dialogo educativo. L’attuazione delle unità didattiche è stata mirata a consolidare le conoscenze e
le competenze disciplinari, nonché le capacità logico espressive. La classe attuale è formata da
ragazzi che, sul piano umano, hanno raggiunto un soddisfacente livello di crescita e di maturazione:
le esperienze condivise hanno ulteriormente rafforzato i legami tra gli alunni che hanno sempre
mostrato atteggiamenti di collaborazione e di accoglienza.
Per quanto riguarda i risultati raggiunti in termini di conoscenza dei contenuti e di abilità acquisite
nelle singole discipline, si possono individuare due gruppi di livello : Un gruppo, formato da pochi
alunni, che ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo e costruttivo e ha mostrato assiduità
nello studio e nell’impegno, nel corso degli anni è riuscito a conseguire la quasi totalità degli
obiettivi programmati. Un altro gruppo, maggioritario, che, a causa di un impegno discontinuo,
evidente nella costante volontà di sottrarsi al rispetto delle consegne scolastiche per lunghi periodi
nel corso dell'anno, ha raggiunto, tuttavia, risultati mediamente adeguati. Alcuni manifestano ancora
difficoltà nella rielaborazione dei contenuti e nella loro esposizione orale e scritta a causa
soprattutto, di un metodo di studio non adeguato, non ha frequentato con continuità ed ha avuto un
interesse e impegno saltuari, ha solo in parte colmato lacune pregresse.
Il rapporto con gli insegnanti è stato improntato al rispetto reciproco e ha consentito di instaurare un
rapporto di dialogo e collaborazione. Anche i rapporti scuola-famiglia sono stati regolari e
generalmente basati sulla collaborazione.
6

4. Verifica e valutazione dell’apprendimento
Materie
Conoscenza e
comprensione
dei contenuti
Analisi e
sintesi
disciplinare
Uso del
linguaggio
specifico
Metodologia
disciplinare
Abilità nella
applicazione
delle conoscenze
Modalità di
recupero
Italiano C C C C C Studio
individuale
Latino C C C C C Studio
individuale Inglese C C C C C In Itinere
Matematica D D D D D In itinere
Fisica C/D C/D C/D C/D C/D In Itinere
Scienze C/D C/D C/D C/D C/D Studio
individuale Storia C C C C C In Itinere
Filosofia C C C C C In Itinere
Dis.Storia.A
rte
C D D D D Studio
individuale
Sc. Mot. e
Sp.
C C C C C In Itinere
IRC C C C C C In Itinere
Legenda: A (ottimo), B (buono), C (discreto), D (sufficiente), E (mediocre)
*corso di recupero, studio individuale, recupero in itinere
7

5. Percorsi interdisciplinari
Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli
studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:
Titolo del percorso Discipline coinvolte
(Si fa riferimento ai
programmi allegati)
Obiettivi Metodi Strumenti utilizzati
1. Le donne nella
storia
Inglese, Storia,
Filosofia,
Matematica,
Comprendere i cambiamenti che
l’immagine e il
ruolo della donna
ha avuto nel XX secolo
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
2. Luci e ombre Inglese, Storia,
Filosofia,
Matematica,
Latino
Comprendere la strutturale
ambiguità dei
processi storici, le
potenzialità positive del secolo e i suoi fattori negativi
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
3. Rapporto
natura-cultura
Inglese, Storia,
Filosofia, Disegno e
Storia dell’arte,
Italiano
Contribuire ad una visione unitaria del
linguaggio
scientifico ed
umanistico attraverso
l’interpretazione
della natura, che diviene anche percorso culturale
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
4. I percorsi
dell’inconscio
Inglese, Storia, Filosofia, Disegno e
Storia dell’arte,
Italiano.
Comprendere quanto la
dimensione inconscia
nell’animo umano
ha influenzato i linguaggi espressivi
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
5. Democrazia e
dittatura
Inglese, Storia, Filosofia.
Distinguere e confrontare le due
diverse forme di
governo.
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
6. Il male di
vivere;
Inglese, Storia, Filosofia, Italiano,
Disegno e Storia
dell’arte.
Esaminare la drammatica crisi
spirituale dell’uomo
moderno che sa di
aver perso i suoi punti di riferimento
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
7. Produzione,
trasporto,
consumo
dell’energia e
ricaduta
sull’atmosfera
Fisica, Matematica,
Scienze.
Comprenderne il rapporto cause –
effetto.
Lezione frontale,
lavoro di gruppo,
lavoro individuale
Libro di testo, LIM,
articoli di giornale o
di rivista, web,
immagini, video
8

6. Cittadinanza e Costituzione
Gli studenti, nell’arco del Triennio, hanno svolto esperienze di educazione alla cittadinanza nei
seguenti settori:
[X] Cittadinanza europea
[X] Cittadinanza e Costituzione
[X] Cittadinanza e legalità
[_] Cittadinanza scientifica
[_] Cittadinanza economica
[X] Cittadinanza e ambiente
[X] Cittadinanza culturale
[_] Cittadinanza digitale
[X] Cittadinanza a scuola
[X] Cittadinanza e sport
[X] Cittadinanza e volontariato
[X] Cittadinanza e salute
Più specificamente, sono state adottate le seguenti iniziative di classe:
Anno scolastico 2016-17
-Le Istituzioni Internazionali e la protezione a livello universale: l’Organizzazione delle Nazioni
Unite (ONU);
-Progetto visite guidate in orario extra-scolastico “Roma da conoscere, Roma da amare”;
-Gara campestre – conoscere e rispettare le aree verdi del nostro quartiere ‘ il parco della Caffarella;’
-Progetto “Giornale in classe”.
Anno scolastico 2017-18
-Nascita e struttura dell’Unione Europea;
-Tutoraggio per i ragazzi del biennio;
-Partecipazione all’organizzazione e all’accoglienza degli studenti delle scuole secondarie di primo
grado, durante le giornate dell’Open Day;
- Progetto ‘Fuori la porta’ sull’inclusione e il disagio;
-Conferenza su ‘La Guerra è il mio nemico.
Anno scolastico 2018-19
-La Costituzione italiana
-Seminario di Cittadinanza e Costituzione all’Archivio del Quirinale;
-Incontri sulla Costituzione presso il nostro Istituto;
-Approfondimenti su energia e cambiamenti climatici;
-Partecipazione all’organizzazione e all’accoglienza degli studenti delle scuole secondarie di primo
grado, durante le giornate dell’Open Day;
-Corso di primo soccorso: BLSD
Inoltre, gli alunni hanno partecipato, individualmente o per gruppi, ai seguenti progetti
extracurriculari:
Si veda allegato 4
9

7. Attività CLIL
Come da verbale n. 2 del C.d.C. di novembre 2018 l’attività CLIL non è stata attuata in quanto
nessuno dei docenti di discipline non linguistiche si è dichiarato disponibile e/o competente a
svolgere tale attività.
8. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
8.1 Percorsi realizzati dalla classe
A.S. 2016-2017
A : Impresa in azione
B : Progetto PLS Stampante 3D Tor Vergata
C : Seminari Tor Vergata
D : Lab. Fisica
E : Scienza impresa – Corso di Astronomia
F : PLS Biologia
G : Corso “De Rossi” presso Centro De Rossi
H : Corso di formazione animatori presso centro “De Rossi”
I : Club Ariaperta
L : Polo Museale del Lazio
M : Centro estivo Libero sport
A.S. 2017-2018
N : No Stigma
O : AVO
P : ProSport
Q : Lab 2 Go
R : Mun
S : PLS Meteo
T : Famiglia Simpatia – presso Scuola della Pace
U : World sport presso Centro estivo Appio Latino
A.S. 2018-2019
V : CNR Artico
Z : IMI
N.B. Ai percorsi sono aggiunte le attività dedicate alla formazione, per un totale di max. 30 ore
8.2 Percorsi realizzati dagli studenti
Si veda allegato 5

9. Attività integrative del curriculum e rapporti con il territorio svolte nel Quinto anno
(inserire tutto ciò che può essere utile a dare indicazioni alla Commissione d’Esame, Uscite
Didattiche, Viaggio di Istruzione, Progetti, Orientamento universitario…)
ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM
TIPOLOGIA DISCIPLINE
COINVOLTE
CONTENUTI
LUOGO
NUMERO
STUDENTI COINVOLTI
Visite guidate
STORIA
IMI: Internati
Militari Italiani II Guerra Mondiale
Museo ANRP
TUTTI
STORIA
“1918” – La Vittoria e
Sacrificio I guerra Mondiale
Stato Maggiore
della difesa –
Ufficio Storico
TUTTI
Uscite
Didattiche
Italiano Spettacolo
Teatrale: “Il Fu Mattia Pascal”
Teatro Quirino
TUTTI
Viaggio di
istruzione
Progetti e
Manifestazioni
culturali
Olimpiadi della Matematica
Gare a Squadre ed individuali
Liceo Russell Sapienza
1 Alunno
Matematica – Sc. Motorie e Sportive
L’uso della
matematica nell’atletica
Ragusa Off
TUTTI
Costituzione La Costituzione della Repubblica
Romana 1849
Archivio del Quirinale
4 Alunni
Storia - Cittadinanza
“Incontri sulla Costituzione”
Liceo Russell TUTTI
Disegno e Storia dell’Arte
Andy Warhol Museo Vittoriano 4 Alunni
Disegno e Storia dell’Arte
Pollock Museo Vittoriano 1 Alunno
Progetto
Bibliopoint
Partecipazione
alla prima di uno spettacolo e
successiva
scrittura di una recensione
Teatro Quirino
2 Alunni
Disegno e Storia dell’Arte
Visita ai Musei Capitolini
Musei Capitolini 1 Alunno
Incontri con
esperti
Orientamento
Disegno e Storia dell’Arte
Architettura Roma 3
Fiera di Roma 3 Alunni
Medicina Tor Vergata 1 Alunno
12

E’ prevista una simulazione di Colloquio di Esame nel mese di giugno, in cui verrà utilizzata
la griglia di valutazione del colloquio allegata al presente documento.
10. Elenco dei libri di testo, documenti e materiali utilizzati
DISCIPLINA TESTO
Italiano Cappellini – Sada “ I sogni e la ragione” C. Signorelli, vv. 5-6
Latino G. Garbarino “Colore 3” Paravia Pearson
Inglese Spiazzi -Tavella “ Only Connect … New Directions” vol II – III ed. Zanichelli
Matematica Re Fraschini – Grazzi “Competenze matematiche “ v.v.4-5 Ed. Atlas
Fisica Romeni “ La fisica di tutti i giorni” ed. Zanichelli, v.v. 4-5
Scienze naturali Crippa – Fiorani – Nepgen Mantelli “ Scienze Naturali“ v.v. 3-4-5 ed. A. Mondadori
Storia Castronovo “ Nel segno dei tempi” vol.3 Nuova Italia
Filosofia Bertini “ Io Penso” vol. 3 Zanichelli
Dis. Storia dell’ Arte Cricco - Di Teodoro “Itinerario nell’arte” 5 v. arancione ed. Zanichelli
Cittadinanza Materiale preparato dal Dipartimento di Storia e Fiulosofia
Sc. Motorie. e Sportive Del Nista, Parker “Sullo sport, …” Ed. D’Anna
IRC Pasquali - Panizzoli, “Segni dei tempi. Il cristianesimo in dialogo col mondo” Editrice La Scuola
Ed. Civica Emanuele Pietro,”Leggere la Costituzione” Ed. Simone per la Scuola
13

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1.PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
pag. 2
2.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE pag. 3-4
3.PROFILO DELLA CLASSE
pag. 5-6
4.VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
pag. 7
5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI
pag. 8
6.PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE pag. 9
7.ATTIVITA’ C.L.I.L. pag. 10
8.PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO pag. 11
9.ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM E RAPPORTI
CON IL TERRITORIO
pag. 12
10.LIBRI DI TESTO E MATERIALI UTILIZZATI
pag. 13
FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
pag. 14
PROGRAMMI DISCIPLINARI E GRIGLIE
Allegato 1
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE (1 E 2 PROVA
SCRITTA) ESAMI DI STATO
Allegato 2
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO
Allegato 3
PROGETTI EXTRA-CURRICOLARI
Allegato 4
QUADRO SINOTTICO E SCHEDE PERCORSI PCTO
Allegato 5
15

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO CLASSICO SPERIMENTALE “B.RUSSELL”
A.S. 2018-2019
Classe 5 H
Programma svolto di Fisica
Prof. Walter Inglese
Testi:
"La Fisica di tutti i giorni", C. Romeni, ed. Zanichelli, voll. 4 e 5
capitolo 22 del volume 3 del testo “I problemi della fisica”, J. Cutnell e altri, ed. Zanichelli
NB. Quello che segue è un elenco degli argomenti affrontati. Per avere un’idea
precisa di ciò che è stato svolto e della profondità con cui si sono affrontati i
singoli argomenti, si veda l’elenco dettagliato dei riferimenti ai testi che si trova
alla fine (essendo il testo, non adottato dal docente attuale, molto prolisso, alcune
parti di specifici paragrafi sono state tagliate, altre parti sono state sintetizzate
dal docente).
Richiami
Equivalenze. Cinematica, dinamica, legge di gravitazione universale. Lavoro. Energia.
Elettrizzazioni. Conservazione della carica. Legge di Coulomb. Campo elettrico. Potenziale
elettrico. Energia potenziale elettrica. Flusso e circuitazione di un campo di vettori. Capacità di
un conduttore. Condensatori in serie e in parallelo.
Corrente elettrica continua
Intensità di corrente. Generatori di tensione e circuiti elettrici (definizioni). Leggi di Ohm.
Resistori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. La trasformazione dell’energia elettrica
(effetto Joule). La f.e.m., la resistenza interna. I conduttori metallici (definizione della velocità
di deriva senza dimostrazione). La dipendenza della resistività dalla temperatura. Carica e
scarica di un condensatore
Campo magnetico
Forza magnetica e linee di campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti.
L’intensità del campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo magnetico
uniforme. Forza magnetica su un filo percorso da corrente. Motore elettrico. Campo magnetico
generato da un filo percorso da corrente. Campo magnetico generato da una spira (nel suo
centro) e da un solenoide. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo magnetico.
Proprietà magnetiche dei materiali. Ciclo di isteresi, l’elettromagnete.
Elettromagnetismo
La corrente indotta. La legge di Faraday-Neumann-Lenz. Autoinduzione. L’alternatore (corrente
alternata e grandezze efficaci). Il trasformatore. Produzione e trasporto dell’energia elettrica
(percorso 7). Il campo elettrico indotto. La corrente di spostamento. Le equazioni di Maxwell.
Le onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche piane. La polarizzazione per
assorbimento. Lo spettro elettromagnetico.

Relatività ristretta
La velocità della luce (no esperienza di MM). Gli assiomi della relatività ristretta. Simultaneità.
Dilatazione dei tempi. Contrazione delle lunghezze nella direzione dello spostamento.
Invarianza delle lunghezze perpendicolari al moto relativo. Trasformazioni di Lorentz. La
formula per la composizione delle velocità (senza dimostrazione). Effetto Doppler relativistico.
Quantità di moto relativistica. Energia totale, energia cinetica, massa.
Introduzione ai concetti fondamentali della fisica quantistica (ancora da svolgere al 6
maggio 2019)
Dualismo onda-corpuscolo. Radiazione di corpo nero e ipotesi di Planck. Fotoni ed effetto
fotoelettrico. Effetto Compton. Lunghezza d’onda di De Broglie. Principio di Heisemberg
Riferimenti ai testi
volume 4
cap. 25 par. 1-2-3-4-5(no potenza dissipata nei partitori, no amperometro e voltmetro)-6(no
trasferimento ...)-7
cap.26 par. 1(solo formula 3 p. 1144)-3(no la scarica del condensatore col foglio elettronico)-
4(no considerazioni ...)
cap. 27 par.1-2-3-4(no momento torcente ..., no momento magnetico ...)-5-6-7(no p.1218)
volume 5
cap. 28 par 1-2-3-4(no circuito RL ...)-6-7(no circuito capacitivo, no circuito induttivo, no
circuito RLC)-8(no potenza assorbita da un circuito RLC in serie)-9
cap. 29 1-2-3(no disegni)-4(no righe da 6 a 14, da "Come discusso" a "dello spazio"; no
emissione e ricezione ..., no energia trasportata, no distribuzione)-5(nel paragrafo sono presenti
errori; perciò è stato dato agli sudenti un riferimento ad altro testo)-6(solo p.1313 e onde radio)
cap. 30 par 1(appunti del docente)-2(solo enunciato dei postulati a p.1334)-3-4(senza la
dimostrazione per le trasformazioni di Lorentz)-5(no mindbuilding)-6(senza dimostrazione)-
7(senza dimostrazione e no effetto Doppler trasverso)-8(appunti del docente)-9(appunti del
docente)
cap. 34 par 1-2 (percorso 7)
volume 3 del testo “I problemi della fisica”, J. Cutnell e altri, ed. Zanichelli
Cap. 22 (introduzione alla fisica quantistica) Paragrafi 1-2-3-4-5-6
NOTA: L’analisi dei circuiti è ancora da svolgere al 6 maggio 2019; i circuiti RLC non fanno parte
di questo programma

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA/FISICA VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
10
Conoscenze
solide,
ampie,approfondite
e personalizzate
Gestisce autonomamente e argomenta
attentamente procedure risolutive di
situazioni o problemi complessi, che
richiedono l’impiego di una
approfondita ricerca e riflessione
personale. Mostra fluidità ed eleganza
nello sviluppo dei calcoli e nella
elaborazione dei grafici. Utilizza con
padronanza metodi anche ricercati di
controllo e di adeguamento delle
procedure
Mostra eccellenti capacità di analisi e
sintesi basate su personale
rielaborazione
critica; sa orientarsi anche in situazioni
problematiche complesse non
strettamente disciplinari costruendo
originali strategie risolutive esposte
con un linguaggio ricco e articolato,
basato sulla terminologia specifica.
9
Conoscenze solide
ampie e
approfondite
E’ in grado di gestire autonomamente
e argomentare in modo completo
procedure risolutive di situazioni o
problemi complessi. Mostra fluidità
nello sviluppo dei calcoli e nella
elaborazione di grafici. Utilizza
metodi di controllo e di adeguamento
delle procedure
Mostra ottime capacità di analisi e
sintesi; effettua collegamenti
significativi fra i diversi argomenti con
un linguaggio ricco, basato sulla
terminologia specifica.
Sa affrontare i problemi costruendo
proprie strategie di risoluzione.
8
Conoscenze solide
e ampie
Gestisce consapevolmente e
argomenta procedimenti risolutivi di
situazioni o problemi anche
complessi. Ha fluidità nei calcoli e
padronanza nella gestione di grafici;
evidenzia capacità di previsione e
controllo dei risultati.
Mostra buone capacità di analisi e
sintesi; effettua collegamenti
significativi fra i diversi argomenti;
costruisce strategie risolutive adattando
schemi noti; effettua valutazioni
autonome e complete. Padroneggia la
terminologia specifica. Ha una buona
proprietà di linguaggio.
7
Conoscenze
complete e
assimilate con
chiarezza
Gestisce e argomenta procedimenti
risolutivi di situazioni o problemi di
tipologia nota anche abbastanza
complessi. Ha padronanza nella
gestione di grafici e calcoli .
Mostra discrete capacità di analisi e
sintesi; Esegue collegamenti; effettua
valutazioni in modo autonomo. Il
linguaggio è preciso e l’ esposizione
corretta.
6
Conoscenze
adeguate pur con
qualche
imprecisione
Se opportunamente orientato sa
gestire procedimenti risolutivi di
situazioni o problemi non complessi.
Ha sufficiente padronanza nella
gestione di grafici e calcoli.
Effettua analisi e sintesi non sempre
complete e approfondite. Individua i
concetti chiave ed esegue semplici
collegamenti .
Linguaggio ed esposizione sono semplici
ma corretti.

5
Conoscenze
superficiali
Affronta situazioni o problemi
applicando le regole in forma
mnemonica; mostra incertezze nella
Effettua analisi e sintesi parziali e
superficiali; insicurezza nei
collegamenti. Il linguaggio non sempre è
gestione di calcoli e/o grafici. adeguato.
3-4
Conoscenze
frammentarie e/o
superficiali
Errori concettuali. Non commenta e
non giustifica le procedure richieste;
mostra scarsa capacità nella gestione
di calcoli e grafici.
Mostra limitate capacità di analisi e
sintesi e incapacità nello stabilire
collegamenti anche semplici. Linguaggio
ed esposizione sono inadeguati.
1-2
Nessuna / irrilevanti Non sa cosa fare/ Non riesce ad
avviare procedure o calcoli
minimamente significativi.
Non riesce ad individuare i concetti
chiave; non argomenta alcun tema
proposto.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO CLASSICO SPERIMENTALE “B.RUSSELL”
PROGRAMMA di INGLESE classe V H (Indirizzo Scientifico)
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 INSEGNANTE: Ersilia Scarano
LIBRI DI TESTO ADOTTATI
Marina Spiazzi, Marina Tavella – Only Connect … New Directions vol. 2 ed. Zanichelli
Marina Spiazzi, Marina Tavella – Only Connect … New Directions vol. 3 ed. Zanichelli
UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 1
TITOLO L’età vittoriana: dalla condivisione dei valori alla crisi dei valori
TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico
MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ I mutamenti dei valori e delle tematiche di un’epoca si riflettono nelle opere letterarie
CONTENUTI Funzionali-comunicativi: testi narrativi e/o poetici del periodo.
Linguistici: Il lessico e le strutture necessarie alla comprensione contestualizzazione
ed analisi dei testi letterari.
Culturali: quadro storico-sociale del periodo Vittoriano. Testi degli autori più
rappresentativi del periodo
The early Victorian Age – Economy and Society – The growth of industrial cities – The
pressure for reform – The cost of living – Poverty and the Poor Laws -The later years
of Queen Victoria’s reign – The Victorian Compromise - The Victorian frame of mind -

PERCORSI:
The Victorian Novel – The cinematic technique – Aestheticism
(percorso interdisciplinare n°6)
Charles Dickens: life and works – the plots of Dickens’s novels – characters – a didactic aim - style and reputation.
-Oliver Twist: plot, analysis of the main themes and literary techniques
Visione integrale e discussione del film:
Oliver Twist (2005) directed by Roman Polanksi
-David Copperfield: plot, analysis of the main themes and literary techniques
(percorso interdisciplinare n°2)
R. L. Stevenson: life and works – the double life - different perspectives -The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde: plot, analysis of the main themes and
literary techniques
Visione integrale e discussione del film:
Dr Jekyll and Mr Hyde (2003) directed by Maurice Phillips
Oscar Wilde life and works – the rebel and the dandy – art for art’s sake. -The
Picture of Dorian Gray: plot, analysis of the main themes and literary techniques

Visione integrale e discussione del film:
Dorian Gray (2009) directed by Oliver Parker
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Conoscere il contesto socio-culturale dell’età vittoriana. Brani tratti da opere degli
autori più rappresentativi del periodo.
Analizzare gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica
dell’autore ed i temi salienti.
Confrontare opere di autori diversi e inserirle nel contesto letterario e socio-culturale
VALUTAZIONE Test strutturati e semistrutturati, riassunti, relazioni, osservazione degli interventi in
classe. Verifiche scritte orali, registrazione degli interventi in classe.
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula ,laboratorio, aula video; libri di testo, fotocopie;
didattica attiva, approccio comunicativo, metodo induttivo.
UNITA’ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO 2
TITOLO Dalla frammentazione dell’esperienza alla destrutturazione dei generi letterari: i
moderni. Il primo 900 nella narrativa, nella poesia e nel teatro.
TIPOLOGIA Approccio per genere letterario e/o cronologico
MOTIVAZIONE E FINALITÀ’ Analizzare le nuove tematiche, le sperimentazioni linguistiche e i generi letterari

CONTENUTI Funzionali-comunicativi: testi letterari del periodo.
Linguistici: nuove sperimentazioni nell' uso del linguaggio letterario; lessico e strutture
necessarie alla comprensione, contestualizzazione ed analisi dei testi letterari.
Culturali: quadro storico-sociale del periodo moderno. Testi degli autori più
rappresentativi del momento.
THE MODERN AGE
The Historical and Social Context
The Edwardian Age, Britain and World War I, The Twenties and the Thirties, The
Second World War; The United States between the Two Wars,
The World Picture
The age of anxiety, Modernism to Postmodernism
The Literary Context
Modernism, The Modern Novel, The interior monologue, The stream of consciousness
technique.
(percorso interdisciplinare n°4)
James Joyce: life and works – ordinary Dublin – the rebellion against the Church – a subjective perspective of time – the impersonality of the artist - Stream of consciousness

PERCORSI:
-Dubliners: plot, analysis of the main themes and literary techniques
-Text analysis: Eveline (from “Dubliners”)
-Text analysis: Where was he? (from “A Portrait of the Artist as a Young Man”)
-A Portrait of the Artist as a Young Man: plot, analysis of the main themes and literary
techniques
-Ulysses: plot, analysis of the main themes and literary techniques
-Text analysis: The funeral (from “Ulysses”, Part III, Hades: Episode 6)
-Text analysis: I said yes I will sermon (from “Ulysses”, Part III, Penelope, Episode 18)
(percorso interdisciplinare n°1 - 4)
Virginia Woolf: life and works - Interior time – a modernist novelist – Moments of being .
Visione integrale e discussione del film:
Suffragette (2015) directed by Sarah Gavron
Mrs Dalloway: plot, analysis of the main themes and literary techniques
Text analysis: Clarissa and Septimus (from “Mrs Dalloway”
-To the Lighthouse: plot, analysis of the main themes and literary techniques
Text analysis: Lily Briscoe (from “To the Lighthouse”, Part III,Chapter 3)

(percorso interdisciplinare n°6)
Thomas Stearns Eliot: life and works – The impersonality of the artist – The conversion.
The Waste Land is a modernistic post-apocalyptic poem, in which the inner self of the
modern urbanite is fragmented by the post-war reality of the beginning of the last
century. The sterile land represents the direct aftermath of the over-exploited, over-
consumed and over(re)produced nature, which has become a social waste.
-The Waste Land: the sections, analysis of the main themes and literary techniques
-Text analysis: The Burial of the Death (from “The Waste Land”, section I)
Text analysis: The Fire Sermon (from “The Waste Land”, section III)
-The Hollow Men: analysis of the main themes
-Text analysis: This is the dead land (from “The Hollow Men”)
(percorso interdisciplinare n°5)
George Orwell: life and works - first hand experiences – an influential voice of the 20th century – the artist’s development – social themes. Newspeak and Doublethink . critic of both capitalism and communism, advocate of freedom and a
committed opponent of communist oppression.

Animal Farm: plot, analysis of the main themes and literary techniques
-Text analysis: Old Major’s speech (from “Animal Farm”, Chapter 1)
-Nineteen Eighty-Four: plot, analysis of the main themes and literary techniques
Visione integrale e discussione del film:
Nineteen Eighty-Four (1984) directed by Michael Radford
THE PRESENT AGE
The Historical Context
The Welfare State, Paths to Freedom, The time of troubles, The Thatcher Years, From
Blair to the Present Day, The United States after the Second World War
The World Picture*
The Cultural Revolution
The Literary Context*
The Contemporary Novel, Post-War Drama
The Theatre of the Absurd
Samuel Beckett*;Life and work – The meaninglessness - The Theatre of the Absurd

Waiting for Godot: plot, analysis of the main themes and literary techniques
Text analysis: We’ll come back tomorrow (from “Waiting for Godot”, Act I)
Text analysis: Waiting (from “Waiting for Godot”, Act II)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Conoscere il contesto socio-culturale del periodo moderno. Brani tratti da opere degli
autori più rappresentativi della prima metà del secolo.
Analizza gli elementi costitutivi dei brani studiati, individuare lo stile e la tematica
dell’autore e le nuove tecniche narrative.
Confrontare opere di autori diversi inserirle nel contesto letterario e socio-culturale.
Riconoscere le nuove sperimentazioni linguistiche
VALUTAZIONE Test strutturati e semistrutturati, riassunti, relazioni, composizioni osservazione e
registrazione degli interventi in classe. Verifiche scritte orali
SPAZI, STRUMENTI , STRATEGIE Aula ,laboratorio, aula video; libri di testo, fotocopie, didattica attiva, approccio
comunicativo, metodo induttivo.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 ANNUALE
DURATA Annuale – riferito alla specificità di indirizzo

TITOLO Use of English
TIPOLOGIA Linguistico – funzionale/comunicativo
MOTIVAZIONE E FINALITA’ Raggiungere un livello di competenza linguistica livello B1/B2
STIMOLO MOTIVANTE Uso della lingua inglese in situazioni comunicative
CONTENUTI Funzionali – comunicativi: uso del linguaggio appropriato nei diversi contesti socio-culturali
Linguistici : il lessico caratterizzante le diverse situazioni presentate. Le strutture morfo-
sintattiche necessarie alla comprensione , produzione e analisi
Culturali: testi di attualità e civiltà – testi letterari
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO Conoscere temi di attualità, civiltà e letterari– strutture morfo-sintattiche e lessicali
Gestisce la lingua in diversi contesti socio-culturali
Rielaborare testi, analizzare ed esprimere criticamente le proprie idee
VALUTAZIONE Test strutturati , semistrutturati, riassunti, discussioni, composizioni, relazioni
SPAZI, STRUMENTI, STRATEGIE Aula, laboratorio linguistico, aula proiezione; libro di testo e fotocopie, filmati, lezione attiva.
*Con l’asterisco sono indicati gli argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio



Liceo “B. Russell”
Indirizzo scientifico
PROGRAMMA DI SCIENZE
A.S. 2018/19
Classe 5 H Insegnante: L. Amatruda
U.D.A. N. 1
LA DINAMICA TERRESTRE E L’ATMOSFERA
Vulcani: struttura, tipi di magmi, vulcanismo effusivo e vulcanismo esplosivo, edifici
vulcanici, vulcanismo secondario
Terremoti: teoria del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografi e sismogrammi,
scale sismiche
Struttura interna della Terra
Campo magnetico terrestre
Dinamica della litosfera: crosta oceanica e crosta continentale, teorie dell'isostasia,
della deriva dei continenti, dell'espansione dei fondali oceanici; teoria della
tettonica a placche : margini convergenti, divergenti, conservativi; cause del
movimento delle placche
Composizione e struttura dell’atmosfera
Bassa troposfera: temperatura, pressione, caratteristiche delle zone di alta e bassa
pressione, umidità assoluta e relativa, formazione delle nubi e precipitazioni, effetto
serra, buco dell’ozono (vedi Percorso “ Produzione, trasporto, consumo dell’energia
e ricadute sull’atmosfera)
Fenomeni atmosferici: origine e tipologie dei venti, circolazione dell'aria nella bassa
troposfera e nella alta troposfera; movimenti dell'aria su ampia e media piccola
scala
U.D.A. N. 2

LA CHIMICA ORGANICA
Richiami su proprietà dell’atomo di carbonio
Ibridazione degli orbitali
Isomerie
Gruppi funzionali
Classi di composti organici, nomenclatura tradizionale e IUPAC
U.D.A. N. 3
LA BIOCHIMICA, IL METABOLISMO E LE BIOTECNOLOGIE
Reazioni di condensazione e idrolisi, monomeri e polimeri
Carboidrati: legame glucosidico, isomeri D e L, anomeri alfa e beta, monosaccaridi,
disaccaridi e polisaccaridi
Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, cere, steroidi
Proteine: amminoacidi, legame peptidico, strutture proteiche, enzimi
Nucleotidi, acidi nucleici, replicazione del DNA
Caratteristiche del codice genetico
Sintesi proteica
Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs, catena di trasporto degli elettroni e
chemiosmosi
Fermentazione lattica e alcolica
Fotosintesi: reazioni della fase luminosa e della fase oscura
Confronto tra respirazione e fotosintesi
Regolazione dell'espressione genica nei procarioti e negli eucarioti
Clonazione delle piante e degli animali
Clonazione genica: DNA ricombinante, enzimi di restrizione, librerie genomiche,
sonde nucleotidiche

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
MATERIA: SCIENZE NATURALI
Assolutamente
insufficiente
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo/
Eccellente
Voto 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10
Conoscenza dei
contenuti
disciplinari
Rifiuto della
prova.
Assente o non
pertinente
Lacunosa e
confusa
Superficiale
e
mnemonica
Essenziale
e
accettabile
Corretta
e
adeguata
Completa
e sicura
Completa,
organica e
approfondita
Uso del linguaggio
specifico e
correttezza
espositiva
Totalmente
errato
o assente
Non
corretto e
inadeguato
Generico e
improprio
Corretto e
semplice
Lineare e
corretto
Elaborato
e chiaro
Appropriato
e rigoroso
Sintesi e
rielaborazione delle
conoscenze
Assente Molto
scarsa
Scarsa e
incerta
Minima Adeguata Accurata Sicura,
precisa e
personale

PROGRAMMA DI ITALIANO PROF.SSA ALESSANDRA ADORNATO CLASSE VH
Liceo B. Russell anno sc. 2018/2019
Argomenti / Autori Programma Spunti iniziali e possibili
connessioni
EDUCAZIONE
ALLA LETTURA
INDIVIDUALE
Lettura periodica e individuale con
commento in classe di opere letterarie
connesse o no con il programma di studio
della letteratura:
- Giovanni Verga, Mastro don Gesualdo
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal;
- Italo Svevo, La coscienza di Zeno;
- Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
In corrispondenza dei singoli
autori
1 U.D.A
GIACOMO
LEOPARDI
Introduzione all'autore. Il sistema filosofico
leopardiano. La poetica.
La teoria del piacere; la concezione della
natura e della civiltà; il pessimismo; la
protesta; il rifiuto del progresso; il
solidarismo umano e sociale.
La poetica del vago e dell'indefinito. La
trattazione della poetica dell'autore e la
lettura dei testi sono state spesso
accompagnate dalla lettura di pagine dello
Zibaldone, in particolare sulla teoria del
piacere e sui temi dell'infelicità, del ruolo
della natura, del vago e dell'indefinito.
Dai canti:
La prima fase della poesia leopardiana:
- L'Infinito
La seconda fase della poesia leopardiana. I
canti pisano-recanatesi:
- La sera del dì di festa;
- Il sabato del villaggio;
- A Silvia
- La quiete dopo la tempesta
Spunto iniziale: la ricerca del
significato dell'esistenza;
l'universalità del dolore; la
noia. (Percorso: il male di
vivere)
La terza fase della poesia leopardiana:
- A se stesso;
- La ginestra: cenni sul contenuto. Lettura e
analisi dei vv. 1-86; 297-317
- Dialogo della Natura e di un Islandese Spunto iniziale: la concezione
della Natura e la sua
evoluzione nel pensiero di
Leopardi: la teoria del piacere.
(Percorso: natura-cultura)
2 U.D.A

LA
SCAPIGLIATURA
Peculiarità generali
Emilio Praga: Preludio
Igino Ugo Tarchetti: Fosca, tra attrazione e
repulsione
NATURALISMO E
VERISMO
Il Naturalismo francese e il Verismo
italiano: poetiche e contenuti. La poetica di
Émile Zola
GIOVANNI
VERGA
Introduzione all'autore. La poetica: la
rivoluzione stilistica e tematica, l'adesione al
verismo e la serie dei Vinti. La tecnica
narrativa: regressione e straneamento
Da Vita dei campi:
- Rosso Malpelo
Spunto iniziale: la tecnica
narrativa verista; il pessimismo
di Verga
- La lupa Spunto iniziale: la tecnica
narrativa verista, il giudizio
popolare e quello dell'autore
sulla protagonista; altre figure
femminili in Verga e in
D'Annunzio: la donna fatale e
la donna virtuosa.
Da Novelle Rusticane:
- La roba
I Malavoglia: i valori dei Malavoglia e
l'insidia del progresso, la raffigurazione
dello spazio, il tempo ciclico e il tempo
storico, i modi della narrazione: il coro
popolare.
Da I Malavoglia:
- La Prefazione ai Malavoglia
- La partenza di 'Ntoni e l'affare dei lupini Spunto iniziale: tecnica
narrativa verista, linguaggio,
sistema patriarcale e irruzione
della storia della comunità di
villaggio.
Connessione con Storia: I
problemi dell'Italia dopo
l'Unità.
- Padron 'Ntoni e il giovane 'Ntoni: due
visioni del mondo a confronto
Spunto iniziale: l'idea del
progresso, il confronto tra
diversi sistemi di valore.
- Il ritorno di 'Ntoni alla casa del nespolo
Mastro don Gesualdo: lettura integrale. Spunto iniziale: il dialogo con
Diodata e la morte di
Gesualdo.
Gesualdo schiavo della roba e
vinto negli affetti. Il fallimento

dell'ascesa sociale.
IL
DECADENTISMO
Il Decadentismo in Europa e in Italia.
Poetica e contenuti
Antonio Fogazzaro: Malombra
GIOVANNI
PASCOLI
Introduzione all'autore. Il 'fanciullino' come
simbolo della sensibilità poetica.
Da La grande proletaria si è mossa:
- La guerra di Libia, impresa gloriosa e
necessaria
Spunto iniziale: la visione dei
migranti italiani e la
giustificazione della guerra
coloniale.
Connessione con storia: il
socialismo e il nazionalismo in
Italia. Le migrazioni degli
Italiani tra Otto e Novecento.
Da Myricae:
- X Agosto
- Arano
- Lavandare
- L'assiuolo
- Temporale
- Tuono
- Novembre
Da Canti Di Castelvecchio
- Il gelsomino notturno
Spunto iniziale: il simbolismo,
il tema della morte, le scelte
stilistiche
GABRIELE
D'ANNUNZIO
Introduzione all'autore. L'ideologia e la
poetica. Tra il 'passato augusto e la
modernità
Il piacere: lettura integrale
Spunto iniziale: la superiorità
dell'artista, l'estetismo, le
scelte stilistiche
Connessioni con Filosofia:
Nietsche;
Storia: il nazionalismo in
Italia;
Inglese: il dandysmo di Oscar
Wilde
- Un ambiguo culto della purezza
Da Canto Novo:
- O falce di luna calante
Da Alcyone:
- La pioggia nel pineto
- La sera fiesolana
- Le stirpi canore
LA RIVOLUZIONE
ROMANZESCA
DEL PRIMO
NOVECENTO
Le nuove tendenze del romanzo europeo:
James Joyce
ITALO SVEVO Introduzione all'autore. La figura dell'inetto
nei tre romanzi sveviani e il rapporto col
nuovo romanzo europeo.

Da Una vita, Alfonso e Macario
da Senilità, Emilio e Angiolina
Da 'La coscienza di Zeno'
- Il dottor S e Zeno
- La morte del padre
Spunto iniziale: la psiconalisi,
il narratore inattendibile,
l'opera aperta (Percorso: i
percorsi dell'inconscio)
Connessioni con Filosofia:
Freud;
Storia: la situazione di Trieste
prima e dopo la Prima guerra
mondiale,
Inglese: J.Joyce
LUIGI
PIRANDELLO Introduzione all'autore. Il saggio su
L'umorismo e la poetica di Pirandello.
Da L'umorismo:
- L'esempio della vecchia signora
'imbellettata'
Spunto iniziale: la differenza
tra umorismo e comicità. La
vita come continuo fluire
Connessione con Filosofia:
Bergson
Il fu Mattia Pascal Spunto iniziale:il relativismo
filosofico, gli aspetti
narratologici del romanzo e La
questione dell'identità dell'io.
Uno, Nessuno e centomila
Sei personaggi in cerca d'autore Spunto iniziale: distinzione tra
personaggioe persona, il
metateatro: la riflessione sulla
violazione dello spazio scenico
e sul ruolo del drammaturgo,
del capocomico, degli attori,
etc.
3 U.D.A
LE
AVANGUARDIE
DEL PRIMO
NOVECENTO
Il futurismo: prsentazione del movimento
- Manifesto del Futurismo
- Manifesto tecnico della letteratura
futurista
I POETI
CREPUSCOLARI
Guido Gozzano. Presentazione dell'autore e
delle opere significative.
'Toto' Merumeni'
S. Corazzini Desolazione del povero
sentimentale
A. Palazzeschi E lasciatemi divertire
GIUSEPPE
UNGARETTI
L'ERMETISMO
Introduzione all'autore e alla poetica.
L'esperienza della guerra di trincea. Il culto
della parola.
- Veglia
- Fratelli
Spunto iniziale: allegria e
naufragio, le scelte stilistiche

- San Martino del Carso
- Commiato
- Mattina
- Soldati
- Porto sepolto
Connessioni con Arte: le
avanguardie; con Storia: la
prima guerra mondiale.
SALVATORE
QUASIMODO Da Acqua e Terre
- Ed è subito sera
Cupo pessimismo
EUGENIO
MONTALE
Introduzione all'autore e alla poetica.
- Spesso il mal di vivere ho incontrato (Percorso: il male di vivere)
- Non chiederci la parola che squadri da
ogni lato
- Ti libero la fronte dai ghiaccioli
- Meriggiare pallido e assorto
Da Satura
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un
milione di scale.
Spunto iniziale: Montale e le
donne: Mosca la donna
concreta, Clizia la donna
angelo ed Esterina la donna
che si getta nella vita
Introduzione all'autore e alla poetica
Da Il Canzoniere
- A mia moglie
UMBERTO SABA - Mio padre è stato per me "l'assassino" Spunto iniziale: la psicanalisi,
il rapporto con la madre e il
padre, le scelte metriche e
stilistiche (i percorsi
dell'inconscio)
- La capra
- Trieste
- Amai
4 U.D.A
ALBERTO
MORAVIA
Lettura integrale de
- Gli indifferenti
- Carla e Leo
Spunto iniziale: analisi acuta
della società borghese romana

BEPPE FENOGLIO Da Il partigiano Johnny
- L'ultima battaglia
Spunto iniziale: gli intellettuali
di dronte la seconda guerra
mondiale. La scelta di
continuare a combattere che
diviene imperativo etico
IL NEOREALISMO Peculiarità generali in letteratura e nel
cinema Visione di un film neorealista
Roma città aperta
PIER PAOLO
PASOLINI
Da "Le ceneri di Gramsci" I sezione
ITALO CALVINO Lettura integrale de "Il sentiero dei nidi di
ragno"
Spunto iniziale: le ragioni della
partecipazione alla Resistenza:
inconsapevolezza oppure scelta ideologica
La parola alla Critica
Giacomo Leopardi W. Binni, Il poeta della persuasione eroica
B. Croce, Le operette morali? Un'opera viziata
F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi
Verga e il Verismo
G. Devoto, Verga, capostipite di una tradizione
L. Spitzer, Verga e il Novecento: dall'ascolto alla solitudine
R. Bigazzi, Un letteratoal confine con la nuova epoca
P. Pellini, Lontano dal romanzo moderno
Giovanni Pascoli
G. Contini, La democrazia poetica di Pascoli
G. Leonelli, La poesia del particolare
C. Garboli, Inattualità di un poeta 'senza desiderio'
Luigi Pirandello
M. Bontempelli, I personaggi sono le sole verità
G. Debenedetti, L'infelicità dei personaggi
G. Macchia, Il teatro della crudelta' e lo spettatore coinvolto
Italo Svevo
G. Fenocchio, Italo Svevo
G. Pampaloni, Una coppia narrativamente riuscita: Emilio e Angiolina
G. Debenedetti, L' inetto 'consapevole' dei romanzi di Svevo
Il Futurismo
F.T. Marinetti, Il perfetto declamatore futurista

Umberto Saba
Saba e la psicanalisi
P.P.Pasolini, Saba, il poeta più difficile
Giuseppe Ungaretti
F. Flora, Il frammento è ancora poesia?
P. V. Mengaldo, La disgregazione del verso tradizionale
Eugenio Montale
G. Nascimbeni, Breve storia degli Ossi: da Torino a Stoccolma
Le figure femminili in Montale
Il correlativo oggettivo in Eliot e Montale
P. V. Mengaldo, La lingua di Montale
Montale e la pittura metafisica
Salvatore Quasimodo
G. Zagarrio, La poesia-manifesto di Quasimodo: Ed è subito sera
Il Neorealismo
Il cinema neorealista
'Una specie di triangolo': i tre modelli del Neorealismo secondo Calvino
Libro utilizzato Cappellini/Sada, I sogni e la ragione, tomi 5/6 Mondadori
GRIGLIA ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO TIPOLOGIA A
Indicatori Descrittore Livelli Voto
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Pertinente, organizzato e pianificato in modo appropriato 9-10
Organizzato e pianificato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso organizzato e pianificato 6
Parzialmente organizzato e pianificato 4-5
Privo di pianificazione e organizzazione 1-3
Coesione e coerenza testuale Coerente e coeso in modo appropriato 9-10
Coerente e coeso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso coerente e coeso 6
Parzialmente coerente e coeso 4-5
Privo di coesione e coerenza 1-3
Ricchezza e padronanza lessicale Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato 9-10
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Non appropriato 1-3
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura 9-10
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso corretto 6

Parzialmente corretto 4-5
Non corretto 1-3
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Approfondito e articolato in modo appropriato 9-10
Approfondito e articolato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Essenziale 6
Generico e poco pertinente 4-5
Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
Pertinente, articolato e personale in modo appropriato 9-10
Articolato e personale in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Complessivamente appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Privo di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 1-3
PARZIALE INDICATORI GENERALI /60
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna
Rispettoso in modo appropriato 9-10
Rispettoso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Complessivamente rispettoso 6
Parzialmente rispettoso 4-5
Non rispettoso 1-3
Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici
Compreso in tutte le sue parti in modo appropriato 9-10
Compreso in modo appropriato pur con qualche fraintendimento 7-8
Compreso nei tratti essenziali 6
Parzialmente compreso 4-5
Compreso in modo frammentario e confuso 1-3
Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)
Puntuale e corretto in modo appropriato 9-10
Puntuale e corretto in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Complessivamente puntuale 6
Parzialmente puntuale 4-5
Non pertinente e/o frammentario e/o scorretto 1-3
Interpretazione corretta e
articolata del testo
Adeguatamente interpretato in modo corretto ed articolato 9-10
Adeguatamente interpretato pur con qualche fraintendimento 7-8
Nel complesso interpretato in modo corretto 6
Interpretato in modo parziale ed improprio 4-5
Interpretato in modo scorretto e frammentario 1-3
PARZIALE INDICATORI SPECIFICI /40
TOTALE /100
PUNTEGGIO VENTESIMI: DIVIDI PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER 5 E APPROSSIMA /20

GRIGLIA ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO TIPOLOGIA B
Indicatori Descrittore Livelli Voto
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
Pertinente, organizzato e pianificato in modo appropriato 9-10
Organizzato e pianificato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso organizzato e pianificato 6
Parzialmente organizzato e pianificato 4-5
Privo di pianificazione e organizzazione 1-3
Coesione e coerenza testuale Coerente e coeso in modo appropriato 9-10
Coerente e coeso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso coerente e coeso 6
Parzialmente coerente e coeso 4-5
Privo di coesione e coerenza 1-3
Ricchezza e padronanza
lessicale
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato 9-10
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Non appropriato 1-3
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura 9-10
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura pur con qualche
imperfezione
7-8
Nel complesso corretto 6
Parzialmente corretto 4-5
Non corretto 1-3
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Approfondito e articolato in modo appropriato 9-10
Approfondito e articolato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Essenziale 6
Generico e poco pertinente 4-5
Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
Pertinente, articolato e personale in modo appropriato 9-10
Articolato e personale in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Complessivamente appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Privo di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 1-3
PARZIALE INDICATORI GENERALI /60
Individuazione corretta di tesi
e argomentazioni presenti nel
Compreso in tutte le sue parti in modo appropriato 13, 5-15
Compreso in tutte le sue parti in modo appropriato pur con qualche 10,5-12

testo proposto fraintendimento
Compreso nei tratti essenziali 9
Parzialmente compreso 6-7,5
Compreso in modo frammentario e confuso 1,5-4,5
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi
pertinenti
Coerente e coeso in modo appropriato 13, 5-15
Coerente e coeso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 10,5-12
Nel complesso coerente e coeso 9
Parzialmente coerente e coeso 6-7,5
Incoerente e privo di connettivi 1,5-4,5
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l'argomentazione
Corretto e congruente in modo appropriato 9-10
Corretto e congruente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Essenziale 6
Generico e poco pertinente 4-5
Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3
PARZIALE INDICATORI SPECIFICI /40
TOTALE /100
PUNTEGGIO VENTESIMI: DIVIDI IL PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER 5 E APPROSSIMA /20

GRIGLIA RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ TIPOLOGIA C
Indicatori Descrittore Livelli Voto
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.
Pertinente, organizzato e pianificato in modo appropriato 9-10
Organizzato e pianificato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso organizzato e pianificato 6
Parzialmente organizzato e pianificato 4-5
Privo di pianificazione e organizzazione 1-3
Coesione e coerenza testuale. Coerente e coeso in modo appropriato 9-10
Coerente e coeso in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso coerente e coeso 6
Parzialmente coerente e coeso 4-5
Privo di coesione e coerenza 1-3
Ricchezza e padronanza
lessicale.
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato 9-10
Ricco, puntuale e pertinente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Nel complesso appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Non appropriato 1-3
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura.
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura 9-10
Corretto in modo appropriato ed efficace nella punteggiatura pur con qualche
imperfezione
7-8
Nel complesso corretto 6
Parzialmente corretto 4-5
Non corretto 1-3
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Approfondito e articolato in modo appropriato 9-10
Approfondito e articolato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Essenziale 6
Generico e poco pertinente 4-5
Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.
Pertinente, articolato e personale in modo appropriato 9-10
Articolato e personale in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Complessivamente appropriato 6
Parzialmente appropriato 4-5
Privo di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti 1-3
PARZIALE INDICATORI GENERALI /60
Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
Pertinente e coerente in modo appropriato 13, 5-15
Pertinente e coerente in modo appropriato pur con qualche imperfezione 10,5-12

dell'eventuale paragrafazione. Nel complesso pertinente e coerente 9
Parzialmente pertinente e coerente 6-7,5
Non pertinente 1,5-4,5
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione
Ordinato e lineare in modo appropriato 13, 5-15
Ordinato e lineare in modo appropriato pur con qualche imperfezione 10,5-12
Nel complesso ordinato e lineare 9
Parzialmente ordinato e lineare 6-7,5
Frammentario e/o disorganico 1,5-4,5
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
Corretto e articolato in modo appropriato 9-10
Corretto e articolato in modo appropriato pur con qualche imperfezione 7-8
Essenziale 6
Parziale e poco corretto 4-5
Privo di riferimenti culturali e frammentario nelle conoscenze 1-3
PARZIALE INDICATORI SPECIFICI /40
TOTALE /100
PUNTEGGIO VENTESIMI: DIVIDI IL PUNTEGGIO IN CENTESIMI PER 5 E APPROSSIMA /20

Programma di Latino Prof.ssa Alessandra Adornato
Classe VH Liceo Scientifico Bertrand Russell A.S. 2018-2019
Autori, tematiche Brani antologici Argomenti interdisciplinari
Unità didattica di apprendimento 1
Seneca
- Le opere
- Lo stile
- Il pensiero filosofico
- Una giornata di Seneca (Epistulae ad Lucilium, 83, 2- 7)
- La vita è davvero breve? (De brevitate vitae, 1, 1-4)
- Il valore del passato (De brevitate vitae, 12, 1-7; 13, 1-3)
- La felicità consiste nella virtù (De vita beata, 16)
- Il dovere della solidarietà (Epistulae ad Lucilium, 95, 51-53)
Luci e ombre del governo di Nerone nei riguardi di Seneca, Petronio e Lucano
Unità didattica di apprendimento 2
Lucano
- la Pharsalia
- Presentazione di Cesare e Pompeo (Bellum civile, I, 125-157)
- Una funesta profezia (Bellum civile, VI, vv. 750- 767; 776-820)
Luci e ombre nelle personalità di Cesare e Pompeo
Quintiliano
- L’oratoria, tendenze e stili
- Retorica e filosofia nella
formazione del perfetto
oratore (Institutio oratoria,
proemium, 9-12)
- Vantaggi e svantaggi
dell’istruzione individuale
(Institutio oratoria, I, 2, 1-2)
- Anche a casa si corrompono
i costumi (Institutio oratoria,
I, 2, 4-8)
Persio - La satira
- La satira, un genere “contro
corrente” (Satira I, vv. 13-
40; 98-125)
- La moda delle recitationes
- La drammatica fine di un
crapulone (Satira III, vv. 94-
106)
Marziale
- Caratteri dell’epigramma
- Una poesia che “sa di uomo” (Epigrammata, X, 4)
- Distinzione tra letteratura e vita (Epigrammata, I, 4)
- Un libro a misura di lettore (Epigrammata, X, 1)
- Matrimoni di interesse (Epigrammata, I, 10)
- Il console cliente (Epigrammata, X, 10)
La donna nella società romana dell’epoca imperiale

- Vivi oggi (Epigrammata, I, 15)
Giovenale
- La satira
- Chi è povero vive meglio in
provincia (Satira III, vv. 164-
189)
- Contro le donne (Satira VI,
vv. 82-113)
- Messalina, Augusta meretrix
(Satira VI, vv. 114-124)
Plinio il Giovane - L’epistolario - Il panegirico di Traiano
- Epistola a Traiano (Epistulae,
X, 96-97)
- La risposta dell’imperatore
(Epistulae, X, 97)
Plinio il vecchio
- La prosa scientifica
- Struttura del trattato
Tacito
- La storiografia nell’ epoca
imperiale : caratteri
- Particolarità dell’opera di
Tacito
- La famiglia (Germania, 18- 19)
- Sine ira et studio (Annales, 1,1)
- Il matricidio: la morte di Agrippina (Annales 14, 7-10)
- Nerone e l’incendio di Roma (Annales XV, 38-39)
- La persecuzione dei cristiani (Annales XV, 44, 2-5)
- La scelta del migliore (Historiae, I, 16)
Imperialismo Rapporto fra intellettuali e potere
Svetonio - La biografia aneddotica
Unità didattica di apprendimento 3
Petronio
- Il romanzo e la fabula
- Datazione dell’opera e
discussione intorno
all’identità dell’autore
- I personaggi e
l’ambientazione
- Trimalchione entra in scena (Satyricon, 37-38, 5)
- La cena di Trimalchione (Satyricon, 41, 9-42)
- Il testamento di Trimalchione (Satyricon, 71, 1-8; 11-12)
- La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112)
Il romanzo come genere letterario
Apuleio
- Il contesto culturale
- Opere di Apuleio
- Il pensiero filosofico
- Lucio si trasforma in asino (Metamorfosi, 3, 24-26)
- Amore e Psiche (Metamorfosii, 4, 28-33)
- Il proemio e l’inizio della narrazione (Metamorfosi, I, 1-3)
- La preghiera a Iside (Metamorfosi, XI, 1-2)
Sant’Agostino
- Le Confessiones
- Esegesi, polemica
antiereticale e riflessione
L’incipit delle Confessiones
(Confessiones, I, 1, 1)
La conversione

teologica
- Il De Civitate Dei
(Confessiones, VIII, 12, 28-
29)
Libro utilizzato: Colores - Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello, Paravia

GRIGLIA GLOBALE DI VALUTAZIONE DI LATINO/GRECO
INDICATORI VOTO
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPERENZE CHIAVE
CONOSCENZE
Conoscenza delle strutture lessicali e morfosintattiche della lingua
Conoscenza di temi, testi, autori
Conoscenza del contesto storico-culturale di riferimento
Conoscenza delle caratteristiche formali e strutturali dei diversi generi
Conoscenza delle principali influenze della letteratura latina/greca sugli esiti della letteratura moderna e contemporanea
Conoscenza degli aspetti di similarità e di alterità tra civiltà classica e contemporaneità
Assenti
Frammen tarie e
confuse
Imprecise e/o
approssimative
Essenziali
Articolate
Approfondite
1. comunicare in
madrelingua
COMPETENZE ABILITÀ
COMPRENSIONE E
ANALISI
LINGUISTICO-
ESPRESSIVA
delle strutture lessicali e morfosintattiche e delle caratteristiche formali di testi di differenti generi letterari e non letterari
ABILITA’ LINGUISTICO-ESPRESSIVE
Riconoscimento e analisi delle strutture lessicali e morfosintattiche della lingua latina/greca in relazione a scopi, contesti, contenuti e genere di un testo
Utilizzo corretto ed efficace del vocabolario
Riconoscimento e analisi delle differenti caratteristiche formali dei vari generi letterari e non letterari
Riconoscimento dei differenti registri comunicativi, in relazione all’autore, ai temi, al genere di appartenenza e al relativo contesto storico e culturale
Confronto delle strutture lessicali e morfosintattiche della lingua latina/greca con le strutture
della lingua italiana
Riconoscimento di cambiamenti lessicali, radici etimologiche e slittamenti semantici avvenuti tra la lingua latina/greca, la lingua italiana e le lingue europee studiate, in relazione ai principali termini della civiltà classica
Assenti o
molto
lacunose
Parziali e
confuse
Imprecise e/o
approssimative
essenziali
Corrette e
evidenti
Approfondite
e puntuali
1. comunicare in madrelingua
COMPRENSIONE ED
INTERPRETAZIONE
CRITICA DEI VARI TIPI DI TESTI per cogliere i vari livelli di significato
ABILITA’ CRITICO-INTERPRETATIVE
Comprensione di nuclei tematici, concetti chiave, temi, argomentazioni e messaggi
Comprensione dei significati denotativi e connotativi
Riconoscimento di collegamenti intratestuali, intertestuali, extratestuali all’interno di un testo
Riconoscimento del contesto storico-culturale e letterario di autori, temi, opere e generi
Collocazione in una visione diacronica gli eventi storico-culturali riconoscendone le relazioni
Riconoscimento delle fasi evolutive nella produzione di un autore e individuazione della sua
poetica in rapporto al tempo
Riconoscimento della diversità nella rappresentazione dello stesso tema in generi diversi
Individuazione delle linee evolutive dei principali topoi letterari
Individuazione sia delle principali influenze della letteratura latina/greca sugli esiti della letteratura moderna e contemporanea sia degli aspetti di attualità nelle tematiche culturali del passato
Assenti
Carenti
Imprecise e superficiali
Essenziali
Ampie
Complete
1. comunicare in madrelingua
2. competenze sociali e civiche
3. consapevolezza ed espressione
culturale
RESA IN LINGUA
ITALIANA DI TESTI di vario autore, genere, contenuto e contesto storico-culturale
Comprensione e interpretazione generale del brano
Competenza lessicale-espressiva
Competenza morfosintattica
Assente o
gravemente carente
Carente
Imprecisa e parziale
Parzialmente corretta
Corretta
Totalmente
appropriata e corretta
1. comunicare in madrelingua
2. consapevolezza ed espressione culturale

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
PROGRAMMA CLASSE 5° SEZIONE H
1° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
Conoscere con l’arte: il ricorso alla scienza e il suo superamento
L’impressionismo (percorso interdisciplinare n°3 Natura- Cultura)
Manet: lo scandalo della verità (Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergères)
Monet: la pittura delle impressioni (Impressione: Sole nascente, La cattedrale di Rouen, La
Grenouillère, Lo stagno delle ninfee)
Renoir: la gioia di vivere (La Grenouillère, Moulin de la Gallette, Colazione dei canottieri, La
montagna Sainte-Victoire)
Degas: il ritorno al disegno (La lezione di ballo, L’assenzio, Quattro ballerine in blu)
Tendenze post-impressioniste
Seurat: l’impressionismo scientifico (Une Baignade à Asnières, Un dimanche après-midi à l’Ille de
la Grande Jatte, Il circo)
Cézanne: “Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono” (La casa dell’impiccato a Auvers,
I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire)
Gauguin: Via dalla pazza folla (L’onda, Il Cristo giallo, Aha oe feii? Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?)
Van Gogh: la riflessione drammatica sull’esistenza (I mangiatori di patate, Autoritratto con
cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles con iris in primo piano, Notte stellata,
Campo di grano con volo di corvi) (Percorso interdisciplinare n°6 Il male di vivere)
L’Europa tra ‘800 e ‘900
Morris e la “Arts and crafts exhibitionn society”
L’art nouveau: caratteri generali
Klimt: (Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-BauerI, Danae)

2° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
Le avanguardie storiche
L'espressionismo (Percorso interdisciplinare n°6 Il male di vivere)
I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza)
La Die Brucke: Kirchner (Cinque donne per la strada)
Munch (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, Pubertà)
Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento)
Egon Schiele (Nudo femminile, L’abbraccio)
Il cubismo
Picasso: il grande patriarca del Novecento (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata,
Guernica)
Braque:”Amo la regola che corregge l’emozione, amo l’emozione che corregge la regola” (Case
all’Estaque, Violino e brocca, Le Quotidien, violino e pipa, Natura morta con uva e clarinetto)
Il futurismo italiano
Balla: Le cose in movimento (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta + rumore,
Compenetrazioni iridescenti n.7)
Boccioni: La pittura degli stadi d’animo (La città che sale, Stadi d’animo, Forme uniche della
continuità nello spazio)
Sant'Elia: Le architetture impossibili (La centrale elettrica, La città nuova)
L'astrattismo
Kandinskij: Il colore come la musica (Il cavaliere azzurro, Murnau- cortile del castello, Senza titolo
1910, Composizione VI, Alcuni cerchi)
Klee: La scoperta del colore (Il fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, Monumenti a G.,
Ragazzo in costume)
Mondrian: Il neoplasticismo (Mulino Oostzijde, Mulino al sole, L’albero rosso, L’albero blu,
L’albero 1912, L’albero grigio, Melo in fiore, Composizione n.10, Molo e oceano, Composizione 11
- rosso, blu e giallo)
3° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
a) La reazione degli artisti di fronte all’orrore della guerra

Il dadaismo
Duchamp Fontana, L.H.O.O.Q.
Man Ray: Cadeau
Il surrealismo (Percorso interdisciplinare n°4 I percorsi dell’inconscio)
Magritte: La dimensione metafisica del quotidiano (L’uso della parola I, La condizione umana, Le
passeggiate di Euclide)
Mirò: La magia dei segni (Montroig, la chiesa e il paese, Il carnevale di Arlecchino, Pittura – collage
preparatorio per pittura, La scala dell’evasione, Blu III)
Dalì: Il torbido mondo della paranoia (Studio per stipo antropomorfo, Costruzione molle con fave
bollite, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel Styler-Tas)
La Metafisica
Giorgio De Chirico: (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Piazza d’Italia con statue e roulotte)
Verso il contemporaneo: Henry Moore (Figura giacente, Madre con bambino), Alexander
Calder ( Mobiles, Stabiles, Flying Colors DC8)
b) La nuova figura dell’architetto
La Bauhaus: la nascita del design Gropius: la sede della Bauhaus
L'architettura nella prima metà del Novecento (percorso interdisciplinare n°3 Natura-
Cultura)
Le Corbusier: L’architettura razionalista (Villa Savoye, Unità di abitazione di Marsiglia, La cappella
di Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp)
Wright: L’architettura organica (Robie House, Casa sulla cascata, Guggenheim Museum di New
York) Il
razionalismo italiano: Terragni (ex Casa del Fascio a Como), Piacentini (La Sapienza, EUR)
4° UNITÀ DIDATTICA DI APPRENDIMENTO
Il caso come legge della realtà: dal gesto, al pensiero, all’evento
L'informale: Pollock (Foresta incantata, Pali blu) Burri (Sacco e rosso, Cretto nero, Grande Cretto)

e Fontana (Concetto spaziale)
La pop art: Warhol (Green coca-cola Bottles, Marilyn, Minestra in scatola Campbell)
Testo in adozione: Cricco – Di Teodoro “ITINERARIO NELL’ARTE” Vol. 5° Ed. Zanichelli

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO “ B. RUSSELL”
PROGRAMMA DI FILOSOFIA Anno Scolastico: 2018- 2019
Classe V H (scientifico)
Docente: Mariantonietta Cimarelli
UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I
TITOLO
Il Soggetto assoluto nella cultura romantica e in Hegel
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione del ruolo centrale per la comprensione delle scienze umane e delle arti del pensiero hegeliano, con particolare attenzione al ruolo svolto nel contesto europeo del XIX secolo
CONTENUTI Unità didattiche 1. Libertà, Natura ed Arte nella cultura romantica, in Fichte e Schelling 2. La dialettica hegeliana. La verità come processo. La Fenomenologia dello Spirito 3. Lo storicismo assoluto di Hegel. La verità come sistema. L’Enciclopedia
OBIETTIVI Conoscenze 1. Tratti fondamentali della poetica romantica tedesca, con particolare attenzione al suo sfondo filosofico 2. Specificità del metodo dialettico hegeliano e la sua articolazione sistematica
Competenze e Abilità 1. Lessico fondamentale del pensiero hegeliano e marxiano 2. Saper discutere e analizzare un brano tratto dalle opere dei romantici 3. Saper riconoscere i nessi tra pensiero artistico e filosofico 4. Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia 5. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica
DOCUMENTI E BRANI 1.J.G. Fichte, La missione del dotto, Quarta lezione, Mursia, Milano 1987, trad. modificata, pp. 134-137. 2.F.W.J. Schelling, Filosofia della natura e filosofia trascendentale, in Sistema dell’idealismo trascendentale, Introduzione, Bompiani, Milano 2006, pp. 53-59 (Rapporto tra natura e cultura) 3. G.W. F. Hegel, La lotta per la vita e per la morte, in La fenomenologia dello spirito, IV, Einaudi, Torino 2008, pp.119-121 e 131-132. 4. G.W. F. Hegel, Hegel contro Beccaria, in Lineamenti di filosofia del diritto, §100, Bompiani, Milano, Milano 2006m p. 209. 5. G.W. F. Hegel, La filosofia è la civetta di Minerva, in Lineamenti di filosofia del diritto, cit., Prefazione, pp. 59-65. (Luci ed ombre) 6. G.W. F. Hegel, La natura come antitesi, in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, §247-252, a cura di V. Cicero, Rusconi, Milano 1996, pp. 421-429. (Rapporto tra natura e cultura)

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II
TITOLO
La filosofia tra Romanticismo e Positivismo
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione delle nuove forme di razionalità della contemporaneità, a
partire dalla centralità data alle “ragioni” del corpo
CONTENUTI Unità didattica
1. La filosofia del pessimismo: Schopenhauer
2. Un poeta e un pensatore per il cristianesimo: Kierkegaard
3.La scuola hegeliana e Feuerbach
4. Marx dalla sinistra hegeliana alla filosofia come praxis
5. Il Positivismo e l’evoluzionismo: Comte e Darwin
OBIETTIVI Conoscenze
1. Il pensiero dei principali autori e movimenti che hanno discusso le
concezioni classiche o dialettiche di razionalità
2. Visione della storia nella cultura romantico-idealista e della sinistra
hegeliana
3. La dimensione etico-politica legata a queste nuove concezioni della
ragione
Competenze e Abilità
1. Lessico fondamentale degli autori
2. Saper discutere e analizzare le diverse modalità di scrittura filosofica
3 Saper riconoscere i nessi tra storiografia e filosofia
4. Saper riconoscere i nessi tra economia e politica
5. Saper discutere e confrontare i modelli di razionalità alternativi alla
tradizione classica, individuandone strategie persuasive e difficoltà
teoretiche, in relazione soprattutto alla mentalità scientifico sperimentale.
DOCUMENTI E BRANI 1.A. Schopenhauer, Il dolore del vivere, in Il mondo come volontà e
rappresentazione, cit. libro IV, 56, pp. 351-352. (Il male di vivere)
2.S. Kierkegaard, La condizione dell’angoscia, in Il concetto di angoscia,
Sansoni, Firenze 1972, p.193. (Il male di vivere)

3.K. Marx – F. Engels, La lotta di classe e il ruolo storico della borghesia, in
Manifesto del partito comunista, Editori Riuniti, Roma 1976, pp. 55-64.
(Democrazia e Dittatura).
4.K.Marx, L’alienazione, in Manoscritti economico-filosofici del 1844, trad.
it. Di N. Bobbio, Einaudi, Torino 1978, pp. 75-83. (Il male di vivere)
5.D. Fusaro, Perché scrivere di Marx, in Bentornato Marx! Rinascita di un
pensiero rivoluzionario, Bonpiani, Milano 2010, pp. 24-29.
UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III
TITOLO
La filosofia nell’età della crisi e i nuovi saperi del Novecento
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione dei motivi principali della crisi del Positivismo e riuscire a
delineare alcune filosofie del XX secolo
CONTENUTI Unità didattiche
1. Nietzsche e la crisi delle certezze
2. Freud e la psicoanalisi
3 Lo spiritualismo francese e la filosofia di Bergson
4. Heidegger: Essere e Tempo
5. La meditazione sull’agire politico: Hannah Arendt
OBIETTIVI Conoscenze
1. Critica alla storia della metafisica e della razionalità occidentale con il
nichilismo.
2. Nuovo interesse verso il problema della coscienza.
3. L’impatto della psicoanalisi nella cultura e nella vita contemporanea.
4. Il riconoscimento della singolarità come caratteristica fondamentale
dell’uomo.
Competenze e Abilità
1. Lessico fondamentale degli autori in questione
2. Saper discutere e analizzare i brani degli autori trattati, con coerenza
espositiva e proprietà linguistica
3. Saper riconoscere e collegare le riflessioni psicologiche ed esistenziali con
la più recente realtà filosofica.
DOCUMENTI E BRANI 1.F. Nietzsche, L’uomo folle, in La gaia scienza e Idilli di Messina, trad.it. di
F. Masini, Adelphi, Milano 1977, pp.162-164. (Il male di vivere)

2.F. Nietzsche, La visione dell’eterno ritorno, in Così parlò Zarathustra,
Adelphi, Milano 1968, pp. 181-186
3.S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Caso di Dora, in La teoria
psicoanalitica, Casi clinici, trad. P. Stampa, Newton Compton, Roma 1972,
p. 29. (I percorsi dell’inconscio).
4. S. Freud, La civiltà reprime le pulsioni, in Il disagiodella civiltà e altri saggi,
Bollati Boringhieri, Torino 2010, pp. 16-18. (I percorsi dell’inconscio).
5.H. Bergson, Le due memorie, in Materia e memoria, trad. di A. Pessina
Laterza, Roma- Bari 1996, pp.66-67. (I percorsi dell’inconscio).
6. M. Heidegger, L’essere per la morte e l’angoscia, in Essere e tempo, cap. I,
a cura di P. Chiodi, Utet, Torino 1986, pp. 378-379. (Il male di vivere)
7. M. Heidegger, Il prendersi cura, in Essere e tempo, a cura di P. Chiodi,
Utet, Torino 1986, pp. 126-127.
8. H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, in E. Gentile, Il
fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Laterza,
Roma-Bari 1970. (La donna nella storia).
VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti gli argomenti principali della programmazione saranno oggetto di
verifiche di varia tipologia (scritta/orale).

RUBRICA DI VALUTAZIONE di FILOSOFIA
INDICATORI VOTO
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPERENZE
CHIAVE
CONOSCENZE
Conoscenza di temi, testi, autori, scuole di pensiero e delle differenti
discipline filosofiche
Conoscenza dell’orizzonte problematico di riferimento (contesto
scientifico, politico, culturale-artistico)
Assenti
Frammentarie e
confuse
Imprecise/
approssimative
Parziali/
essenziali
Articolate
Approfondite
1. comunicare in
madrelingua
COMPETENZE ABILITÀ
POSSESSO DEGLI
STRUMENTI
ESPRESSIVI ED
ARGOMENTATIVI
NELLA
COMPRENSIONE E
PRODUZIONE DI
TESTI
SCRITTI/ORALI
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale,
a seconda di differenti
tipologie, contesti,
contenuti e scopi
comunicativi
ABILITA’ LINGUISTICHE
Riconoscimento e analisi delle caratteristiche formali delle varie forme
di scrittura filosofica e padronanza del lessico
Chiarezza e correttezza espositiva in relazione agli scopi, ai contesti e ai contenuti.
Assenti o molto
lacunose
Parziali e
confuse
Imprecise/
approssimative
Parziali/
essenziali
Corrette e
evidenti
Approfondite e
puntuali
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
digitale (uso degli
strumenti
informatici nelle
attività di ricerca
e approfondi-
mento).
ABILITA’ INTERPRETATIVE, ARGOMENTATIVE E
VALUTATIVE
Comprensione di contesto, scopo, destinatario e differenti registri
comunicativi
Saper definire le parole chiave e le idee centrali, riassumere i contenuti,
ricondurre una tesi al pensiero dell’autore e riconoscerne il contesto
problematico e argomentativo ( collegamenti intratestuali, intertestuali,
extratestuali all’interno delle opere)
Presenza ed utilizzo delle fonti
Presenza e qualità dei collegamenti intertestuali, extratestuali e interdisciplinari
Capacità di analisi e sintesi e di produzione di un testo coerente ed
efficace dal punto di vista comunicativo, in gradi di argomentare il proprio punto di vista e di individuare il punto di vista altrui in modo
fondato Pertinenza dei contenuti rispetto alle consegne Originalità e creatività
Assenti
Carenti e
frammentarie
Imprecise e
superficiali
Essenziali e
appena
articolate
Ampie ed
evidenti
Complete
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
sociali e civiche
3. consapevolezza
ed espressione
culturale
4. imparare a
imparare
VALUTAZIONE FINALE ……/10

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO “ B. RUSSELL”
PROGRAMMA DI STORIA Anno Scolastico: 2018- 2019
Classe V H (scientifico)
Docente: Mariantonietta Cimarelli
UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. I
TITOLO
Dall’imperialismo alla Grande Guerra e alla rivoluzione bolscevica
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprendere l’impatto della società di massa e della II rivoluzione
industriale nei diversi ambiti della vita politica e quotidiana, e delineare i
progetti politici che nei primi decenni del XX secolo si sono confrontati con
queste novità
CONTENUTI Unità didattiche
1. L’irruzione delle masse nella storia
2. L’economia e l’industrializzazione nella società di massa
3. L’epoca giolittiana in Italia: la modernizzazione del sistema economico e
politico
4. Conflitti dell’imperialismo e del nazionalismo, fino alla Grande Guerra
5. La rivoluzione bolscevica
OBIETTIVI Conoscenze
1. Le conseguenze della presenza attiva delle masse nella storia a livello
politico (partiti di massa, sindacati) ed ideologico (nazionalismo, socialismi,
cattolicesimo sociale, questione femminile)
2. Le innovazioni tecnologiche e le conseguenze della seconda rivoluzione
industriale, a livello di organizzazione del lavoro, di gestione del tempo
libero, e di dinamiche sociali nelle metropoli
3. La modernizzazione compiuta dall’Italia nell’epoca giolittiana e i problemi
rimasti insoluti
4. Le alleanze e i motivi di conflitto tra le grandi potenze europee, fino alla
Grande Guerra
5. Dinamiche militari e diplomatiche della Grande Guerra
6. Situazione politica ed economica dell’Impero russo, il progetto bolscevico
e i modi di conquista del potere durante la rivoluzione d’ottobre
Competenze e Abilità

1. Lessico fondamentale del dibattito ideologico dell’inizio del XX secolo
2. Saper leggere un documento o un brano d’interpretazione storica,
sapendo riconoscere l’orizzonte ideologico e il contesto dell’autore
3. Individuare i nessi tra le innovazioni tecnologiche e industriali e le
soluzioni politiche proposte ad inizio del XX secolo
4. Saper discutere gli elementi che costituiscono la società di massa
5. Saper discutere gli elementi di diversità dal modello di potere bolscevico
rispetto a quelli già sperimentati in Europa nei secoli precedenti
DOCUMENTI E BRANI 1. Questioni di genere: Le donne e il sapere scientifico, da V. Castronovo, Nel segno dei tempi MilleDuemila, Vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. (Le donne nella storia)
2. F. W. Taylor, La ripartizione dei compiti e delle responsabilità, Tratto da Principi di organizzazione scientifica del lavoro, Etas- Kompass, Milano 1967. (doc. 1 pag. 30)
3. Gaetano Salvemi, Luci ed ombre nell’opera di Giolitti, Tratto da Il ministro della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana, Feltrinelli, Milano 1962.
4. Luoghi simbolo: Le trincee, da V. Castronovo, Nel segno dei tempi MilleDuemila, Vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. (Tra natura e cultura).
5. Lettere dal fronte, in Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, raccolta di lettere inedite, a cura di G. Procacci, Editori Riuniti, Roma 1993. ( Il male di vivere)

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. II
TITOLO
La crisi delle democrazie e l’avvento dei totalitarismi
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione della specificità del fenomeno totalitario, delle sue
motivazioni e della sua risoluzione militare e biopolitica
CONTENUTI Unità didattiche
1. Il dopoguerra in Italia e Germania
2. L’ideologia fascista, e la diffusione di modelli politici autoritari
3. Lo stalinismo
4. Dalla Repubblica di Weimar alla salita al potere del nazismo in Germania
5. La crisi economica del 1929 e le crisi politiche dell’Europa
6. La Seconda Guerra Mondiale
7. La politica di sterminio dei nazisti
OBIETTIVI Conoscenze
1. Gli effetti della I guerra mondiale e dei trattati di pace nella vita politica
dei paesi belligeranti
2. Le ideologie totalitarie, con particolare attenzione alla dimensione del
terrore e del consenso come fenomeni di legittimazione del potere, e al
controllo biopolitico dell’esistenza come modo di attuazione del potere
3. Le dinamiche politiche ed economiche che conducono alla Seconda
Guerra Mondiale e le principali fasi del conflitto.
Competenze e Abilità
1. Lessico fondamentale delle ideologie totalitarie
2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il
contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore
3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica
4. Saper discutere gli elementi che caratterizzano la società totalitaria, e i
nessi con gli strumenti di propaganda e di formazione del consenso
intellettuale e popolare
5. Saper distinguere le diverse modalità di conflitto che durante la Seconda
Guerra Mondiale hanno luogo, e intendere la specificità dei campi di
concentramento e di sterminio rispetto ad altre forme di prigionia e di
esclusione dalla vita politica

DOCUMENTI E BRANI 1. I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionale, in P. Renouvin, La crisi del secolo XX, Dal 1914 al 1929, in Storia politica del mondo, vol. VI, Unedi, Roma 1975. (Democrazia e dittatura)
2. Diventare cittadine: Richiesta del diritto di voto per le donne in Italia, Tratto da Comitato Nazionale Pro Suffragio Femminile, Richiesta del diritto di voto per le donne in Italia, 1909, in ‘La Voce’ 16 dicembre 1909. (La donna nella storia).
3. Vita di Trincea, Tratto da P. Fussell, La Grande Guerra e la memoria moderna, il Mulino, Bologna 2000 (1984). (Tra natura e cultura)
4. Eric J. Leed, Il trauma della guerra e la diffusione delle nevrosi, Tratto da Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità personale nella Prima Guerra Mondiale, il Mulino, Bologna 1985. (Percorsi dell’inconscio).
5. Carl J. Friedrich e Zbigniew, Per un tentativo di definizione completa del totalitarismo, in E. Gentile, Il fascismo. Le interpretazioni dei contemporanei e degli storici, Laterza, Roma – Bari 1970. (Democrazia e Dittatura)
6. Stalin, Kirov, Zdanov, Osservazioni sul compendio del manuale di ‘ Storia moderna’, Tratto da La società sovietica, a cura di L. Foa, Loascher, Torino 1974. (I percorsi dell’inconscio)
UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. III
TITOLO
L’epoca della Guerra Fredda
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprensione dell’ordine geopolitico tra il 1948 e il 1969, e delle
innovazioni sociali e di costume che si sono prodotte durante quei decenni
CONTENUTI Unità didattiche
1. L’Italia Repubblicana, il centrismo
2. La guerra fredda e il disgelo negli anni Sessanta
3. La creazione della Comunità Europea
4. La scacchiera del Pacifico: l’esordio della Cina comunista, la Guerra di
Corea
5. Verso una coesistenza competitiva: La crisi missilistica di Cuba, la Guerra
in Vietnam
OBIETTIVI Conoscenze
1. Articolazione della Costituzione italiana
2. Le diverse fasi della guerra fredda a livello di propaganda, di conflitto

diplomatico, e di interventi militari locali
3. Il progetto di costruzione dell’Europa unita, e le diverse organizzazioni
sovranazionali
Competenze e Abilità
1. Lessico fondamentale degli statuti e delle costituzioni
2. Saper leggere e commentare un documento storico, riconoscendo il
contesto e l’orizzonte ideologico dell’autore
3. Saper argomentare in un saggio breve una tesi storiografica
4. Saper riconoscere la dimensione storica dei fenomeni di costume, e i
nessi che si stabiliscono a partire dagli anni ’50 con la cultura giovanile
5. Saper riconoscere le modalità d’articolazione d’un progetto politico in
relazione alla scrittura di costituzione e trattati
DOCUMENTI E BRANI 1. Il ruolo della donna nella resistenza, da V. Castronovo, Nel segno dei tempi
MilleDuemila, Vol. 3, La Nuova Italia, Milano 2015. (La donna nella storia)
2. Renzo De Felice, Alla scoperta della ‘zona grigia’, tratto da Rosso e nero,
Baldini & Castoldi, Milano 1995. (Luci ed ombre)
3. Harry Truman, La dottrina Truman, Tratto da R. Monteleone, Il
Novecento un secolo insostenibile: civiltà e barbarie sulla via della
globalizzazione. Edizione Dedalo, Bari 2005.
4. George Masrshall, Un programma comune per l’Europa, Tratto da R.
Hofstadter, Le grandi controversie della storia americana, Opere nuove,
Roma 1966.

UNITA’ DIDATTICA D’APPRENDIMENTO n. IV
TITOLO
Cittadinanza e Costituzione
MOTIVAZIONE E FINALITÀ Comprendere i temi classici dell’educazione civica unendo anche
l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità e il valore del rispetto
delle regole.
CONTENUTI Unità didattiche
1. Quando e perché sono nate le Costituzioni
2. La Costituzione italiana: dallo Statuto albertino all’Assemblea costituente
3. I principi fondamentali della Costituzione
4.L’organizzazione dello Stato italiano
OBIETTIVI Conoscenze e abilità
Un’idea di storia come educazione alla riflessione e all’esercizio critico
VERIFICHE E VALUTAZIONI. Tutti i principali argomenti della programmazione saranno oggetto di veriche di
varia tipologia (scritta/orale)

RUBRICA DI VALUTAZIONE di STORIA (E GEO-STORIA)
INDICATORI VOTO
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 COMPERENZE
CHIAVE
CONOSCENZE
Conoscenza dei principali eventi e delle trasformazioni di lungo periodo,
in particolare dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia globale del
mondo
Conoscenza dei presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con particolare riferimento all’Italia (Costituzione italiana) e all’Unione Europea
Riconoscimento degli aspetti geografici dell’ambiente naturale e
antropico e delle connessioni con le strutture demografiche e culturali
Correlazione della conoscenza storica agli sviluppi delle scienze e delle
tecnologie
Assenti
Frammentarie e
confuse
Imprecise/
approssimative
Parziali/
essenziali
Articolate
Approfondite
1. comunicare in
madrelingua
COMPETENZE ABILITÀ’
POSSESSO DEGLI
STRUMENTI
ESPRESSIVI ED
ARGOMENTATIVI
NELLA
COMPRENSIONE E
PRODUZIONE DI
TESTI
SCRITTI/ORALI
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale,
a seconda di differenti
tipologie, contesti,
contenuti e scopi
comunicativi
ABILITA’ LINGUISTICHE
Riconoscimento e analisi delle differenti caratteristiche formali delle
varie forme di documento storico e padronanza del lessico delle scienze
storico-sociali
Chiarezza e correttezza espositiva in relazione agli scopi, ai contesti e ai
contenuti.
Assenti o molto
lacunose
Parziali e
confuse
Imprecise/
approssimative
Parziali/
essenziali
Corrette e
evidenti
Approfondite e
puntuali
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
digitale (uso degli
strumenti
informatici nelle
attività di ricerca
e approfondi-
mento).
ABILITA’ INTERPRETATIVE, ARGOMENTATIVE E
VALUTATIVE
Individuazione dei cambiamenti culturali, socio-economici e politico-
isituzionali e dei contesti che li hanno resi possibili
Applicazione di lessico, categorie, strumenti e metodi delle scienze
storico-sociali per comprendere mutamenti storico-economici
Uso di fonti storiche di diversa tipologia (anche visive e multimediali)
Analisi critica delle radici storiche e dell’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali
Presenza e qualità dei collegamenti intertestuali, extratestuali e interdisciplinari
Capacità di analisi e sintesi e di produzione di un testo coerente ed efficace dal punto di vista comunicativo
Pertinenza dei contenuti rispetto alle consegne Saper argomentare il proprio punto di vista e saper individuare il punto
di vista altrui in modo fondato
Assenti
Carenti e
frammentarie
Imprecise e
superficiali
Essenziali e
appena
articolate
Ampie ed
evidenti
Complete
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
sociali e civiche
3. consapevolezza
ed espressione
culturale
4. imparare a
imparare
VALUTAZIONE FINALE ……/10

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO “ B. RUSSELL”
Programma svolto di Matematica nell’anno scolastico 2018/2019 sino al 15/05/2019
Classe 5 sez. H
Docente: Federica Tommasi
Testo utilizzato: COMPETENZE MATEMATICHE -Vol 4 e Vol 5- Fraschini- Grazzi
CALCOLO COMBINATORIO E PROBABILITA’
Calcolo combinatorio
Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con ripetizione
Coefficienti binomiali
Potenza di un binomio
Calcolo delle probabilità
Eventi elementari, certi, impossibili, aleatori
Definizione classica di probabilità
Probabilità totale di eventi compatibili e incompatibili
Probabilità contraria
Probabilità condizionata
Probabilità composta
Formula di disintegrazione
Formula di Bayes
FUNZIONI ( ripasso)
Definizioni fondamentali
Funzioni elementari: polinomi,funzioni razionali, funzioni irrazionali,funzioni goniometriche, funzione
logaritmica, funzione esponenziale,funzione valore assoluto.
La funzione f(x). La funzione inversa
Grafici deducibili da quello della funzione f.
LIMITI DI UNA FUNZIONE
Nozione di limite
Limite infinito
Limite finito di una funzione all’infinito
Asintoti orizzontali

Limite infinito di una funzione all’infinito
Limite sinistro, limite destro.
Teoremi sui limiti :
Teorema unicità del limite ( dim.)
Teorema del confronto ( dim)
Teorema della permanenza del segno ( dim)
Teorema inverso della permanenza del segno
FUNZIONI CONTINUE
Definizione di funzione continua
Continuità a destra o a sinistra
Continuità delle funzioni elementari
Operazioni sui limiti
Limite delle funzioni razionali intere e fratte
Limite delle funzioni composte: cambiamento di variabile
Limiti notevoli ( dim)
Punti di discontinuità
Classificazione delle singolarità
Teoremi fondamentali sulle funzioni continue :
Teorema di Weierstrass
* (Le donne nella storia)
Il senso di Sofia per la matematica: risultati raggiunti da Sofia Kovalevskaja nel campo della matematica (materiale fornito dal docente)
Teorema dei valori intermedi e conseguenze (dim)
Infinitesimi e infiniti
Confronto tra infinitesimi
Confronto tra infiniti
Asintoti:
Asintoti verticali
Asintoti orizzontali
Asintoti obliqui
LE DERIVATE
Definizione di derivata
Significato geometrico del rapporto incrementale

Significato geometrico di derivata
Funzione derivata
Derivata destra e sinistra
Punti notevoli del grafico di una funzione
Continuità delle funzioni derivabili ( dim)
Derivate delle funzioni elementari :
Derivata di una costante ( dim)
Derivata della funzione identica ( dim)
Derivata della funzione sin x ( dim)
Derivata della funzione cos x
Derivata della funzione logaritmica ( dim)
Derivata della funzione esponenziale ( dim)
Regole di derivazione
Derivata della funzione composta
Derivata della funzione inversa
Derivata delle funzioni inverse delle funzioni goniometriche ( dim)
Funzione derivata prima e derivate successive
Differenziale
Significato geometrico di differenziale
I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Massimi e minimi relativi ed assoluti
Teorema di Fermat e di Rolle ( dim)
Teoremi di Lagrange ( dim)
Significato geometrico del teorema di Rolle e del teorema di Lagrange
Conseguenze del teorema di Lagrange
Funzioni crescenti o decrescenti:
Teorema: Monotonia di una funzione derivabile
Teorema: Derivata di una funzione monotona
Teorema di Cauchy ( dim)
Il teorema di de L’Hopital
Criterio sufficiente di derivabilità
Limiti notevoli che si risolvono con il teorema di De L’Hopital

MASSIMI, MINIMI E FLESSI
Condizione sufficiente per l’esistenza di un estremo
Ricerca degli estremi relativi e assoluti
Concavità, convessità, flessi
Criterio di concavità e convessità in un punto
Condizione necessaria per i punti di flesso
Teoremi sull’ uso delle derivate successive:
Teorema: Derivata seconda ed estremi relativi:
Teorema: Derivate successive e punti stazionari
Applicazione alla risoluzione approssimata di equazioni:
Teorema di unicità della radice
Problemi di ottimizzazione
GRAFICI DI FUNZIONI
* ( Luci e ombre)
Funzioni periodiche
Massimi e minimi di una funzione Studio del grafico di una funzione
Dal grafico di una funzione a quello di una sua primitiva
Dal grafico di una funzione a quello di una sua derivata
L’INTEGRALE INDEFINITO
Primitive di una funzione
Proprietà dell’integrale indefinito
Integrali indefiniti immediati
Integrazione delle funzioni razionali
Integrazione per sostituzione
Integrazione per parti
Integrazione delle funzioni razionali fratte
L’INTEGRALE DEFINITO
* (Produzione, trasporto, consumo dell’energia e ricadute sull’ambiente.)
Calcolo della potenza media in un circuito resistivo utilizzando il teorema del valor medio
Area del trapezoide
Somme integrali generalizzate

Integrale definito.
Proprietà.
Il teorema della media
Significato geometrico
La funzione integrale: il teorema fondamentale del calcolo integrale
Formula fondamentale del calcolo integrale ( dim)
Integrali delle funzioni pari e dispari
Integrale per sostituzione
Calcolo di aree di domini piani
GEOMETRIA ANALITICA DELLO SPAZIO
Equazione di un piano e condizioni di parallelismo e perpendicolarità tra piani
Equazione di una retta e condizione di parallelismo e perpendicolarità tra rette e tra retta e piano
Distanza di un punto da una retta o da un piano
Superficie sferica e sfera
RISOLUZIONE DI PROBLEMI
In ambito analitico In riferimento alla ricerca dei massimi e dei minimi
Riguardanti studi di funzioni
Riguardanti applicazioni alla fisica
Programma che si intende svolgere dopo il 15/05/2019
DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA’
Variabili aleatorie e funzione di distribuzione
Valor medio, varianza e scarto quadratico medio
Proprietà del valor medio e della varianza
Funzione di ripartizione e proprietà
Speranza matematica e giochi equi
Distribuzione binomiale
Distribuzione di Poisson
Distribuzione geometrica

GRIGLIA VALUTAZIONE MATEMATICA/FISICA
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE
10
Conoscenze solide,
ampie,
approfondite e
personalizzate
Gestisce autonomamente e argomenta
attentamente procedure risolutive di
situazioni o problemi complessi, che
richiedono l’impiego di una
approfondita ricerca e riflessione
personale. Mostra fluidità ed eleganza
nello sviluppo dei calcoli e nella
elaborazione dei grafici. Utilizza con
padronanza metodi anche ricercati di
controllo e di adeguamento delle
procedure
Mostra eccellenti capacità di analisi e
sintesi basate su personale
rielaborazione critica; sa orientarsi
anche in situazioni problematiche
complesse non strettamente disciplinari
costruendo originali strategie risolutive
esposte con un linguaggio ricco e
articolato, basato sulla terminologia
specifica.
9
Conoscenze solide
ampie e
approfondite
E’ in grado di gestire autonomamente
e argomentare in modo completo
procedure risolutive di situazioni o
problemi complessi. Mostra fluidità
nello sviluppo dei calcoli e nella
elaborazione di grafici. Utilizza
metodi di controllo e di adeguamento
delle procedure
Mostra ottime capacità di analisi e
sintesi; effettua collegamenti
significativi fra i diversi argomenti con
un linguaggio ricco, basato sulla
terminologia specifica. Sa affrontare i
problemi costruendo proprie strategie
di risoluzione.
8
Conoscenze solide
e ampie
Gestisce consapevolmente e
argomenta procedimenti risolutivi di
situazioni o problemi anche
complessi. Ha fluidità nei calcoli e
padronanza nella gestione di grafici;
evidenzia capacità di previsione e
controllo dei risultati.
Mostra buone capacità di analisi e
sintesi; effettua collegamenti
significativi fra i diversi argomenti;
costruisce strategie risolutive adattando
schemi noti; effettua valutazioni
autonome e complete. Padroneggia la
terminologia specifica. Ha una buona
proprietà di linguaggio.
7
Conoscenze
complete e
assimilate con
chiarezza
Gestisce e argomenta procedimenti
risolutivi di situazioni o problemi di
tipologia nota anche abbastanza
complessi. Ha padronanza nella
gestione di grafici e calcoli .
Mostra discrete capacità di analisi e
sintesi; Esegue collegamenti; effettua
valutazioni in modo autonomo. Il
linguaggio è preciso e l’ esposizione
corretta.
6
Conoscenze
adeguate pur con
qualche
imprecisione
Se opportunamente orientato sa
gestire procedimenti risolutivi di
situazioni o problemi non complessi.
Ha sufficiente padronanza nella
gestione di grafici e calcoli.
Effettua analisi e sintesi non sempre
complete e approfondite. Individua i
concetti chiave ed esegue semplici
collegamenti . Linguaggio ed esposizione
sono semplici ma corretti.
5
Conoscenze
superficiali
Affronta situazioni o problemi
applicando le regole in forma
mnemonica; mostra incertezze nella
gestione di calcoli e/o grafici.
Effettua analisi e sintesi parziali e
superficiali; insicurezza nei
collegamenti. Il linguaggio non sempre è
adeguato.
3-4
Conoscenze
frammentarie
e/osuperficiali
Errori concettuali. Non commenta e
non giustifica le procedure richieste;
mostra scarsa capacità nella gestione
di calcoli e grafici.
Mostra limitate capacità di analisi e
sintesi e incapacità nello stabilire
collegamenti anche semplici.
Linguaggio ed esposizione sono

inadeguati.
1-2
Nessuna /
irrilevanti
Non sa cosa fare/ Non riesce ad
avviare procedure o calcoli
minimamente significativi.
Non riesce ad individuare i concetti
chiave; non argomenta alcun tema
proposto.
Conoscenza: acquisizione di contenuti quali : concetti, termini specifici, principi, teorie,
regole, leggi, procedure, metodi e tecniche, in modo da saperli identificare/ distinguere tra
loro, saperne dare definizione /enunciazione)
Abilità: saper utilizzare in contesti usuali e disciplinari le conoscenze acquisite (saper
risolvere semplici problemi di tipologie note con gli opportuni strumenti (principi, leggi,
metodi)
Competenza saper proporre e utilizzare opportune conoscenze e abilità nella risoluzione di
problemi anche complessi e di tipologia non nota.
N.B.Il concetto di competenza si distingue da quello di abilità perchè la persona competente si
dimostra in grado di scegliere con consapevolezza e autonomia conoscenze, strumenti e metodi,
le strategie risolutive più efficaci per la risoluzione dei problemi anche complessi e/o di
tipologia non nota. La competenza richiede rispetto alla semplice conoscenza una riflessione e
una rielaborazione critica anche personale.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
LICEO “ B. RUSSELL”
PROGRAMMA
Disciplina: IRC
Anno scolastico 2018-2019
Docente: Prof.ssa Magnano Fiorella
Classe V H
UDA n. 1
TITOLO
Chiesa cattolica e mondo moderno: il cattolicesimo liberale
MOTIVAZIONE
E FINALITA’
Individuare nella storia del Novecento la funzione e il ruolo svolto
dalla Chiesa Cattolica nel confronto con le istanze del mondo
moderno.
DURATA 13 ore

CONTENUTI
Il rapporto tra Chiesa e società successivamente a quanto accaduto con la Rivoluzione francese;
Lettura e commento di brani tratti dall’Emilio di J. J. Rousseau; Gli orientamenti del mondo cattolico durante l’epoca della
Restaurazione con particolare riferimento alla corrente del cattolicesimo liberale: Manzoni, Gioberti, Rosmini;
Gregorio XVI (1831-1846): lettura e commento di alcuni estratti delle encicliche Mirari vos e Singulari vos;
Hugues Felicité Robert de Lamennais il suo programma legislativo: lettura e commento di alcuni estratti dell’Avenir;
Pio IX (1846-1878): l’ultima Papa re;
La breve parentesi della Repubblica romana; Il dogma dell’Immacolata Concezione proclamato da Pio IX nel
1854;
Breve sintesi della storia di Santa Bernadette di Soubirous;
Lettura e commento di alcuni estratti dell’enciclica Quanta cura e del Syllabo di Pio IX;
Il Concilio Vaticano I (1869-1870) e le costituzioni conciliari Dei Filius e Pastor Aeternus;
Il primato del Papa e il dogma dell’infallibilità papale proclamati da Pio IX: lettura e commento di alcuni estratti della Pastor Aeternus;
Il dogma dell’Assunzione di Maria Vergine al cielo in anima e
corpo (1950);
L’attuale dialogo tra il teologo Hans Küng e Papa Francesco al riguardo del dogma dell’infallibilità papale;
UDA n. 2
TITOLO
Chiesa cattolica e questione sociale: il cattolicesimo sociale
MOTIVAZIONE
E FINALITA’
Motivare l’impegno sociale e politico del cristiano alla luce dei
principi della dottrina sociale.

DURATA
10 ore
CONTENUTI
Il contesto storico: la seconda rivoluzione industriale;
Il taylorismo e l’avvento della società di massa;
Nascita del capitalismo;
Scienza e progresso: Comte e il positivismo;
Il darwinismo sociale: Herbert Spencer;
La questione operaia;
Leone XIII (1878-1903);
Lettura e commento di alcuni estratti della Rerum Novarum; La dottrina sociale della Chiesa: i principi di solidarietà,
sussidiarietà e bene comune;
UDA n. 3
TITOLO
I Patti Lateranensi e il Concilio Vaticano II
MOTIVAZIONE
E FINALITA’
Divenire consapevole della progressiva separazione intervenuta tra
fede e cultura nel mondo moderno e dei tentativi di superamento
operati dal Concilio Vaticano II.
DURATA
5
CONTENUTI
Il contesto storico: l’avvento e il crollo del fascismo;
La politica culturale del fascismo;
I Patti Lateranensi (1929): lettura e commento di alcuni estratti al fine di delinearne la struttura e la finalità;
Lettura e commento dell’articolo 7 della Costituzione italiana;
La revisione del Concordato (1984);
L’attuale dibattito politico a riguardo del Concordato tra Stato e Chiesa;
Cenni sul Concilio Vaticano II e le costituzioni dogmatiche Sacrosantum Concilium, Lumen Gentium, Dei Verbum e Gaudium et Spes;

LICEO CLASSICO SPERIMENTALE STATALE ”BERTRAND RUSSELL”
Programma 2018/2019
docente prof.: POLESE DANIELE
Libro di testo adottato - Titolo: Balboni – movimento, sport e salute
volume unico - casa editrice: Capitelli
Liceo Scientifico: classe QUINTA sezione H
UdA n.1 - TITOLO: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
ARGOMENTI:
- Dalla regola imposta alla regola compresa e condivisa, - Il fair play,
- le prepotenze,
- il bullismo ed il cyber bullismo, - la violenza nello sport,
- Il doping e lo sport,
- la Costituzione, la diversità e lo sport.
COMPETENZE:
- Collaborare e partecipare.
- rispettare le regole sociali e scolastiche.
- praticare il fair play anche nel sociale.
- praticare lo sport privilegiando la componente educative ed inclusiva.
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione,
- Riconoscere la diversità come un valore aggiunto di ogni singolo individuo.
- praticare lo sport applicando strategie efficaci alla risoluzione delle situazioni problematiche,
- prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo
- Saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune.
- Saper interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole
della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari
- Partecipare attivamente alle attività formali e non formali, senza escludere alcuno dalla conversazione o dalle attività. -Individuare e conoscere le conseguenze civili e penali comminate dalla legge per gli atti di bullismo e per
l’utilizzo di droghe e di doping.

UdA n.2 - TITOLO: MOVIMENTO E SPORT
ARGOMENTI:
- Acquisizione dei valori interculturali del movimento, del gioco e dello sport,
- acquisizione del valore della corporeità, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di
espressione e di relazione, in funzione della formazione della personalità,
- consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita, intesa anche come capacità di realizzare attività finalizzate e di valutarne i risultati e di individuarne i nessi pluridisciplinari,
- caratteristiche e benefici del movimento e dello sport,
- il potenziamento fisiologico, - la corsa
- il recupero,
- il defaticamento, - lo stretching.
- test motori
COMPETENZE:
- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la
gestualità.
- Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta. - Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi sportivi e sport individuali - Praticare lo sport privilegiando la componente educativa,
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione,
- Praticare lo sport applicando strategie efficaci alla risoluzione delle situazioni problematiche, - Prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo
- Saper lavorare per un tempo medio.
- Saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune. - Conoscere il lessico settoriale.
- riconoscere e valutare le prestazioni motorie
UdA n.3 - LE REGOLE, LE TECNICHE DI GIOCO, I RUOLI E I COMPITI NELLA
PALLAVOLO
ARGOMENTI:
- il gioco e le regole fondamentali,
- il terreno di gioco e la palla,
- le squadre e le zone, - la partita, - i fondamentali individuali e di squadra,
- il servizio, - il bagher, - il palleggio,
- la schiacciata, - il muro, - la ricezione,
- la difesa.
COMPETENZE:

- Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le azioni attraverso la gestualità ed il
gesto tecnico.
- Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l'azione motoria richiesta. -
Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale il gioco della pallavolo
- Possedere competenze tecniche della pallavolo
- Saper collaborare con gli altri per un risultato sportivo e sociale comune.
- Conoscere il lessico settoriale.
- praticare lo sport privilegiando la componente educativa,
- collaborare all’interno del gruppo sviluppando il concetto di socializzazione ed inclusione,
- praticare lo sport applicando strategie efficaci alla risoluzione delle situazioni problematiche,
- prediligere la competizione sana e la cooperazione di gruppo
UdA n.4 - TITOLO: CITTADINANZA E SALUTE
ARGOMENTI:
- Benefici dell’attività fisica sulla
salute, - anatomia e fisiologia dell’apparato
locomotore,
- alimentazione e sport
- il doping e lo sport
COMPETENZE:
- Rispettare il proprio corpo attraverso una sana ed equilibrata alimentazione ed attività fisica blanda e
costante,
- Essere responsabili della propria ed altrui sicurezza sia nel sociale che nel privato nonché in palestra, a
scuola e negli spazi aperti,
- Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale,
- Conoscere il proprio corpo e le sue principali funzioni.
- effetti collaterali del doping


GRIGLIA DI VALUTAZIONE
2018/19 Scienze motorie e sportive Polese Daniele
La valutazione terrà conto oltre che dei risultati oggettivi anche dell'impegno, del comportamento, della
partecipazione (intesa come attenzione, precisione nel mantenere gli impegni, puntualità, richiesta di
chiarimenti, disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni) e del numero di giustificazioni. Per gli
alunni esonerati la valutazione avverrà su interrogazioni scritte o orali e sulla capacità di arbitraggio.
INDICATORI VOTO
1-2 3-4 5 6-7 8-9 10 COMPERENZE
CHIAVE
CONOSCENZE
Conoscenza delle
principali potenzialità
fisiologiche in
relazione al corpo
umano
Conoscenza delle
capacità senso
percettive e
coordinative
Conoscenza della terminologia specifica
, dei regolamenti e
della tecnica
essenziale di alcuni
sport
Conoscenza dei
principi di educazione
alla salute e
prevenzione intese
come stile di vita
Nulle
Imprecise e
confuse
Parziali e
superficiali
Essenziali
Articolate
Approfondite
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
sociali e civiche
COMPETENZE ABILITÀ’
ABILITA’ MOTORIE
CONDIZIONALI
Nulla
Meno che
Parziali
Essenziali
Corrette e
Approfondite
1. comunicare in
madrelingua
Praticare attività
motorie
adeguandosi ai
contesti, sfruttando
al meglio le proprie
potenzialità
organico-funzionali
e orientandosi nel
rispetto delle regole
Variazioni del livello di
condizionamento rispetto al
livello individuale di
partenza in relazione alle
seguenti abilità motorie :
Velocità
Forza
Resistenza
essenziale evidenti
ABILITA’ MOTORIE
COORDINATIVE
Variazione del livello di
espressione di :
Nulla
Meno che
essenziale
Parziali
Essenziali
Corrette e
evidenti
Approfondite
1.comunicare in
madrelingua
2.competenze
sociali e civiche
Destrezza
Mobilità articolare
Saper riprodurre e
memorizzare
sequenze motorie
semplici, a corpo
libero, con piccoli e
grandi attrezzi e
attraverso gesti
sportivi.
Realizzazione di alcune sequenze
motorie che valorizzino le capacità
individuali
Riproduzione dei
fondamentali
individuali e di
squadra dei principali
sport praticati a scuola
Nulla
Meno che
essenziale
Parziali
Essenziali
Corrette e
evidenti
Approfondite
1.comunicare in
madrelingua
2.competenze
sociali e civiche

Apprendere la
teoria relativa a:
organi ed apparati
che concorrono al
movimento
regolamenti degli
sport;
prevenzione nelle
libere attività.
Ricerca, acquisizione
e selezione dalle fonti
di informazioni
generali e specifiche
Selezione e qualità
dei collegamenti
intertestuali,
interdisciplinari
Coerenza concettuale
e contestualizzazione
Capacità di analisi e
sintesi
Pertinenza dei
contenuti rispetto alle
consegne
Nulla
Frammentarie
e/o incoerenti
Superficiali
e/o
schematiche
Essenziali
Articolate
Pienamente
argomentate
1. comunicare in
madrelingua
2. competenze
sociali e civiche
3.
consapevolezza
ed espressione
culturale

10


11

11.