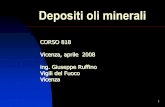DIAGNOSTICA STRUTTURALE E PROVE NON...
Transcript of DIAGNOSTICA STRUTTURALE E PROVE NON...
DIAGNOSTICA STRUTTURALE E PROVE NON DISTRUTTIVEIng. Alessandro Battisti
- Prove di carico.
- Carotaggi e microcarotaggi.
- Prove di pull-out.
- Prove sclerometriche.
- Prove soniche.
- Prove combinate (Sonreb).
- Prove pacometriche.
- Prove di martinetto piatto singolo e doppio.
- Altre prove non distruttive.
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
Si valuta la risposta in termini di deformazione verticale in punti noti della struttura
sottoposta a carichi predeterminati ed equivalenti a quelli teorici previsti; si verifica che
l’entità delle frecce registrate sia inferiore a quella teorica, che le stesse si manifestino
proporzionalmente ai carichi applicati e che le deformazioni residue tendano allo zero.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
MODALITA’ ESECUTIVE� PROGETTO DELLA PROVA: la prova di carico va progettata con attenzione; spesso la logistica esecutiva è più complessa
dell’esecuzione stessa; è importante produrre una simulazione preventiva applicando, in funzione dello schema statico di
progetto, i carichi reali di collaudo e valutando preventivamente l’entità delle frecce conseguenti nei punti in cui si
andranno a misurare in cantiere. Ciò è solitamente demandato al progettista delle strutture che deve valutare anche le
eventuali criticità (punzonamenti, rischi locali etc.).
� VALUTAZIONE DEL CARICO DI PROVA: il carico da applicare sulla struttura da testare raramente equivale a quello teorico
di progetto; è quasi sempre necessario procedere al calcolo dello stesso in funzione delle condizioni al contorno tipiche
della situazione di prova e sempre diverse: tipicamente il carico reale dipende dalla tipologia di applicazione (distribuito
o puntuale), dalla dimensione dell’impronta, dal grado di collaborazione laterale nel caso di impalcato, dalla percentuale
di ricoprimento dell’area d’influenza (nel caso di serbatoi d’acqua) etc. ed è sempre maggiore o uguale a quello teorico.
� ESECUZIONE MATERIALE DELLA PROVA: salvo diversa indicazione del Collaudatore, la prova viene eseguita applicando per
cicli successivi di carico-scarico secondo step regolari le azioni definite nella relazione di progetto della prova stessa,
misurando in punti caratteristici prestabiliti le frecce indotte, attraverso sistemi più o meno sofisticati. Le azioni, come
riportato nel D.M. 14/01/2008 dovranno essere in generale «tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per
combinazioni caratteristiche rare». Salvo casi rarissimi in cui l’elasticità della struttura in prova sia assolutamente
comprovata a priori è sempre opportuno procedere ad almeno due cicli completi di carico scarico per consentire alla
struttura stessa di «depurarsi» durante il primo ciclo, di eventuali deformazioni residue dovute ad assestamenti del
complesso strutturale. Al termine della prova dovrà essere possibile costruire un grafico isteretico rappresentativo.
� NORMATIVA E RESPONSABILITA’: le prove di carico sono normate dal cap. 9.2 del D.M. 14/01/2008 che, per quanto
riguarda le competenze, recita: «Il programma delle prove, stabilito dal Collaudatore, con l’indicazione delle procedure di
carico e delle prestazioni attese deve essere sottoposto al Direttore dei lavori per l’attuazione e reso noto al Progettista ed
al Costruttore. Le prove di carico si devono svolgere con le modalità indicate dal Collaudatore che se ne assume la piena
responsabilità, mentre, per quanto riguarda la loro materiale attuazione, è responsabile il Direttore dei Lavori.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
MODALITA’ ESECUTIVE� Anche se ogni prova di carico presenta caratteristiche proprie e peculiari, in linea di, massima, per quelle più diffuse sugli
orizzontamenti, si dovranno tener presenti alcuni criteri generali:
a) la zona di carico (nel caso di prove su solai) dovrà essere sufficientemente distante dalle travi o sostegni paralleli
all’orditura per non risentire del loro possibile effetto collaborante che, per strutture di recente concezione, è
spesso non trascurabile per la presente della cappa superiore armata;
b) la larghezza della striscia di carico (per prove con serbatoi) dovrà essere tale da interessare almeno tre travetti
contigui;
c) nel caso di solaio a getto pieno la distribuzione di misura delle deformazioni verticali dovrà comprendere almeno
tre punti per ciascuna delle due direzioni principali di orditura;
d) visto che di solito le prove di carico si eseguono sulla struttura grezza, al carico variabile di normativa dovrà
essere opportunamente sommato quello permanente dovuto ai carichi mancanti, non ancora posati;
e) per evitare fenomeni dinamici o rotture fragili il carico di prova dovrà sempre essere applicato per gradi e
secondo step di entità costante ed intervalli di tempo regolari, monitorando in continuo (ecco l’importanza di
avvalersi di un’attrezzatura adeguata e professionale) gli spostamenti nei punti predefiniti e consentendo alla
struttura un adeguato completamento dello stato deformativo, sia in fase di carico che in fase di scarico;
f) nel caso di solai monodirezionali sarà sempre opportuno misurare, oltre alle frecce caratteristiche della campata
lungo la direzione principale (appoggi, mezzeria, quarti etc..) anche qualche valore delle deformazioni trasversali
in modo da poter successivamente valutare il grado di collaborazione laterale.
� TIPOLOGIE DI APPLICAZIONE DEL CARICO DI PROVA: nella maggioranza dei casi il carico di prova è applicato attraverso il
posizionamento di serbatoi per collaudi di idonee dimensioni, opportunamente caricati d’acqua; questo metodo ha il
grande pregio di essere in grado di riprodurre più fedelmente quanto ipotizzato in fase di progetto (carico distribuito) ma
comporta un tempo relativamente lungo d’esecuzione; con le dovute cautele (rischio di punzonamento o di incapacità
resistente del contrasto superiore) è possibile in taluni casi simulare il carico distribuito utilizzando sistemi idraulici in
grado di applicare uno o più carichi puntuali che producano un momento flettente a punti equivalente a quello teorico.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
ALCUNE TIPOLOGIE DI PROVA
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
ALCUNE TIPOLOGIE DI PROVA
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
MODALITA’ ESECUTIVE� Nel caso di strutture secondarie, travi singole, travi reticolari o orizzontamenti in cui non sia possibile utilizzare contrasti
superiori (coperture, impalcati di galleria, etc.) i carichi concentrati equivalenti possono essere applicati per «tiro»
anziché per «spinta». Per ponti, viadotti, ed altre strutture civili il carico variabile è solitamente simulato attraverso il
transito e lo stazionamento in posizioni note che massimizzino i comportamenti voluti (momento positivo in mezzeria,
momento negativo all’appoggio, taglio sulla pila, eccentricità di impalcato e di pila etc.) di automezzi pesanti
opportunamente caricati e pesati.
Ing. Alessandro Battisti
ASTE E STATIVI A SOSTEGNO DEI TRASDUTTORI STAZIONE DI ELABORAZIONE
ESEMPIO DI ATTREZZATURA
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
ANALISI DEI RISULTATI� I risultati delle prove di carico devono essere riassunti in un verbale che contenga tutte le informazioni necessarie
all’identificazione univoca della struttura in esame ed una sua descrizione, i criteri teorici e quelli funzionali che hanno
condotto alle scelte esecutive messe in atto durante il collaudo e, naturalmente, i dati di deformazione registrati nei punti
di misura scelti in fase preliminare. Il giudizio sull’esito della prova (Cap. 9.2 del D.M. 14/01/2008) è responsabilità del
Collaudatore.
� L’esito della prova, ai sensi del D.M. 14/01/2008, deve essere valutato secondo i seguenti criteri:
a) le deformazioni si accrescano all’incirca proporzionalmente ai carichi;
b) nel corso della prova non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la
sicurezza dell’opera;
c) la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella
totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel
caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive devono indicare che la struttura tenda ad
un comportamento elastico;
d) la deformazione elastica non risulti maggiore di quella calcolata.
Il Collaudatore, nel caso ed in relazione all’importanza dell’opera, può integrare le prove statiche con prove dinamiche e
prove a rottura su elementi strutturali o, in alternativa, può ordinare l’esecuzione di una campagna di prove non distruttive
o semi distruttive.
� La rappresentazione tipica dei risultati di una prova di carico avviene sotto forma di diagramma carico-deformazione
multi ciclico o «diagramma isteretico» della prova; Dal grafico e dalla forma delle curve d’isteresi si possono
immediatamente desumere alcune informazioni estremamente importanti : più la curva tende a rappresentare una retta,
più il comportamento della struttura si può dire elastico; ciò raramente accade per la presenza di deformazioni
permanenti e plastiche dovute al peso proprio e ad altri carichi permanenti, all’eventuale parziale cedimento degli
appoggi etc. La curva è quindi una spezzata e l’area da essa racchiusa rappresenta l’energia dissipata durante il processo
di carico-scarico della struttura eseguito per fasi successive.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI CARICO – CAP. 9.2 DEL D.M. 14/01/2008 e circ.espl.
ANALISI DEI RISULTATI
� ESEMPIO DI GRAFICO ISTERETICO RELATIVO A 6 PUNTI DI MISURA
Carico (daN/mq)
Def. (mm)
Ing. Alessandro Battisti
CAROTAGGI E MICROCAROTAGGI – UNI EN 12504-1
Anche se la metodologia non può definirsi propriamente «non distruttiva» essa è molto
utilizzata come «taratura preliminare» ed a completamento di qualsiasi campagna
diagnostica per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e per
l’individuazione della composizione stratigrafica di solai e murature.
Ing. Alessandro Battisti
CAROTAGGI E MICROCAROTAGGI – UNI EN 12504-1
NORMATIVA: per le procedure di prelievo ed estrazione di campioni attraverso carotaggio del calcestruzzo indurito e le
successive modalità di prova a compressione si può far riferimento alle norme UNI EN 12504-1 «prelievo sul calcestruzzo
nelle strutture – Carote – prelievo, esame e prova a compressione» , UNI EN 12390-1 «Prova sul calcestruzzo indurito –
Forma, dimensioni ed altri requisiti per provini e per casseforme», UNI EN 12390-3 «Prova sul calcestruzzo indurito –
Resistenza alla compressione dei provini» ed alle «Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la
valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive» emanate dal Servizio
Tecnico Contrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Come recita il Cap. 11.2.6 del D.M. 14/01/2008 « … E’ accettabile un valore medio della resistenza strutturale, misurata con
tecniche opportune (distruttive e non distruttive) e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o cubica, non inferiore
all’85% del valore medio definito in fase di progetto …»
MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE: in fase di prelievo e prima dell’esecuzione della prova di compressione assiale,
come si evince anche dall’art. C.11.2.6 della Circ. Min. Infr. e Trasporti 02/02/2009 nr. 617, occorre prestare particolare
attenzione in modo che:
- Il diametro delle carote sia superiore ad almeno tre volte il diametro massimo degli aggregati (normalmente non
inferiore a 100 mm);
- le carote prelevate e destinate a prove di laboratorio non contengano porzioni di ferri d’armatura; è quindi
fondamentale, prima dell’estrazione, procedere all’esecuzione di una prova pacometrica che individui
correttamente la posizione delle barre all’interno del conglomerato in modo da evitarne il taglio;
- per ciascuna area di prova sia prelevato un insieme statistico composto da almeno tre carote al fine di garantire
una stima attendibile delle caratteristiche di resistenza indagate;
- il rapporto tra la lunghezza ed il diametro dei provini sia uguale a 2 o comunque superiore ad 1 ed inferiore a 2;
Ing. Alessandro Battisti
CAROTAGGI E MICROCAROTAGGI – UNI EN 12504-1
- Sia durante il prelievo che nella fase successiva di deposito in attesa di rottura è importante evitare che i provini
siano sottoposti ad essicazione all’aria; le prove di compressione assiale, normalmente, si eseguono su campioni
umidi;
- nella stesura del piano di prelievo si deve tener presente che la resistenza del calcestruzzo dipende dalla
posizione del getto;
- il campione sottoposto a prova di compressione presenti perfetta planarità ed ortogonalità delle superfici di
appoggio e, durante il taglio a tal fine, il campione rimanga indisturbato.
VALORI DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO INDURITO: il D.M. 14/01/2008 (Cap. 11.2.10.1) dichiara che: «In sede di progetto
si farà riferimento alla resistenza caratteristica cubica ���»; dalla resistenza cubica si passerà a quella cilindrica attraverso
l’espressione: fck � 0,83���e, sempre in sede di previsioni progettuali, si potrà passare al valor medio della resistenza
cilindrica mediante l’espressione: �� � �� � 8�
���.
Ing. Alessandro Battisti
Eseguiti i prelievi di determina il valore medio della resistenza cilindrica dell’insieme di provini che non deve quindi essere
inferiore all’85% del valore medio �� definito in fase di progetto. Si riporta l’esempio descritto nella Circ. Min. Infr. e
Trasporti 02/02/2009 nr. 617:
- in fase di progetto si è utilizzata una resistenza caratteristica cubica ��� pari a 30�
���;
- il valore caratteristico cilindrico �� � 0,83��� sarà pari a 24,9�
���;
- il valore medio cilindrico sarà quindi: �� � �� � 8 � 32,9�
���;
- dovrà allora risultare: � ����� � 0,85 �� � 0,85 ∗ 32,9 � 27,9�
���.
PROVE DI PULL-OUT – UNI EN 10157, ASTM C900
La resistenza caratteristica del materiale è in questo caso valutata attraverso la misura della
forza applicata da un martinetto idraulico e necessaria per l’estrazione meccanica di un
tassello in acciaio preventivamente inserito nel manufatto in prova. Importante, nel caso
del calcestruzzo è pure la «forma» e l’ «omogeneità» del cono di distacco.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI PULL-OUT – UNI EN 10157, ASTM C900
NORMATIVA: Le prove di pull-out sono regolamentate dalle normative UNI 10157:1992 «Calcestruzzo indurito.
Determinazione della forza di estrazione mediante inserti post-inseriti ad espansione geometrica e forzata», UNI EN 12504-
3:2005 «Prove su calcestruzzo nelle strutture – Parte 3: Determinazione della forza di estrazione» , ASTM C900-06 «Standard
Test Method for Pullout Strenght of Hardened Concrete».
Ing. Alessandro Battisti
TIPOLOGIA DI PROVA E FINALITA’: la prova di pull
out consente la determinazione della proprietà
meccaniche del calcestruzzo in opera attraverso
l’inserimento di un tassello d’acciaio di forma
standard e la sua successiva estrazione attraverso
un sistema idraulico composto da martinetto,
pompa e manometro; il valore della forza (o
pressione) di estrazione riportato su una curva di
correlazione sperimentale (cha varia al variare
della tipologia e delle caratteristiche del
tassello!) consente la determinazione della
resistenza media dell’area di calcestruzzo
indagata.
La rottura della parte sottoposta a tensione
avviene per compressione-taglio tra la parte
allargata del tassello e la base del martinetto con
estrazione di un cono di forma predeterminabile.
PROVE DI PULL-OUT – UNI EN 12504-3, 10157, ASTM C900Ing. Alessandro Battisti
MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE: la prova di pull out deve essere eseguita
seguendo una determinata procedura che ne garantisce l’affidabilità dei risultati:
- il foro per l’inserimento del tassello ad espansione geometrica deve essere
praticato previa prova pacometrica che individui la posizione dei ferri
d’armatura; ogni foro deve distare dagli altri almeno 5", distare dai bordi
almeno 2.5" con "�#$ � 35��.
- sono necessarie per ogni zona indagata almeno 3 prove di estrazione;
- se è presente l’intonaco, esso va asportato per una superficie sufficiente
all’esecuzione dei tiri; lo spessore minimo del calcestruzzo deve essere 2,5".
- la superficie stessa deve essere regolarizzata e resa planare;
- il foro va eseguito solamente con la punta adatta in dotazione al kit di pull
out, deve essere svasato e ripulito dalla polvere con getto d’aria;
- il tassello standardizzato deve essere inserito e ribattuto più volte con l’ausilio
dell’adattatore presente nel kit al fine di svasare correttamente la testa e
farlo aderire perfettamente alle pareti del foro;
- il martinetto idraulico va avvitato con l’apposita prolunga al tassello avendo
cura che l’anello di contrasto aderisca in modo uniforme al supporto;
- il sistema idraulico deve essere avviato e manovrato con step di carico
modesti (avendo cura di non sostare di fronte al martinetto) sino al distacco ;
- a questo punto è possibile leggere sul manometro tramite lancetta di
massimo il valore di pressione corrispondente alla rottura e, riportandolo
sulla curva di correlazione, ottenere la stima desiderata di ���.
PROVE SCLEROMETRICHE – UNI EN 12504-2
La resistenza superficiale del materiale è calcolata attraverso la misura dell’indice di rimbalzo
di una massa spinta da una molla calibrata e tarata. Sono disponibili modelli diversi di
sclerometro per applicazioni su materiali diversi (calcestruzzo, malte, rocce etc.). Prima
dell’esecuzione della prova è necessario individuare con un pacometro le armature presenti.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE SCLEROMETRICHE – UNI EN 12504-2Ing. Alessandro Battisti
NORMATIVA: Le prove di durezza superficiale o prove sclerometriche sono regolamentate dalle normative UNI EN 12504-2 «
Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Prove non distruttive – Determinazione dell’indice sclerometrico»
TIPOLOGIA DI PROVA E FINALITA’: la prova
sclerometrica ha come scopo la stima della
resistenza a compressione del calcestruzzo in
opera (su strutture già realizzate); la superficie
viene colpita nel punto da verificare da una forza
nota applicata con un cilindro metallico spinto da
una molla; il valore che si legge su una scala
lineare alloggiata nella cassa dello sclerometro è
detto «indice di rimbalzo».
L’indice di rimbalzo viene quindi riportato su un
grafico specifico per ogni sclerometro e,
attraverso le relative curve di correlazione
definite in funzione dell’angolo di battuta, si
ricava la resistenza cubica del calcestruzzo.
Devono essere eseguite più battute per ciascuna
area da indagare, scartando i due valori d’ala;
Lo sclerometro deve necessariamente essere
manutentato e ritarato con una certa frequenza.
PROVE SCLEROMETRICHE – UNI EN 12504-2Ing. Alessandro Battisti
MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE: per ottenere dei risultati il più possibile
affidabili e, comunque, per la natura stessa della prova, con una precisione
stimata dell’ordine del 15-20%, è necessario rispettare alcune regole di buona
esecuzione:
- azionare lo strumento almeno tre volte prima di cominciare le battute;
- procedere preventivamente all’esecuzione di una prova pacometrica che
individui la posizione delle barre d’armatura in modo da eseguire le battute
lontano da queste;
- se la superficie è intonacata, rimuovere l’intonaco, pulire e rettificare la
superficie sottostante con l’apposita pietra pomice in dotazione;
- durante la battuta mantenere lo strumento assolutamente perpendicolare
alla superficie;
- indagare elementi di spessore minimo pari a 150 mm;
- evitare zone che presentino vespai, scalfitture, porosità elevata;
- procedere all’esecuzione di almeno 9 battute (UNI EN 12504-2) o 10 battute
(Circ. Min. Infr. e Trasporti) ad una distanza tra loro non inferiore ai 25 mm;
- NOTA: lo sclerometro misura una resistenza superficiale ed è sensibile alla
variazione di omogeneità e isotropicità del calcestruzzo; è indicato per
valutazioni su calcestruzzi giovani perché il fenomeno della carbonatazione,
indurendo lo strato superficiale, può portare a sovrastimare i calcestruzzi
datati.
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1, UNI
12504-4
Attraverso l’invio di un impulso d’onda nel manufatto e la comparazione dei tempi di ritardo
e delle velocità di propagazione, si ricostruiscono difetti e caratteristiche meccaniche del
materiale indagato. La tecnologia sonica può essere utilizzata sia sulle murature che sui
manufatti in cemento armato .
Ing. Alessandro Battisti
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1,
UNI EN 12504-4 Ing. Alessandro Battisti
NORMATIVA: Le prove soniche sono attuabili secondo le prescrizioni contenute nelle norme UNI EN 583-1 «Prove non
distruttive - Esame ad ultrasuoni - Parte 1: Principi generali» e UNI EN 12504-4 «Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte
4: Determinazione della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici».
TIPOLOGIA DI PROVA E FINALITA’: l’indagine sonica può
essere utilizzata con successo per diversi tipi di materiali,
e in modo particolare su elementi in muratura e su
manufatti in calcestruzzo al fine di indagarne l’elasticità,
l’omogeneità, la presenza di difetti, le caratteristiche
meccaniche o la variazione di queste grandezze.
Nella maggior parte dei casi vengono utilizzate due
sonde, una emettitrice ed una ricevente, che possono
essere posizionate o su facce opposte dell’elemento da
indagare (misura diretta), sulla stessa faccia dello stesso
(misura indiretta) o su facce tra loro ortogonali (misura
semidiretta).
La sonda emettitrice produce degli impulsi che vengono
captati dalla sonda ricevente e registrati
dall’apparecchiatura e dal software dedicato;
conoscendo la distanza tra le sonde e misurando il
tempo di transito si può calcolare la velocità di
propagazione.
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1,
UNI EN 12504-4 Ing. Alessandro Battisti
MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE: per una corretta esecuzione della prova, a prescindere dalla tipologia di struttura
esaminata, sarà opportuno porre particolare attenzione a:
- Individuare correttamente e precisamente la geometria esecutiva della prova contrassegnando con precisione i punti
opposti alla superficie o, se prova indiretta lungo una direttrice a distanze di 20,0 cm. tra 5 punti, in modo da non
produrre errori sulla valutazione della distanza tra le sonde;
- pulire e levigare le superfici in cui verranno posizionate le sonde;
- posizionare con precisione le sonde avendo cura di interporre tra esse ed il supporto l’apposito gel conduttivo a base
d’acqua, caolino, vaselina etc.
- valutare correttamente la situazione ambientale o, nel caso di calcestruzzo armato, la presenza di armature; la velocità
di propagazione delle onde %&�
'(, infatti, è più elevata in presenza di umidità e di elementi conduttivi metallici; nei
tondini d’armatura la velocità può risultare superiore addirittura del 40% rispetto a quella riscontrata nel calcestruzzo;
- se la temperatura d’intervento risulta esterna all’intervallo �5°* + , + �30°*, considerare la necessità di applicare
dei coefficienti correttivi riferiti a calcestruzzi asciutti e saturi, recuperabili in letteratura (vedi raccomandazione RILEM);
- procedere con la misurazione rilevando il valore medio di 3 passaggi consecutivi che varino tra di loro per non più del
5%;
- tarare lo strumento attraverso il cilindro in dotazione prima e dopo l’esecuzione delle prove o ogniqualvolta si eseguano
modifiche alla configurazione generale del sistema (sostituzione di cavi, sonde etc.);
- verificare che, se la dimensione nominale dell’aggregato è pari a 20 mm la lunghezza del calcestruzzo indagato sia
almeno di 100 mm e che se la dimensione nominale dell’inerte è compresa tra 20 e 40 mm la lunghezza del calcestruzzo
sia almeno di 150 mm; ciò vale pure per la distanza minima tra i punti di misura;
- venga esercitata sulle sonde puntuali una adeguata pressione di accoppiamento.
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1,
UNI EN 12504-4 Ing. Alessandro Battisti
La resistenza cubica a compressione -. può essere valutata attraverso la formula sperimentale: �� �/
0∗ 12 3 5&45�(
ricavata dal confronto con i valori ottenuti dalla media delle prove di pull – out e/o carotaggi, dove:
6 �78
98:;;
12 � velocità media &�
'(;
1� e ��= velocità media dell’onda e resistenza media misurate per gli altri metodi, negli stessi punti.
In alternativa, in via più semplificata e sempre sperimentale, è ancora talvolta utilizzata la formula desunta dalla normativa
Belga NBN B15 – 229/1976: �� � 1,88 ∗ 10=�� ∗ 12>,/?@ dove:
12 �2
A;
Il modulo di elasticità dinamico BCdel calcestruzzo è quindi calcolabile con l’espressione: DE � 1F� ∗ G ∗
H/:IJH/=�IJ
KH/=IJdove:
DE �modulo elastico dinamico &45�(;
1F �velocità rilevata�
';
G �W
K� densità del calcestruzzo
X�
�Y;
% � coeff. di Poisson del calcestruzzo in opera (normalmente: % � 0,15per cls alta resistenza; % � 0,30 per bassa resistenza);
Z � ����[���\]�^�_]Z��%]`à � 9,81�
'�.
Il modulo di elasticità statico Bbdel calcestruzzo è allora determinato con la formula di Weber-Hermenn: D' �cd
/,e>�.
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1,
UNI EN 12504-4 Ing. Alessandro Battisti
Rilievo delle profondità di lesioni longitudinali: una delle applicazioni per cui usualmente è possibile utilizzare la tecnica
ultrasonica è il rilievo della profondità di una lesione;
Metodo combinato «Sonreb» (BS 1881-204, DIN 1045, CP110): si tratta di un approccio che combina l’indagine non
distruttiva sclerometrica con quella ultrasonica al fine di aumentare il grado di accuratezza ed attendibilità dei risultati
ottenuti per la resistenza del calcestruzzo; i vantaggi del metodo sono:
- annullamento dell’influenza dell’umidità e del grado di maturazione del calcestruzzo sui risultati dell’indagine in quanto
essi hanno effetti opposti (a parità di resistenza) sulla velocità di propagazione del suono e sull’indice di rimbalzo;
- riduzione, rispetto al solo metodo ultrasonico, dell’influenza dalla granulometria dell’inerte, del dosaggio e del tipo di
cemento e dell’eventuale additivo utilizzato per il getto del calcestruzzo;
- riduzione, rispetto al solo metodo sclerometrico, dell’importanza delle variazioni di qualità tra strati superficiali e strati
profondi del calcestruzzo.
- La lunghezza del percorso compiuto dalle onde in
presenza di fessure (semplice considerazione
geometrica) è: fg � 2 ∗ h� � "�.
- Il tempo di percorrenza delle onde nel calcestruzzo
fessurato è: ,g ��
7∗ h� � "�.
- Il tempo di percorrenza delle onde nel calcestruzzo
non fessurato è: ,g ��
7∗ h.
Con 1 = velocità di propagazione longitudinale delle onde;
la profondità della fessura, quindi, è: " � h ∗ij
�
ik� 3 1 .
PROVE SONICHE E COMBINATE (SONREB) – UNI EN 583-1,
UNI EN 12504-4 Ing. Alessandro Battisti
La prova si esegue determinando per ciascuna area di verifica
due coppie di valori:
- 12 �velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici.
- m � indice di rimbalzo dello sclerometro .
Una delle curve di correlazione analitica che è possibile
utilizzare (raccomandazione Rilem) è:
- �n � 7,695 ∗ 10=// ∗ m/,@ ∗ 12�,>
La precisione della stima è di circa il 15%. In alternativa è
spesso utilizzata anche la relazione:
- �n � 1,20 ∗ 10=p ∗ m/,e;? ∗ 12�,@>
con 12 espresso in�
'. I valori medi dei due parametri
vengono valutati su almeno 3 misurazioni dirette di velocità
di propagazione e almeno 9-10 misurazioni dell’indice di
rimbalzo.
PROVE PACOMETRICHE – BS 1881:2004
Attraverso il principio dell’induzione magnetica il pacometro consente con semplicità e
relativa precisione l’individuazione all’interno di un manufatto della posizione, del diametro e
della distanza dalla superficie (copriferro) delle barre di armatura e delle staffe. Si compone
di una sonda emettitrice di campo magnetico e di una unità di elaborazione grafica e sonora.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE PACOMETRICHE – BS 1881:2004Ing. Alessandro Battisti
NORMATIVA: le indagini pacometriche (o pachometriche) sono governate dalle normative BS 1881:2004
TIPOLOGIA DI PROVA, MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE: Lo scopo della prova è quello di determinare la posizione
delle barre d’armatura, lo spessore del copriferro e, con buona approssimazione, il diametro dei ferri, facendo scorrere sulla
superficie del manufatto una sonda emettitrice di campo magnetico, collegata ad un’unità di acquisizione ed elaborazione
digitale, munita di display grafico ed emettitore sonoro;
E’ una prova utile, se non indispensabile, come propedeutica all’esecuzione di tutta un’altra serie di indagini ND in cui la
presenza delle barre d’armatura deve essere ben definita e tracciata come, ad esempio, i prelievi di carote, le prove di pull
out e pull-off, le indagini microsismiche, quelle sclerometriche etc.
L’esecuzione della prova segue una ben chiara procedura:
- posizionare la sonda con l’asse longitudinale parallelo alla presunta direzione principale delle barre;
- muovere strisciando la sonda in direzione trasversale rispetto a quella principale presunta della barra indagata per
verificare se effettivamente essa è quella corretta; in caso affermativo continuare con il medesimo movimento sino a
quando il segnale sonoro (che aumenta o diminuisce di intensità a seconda se ci si avvicina o ci si allontana dal centro
del ferro) raggiunge l’apice; a questa condizione corrisponderà anche, graficamente, il massimo allungamento della
barra di potenza del segnale elettromagnetico;
- usando le manopole di regolazione del segnale acustico confermare la posizione e tracciare quindi con l’apposito gesso
la direzione della barra d’armatura; a questo punto sul display è possibile leggere (in prima approssimazione) i valori
stimati dallo strumento per il copriferro e per il diametro del tondino;
- ripetere la procedura per ciascuna barra d’armatura da indagare;
- altre procedure più sofisticate e gestite via software consentono poi di meglio caratterizzare il copriferro o il diametro
della barra.
PROVE DI MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO -
Si ricorre a questa prova per la valutazione delle caratteristiche di deformabilità e resistenza
delle murature di diversa natura (blocchi squadrati, pietra, mattoni etc.); usualmente con un
singolo martinetto si ricava lo stato tensionale esistente nella sezione di prova mentre con
due martinetti si ricostruisce il legame carico-deformazione, il modulo elastico ed il carico di
prima formazione delle fessure.
Ing. Alessandro Battisti
PROVE DI MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO – ASTM
C1196 – C1197 Ing. Alessandro Battisti
NORMATIVA: per l’esecuzione di prove di martinetto piatto singolo e doppio si può fare riferimento alle indicazioni ASTM
C1196 e C1197 (American Society for Testing materials).
TIPOLOGIA DI PROVA E FINALITA’: assieme alle prove microsismiche (soniche ed ultrasoniche) ed in particolare alla
tomografia sonica, alle indagini radar ed alle termografiche, le prove di martinetto piatto singolo e doppio sono le più
utilizzate per la determinazione dello stato di sollecitazione a compressione esistente su una porzione di muratura
(martinetto singolo) o del modulo elastico, delle caratteristiche di deformazione e della resistenza di rottura o prima
fessurazione della muratura stessa (martinetto doppio).
Lo stato tensionale in essere ricavato con la prova di martinetto singolo, confrontato con quello ultimo ricavato dalla prova
con martinetto doppio o da altre prove di laboratorio consente di valutare il «grado di sfruttamento» della muratura.
MODALITA’ ED AVVERTENZE ESECUTIVE:
Prova di martinetto piatto singolo: per prima cosa si
libera dall’intonaco una porzione di muratura delle
dimensioni di circa 100 x 100 cm; si posizionano quindi
sei mire di misura simmetriche rispetto alla sezione di
taglio preventivamente individuata; si misura con un
deformometro di precisione la distanza verticale esatta
tra ciascuna coppia di mire; si procede al taglio con
rototroncatrice asimmetrica ad anello diamantato; si
inserisce il martinetto nella fessura praticata e si collega
alla pompa idraulica dotata di manometri.
PROVE DI MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO – ASTM
C1196 – C1197 Ing. Alessandro Battisti
Si incrementa quindi la pressione secondo step regolari di 1 bar attendendo sino alla stabilizzazione delle deformazioni
prima di passare allo step successivo; quando le deformazioni sotto l’esercizio del martinetto si annullano ovvero le letture
rilevate con il deformometro sono identiche a quelle presenti prima del taglio, si registra la pressione del martinetto.
Questa è la pressione in esercizio per quella muratura, a meno di una costante che tiene conto del rapporto tra l’area del
taglio e quella del martinetto; la tensione media è quindi calcolato con la relazione: q � rs ∗ rt ∗ u dove:
- 6v �vwxv�vwA#$xAAy
vwxvAvKz#y;
- 6� � ��{`�^`�����``��]{`]��_]�]�{�|^���`]^�``� 0,85 } 0,95 ;
- � � ���{{]�^�_�[���`]^�``�&~��(;
Prova di martinetto piatto doppio: allo scopo di
determinare le caratteristiche di deformazione della
muratura si pratica un secondo taglio parallelo al primo,
ad una distanza solitamente inferiore ai 50 cm, e vi si
introduce un secondo martinetto piatto, identico al
primo; si isola allora parzialmente un concio di muratura
in condizione di compressione monoassiale.
Con le dovute cautele si procede quindi, attraverso cicli di
carico scarico al progressivo incremento della pressione
nei martinetti, sino al raggiungimento del limite di rottura
del concio (detto anche limite di prima fessurazione); si
costruisce cioè la curva carico-deformazione
rappresentativa della muratura in quel punto.
PROVE DI MARTINETTO PIATTO SINGOLO E DOPPIO – ASTM
C1196 – C1197 Ing. Alessandro Battisti
La pressione effettivamente applicata
sul concio di muratura, quindi, è:
q ��t
��
∗ rt ∗ u
dove:
- �� � area del martinetto;
- �A � media delle due aree di taglio;
- 6� � media delle costanti di
taratura dei due martinetti;
- � � pressione registrata dal
manometro;
Il valore del modulo elastico è allora:
B � q
��
con �I � deformazione verticale in
prossimità dell’asse centrale del concio.
Essendo il provino di muratura in realtà vincolato su tre lati è importante tener presente che la prova di martinetto piatto,
normalmente, tende a sovradimensionare i risultati che si ottengono proprio a causa dell’effetto collaborante della
muratura circostante e della non uniformità nella distribuzione della pressione nei martinetti, per mancata aderenza.
ULTERIORI PROVE NON DISTRUTTIV O SEMIDISTRUTTIVE Ing. Alessandro Battisti
PROVA DI PULL OFF: serve ad identificare la forza di adesione tra materiali diversi (intonaci, resine,
malte, vernici) ed un supporto attraverso l’individuazione del carico di rottura per trazione di tasselli
(detti dolly) incollati alla superficie; il macchinario utilizzato è un estrattore idraulico munito di
dinamometro con possibilità di memorizzazione della forza corrispondente al momento del
cedimento dell’insieme; il tipo di frattura deve essere accuratamente valutato.
INDAGINE ENDOSCOPICA: si può classificare come indagine microinvasiva in quanto con un semplice
e piccolo foro eseguito con un trapano a punta svasata (e quindi un intervento minimale e non
distruttivo) consente di classificare la tipologia, stratigrafia, consistenza e natura del materiale che
costituisce la struttura indagata, attraverso visualizzazione digitale immediata ed eventuale
restituzione di documentazione fotografica o video.
PROVA DI PENETRAZIONE CON SONDA WINDSOR: lo scopo dello strumento è simile a quello dello
sclerometro ovvero serve a determinare la resistenza del calcestruzzo indurito in funzione dell’inerte
e della resistenza alla penetrazione di una sonda in acciaio «sparata» per circa 4 cm. nel manufatto
con spinta balistica; la resistenza media a compressione si legge quindi su una curva di correlazione
in funzione della lunghezza media di penetrazione e della durezza superficiale.
ANALISI DELLA PROFONDITA’ DI CARBONATAZIONE: serve per determinare la profondità di
carbonatazione di un elemento in calcestruzzo e si esegue prelevandone un campione (usualmente
attraverso carotaggio o microcarotaggio) e, immediatamente dopo, nebulizzando sulla superficie
laterale fenoftaleina con soluzione all’1% di alcool etilico che reagisce colorando di rosso la parte
NON carbonatata; quella carbonatata, superficialmente più dura, rimane di colore inalterato.
ULTERIORI PROVE NON DISTRUTTIV O SEMIDISTRUTTIVE Ing. Alessandro Battisti
MISURA DEL POTENZIALE DI CORROSIONE: si tratta di eseguire una mappatura di potenziale
attraverso un sistema elettrochimico al fine di valutare lo stato di corrosione delle armature; lo
strumento è un pacometro cui viene collegato un elettrodo di riferimento che viene appoggiato sulla
superficie del calcestruzzo. L’estensione e l’intensità del fenomeno corrosivo viene correlata alla
diminuzione dell’alcalinità del calcestruzzo dovuta a carbonatazione o sostanze aggressive.
STRAIN-GAUGES E LO STATO TENSIONALE: scopo della prova è verificare lo stato tensionale di
elementi sottoposti a stress (metalli, calcestruzzi etc.) attraverso l’installazione di estensimetri micro
elettrici la cui variazione di resistenza consente di valutare l’entità dell’allungamento; l’allungamento
moltiplicato per il modulo elastico del materiale costituente consente di calcolare la tensione lungo la
direzione di applicazione considerata.
ANALISI CON GEORADAR: è una sorta di «ecografia» dell’oggetto indagato, non invasiva e neutra
rispetto ai materiali, eseguita attraverso l’emissione di un impulso elettromagnetico da parte di un
antenna emettitrice e la ricezione dello stesso «riflesso» dal target presente nel manufatto, quando
differente dal materiale omogeneo in cui è immerso.
MONITORAGGI FESSURIMETRICI O INCLINOMETRICI: sono fondamentali e pressochè insostituibili nei
casi in cui siano presenti cinematismi in atto con potenziale progressione del fenomeno nel tempo; si
monitorano quadri fessurativi, inclinazioni, vibrazioni etc. attraverso il posizionamento di sensori
potenziometrici collegati a data-logger che registrano i dati misurati e li trasmettono ad una
centralina generale; normalmente il sistema è gestibile in remoto.
ULTERIORI PROVE NON DISTRUTTIV O SEMIDISTRUTTIVE Ing. Alessandro Battisti
LASER SCANNER: nato per la ricostruzione digitale in 3D di manufatti ed oggetti di varia natura, nel
campo della diagnostica non distruttiva, grazie alla precisione delle sue restituzioni grafiche, può
talvolta essere utilizzato per il monitoraggio di dissesti con particolare riferimento all’evoluzione nel
tempo dei cinematismi; produce files digitali contenenti insiemi di punti ciascuno caratterizzato dalle
proprie coordinate spaziali in modo da essere rappresentato in un sistema CAD.
DETERMINAZIONE MODULO ELASTICO DEL LEGNO CON PILODYN: scopo della prova è la
determinazione del più probabile modulo elastico locale del legno indagato in funzione di specifiche
correlazioni con la profondità di penetrazione di un punzone che viene «sparato» nell’elemento; il
Pilodyn è appoggiato sulla superficie legnosa e infligge un chiodo calibrato; la misurazione può essere
influenzata anche in modo sensibile dalle condizioni locali del legno, in prossimità della superficie.
Grazie per l’attenzione.Alessandro Battisti