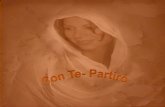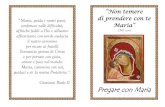"Con te"
-
Upload
ripensandoci-edita -
Category
Documents
-
view
231 -
download
0
description
Transcript of "Con te"
Con testorie di aiuto del Salento
silvia cazzatoleda cesarifotografie
salvatore bellol’acquerello in copertina è di
marco bernardini
la poesia Continenti a pagina cinque è distefania portaccio
le immagini del preambolo sono difrancesca speranza
l’immagine scattata al microscopio elettronicodi pagina centottantatre è di
teresa pellegrino
progetto grafico e impaginazione
laboratorio pubblicitario
www.studiop.biz
si ringrazia
realizzato grazie a
finito di stampare nel mese di novembre 2008
editavia g. argento 5 - Leccetel./fax 0832 [email protected]
Continenti. Noi. La spada dei montiche ci taglia e fermale nubi a quell’ora sempre e nello stesso puntoil ghiacciaio che nutre le vallatesovrabbondanza e giù nel sud miseriadi pietraie e mai che si riescama speriamo che ci venga un’idea. Una novità
Sbarcarelungo la pelle lucida d’un %umeinoltrarsi per stelle e congetturemappe d’ipotesi e di odori
Sbarchi in me da lontano e arrivi incognitoio approdo con barche colme e non so nienteanni di esplorazioni inganni estasi
Così ci conosciamo veniamo uno nell'altroviolandoci lasciandoci deluderecambiamo
La poesia della pagina precedente, Continenti, è di Stefania Portaccio.
Nata a Lecce nel 1957,vive a Roma.Ha vinto nel 1986 il Premio Montaleper la sezione inediti.Sue poesie e raccontisono apparsi su diverse riviste.Ha pubblicato Contraria Pentecoste,nel 1996, e Continenti, nel 2007.
Siedo, per stilare la premessa di questo lavoro, da-vanti ad un bicchiere di vino rosso. È un bicchieredi vetro spesso, perché il vino è salentino, fatto arti-gianalmente.Cerco sempre di accordare il bicchiere con ciò che
vado a bere.:-)Vane sovrastrutture culturali che talvolta ci capita di
assecondare, quando non siamo schiacciati da più seriproblemi di sopravvivenza.:-)
Questo vino mi è stato regalato da un collega dilavoro, Sebastiano, persona eccezionale, quandosono andata a trovarlo nella sua casa di campagna.Lo produce lui.Per hobby.Ma il vino è buonissimo. Meglio, molto meglio di
tanto altro messo in commercio.
Sarà che non vado da molto in case di campagna,dove il tempo scorre lento, dove il fare segue il ritmodella natura. Si sa com’è, in campagna. Tutto è piùnaturale.
Anche se più di qualcuno, oggi, riesce persino astressarsi per tanta natura, se preferisce vivere il“come è bella la città, come è grande la città”.Sarà che non vado più molto spesso dagli amici
che vivono nel Capo, per cui era da tanto che nonricevevo in dono, al momento del commiato, i ge-nuini frutti della terra.
Ricordo, da piccola, quando con la mia famigliaandavamo a trovare le persone in campagna. Acca-deva sempre che lasciando quei luoghi, pianura,mare o montagna che fosse, ricevessimo frutta, ovino, o pesce, o olio, o funghi, o qualsiasi bene ali-mentare prodotto dal luogo che quelle ospitali per-sone abitavano con armoniosa serenità.
Accadeva anche che i frutti, ad esempio, venisseroraccolti mentre noi eravamo là in visita. I migliorifrutti, venivano scelti.Con calma, sempre con estrema calma. E con
tutta la cura del mondo.Mi ricordo che da piccola questa cosa accadeva
di frequente, e che il loro offrire, a fronte di tantanostra insistenza per non prendere, lasciava sem-pre nel cuore un’eco duratura di gratitudine e appa-gamento.Ancora oggi, ora, mentre ne scrivo, riecheggia in
me quella piacevole sensazione.
A guardare in modo un po’ più approfondito,con l’occhio attuale dei quaranta anni trascorsi,
direi che quel gesto generava in me la gioia che dàl’essere accuditi, abbracciati, coccolati.Era una condivisione, oltretutto, che mi dava un
senso di sicurezza; la sicurezza che dunque, in que-sto mondo, c’era qualcun altro disposto ad aiutarmi,alla bisogna.Ecco, direi che quel dono mi faceva sentire, a di-
spetto del mio congenito percepirmi sola sul cuordella terra, in compagnia.
Non si era soli, dunque, come in fondo io sentivodi essere. Perché così, senza aver dato nulla in cam-bio, per il solo fatto di esistere e di essere apparsa invisita all’altrui orizzonte, ero stata amorevolmenteaccolta. Oltretutto era stato condiviso con me unbene materiale, un bene che chi offriva avrebbe po-tuto invece tenere per sé, egoisticamente.Si trattava dunque di un segno tangibile di amore
gratuito.Non credo fossero bruscolini.
Tutti questi episodi di ospitalità altruista accade-vano, durante la mia infanzia, nel Salento, quandovenivo in villeggiatura, e in Piemonte, con la gentesemplice che abitava la collina o la montagna.Assai di più in montagna che in collina, in effetti.
L’altitudine sembrava proporzionale alla generosità.Perché forse, vivendo in zone più impervie, nellequali il sopravvivere è più difficoltoso, aiutarsi di-ventava più naturale.Forse, ho pensato.
Parallelamente, invece, la vita nellamia città natale,Torino, mi avrebbe fornito esempi di segno opposto.A Torino, nell’algida Torino, ricordo una vicina di
casa alla quale, verso l’ora di pranzo, trillò il citofono.Era la sorella, che normalmente abitava a molti chi-lometri di distanza, capitata in città in maniera im-prevista; questa sorella aveva pensato di attenderedalla mia vicina le cinque ore che la separavano daun treno successivo.Una sorella che la mia vicina non vedeva da quasi
un anno, peraltro.- Chi è?- Sono Anna.Dopo un lungo, secondome eterno, attimo di esita-
zione, la vicina di casa, invece di un “Anna, che sor-presa!”, invece di un “Anna, sali!”, invece di un “Anna,che gioia che tu sia qui!”, proferisce un incerto:- Anna… Anna… sei qui? Perché non mi hai av-
visata che venivi? Non ho preparato nulla per pran-zo…La risposta di Anna, d’altro canto, allineata con la
calorosa accoglienza, è stata:- No, no, Laura, non ti preoccupare. Sono solo di
passaggio, ho già mangiato in stazione. Sono pas-sata solo per salutarti e poi riparto alle sei.- Ah…Ma sali, dài!Lascio all’immaginazione del lettore la scelta dei
toni. Io ne rimasi strabiliata.
Sempre a Torino, in quella Torino snob che maiho sentito mia, mio padre, che era costruttore edile,un bel giorno, facendo un giro in alcuni stabili, notòche una vecchina viveva in un monolocale senzaporta. Da anni. Nessuno l’aveva mai aiutata. Daanni, senza porta.Da restare nuovamente esterrefatti.Papà, zitto zitto, nell’anonimato, mandò gli operai
a metterle una porta. Giunse così, in quel palazzo
di ghiaccio, una ventata di calore umano.Sbalorditivo.
Certamente, ripercorrendo la propria storia, cia-scuno può pescare esempi diversi, di gente che hadato e di gente che non ha dato.E ciascuno, guardando in sé stesso, può leggere le
ragioni che si dà per giustificare un proprio dare oun proprio non dare.
Sempre mi chiedo, non riesco proprio a fermarmiin superficie, quali siano le ragioni profonde del no-stro agire, quali le matrici di pensiero, comuni a tuttinoi esseri umani, che si compongono, come in ma-gici caleidoscopi, e danno vita al nostro essere unici.E nel chiedermi come ciò accade intravedo correnti,flussi energetici, forze centrifughe e centripete cheimpastano il nostro vivere, composti come siamo dagranelli multicolori di esperienze di vita, di impulsiviscerali, di modelli interiorizzati, di cattivi maestririfiutati, di principi ancestrali, di male e di bene.Oscillano, il mio pensiero e il mio sentire, tra la
superba tendenza a cercare di voler capire le cose el’umile capacità di accettarne il mistero. Oscillano esi fermano, come sospesi fuori dallo spazio e daltempo, dinanzi al fatto che tutto è, non v’è dubbio,anche indipendentemente dal mio occhio. Tutto è,malgrado me, in pratica. E purtuttavia anche iosono, non v’è dubbio. Anche io sono, io “sento” di es-sere, al di là delle contingenze, malgrado si tenti co-stantemente di metterlo in dubbio relegando lapercezione del sé a qualcosa di meramente materialee finito, scomparso il quale scomparirà anche l’illu-sione dell’esistere e dell’essere esistiti.In realtà, ben lo sappiamo, chi mai su questa terra
potrà dirci tutto ciò? Chi mai potrà sorgere, diumano, da un anteriore passato o da un futuro re-moto, a chiarirci una volta per tutte come stanno ve-ramente le cose? Chi potrà mai possedere, di umano,così tanta consapevolezza da darci soluzioni, da ac-quietare il travagliato dilemma esistenziale che ciportiamo dentro?Chi potrà essere costui? Non è forse più verosimile
che frammenti di verità, di comprensione, affiorinoqua e là, in esseri umani, stavolta sì, sparsi nei luo-ghi e nei secoli, come fugaci barlumi che ci indicanola strada? Non sta, magari, accadendo a noi tuttiproprio qualcosa del genere?
E poi in definitiva, tra l’altro, a che ci serve voler sa-pere tutto ciò, se tanto la partita di cui sopra scorre co-munque incessantemente e ci pone giorno per giornointerrogativi concreti, dimensioni da esperire mate-rialmente, verità da afferrare col cuore, prima che conla ragione?Si può piuttosto, questo sì sembra aver maggior
senso fare, lavorare al raggiungimento di un’armo-nia, di un’elevazione dell’individuo, di un luogoideale dove l’amore diventa una nuova regola delgioco.Si può, siamo liberi come l’aria. Si può, siamo noi
che facciam la storia.Cantava, a un certo punto, in un certo luogo, un
certo Giorgio Gaber.
Siamo chiamati, io come tutti, a giocare dunquequesta benedetta partita della vita, a muovere unalfiere piuttosto che una torre, a scegliere un arroccoinvece di voler dare scacco. Liberi, siamo. Siamosempre lasciati liberi di decidere il da farsi.
E questo vorrà pur dire qualcosa, penso.
Ricordo che, un giorno, una persona mai cono-sciuta mi ha scritto che viveva per “realizzare la vo-lontà”. Una riflessione sul senso che dava allapropria esistenza che mi colpì molto, in relazioneanche alla persona che era, o che mi è sembrato chefosse.Perché, in effetti, a ben pensarci, questa è la prin-
cipale regola del gioco, non v’è dubbio.Su come il gioco possa venir giocato, poi, su quello
proprio si può aprire il dibattito.
Uno sceglie. Uno è sempre libero di diventareAmma Amritanandamayi oppure Hitler. Uno puòdiventare sant’Ignazio da Loyola o Richard Ku-klinski. Questa possibilità di essere chi si vuole èdata a tutti. Ma forse una cosa bisogna ammet-tere: che, non volendo dar credito allo Scialpi checi rammentava (grazie comunque) di essere isolenell’oceano della solitudine, il creare una rete tra lepersone, il darsi una mano, il “fare sistema”, comesi ama dire oggi, è una mossa assai intelligente,per degli esseri umani che non si credano delle di-vinità.
L’aiutare, l’aiutarsi, diventa un sistema per far cir-colare il meglio di cui siamo composti. Aiutarsi si-gnifica andare in una direzione benefica, positiva,arricchente, per sé e per gli altri.Aiutarsi potrebbe, dico potrebbe, se visto in que-
st’ottica, tradurre addirittura parte consistente delsenso del nostro esistere.Converrete.Ma, magari, aiutarsi in maniera ampia, estesa,
universale. Aiutare la propria famiglia, i propri si-mili, forse ci viene più naturale. Ma aiutare anche“altri”, questa è un’altra delle sfide percorribili.Io non posso credere che si aiuti in base a una con-
sanguineità. Non posso pensare che solo se qualcunoè mio parente sia affar mio, e degli estranei chisse-neimporta.Ma come? Non ci si aiuta in relazione al bisogno?
Non è, il bisogno, un buon metro per regolare ilflusso del soccorso? Non ci balzano agli occhi le ne-cessità di un essere umano in sofferenza estrema, in-dipendentemente da dove si trovi o dal nostro gradodi parentela con lui?Gli occhi contornati di mosche di un bimbo afri-
cano denutrito, dunque, davvero ci lasciano indiffe-renti, in quanto non si tratta di un nostro parente?
Davvero?
Quando, una mattina, mi è balenata in mentel’idea di innescare un dibattito sul tema del dare,partendo da questo libro, ma continuando con in-contri, confronti, conversazioni, mi sono posta ilproblema del come realizzare concretamente tuttociò. Bisognava trovare una persona che ci desse unamano, dunque. E ho scritto una lettera al dottor Pa-
ride De Masi, non tanto per la notorietà oggettivadel marchio Italgest, quanto perché mi era stato in-dicato come una persona con la sensibilità giusta percondividere il mio ragionamento sul dare.Per aderire al principio di base sul quale questo
libro prende forma, bisogna avere una mentalitàparticolare, credere nella squadra, credere nel valoredell’aiuto, credere che il progresso del singolo contri-buisca al progresso di tutti. E viceversa.La risposta di Italgest è stata immediata. Un sì.E i singoli passaggi, come il devolvere parte dell’in-
casso delle vendite del volume a un centro per bambiniabusati e maltrattati, come il creare momenti di di-battito nelle diverse realtà che operano in termini diaiuto al prossimo, come il cercare il confronto con lepersone in un dialogo che fosse più intenso e profondodi quello che si intraprende di solito nelle pause dellafrenesia quotidiana, sono stati condivisi e promossi daItalgest, come coerente espressione di un agire azien-dale che si muove, che sceglie di muoversi sui difficilibinari dell’agire etico. Sui binari in fondo molto sem-plici, ma chissà perché al contempo tanto difficili, deldare una mano.Non sto sviolinando lo sponsor, non è nelle mie
corde. Sto parlando di come ci si aiuta concreta-mente tra esseri umani.Questo libro è il primo faro, acceso grazie a Ital-
gest, sull’argomento.Questo dibattito, poi, continuerà anche all’interno
dell’Università, perché il professor Carlo Alberto Au-gieri, di Teoria della Letterautra, ha deciso di partireda ciò che si dice in questo libro per avviare un se-minario sul tema del dare.E così via, verso altre occasioni di dialogo che vi
comunicheremo volta per volta.
Vorrei però, prima di lasciarvi alle narrazioni cheseguiranno, dire due parole sul perché si devolve ilricavato delle vendite del libro al Centro per Bam-bini Abusati e Maltrattati della Comunità Emma-nuel, “L’Aurora”.È estremamente semplice.Un adulto, una persona che già oggi è adulta, può
decidere di aiutare o di non farlo. L’abbiamo giàdetto.Ma quando decide di non farlo, perché ciò accade?
Comemai, questa persona, non dà, a fronte di tantibenefici per il suo spirito che trarrebbe se decidessedi agire diversamente?
Forse perché non riesce. Forse non riesce perché èin credito. In credito di qualcosa. Forse è in creditodi amore. Forse, persino, qualcosa gli sarà stato pro-prio tolto, magari nella prima infanzia, forse anchedopo. Chissà. Ognuno sa il fatto proprio, logica-mente.Quello che si può immaginare, però, quello che si
può magari anche sapere sulla base dell’attenzioneche altri uomini hanno posto alle dinamiche di vitadi chi ha sofferto, è che chi subisce violenza da bam-bino, se non viene tempestivamente aiutato (e direi,possibilmente, anche amato), da adulto potrebbescegliere il male. Come rivalsa, come modo per darsfogo a una sofferenza inaudita, come meccanismoper gridare al mondo un dolore troppo intenso dareggere per un bambino che si è appena affacciatoalla vita.Sembra impossibile, io sul serio a tratti non mi ca-
pacito, che degli esseri umani possano infliggere similisofferenze ai cuccioli della propria specie. Sembradavvero impossibile. Invece l’infanzia spezzata esiste,
e forse andrebbe aiutata proprio per prima, per inter-rompere il meccanismo malefico che si potrebbe ge-nerare e che creerebbe adulti non più capaci di dare,ma solo, e con violenza, di togliere.
Bene, siamo forse scesi troppo in fondo, sento. Ri-saliamo sul pelo dell’acqua per una boccata d’arialeggera.Il bicchiere di vino di Sebastiano, intanto, è finito
e qui concludo questo preambolo, lasciandovi a os-servare ciò che segue, insieme a queste due rilassatesignore immerse in un bagno termale a Budapest.Volendo insistere sulle metafore, potrei dirvi che
questo libro è proprio come un bordo-piscina, sul
quale si potrebbe comodamente sostare limitandosia osservare, o piuttosto partire al salvataggio diqualche incerto nuotatore.Potrei.Ma quanto sono odiosi quelli che danno i suggeri-
menti. Nemmeno io li sopporto.
:-)
Buona lettura a tutti.
A presto.
Silvia Cazzato
Leda Cesari
Nata a Lecce nel 1966.Giornalista professionista,ama gli animali (soprattutto Ninni),le pietre (anche non preziose),la Grecia e il mondo classico (in testaMemorie di Adriano), i Rolling Stones,il Hrmamento (astronomico e astrologico).Frase-chiave, infatti, di Oscar Wilde,scrittore preferito:“Siamo tutti immersi nel fango,ma alcuni guardano le stelle”.
Se è vero che l’altruismo è la forma più raffinata diegoismo, beh, allora i signori di cui si parla nel ca-pitolo seguente sono molto, molto egoisti. Nel sensoche hanno intrapreso da tempo una strada imper-via e accidentata, la strada della solidarietà (comeci hanno fatto odiare questa parola, la politica e laburocrazia), facendone ragione e impegno precisodi vita. Impegno tanto più autentico in quanto pro-fuso in silenzio, al netto di grancasse mediatiche efanfare televisive. Impegno tanto più vero in quantotutti i protagonisti degli articoli che seguono hannochiesto espressamente di non personalizzare ecces-sivamente a loro favore le short stories, di dare ri-levanza all’attività del centro, della struttura e delteam da cui dipendono, dando ampio merito a su-periori e collaboratori. I cui nomi sono stati spessoomessi nel corso dell’intervista, ma per esclusivacolpa dell’autrice degli articoli, che ha dovuto sin-tetizzare e sfrondare il contenuto dei colloqui.
Qualcuno non usa mezzi termini: Infernet, lachiama sfottente, per significare la sua attitudine adare spazio a tutto ciò che di torbido esiste nel-l’animo umano. Nulla di più errato: perché il mezzoè neutro rispetto all’uso che se ne fa, e infatti lei, laRete, può anche essere formidabile mezzo di con-divisione e di lotta alla solitudine: quella che con-trassegna ad esempio chi soffre di anoressia,malattia ad alto tasso di isolamento. Anche Inter-net, insomma, può servire a dare qualcosa.
Già, l’anoressia, la bulimia. In fondo anche Il-degarda di Bingen infliggeva al proprio corpo ilmartirio supremo della fame e della scarnifica-zione, no? La differenza tra la mistica tedesca equelle che Mauro Marino definisce “le eroine delnostro tempo” sta forse nel fine, che comunque –Machiavelli o no – non sempre giustifica i mezzi,neppure se i mezzi sono quelli praticati dalle“spose di Cristo”. In soldoni, e per uscire dai giridi parole: è sempre un opporsi a qualcosa chenon si condivide, l’anoressia, un modo per dire:“Non sono d’accordo con te”; un’attitudine a sa-crificarsi perché un progetto, una speranza,un’idea vadano in porto. Non è insomma sol-tanto il desiderio eterno di sentirsi in linea con ilmodello estetico dominante, che può essere unodegli obiettivi da perseguire astenendosi dal cibo,non certo l’unico. Anoressia e bulimia, infatti,sono sempre la spia di un disagio più grande,
mani sorelle
contro cui fino a qualche tempo fa anche medicie psicologi potevano essere disarmati: certi tragicibilanci familiari sono lì a testimoniarlo.
Ma a volte bisogna fare i conti col potere tera-peutico della scrittura. E comincia l’avventura diMani sorelle – anzi, per essere precisi, lemaniso-relle.blogspot.com – “blog di disagi e sorrisi dellaboratorio di scrittura del Centro per la cura e laricerca sui disturbi del comportamento alimen-tare dell’Asl di Lecce”. Luogo virtuale dove i pa-zienti del suddetto centro trovano pane per i lorodenti. Non sarà una metafora felice, visto che didisturbi alimentari si parla, ma è proprio così: “Lascrittura è uno degli elementi alleati di una tera-pia”, spiega Mauro Marino, intellettuale e artistasalentino che ha scelto di fare qualcosa a benefi-cio del famoso “Prossimo”, del fantomatico “Altroda sé”, collaborando con il Centro diretto dalladottoressa Caterina Renna.
“Mezzo di autocoscienza del disagio”, la scrit-tura. Niente a che vedere con i famigerati Pro-Anae Pro-Mia, siti Internet chemagnificano la bellezzadi pesare 35 chili vestiti compresi o, al contrario,la piacevolezza di abbuffarsi per poi scappare inbagno e restituire alla terra quello che se n’è avuto,giusto mettendosi due dita in gola. “No, il nostroblog è un esperimento terapeutico, un modo perprovare a intercettare il disagio che sfugge ai ser-vizi pubblici. Queste persone, da noi, possonoavere uno scambio di idee e tanto sostegno”. E unapatente d’eroismo, insisteMarino: “Anoressia e bu-limia, alla fine, sono solo unmeccanismo che cercadi dare risposte, atti eroici che si contrappongonoalla presa di posizione dell’Altro: ‘Tu non capisci ilmio punto di vista’. Così resistere al cibo – vita e
dannazione insieme – diventa una forma di rap-presentazione del disagio’ Perché alla fine questoè, l’anoressia: una malattia ‘politica’, un volersi op-porre, un rifiutarsi di scendere a patti con qualcosache non si condivide. Oppure si decide di lasciarsitravolgere, come nel caso della bulimia, dove lasofferenza è anche maggiore perché ha le forme diuna tensione drammatica che avvolge chi nega epoi cede”.
Pazienti, abbiamo detto, e non è un dettaglio.Perché l’anoressia, contrariamente ai luoghi co-muni del caso, non è un disturbo tutto femminile:“Ultimamente abbiamo in cura anche molti ra-gazzi, peraltro giovanissimi – perché l’età mediadel disturbo si è abbassata – e anche bambini. Sì,prima causa di malessere è il modello estetico im-posto, che nei ragazzi si traduce anche in abuso dianabolizzanti. Però è solo una delle cause, e allafine, nel caso dei disturbi da bulimia, può essereanche un alleato della terapia”. Come il blog,luogo di sorellanza che supera i confini provin-ciali: contributi e commenti arrivano da Lecce,Brindisi e Taranto. Non male per un’esperienzanata per caso, grazie a un gruppo di pazienti par-ticolarmente creativi, e subito divenuta stru-mento che, linkato per caso su Internet, puòessere l’anticamera per il Centro e le sue terapie:“On line agganciamo persone che vivono il di-sturbo in perfetta solitudine. Così lemanisorellediventa un luogo in cui parlare della malattia ecapire che la propria storia è molto simile a tantealtre, un posto in cui costruire una coscienza chepermetta di attivare strategie di uscite dalla ma-lattia”. Un luogo da cui gestire anche le ricadute:“Non sono disturbi da ricchi, anoressia e bulimia,
come si potrebbe pensare, bensì patologie tra-sversali e interclassiste che diventano ossessione:affamarsi e, al contrario, abbuffarsi diventanol’unico pensiero”. Una delle cure, appunto, lascrittura, tramite il blog che Mauro Marino con-tinua pervicacemente a coltivare nonostante ledifficoltà: i rapporti con il pubblico, of course, cherende ovviamente tutto abbastanza difficile perchi lavora con contratti di collaborazione esterna.Ma se hai deciso di spenderti per una causa chemerita attenzione, non c’è Burosauro che tenga.Anche perché la presa in carico delle sorti di un
Altro si traduce immancabilmente in beneficioper il tuo, di disagio: “Dal confronto con l’altruisentire arrivano le risposte: se si è molto felici dif-ficilmente si decide di mettersi in gioco. Eccoperché dico che l’inquietudine non è sempre unfatto negativo. Ecco perché a volte trovi la tuapersonale via d’uscita facendo qualcosa per altrepersone: grazie al blog ho scoperto persone digrande talento che adesso scrivono di profes-sione, oppure cantano. E sapere di aver contri-buito a questo ti nutre molto, moltissimo”. E nonc’è anoressia che tenga.
No che non è proprio normale – nel senso diistintivo – mettersi accanto a un malato di cancroe accompagnarlo nel difficile viaggio verso il tra-passo: è una cosa che fa a pugni con l’istinto di so-pravvivenza, con la nostra illusione di essereimmortali, con la nostra voglia di rimuovere ciòche non è rimovibile, così si può fare al limite perun parente, non per uno sconosciuto. Eppure c’èchi questo coraggio ce l’ha, pur sapendo che ungiorno arriverà e troverà quel letto vuoto perché lamalattia l’ha avuta finalmente vinta. E spesso il co-raggio nasce dall’esperienza, dall’aver provato sullapropria pelle di figlio, marito, genitore di un ma-lato terminale cosa significhi assistere una personache sta morendo di cancro. Un nome e un co-gnome terribili, per una morte. Non abbastanza,però, per stroncare certi meccanismi. Per abbatterela voglia di fare qualcosa che porti in attivo le voci“dare-avere”.
Per questo un anno fa è nata “Il mantello di SanMartino”, denominazione non casualmente sim-bolica di un sodalizio fatto di gente che quell’espe-rienza l’ha conosciuta. EWalter Tornese, che nellavita “fuori” fa il cancelliere presso il Tribunale pe-nale di Lecce, “dentro” – nell’Hospice per malatiterminali presso l’ospedale di San Cesario – è ap-punto questo: il volontario di un’associazione chesi occupa di condannati a morte certa e immi-nente, i malati terminali: “siamo tutti parenti di
persone decedute per cancro, dunque gente checonosce bene quella realtà e sa come affrontarla.Eppure, pensi, nonostante questo siamo una strut-tura sconosciuta ai più, spesso anche ai medici. Oci scambiano per un ospizio, visto il nome, contutti i pregiudizi che ne conseguono”.
Una struttura che prende in carico persone conneoplasie talmente aggressive da non lasciarescampo. “Casi in cui il paziente non è neppure sta-zionario, e allora l’Hospice è la soluzione ideale, coni suoi dieci miniappartamenti che consentonoanche la presenza di un assistente fisso”. Letto perdegente e ospite, bagno completo, climatizzazione,impianto televisivo, “una struttura quasi texana”,spiega ancora Tornese. “Saremmo a cavallo se tuttele strutture fossero come questa, luoghi in cui ilmalato può usufruire di assistenza continua, giornoe notte, e di cure palliative”. Ovvero somministra-zione di farmaci che bloccano il dolore: “Mio padreè stato lì per un mese e mezzo, e mai un lamento,fino allamorte. Questo per la professionalità del re-sponsabile del centro, il dottor Enzo Caroprese –un medico vero – e dei suoi infermieri, personesplendide, che io chiamo angeli. Quello che civuole, pazienza e tanto amore, per persone desti-nate a non guarire”. I cui parenti, spesso, non hannoneanche i mezzi economici per prenotare il se-condo letto, nonostante il prezzo irrisorio (ottoeuro a notte). Ma certe esperienze segnano persempre, “e così, grazie alla recente donazione deiparenti e degli amici di una defunta”, raccontaWal-ter Tornese, “compreremo alcune poltrone-lettoper chi non può permettersi neppure quella spesa”.
Questo per ora: ché per il futuro Il mantellodi San Martino ha progetti assai più ambiziosi,
il mantello di san martino
tipo formare assistenti competenti e preparati.Perché tutto è, tranne che facile, assistere un ma-lato terminale. Così l’associazione, che fornisceperaltro anche emergenza domiciliare nonostantela scarsità di volontari (una quindicina in tutto,allo stato), spera di farsi conoscere quanto prima:“Uno dei nostri obiettivi è la divulgazione dellanostra attività, perché ci rendiamo conto di es-serci andati a cercare un segmento molto impe-gnativo, che comprende tanto la sofferenza di chista per affrontare l’ultimo passo della sua vita,quanto il dolore di chi non è pronto a accettareche un familiare se ne stia andando. Affrontandoal contempo il pregiudizio tutto meridionale cheaffidare un parente a una struttura del genereequivalga ad abbandonarlo”. L’assistenza, in que-sto caso, è anche psicologica, e serve anche dopo,“per la metabolizzazione del lutto”, spiega ancoraTornese, “mentre non riusciamo sempre a garan-tire quella spirituale, i sacerdoti sono sempre cosìimpegnati…. Ma proprio per questo è bello,
quello che facciamo, è una sfida: non ci limitiamoa raccogliere soldi per questa o quella causa,siamo in ballo direttamente e torniamo ogni voltaa casa felici per quanto fatto, e contemporanea-mente frustrati perché avremmo voluto fare dipiù”.
Ma anche più forti dentro: “Vorrei che anchegli altri malati terminali avessero la fortuna toc-cata a mio padre, che è morto tra le mie braccial’anno scorso, a mezzanotte di Capodanno. Infattipenso che il mio impegno con l’associazione siaun modo personalissimo di elaborare il lutto, chenon vuol dire dimenticare, ma soltanto fare iconti con una nuova realtà. Sono lì con gli altriper dare qualcosa, insomma, senza farmi vedere,senza riflettori: mi piace lavorare nell’ombra, perme cinque persone sono già una folla…”, con-clude Tornese. “Ciò detto, per collaborare con noidel Mantello di San Martino ci vuole poco. E lecose da fare, invece, sono tante”. Aspiranti volon-tari avvisati.
Tu puoi fare tutti i programmi che vuoi, con-vincerti di avere la tua vita nelle tue mani, pensaredi poterla modellare secondo le tue esigenze e ituoi desideri. Ma quando la Voce chiama, non puoitentennare. Non puoi dibatterti, non puoi sottrarti:puoi obbedire di buon grado e basta: “fino a un at-timo prima hai avuto la certezza di aver avuto dallavita tutto ciò che desideravi. Poi il senso di vuototi sommerge comunque, e parti alla ricerca di qual-cosa di più grande. Che per noi si chiama Gesù, ela scelta di metterlo al primo posto della nostravita”.
È stato così che la leccese Stefania Gualtieri e ilnapoletano Luigi d’Avolio, marito e moglie da ottoanni, si sono ritrovati in missione, neanche tantosupersegreta, in Ecuador, un oceano tra la casa dilamiera in cui vivono da cinque anni a questa parte,ad Esmeraldas, e il luogo da cui sono partiti, Co-munità Emmanuel, Lecce. Per fare in fondo quelloche Gesù aveva chiesto ai suoi: andate per il mondoe date il buon esempio. Anche adesso che alla squa-dra si è aggiunto il piccolo Salvatore Emanuele,frutto del loro amore nato a maggio di quest’anno,durante un segmento leccese della loro vita, epronto a prendere il prossimo aereo per l’AmericaLatina insieme a mamma e papà: il tassello chemancava, a ben vedere, al mosaico che Stefania eLuigi costruiscono ogni giorno tra le casette delquartiere povero in cui sono stati inviati dal ve-
scovo di Esmeraldas, “un religioso davvero dallaparte dei poveri e dei diseredati”.
Un luogo benedetto da Dio in fatto di natura,“pianti un seme in terra e nasce l’impossibile”, madegradato dal punto di vista umano. Un posto incui l’aggettivo “povero” non rappresenta soltantola definizione frettolosa di una persona che nonha mezzi di sussistenza: in America Latina, infatti,“la povertà è un dato che ha connotazioni anche esoprattutto morali”, spiegano i due coniugi inpausa maternità all’ex camping di Solicara, sullavia per Torre Chianca. Ovvero: famiglie sbricio-late, grande promiscuità sessuale, condizioni igie-niche allarmanti, precarietà professionale. Ancora:bambine che fanno figli a dodici anni (per poi la-sciarli crescere per strada), che non li allattano pernon sciuparsi il seno, che a vent’anni si fanno cu-cire le tube come metodo anticoncezionale. Geni-tori che, pur di garantire la festa dei diciott’annialle proprie figlie, si indebitano fino all’osso: “persfuggire alla miseria, diventano ancora più poveri”,è la testimonianza di Stefania e Luigi. Che entranoin azione proprio a questo punto: “noi propo-niamo un’alternativa a tutto questo. Come? Con ilnostro esempio”.
Sicché la casetta col tetto di lamiera nel letto delfiume, più che un’abitazione privata, è concepitaper rappresentare un luogo d’incontro; sicché l’uf-ficio di Stefania e Luigi, mandati ad Esmeraldasdalla Comunità Emmanuel a fondare una comu-nità cristiana di base, diventa solo ed esclusiva-mente la strada. E sono chilometri, tutti i giorni,fino a sera, per espletare al meglio le funzioni dicui sono stati incaricati: anche Gesù, alla fine, nonse ne stava a predicare nel tempio ma macinava
esmeraldas
strade, paesi, regioni. Qualcuno potrebbe definirlepubbliche relazioni, e il paragone, in fondo, non èazzardato, perché è proprio questo che fanno i dueconiugi partiti da Lecce cinque anni fa, pur avendoin principio immaginato altri percorsi esistenziali(lei il Ciad, lui il Sudamerica con i Comboniani):incontrano la gente di Esmeraldas, tentando dispiegare che unmodo di vivere diverso è possibile.“Che la fedeltà coniugale non è una iattura, cheuscire dalla precarietà si può”.
Praticamente: aiutando un gruppo di donnecon i mariti alcolizzati a dare vita a un laboratoriodi taglio e cucito, per esempio. Insegnando ai bam-bini che i bisticci non vanno risolti a pietrate. Di-mostrando ai genitori che i figli non si educanocon la frusta. Oppure mettendo in moto le istitu-zioni locali perché si mettano a disposizione di chivuole uscire dalla miseria. Oppure, ancora, for-mando volontari che si facciano carico delle sorti
del quartiere, oppure dichiarando guerra alla cor-ruzione: “siamo stati anche minacciati di morte,per questo, e non nascondiamo che adesso, col pic-colo al seguito, le difficoltà aumenteranno. Ci toc-cherà preservarlo dai pericoli in cui siamo abituatiad aggirarci: non andremo più a occupare la sedeministeriale, ad esempio. Ma questo non ci spa-venta più di tanto: la gente del quartiere cominciaa reagire positivamente ai nostri sforzi. Non cichiede più soldi ma, in compenso, sta imparandoa condividere la miseria, il piatto di riso, con chi èpiù povero. E nostro figlio sarà anche lui un pic-colo missionario, incaricato di testimoniare lagioia di una famiglia regolare, di una vita discipli-nata. E Gesù si prenderà cura di lui come si prendecura della nostra salvezza. Che bambino fortunatosarà, il nostro: avrà l’opportunità di fare un’espe-rienza umana eccezionale, e al contempo potrà im-parare lo spagnolo assieme all’italiano”.
Si è propensi a fare qualcosa per gli altri perchénella vita privata va tutto bene, dunque si ha la se-renità necessaria per distogliere lo sguardo da sé?O, al contrario, il privato è felice (per quanto questaparola identifichi uno stato d’animo precario e fug-gevole) perché la vita ti ricompensa per quello chesai dare agli altri? Saranno vere entrambe le cose,alla fine: hai una vita privata soddisfacente perchéla tua propensione all’Altro ti gratifica e rasserena,e – viceversa – il senso di gratitudine per l’avere unbilancio esistenziale decisamente in attivo ti mettein condizione di sentirti ricco, di capire che puoirinunciare a qualcosa per dare qualcosa al pros-simo.
Così la dottoressa Rossella Vigilante, mammadi splendide figlie, nonna di splendide bambine epedagogista con tesi sul “Significato del disagio in-fantile nella scuola moderna”, ha scelto il segmentodella schizofrenia grave per provare l’assunto chel’arte e la pittura possono essere decisivi per estrin-secare appieno il disagio, neutralizzandolo almenoin parte. Una novità, per lei? “In realtà sono sem-pre stata incline a occuparmi degli altri, a difen-dere il soggetto debole della situazione”, replical’interessata. “Anche quando facevo la professo-ressa di filosofia, riuscivo a ottenere la fiducia deiragazzi, che venivano a raccontarmi anche le cosepiù intime, sebbene fossi solo una supplente an-nuale. E i miei colleghi si chiedevano: ma perché
non si confidano con noi? Non avevo una risposta,probabilmente era un fatto naturale. Le persone sitrovano sempre a proprio agio con me”.
Capita, insomma. E così qualche anno fa è lacompagnia “Il mercato dei sogni”, progetto realiz-zato in tandem con l’associazione “Nuove spe-ranze”. Un percorso lungo, perché arrivasse aquesto Rossella, partita come insegnante di Filo-sofia e arrivata a Bari per formarsi e convergere sulprimo progetto-obiettivo per i centri diurni. “Ab-bandonando le supplenze, con un pizzico di inco-scienza”, racconta ancora Rossella, “ma questo miha consentito di crescere imparando certe cosegrazie al contatto diretto con il paziente… Perchéi libri sono altro, e le persone di cui mi occupo ionon hanno il tumore, non soffrono di unamalattiariscontrabile grazie agli esami clinici”. Pazienti chevivono in famiglia, e che il Csm invia ai centri dicui sopra per un inserimento graduale, e semprepiù radicato, nel tessuto sociale cosiddetto “nor-male”. E Rossella, operatore di collegamento tra icentri di Lequile e Campi, dà ogni giorno nuovosignificato a questa parola, “inserimento”, grazieall’arte-terapia: cabaret, teatro, mostre, laboratoridi espressione corporea per chi soffre di schizofre-nia grave, appunto. Finanziati dall’Europa, anche,oppure dalle Asl. Il che significa ovviamente anchetante occasioni di socializzazione: la pizzeria, lagita, la giornata al mare.
E i risultati si vedono tutti, s’intende: “spesso,quando arrivano al centro, i nostri pazienti sonoad autonomia zero: totalmente non-autosuffi-cienti. Pensi, una volta c’era un ragazzo che non sa-peva neppure cosa fossero i soldi. Non era maiuscito da casa, se non per andare in campagna”. Il
arteterapia
centro come luogo di ri-apprendimento insommadelle regole del gruppo, di riappropriazione deglistrumenti per affrontare la quotidianità. E nonsolo: grazie ai laboratori di espressione corporea,infatti, i pazienti possono riacquistare consapevo-lezza di sé e del proprio corpo, nozioni in qualchemodo “disturbate” dalla malattia. Perché schizo-frenici si diventa, “non si nasce: a volte basta untrauma per determinare l’insorgenza del disagio.Forse si deve essere predisposti, sì, però abbiamocasi di studenti universitari e di persone che lavo-rano normalmente e che a un certo punto si sono
ammalate”. Per fortuna, grazie all’arte e alla creati-vità, i progressi sono grandi, rassicura la dottoressaVigilante. E avvengono anche in virtù della colla-borazione delle famiglie, che non si nascondonodietro il velo dell’ipocrisia: “si mettono in discus-sione, sono orgogliose dei propri ragazzi e dei lorosforzi. E quando li vedono recitare sul palcosce-nico dei Teatini, o alla Notte Bianca, si commuo-vono”. Perché a questo serve “Il mercato dei sogni”,progetto-compagnia che cura gli schizofrenicigravi: “è un modo per dare un sogno a chi i sogninon ce l’ha…”.
Sono Quelli Che Non Guardano Mai L’Orolo-gio. A dispetto del daffare, che a volte rende invi-sibile anche la vecchietta abbandonata in un lettod’ospedale, implorante un sorso d’acqua nell’indif-ferenza generale. Compresa quella di un inser-viente che, dinanzi alla protesta di un medico,risponde serafico: “se mi metto a distribuire bic-chieri d’acqua, al mio lavoro chi ci pensa?”. Nor-male amministrazione in una corsia d’ospedale,probabilmente, ma capita anche che, una volta sucento, quell’atto di insensibilità sia il fertilizzantedi un terreno predisposto a dare molti frutti. Fucosì che, trent’anni fa, nacque a Milano l’Avo, As-sociazione volontari ospedalieri: perché il profes-sor Erminio Longhini, assistendo a quella scena,si convinse assieme a sua moglie della necessità diradunare uomini e donne di buona volontà e dimandarli per ospedali, a lenire sconforto e soffe-renze là dove ci sia da lenirne.
“Ed è esattamente quel che facciamo”, raccontala signora Titti Formoso, vicepresidente regionaledell’Avo Salento e presidente dell’Avo Lecce, in forzapresso l’ospedale “Fazzi”. Non che le due cariche lainorgogliscano più di tanto: “gerarchie stabilite soloperché la Puglia è lunga, e una suddivisione terri-toriale delle competenze era necessaria”, spiega. Epoi, capirai, finché ci fosse da distribuire onori eprebende. “Ti arricchisci sì, ma solo della straordi-naria esperienza umana che dare qualcosa agli altri
rappresenta. Per il resto lavoriamo e basta, autofi-nanziandoci. A volte combattendo anche contro ladiffidenza di chi pensa che tu voglia sostituirti alui. Rubargli il lavoro”. Perché anche far credere divoler fare qualcosa per il prossimo senza nullachiedere in cambio è difficile, di questi tempistrani.
E, come spesso capita, la molla che fa scattare ildesiderio di uscire da sé e dalle proprie incombenzepersonali, per attenuare anche solo per due oreoceani di solitudine e sofferenza, è un lutto grave:“fu unamia amica a convincermi, dopo lamorte dimio padre, insistendo che avevo la sensibilità giustaper fare volontariato. Sono sempre stata così. Percarità, non migliore degli altri, si intende: c’è chi fadi più e meglio di quel che facciamo noi dell’Avo.Ma l’importante è avere qualcosa da dare al pros-simo. Comunque”. Propensione a volte assente pro-prio in chi degli altri deve occuparsi per lavoro,capita di notare. Ma è un problema di compiti gra-vosi e di tempo mancante, taglia corto la signoraFormoso: “purtroppo il personale sanitario scar-seggia sempre di più e, per converso, ha sempre piùincombenze. Anche in fatto di documenti da com-pilare”.
Umanizzazione della Medicina, si chiama lanuova battaglia intrapresa dall’Avo oltre a quella,quotidiana, a favore di chi giace in un letto d’ospe-dale: quasi un controsenso, perché come definireMedicina quella che non ha comemissione princi-pale la cura fisica e psicologica delle sofferenze?Basta una parola di conforto, oppure un sorriso:vogliamo parlare del potere terapeutico di un sor-riso? “Il problema è che il personale sanitario, oltrea essere gravato di mille cose da fare, è a contatto
terapia d’amore
quotidiano con il dolore, che a lungo andare di-venta routine”. Quelle due ore settimanali di pre-senza garantita dai volontari Avo diventano alloraper gli ammalati manna dal cielo: “a volte all’iniziohanno paura, non riescono ad aprirsi con noi. Poi,però, cominciano ad aspettarci. Ed è un’attesa chenon possiamo deludere, anche se cerchiamo di evi-tare di instaurare rapporti affettivi troppo stretti,perché poi si devono interrompere e allora sonoguai”. Perché a volte l’ammalato è solo, pur inmezzo a una pletora di parenti e amici: “capita in-fatti che un paziente riesca a comunicare le proprieinsicurezze e le proprie paure più a noi che a unfamiliare, per evitare di rattristarlo”.
Formazione puntuale e completa in tutte le ma-terie sanitarie, grande predisposizione all’ascolto:“facciamo il turno in due, per non lasciare mail’ammalato scoperto, e non guardiamo mai l’oro-logio, altrimenti è finita, hai perso la sua fiducia.Per il resto facciamo di tutto, pur senza mai sosti-tuirci agli infermieri: laviamo il paziente, lo petti-niamo, lo sbarbiamo, lo rincuoriamo. E se peresempio non è cosciente gli parliamo, sperandoche senta. È una comunione di anime”, e funziona:eccome. “Una volta mi è capitato di assistere un ra-gazzo di Nardò ricoverato per un incidente in ria-nimazione. Stava benino, ma era terrorizzato: siguardava intorno, vedeva gli altri pazienti in coma,era sicuro di dover morire. Fu uno sforzo non daridere convincerlo che presto sarebbe tornato acasa”.
Grande pazienza, grande umanità: impegnonon indifferente, ma ne vale la pena: “cambia la tuavisione della vita, davanti a certe cose. Cominci apensare che i tuoi problemi siano nulla, a con-
fronto di certe tragedie”. Anche i problemi di so-stentamento di un’associazione che sopravvive gra-zie alle quote annuali versate dai soci: “i sacrificisono tanti, ma poi stare accanto agli ammalati tiripaga di tutto. Ti fa superare anche i momenti didifficoltà personale: cominci a capire i meccanismi
per uscire dal tuo guscio. E alla fine è un impegnoaccettabile: due ore alla settimana e non di più,perché è giusto avere la propria vita e i propri in-teressi. Dobbiamo andare a dare forza al paziente,a infondergli energia e ottimismo”, avverte la si-gnora Formoso, “altrimenti che senso ha?”.
Salvatore Bello
Nato a Presicce (Le) nel 1965.Dopo gli esordi in uno studio fotogra7cosi specializza in fotogra7a di reportage,culminata con l’esperienza degli sbarchidi migranti sulle coste salentine,dalla quale ha realizzato mostre a tema.Ha lavorato e lavora per L’Impaziente,Il Manifesto, Nuovo Quotidiano di Puglia,Qui Salento.Ha realizzato mostre fotogra7chesull’immigrazione e la mostra Salento FuoriOrario. Fotografo di scena per 7lme casting per spot pubblicitari.È iscritto all’Ordine dei Giornalistidi Puglia.
Dà, un bambino,gioia, sorrisi, carezze.Generatenerezza infinita,cieli di stelline,contagiosi stupori.
Lancia, un bambino,sguardi colorativerso piccole casettedai tetti di marzapane.
Fa, un bambino,mille faccine buffeper la prima, incredibile, assoluta volta.
È la prima volta che indossa un corpo, un bambino.
Vola, dunque, un bambino,farfallina impalpabile,tra i molti venti della terra.
Prego,prego forte forte forte,che tutti i bambini mai esistititra i fioritrovino riparo.
con sudoremanorespiro interrotto
per pocoper nienteper almeno dire paneper il sollievodel cuscino morbido
lavorerai
a prendere in giro la vitafingendo che il gioco sia serio
mamma - mamma - parte - bello - dove -lungo - lungo -ferma - parte - ferma - parte - ferma -stanco - lungo - voci -verde - pieno - sento -lungo -sonno - gente -basta - mare - noia -dico - nulla -lungo - naso - piede -stop
fissonella menteun ricordo senza bordi
l’istante di quell’aver sentito
un raggio di energiache trapassa la materiae di lei si serve
per segnare sull’animauna sensazione di infinito
solo un mare grandepuò scioglierela durezza delle scorzecreare assonanze con l’animausando il codice di chi non ha codici
Piegatala terraa servizio dell’uomo.
Ingegno.Congegno.Meraviglia.Stupore.
Sublime.Eccelso.Sommo.Mirabile.
Grandioso.Maestoso.Sontuoso.Solenne.
Eccellente.Divino.Celestiale.Sovrumano.
Quattro atomi messi in croce.
Sempre tristeil clownmi è sembrato
metafora struggentedel disincanto che non si rassegna.
Sempre triste.Fino a che non gli ho parlato.
Solo il conoscerlome lo ha rivelato.
Raggiungo.Raggiungo l’altrovicino a una fontanavicino ad un murettovicino ad un sentiero.Raggiungo.
Manciate di secondila mia vita.
Se lascio il vuoto intornoil vuotodentro mestraripa.
Raggiungo.
Preferisco.
Silvia Cazzato
Nata a Torino nel 1968.Giornalista,capo uVcio stampadell’Università del Salento,scrittrice, esperta di comunicazione,madre.Volontaria in diverse realtà,ha intrapreso il percorso di studiper diventare psicoterapeuta.
Megafoni, per non correre il rischio di prematureagiografie.
Le interviste che seguono sono solo unmezzo peramplificare voci di persone dal pensiero denso edall’agire deciso. Una disamina priva di griglie pre-stabilite, ma fluida, come fluido è lo scorrere/tra-scorrere delle esistenze, delle ragioni profonde percui si dà o si riceve.
Ogni persona incontrata rivela il mondo unico eirripetibile che la connota. Basterà ascoltare. E si di-segneranno nel cielo di chi legge le trame sottili checollegano il loro benefico fare. Si potrebbe scoprireche esistono radici comuni in chi opera del beneverso gli altri. Si potrebbe scoprire, ancora più inte-ressante, che cosa c’è dentro noi stessi, e in che cosanoi convergiamo o divergiamo rispetto al metterciin connessione con gli altri.
Si potrebbe.
Le foto che accompagnano la sezione sono par-ticolari dell’Istituto di Salute e Medicina Spirituale“Le Sorgenti”, che si trova sulla strada statale Lecce-Novoli. Un luogo nel quale si svolgono attività di ri-cerca e formazione socio-culturale, formazionespirituale e ricerca vocazionale, incontri, seminari,
convegni, approfondimenti su medicina e terapienaturali.
Di quel luogo sottolineerei due caratteristiche.Una è l’apertura verso chiunque. Una delle prime
stanze che accoglie il visitatore è la stanza del “puntointerrogativo”, di chi si pone in ricerca. Di chi decide,invece di galleggiare sulla vita, di andare più afondo. In questa prima stanza, circolare, non c’ènulla. Solo dei punti interrogativi sulle appliquesdella luce. Solo chi decide di entrare in quella stanzaavrà poi motivo di entrare nelle altre.
Una metafora efficace di un radicale cambio dirotta.
Seguono a questa stanza corridoi, altre stanze,icone e immagini simboliche che spingono alla ri-flessione sul senso dell’esistere, sul differenziarsi dellereligioni, sulla dimensione spirituale dell’uomo comeelemento di coesione culturale, capace di far entrarein dialogo ciascun portatore di differenze.
L’altra caratteristica è la semplicità dei luoghi.Pochi oggetti, nessun orpello. Perché la bellezza stanel togliere, non nell’aggiungere, come spiega il gesuitaMario Marafioti, ideatore del centro. Un ambientespoglio, ma che trasmette calore a chi vi transita,energia a chi vi sosta.
E c’è una caratteristica che riguarda i blocchi dipietra leccese di cui sono fatte le pareti, prive di in-tonaco: sono stati tagliati non dal cuore della cava,ma quando la cava è appena inaugurata. Per cuinon sono gialli in modo uniforme, ma striati, convenature rossastre e marroncine.
La conseguenza è che ogni pezzo è unico.Come unico è ogni uomo.
Buon viaggio a tutti.
Zoologo. Etologo. Comportamentista. Laureatoin Scienze Biologiche e in Scienze Naturali. Profes-sore di Zoologia all’Università del Salento. Respon-sabile del laboratorio di Zoogeografia e Faunisticadell’ateneo. Maree di articoli e volumi scientifici.Speleobiologo subacqueo. Ecoturista.
E ci fermiamo qui, per non dilungarci.Ma la cosa principale è che ha una fantastica
calligrafia. E che colleziona cucchiai di legno inta-gliati a mano.
Il tema centrale del libro è il dare. L’altruismo,latu sensu. Uno studioso quale tu sei potrebbe forsedirci se si tratta di una prerogativa solo umana.
Posso dirti che studiando altre situazioni nonnostre, ma simili alle nostre, capiamo di non esseresoli in questi atteggiamenti. D’altronde studiare lanatura, lo dico sempre ai miei studenti, significaavere occasione di elaborare delle riflessioni. C’èun entomologo, una specie di geniaccio della bio-logia recente, forse poco conosciuto nei salotti, chesi chiama Edward O. Wilson: questo è uno di quelliche fa il filosofo, essendo un naturalista, ed è quelloche ha tirato fuori la teoria della sociobiologia.Questa teoria afferma che la società, cioè il vivereinsieme, sia il massimo livello di evoluzione cheuna specie si può dare. Lui studia le formiche, stu-dia insetti sociali. E ci spiega che ci sono alcuni fe-nomeni molto trasversali tra gli esseri viventi. Non
siamo noi umani a presentare, in pratica, le cosepiù singolari, più spinte o più strane. Anzi. Nellecolonie dove gli organismi sono uno dentro l’altro,e quindi non si sa se l’individuo è l’uno o il com-plessivo, esiste addirittura l’annullamento dellapersonalità. Anche nelle società degli insetti l’in-dividuo ha poca importanza a favore del gruppo.
C’è poi uno studio fatto da grandi entomologidegli anni Settanta, lo studio del fenomeno del co-siddetto “altruismo in natura”, anche se non è da in-tendersi come il concetto di altruismo coniato perdescrivere un atteggiamento umano (lo chiariscoperché l’esistenza dell’altruismo è sempre stata unacritica all’evoluzione). Per dirla in breve: l’ape ope-raia, sterile, rinuncia alla propria discendenza a fa-vore della discendenza dell’ape regina. E quindi, sel’ape operaia è altruista, ha cioè il gene dell’altrui-smo (perché poi alla fine se parliamo di evoluzioneparliamo di genetica) e non ha una discendenza,ma si conserva solo la discendenza della regina chesi riproduce, come mai allora ricompare dopo unaltruista, se nessuno gli ha trasmesso ereditaria-mente questa caratteristica?
Come mai?In realtà si vide, e qui salta fuori un’altra rifles-
sione di un altro naturalista che diventa filosofo,Dobson, la teoria del gene egoista. Il principio se-condo il quale noi non siamo individui, ma è ilnostro patrimonio genetico che ci determina. Nelcaso delle api assistiamo a un fenomeno, ad esem-pio, che se una persona non fa lo zoologo, il natu-ralista, non può nemmeno immaginare: i maschisono aploidi, perché le femmine per partenoge-nesi, quindi senza fecondazione, riescono a dare al
genuario belmonte
mondo dei figli maschi. Da noi sarebbe un mira-colo, lo stesso su cui si fonda tutta la cristianità, perle api è la norma. Accade dunque che le femminedelle api non fecondate fanno nascere un maschioaploide, che non ha i cromosomi del padre e dellamadre, ma solo quelli della madre; per cui, quandoquesto maschio produrrà i suoi gameti per fecon-dare le uova, fornirà a tutti un gamente identico,perché non farà ricombinazione. Cioè, in unaploide non accade la meiosi, ma semplicementela mitosi, cioè una clonazione, una riproduzioneasessuata delle cellule. Non c’è ricombinazione, percui tutte le cellule sono uguali, tutti i gameti sonouguali. Non è come nel caso dell’uomo, in cuiavremo almeno metà di gameti in cui c’è la x emetà di gameti in cui c’è la y. Lì son tutti uguali.È la madre invece, o meglio, la moglie di questomaschio che metterà a disposizione delle uova incui è avvenuta la meiosi, dunque la ricombina-zione. Cosa accade a questo punto? Che le fem-mine che nascono dalle uova fecondate (da cuinascono sempre e solo femmine, se non sono fe-condate nascono maschi), hanno un patrimoniocromosomico, tra sorelle, molto più condivisoche non con le proprie figlie, se ne avessero. Lacosa terribile di tutto questo discorso è che l’apeche rinuncia alla propria discendenza non rinun-cia a nulla. Chi si sacrifica, geneticamente par-lando, è la regina, perché l’ape aiuta una propriasorella con la quale condivide, come minimo, ilcinquanta per cento del patrimonio, che è quellodel padre perché è uguale per tutte, più il cin-quanta per cento della madre che è quello chepuò variare; nel caso ci sia tutto è dal cento al cin-quanta per cento. Quindi, mediamente, è del set-
tantacinque per cento. Se avesse dei propri figlipotrebbe dare loro soltanto, al massimo, il cin-quanta del proprio patrimonio.
Questa cosa fa molto riflettere, perché ci diceche non si tratta di un discorso di volontà, ma c’èun meccanismo biochimico a monte che governaanche il comportamento favorendo una cosa piut-tosto che un’altra.
Diciamo che darebbe da pensare, il principio amonte di tutto questo.
Sì, perché questo discorso, filosoficamente par-lando, va verso quello che può essere considerato“il gene egoista”; cioè è il gene, è il dna che tende aconservare sé stesso e usa tutti noi perché il suoobiettivo è quello. Il gene è eterno, perché passa at-traverso le generazioni, ma resta sempre quello. Seriesce a tramandarsi alle generazioni successive, luiè eterno. È questo l’aspetto filosofico di questo det-taglio che invece è il dettaglio reale, naturalistico.
E il nostro libero arbitrio?Per carità, un minimo di arbitrio noi ce lo vo-
gliamo consentire, perché se no saremmo perduti.Ma seguendo questo ragionamento in manierastringente sembrerebbe che il modo migliore pergabbare la natura, per gabbare i nostri geni, sa-rebbe, lo dico come paradosso, il suicidio. Perchéin realtà se uno sopravvive, se uno si riproduce, èstato per tutta la vita governato dalla propria ge-netica, che lo spinge, ad esempio, a fare anche que-sta intervista qui piuttosto che un’altra cosa. Tutto,voglio dire, è funzionale al trasferimento del geneche duplica sé stesso, non è una cosa nostra, è luiche ha noi. Cioè noi apparteniamo ai geni. Questa
è la teoria filosofica che si sviluppa a partire daqueste conoscenze.
Quindi, dell’altruismo nemmeno l’ombra.Io dico sempre ai miei studenti che l’altruismo
vero non esiste. Lo si deduce studiando anche lesocietà di scimpanzé, quelli a noi più vicini, o lesocietà delle api, delle formiche o delle termiti.Negli scimpanzé il vero altruismo non esiste per-ché è sempre funzionale a un ritorno di qualcosa.Nel mondo animale si può constatare che l’altruistaè colui che ad esempio si aspetta un ringrazia-mento dall’amico a cui ha rivolto le proprie atten-zioni. Ciò accade anche tra gli uccelli: l’altruista èin genere un giovane che si mantiene attorno a unacoppia, aiutandola ad allevarne i pulcini, perchépoi quella coppia, più anziana, gli lascerà il nido. Inqualche modo quindi questo uccello, così facendo,aiuta in realtà la propria discendenza.
Che delusione, anche gli uccelli hanno un se-condo fine.
Sì, il loro non è un agire incondizionato. Esisteanche, per esempio, un caso che riguarda specie di-verse di uccelli: la specie che alleva le uova del cu-culo potrebbe essere definita altruista, in qualchemodo. Ma in realtà il cuculo è un ingannatore,quindi si tratta in quel caso di un altruismo estorto,di una frode. Il cuculo mette il suo uovo nel nido diun altro uccello e quando il piccolo nasce (nascesempre prima degli altri) butta giù le uova dal nidoe si fa nutrire lui solo dalla coppia di genitori adot-tivi. Oltretutto la coppia non sa di allevare un mo-stro, perché poi il cuculo è più grande del passerottoe quindi ha bisogno di quantità enormi di cibo. La
coppia si chiederà: ma come mai questo figlio no-stro mangia tanto? Perché è un altro animale!
Egoista, ’sto cuculo.Diciamo così. Ma in quel caso c’è un’evolu-
zione in parallelo. Come diceva qualche buon-tempone, ogni mattina la gazzella si sveglia nellasavana perché deve correre più veloce sennò quelgiorno potrebbe morire e allo stesso modo ognigiorno il leone che si sveglia deve correre più ve-loce se no quel giorno potrebbe non mangiare.C’è come una generale corsa agli armamenti. Noisappiamo che le uova degli uccelli non sonouguali, ma diversamente colorate, picchiettate,macchiettate: il cuculo riesce a fare l’uovo del co-lore della specie che deve affliggere (e gli uccellicambiano continuamente il colore delle uova per-ché così le riconoscono). È, potremmo dire, unacorsa al perfezionamento della strategia di frodee della strategia di difesa.
Insomma, quest’altruismo in natura sembre-rebbe proprio non esistere.
In realtà noi non conosciamo la psicologiadegli animali. Non sappiamo nulla del funziona-mento della loro mente per ciò che attiene lasfera in cui noi esseri umani collochiamo la no-stra libertà e il distacco dalla naturalità. L’altrui-smo potrebbe essere dunque, come dicevo primacon la mia affermazione paradossale, l’apoteosidel distacco dalla nostra condizione naturale.Una condizione naturale, se vogliamo, è anche lacondizione cosiddetta diabolica: il demonio è na-tura mentre l’ascesi è spiritualità e santità. Il demo-nio è carnalità, è vizio, è istinto. Il dio dei boschi,
È accaduto che ad un certo punto, in un certoluogo, uomini e donne di diversa provenienza sisiano riuniti per un’occasione speciale.
Nel centro di recupero femminile della Comu-nità Emmanuel, annualmente, viene realizzatouno spettacolo dalle ragazze ospiti. Uno di questispettacoli ha visto la partecipazione di un gruppodi salentini che hanno collaborato alla riuscitadello show contribuendo alla messa in scena di“Angels”, spettacolo interamente ideato dalle ra-gazze del centro.
Questa compagnia di amici, dunque, con sem-plicità ed allegria, ha dato una mano preparandocostumi, recitando, suonando, realizzando iltrucco di scena, selezionando ed elaborando la co-lonna sonora. Hanno inoltre partecipato all’esibi-zione, dieci di loro, trasformandosi nei LeningradoAll Blacks, un improbabile gruppo di colore ve-nuto qui dagli anni Venti per cantare e ballare aritmo di blues.
Con tanto di cerone marrone, capelli neri ricci,guanti bianchi, divisa nera d’ordinanza. Mica cosìcome si trovavano, per dire…
Il senso di tutto questo risiede nelle pieghe piùprofonde dell’animo di ciascun partecipante al-l’evento.
Il senso di tutto questo, ad uno sguardo fretto-loso e superficiale, potrebbe forse sfuggire.
Il senso di tutto questo, in definitiva, rivela ilmagico meccanismo del dare e ricevere. E del vo-lersi bene, dell’aiutarsi, del condividere.
Qualcosa che, probabilmente, potrebbe dare si-gnificato all’esistenza di ciascuno più di ogni altracosa.
Certamente darebbe più significato di quelloche deriva da una fama effimera. Più di quello cheproviene dall’accumulo di denaro.
Più di quello che permea la quiete di una vitapassata a vegetare in uno sterile e mortifero indi-vidualismo.
Non abbiamo intervistato i Leningrado perchéci sarebbe voluto un altro libro. Ma le poche im-magini che seguono potranno essere ugualmenteeloquenti.
leningrado all blacks
I Leningrado All Blacks (2008) sono: Ciccio Al-bano – Maurizio Buccarella – Anna Colaci – TobiaDe Luca – Carlo Greco – Ilenia Mazzotta – Gae-tano Montinaro – Evelina Pascariello – Terri Pe-done – Sofia Quarta – Hiber Scardino – RosannaScardino – Giancarlo Stefanelli – Antonio Terzi –Carlo Tricarico
indice
preambolo 7
sezione prima 17mani sorelle 21il mantello di san martino 25esmeraldas 27arteterapia 29terapia d’amore 31
sezione terza 35
sezione seconda 55genuario belmonte 59madre superiora 67loredana greco 73prem mahapath 77antonio fiore 85mario marafioti 89roberto tanisi 95paride de masi 101maria lanzillotto 109raffaele mucciato 117mario prontera 125arcangela rana 129famiglia cacciatore 137francesca sgobio 155alessandra petrucci 161pancrazio campagna 167matilde poso 173teresa pellegrino 179leningrado all blacks 185