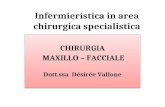CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
Transcript of CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

CHIRURGIA
MAXILLO-FACCIALECORSO AIMS 2021-2022

TRAUMATOLOGIACHIRURGIA DI
TESTA E COLLO
CHIRURGIA MAXILLO-
FACCIALE
ORTOGNATICA
CHIRURGIA PLASTICA
FACCIALE
CHIRURGIA
MALFORMATIVA
CHIRURGIA ORALE

ANATOMIA DEL DISTRETTO
MAXILLO FACCIALE

COMPARTIMENTO OSSEO

OSSO MASCELLARE
Quattro processi: zigomatico,
frontale, palatino, alveolare
Partecipa alla formazione delle
cavita nasali, palato duro e
cavita orbitali.
Grazie allo hiatus mascellare si
apre nel meato medio.
Osso cavo: Presenta l’antro di
Higmoro

OSSO MASCELLARE
Quattro processi: zigomatico,
frontale, palatino, alveolare
Partecipa alla formazione delle
cavita nasali, palato duro e
cavita orbitali.
Grazie allo hiatus mascellare si
apre nel meato medio.
Osso cavo: Presenta l’antro di
Higmoro

OSSO ZIGOMATICO
In rapporto superiormente con il frontale,
medialmente con il mascellare, posteriormente
con il temporale e con lo sfenoide.
Partecipa alla formazione delle
fosse temporale e infratemporale, ed inoltre
costituisce parte della parete laterale e del
pavimento della cavità orbitaria.

FOSSA TEMPORALE
Delimitata da:
in basso dall’arcata zigomatica
in alto dalla linea temporale superiore
Anteriormente dal processo frontale dell’osso zigomatico.
La base della fossa, inferiore, corrisponde allo spazio compreso tra
l’arcata zigomatica e la cresta infratemporale della grande ala
dello sfenoide attraverso questo spazio la fossa temporale
comunica con la fossa con la fossa infratemporale.

FOSSA INFRATEMPORALE
In alto è delimitata dalla grande ala dello sfenoide, e dalla fossa
temporale.
Lateralmente dal ramo della mandibola
Medialmente dalla lamina laterale del processo pterigoideo
Anteriormente dalla tuberosita mascellare.
Posteriormente e inferiormente non vi sono pareti ossee ma
la parotide e le strutture del collo.

FOSSA PTERIGOPALATINA
La fossa pterigopalatina è un piccolo spazio ad imbuto, situato subito
dietro la mascella.
Delimitata:
Anteriormente dalla tuberosita del mascellare
Posteriormente dal processo pterigoideo dello sfenoide
Lateralmente dalla comunicazione con la fossa infratemporale
Medialmente dalla lamina perpendicolare dell'osso palatino

OSSO PALATINO
Situato nella parte posteriore della cavità
nasale, tra la mascella e il processo
pterigoideo dello sfenoide.
Contribuisce a costituire le pareti di tre
cavità: il pavimento della cavità nasale, il
tetto della cavità orale e il pavimento
dell'orbita oculare.

OSSO MANDIBOLARE
Si compone di due rami o branche e di un corpo.
Al di sotto del II premolare troviamo il forame mentoniero, che reca passaggio
all’omonimo nervo.
Nella sua faccia interna, in sede mediana, le quattro spine mentoniere offrono
inserzione ai muscoli genioiodeo e genioglosso; al di sotto e lateralmente si
incava la fossetta del digastrico. Lateralmente si disegna la linea obliqua interna
per inserzione del muscolo miloioideo.
Nello spessore del corpo della mandibola decorre il canale mandibolare, per
il passaggio del nervo alveolare inferiore ed i vasi mandibolari, che in avanti si
apre nel forame mentoniero, continua in avanti con il canale incisivo e termina il
suo percorso fino alle radici dei denti anteriori.
Nella faccia laterale, offrono inserzione al muscolo massetere
Sulla faccia mediale presentano il foro mandibolare, apertura del canale
mandibolare, protetto dalla spina dello Spitz.
In prossimita dell’angolo si nota una rugosita per l’inserzione del muscolo
pterigoideo interno.

OSSO FRONTALE
Si distingue un processo verticale o squama ed una porzione
orizzontale.
Sulla faccia esterna della squama si solleva la sporgenza della
glabella, mentre le arcate sopracciliari, che sormontano le bozze
frontali, separano la superficie del neurocranio dallo splancnocranio.
Lungo le arcate sopracciliari, all’unione del terzo medio con i
due terzi laterali, si affossa l’incisura sovraorbitale, attraversata
dal nervo sopraorbitario, ramo terminale del nervo frontale,
ramo del V n.c.
Nel tratto mediano, l’incisura nasale si articola con le ossa nasali.

ETMOIDE
Costituito dalla lamina orizzontale o cribrosa, che accoglie il passaggio dei
filuzzi olfattivi che dal bulbo olfattorio si portano nella mucosa della parte alta
delle fossa nasali, di cui tale lamina ne costituisce la volta.
La lamina verticale, con la sua parte superiore sporge in fossa cranica
anteriore come apofisi crista galli per l’inserzione della grande falce del
cervello; con la sua parte inferiore partecipa alla costituzione del tratto più alto
del setto nasale.
Le masse laterali o labirinti etmoidali sono simmetriche ai lati della lamina
orizzontale. Con la sua faccia laterale, o orbitale, sottile, detta lamina
papiracea, concorre a formare la parete mediale della cavita orbitaria.
Si distinguono un turbinato superiore e un turbinato medio, a partenza
dalle masse laterali dell’etmoide
il cornetto nasale inferiore è un osso a se stante.

CAVITÀ ORBITARIA
La parete superiore: superficie orbitaria dell’osso frontale e dalla
piccola ala dello sfenoide;
La parete inferiore o pavimento è costituita dal processo zigomatico
del mascellare e dal processo orbitale del palatino; vi decorre solco
infraorbitario per il nervo omonimo.
La parete mediale costituita dal processo frontale del mascellare,
dall’osso lacrimale, dalla lamina papiracea dell’etmoide e dal corpo dello
sfenoide;
La parete laterale: processo orbitale dell’osso zigomatico e
posteriormente dalla faccia mediale della grande ala dello sfenoide.
fessura orbitale inferiore, compresa tra grande ala dello sfenoide e
osso mascellare, per il passaggio del nervo infraorbitario, arteria
infrorbitaria e nervo zigomatico.
La base corrisponde alla cornice orbitaria, costituita in alto dall’arcata
orbitaria dell’osso frontale, medialmente dal processo frontale dell’osso
mascellare, infero-lateralmente dal margine antero-superiore dell’osso
zigomatico.

COMPARTIMENTO
MUSCOLARE

MUSCOLI MIMICI
Muscoli pellicciai, costituiscono la
muscolatura intrinseca della testa e prendono
inserzione con almeno uno dei capi, dalla
porzione profonda della cute. Sono tutti
innervati dal nervo faciale, VII nc.

MUSCOLI DEL COLLO
Muscoli della regione anteriore: sono suddivisi in sopraioidei e sottoioidei.
o Muscoli sopraioidei:
o Digastrico (due ventri) congiunti dal tendine intermedio che si fissa
all’osso ioide Il ventre anteriore è innervato dal V n.c. mentre il ventre
posteriore è innervato dal VII nc. Il ventre posteriore si inserisce in
mastoide, l’anteriore in fossetta digastrica
o Stiloioideo: eleva e porta indietro quest’ultimo (innervato dal VII pnc)
o Miloioideo Lamina triangolare che dalla linea miloioidea si porta alla
faccia anteriore osso ioide. Medialmente le fibre convergono a
formare il rafe mediano, che separa cavo orale dalla regione
sovraioidea (innervato dal V)
o Genioioideo: situato superiormente al miloiodeo, è teso tra spina
mentale e osso ioide, abbassa mandibola e innalza osso ioide.
Innervato dall’ipoglosso

MUSCOLI DEL COLLO
Muscoli sottoioidei: posti davanti di laringe, trachea e
tiroide, innervati dall’ansa cervicale del plesso cervicale C1-
C3, ad eccezione del tiroioideo innervato dl nervo
ipoglosso. Portano in basso l’osso ioide:
Superficiali: sternoioideo, omoioideo
Profondi: sternotiroideo, tiroioideo

MUSCOLI DEL COLLO
Muscoli regione laterale:
Platisma, muscolo sottocutaneo del collo, innervato dal VII nc, al di
sopra di grande pettorale e deltoide, termina sul bordo inferiore della
mandibola, sulla regione masseterina e commessura labiale. Tende
la cute del collo, abbassa la mandibola e stira la commissura
labiale.
Sternocleidooccipitomastoideo, ricoperto dal platisma, innervato dal
XI, dal processo mastoideo discende verso il basso per inserirsi su
manubrio dello sterno e sulla clavicola. Flette e inclina la testa.
Scaleni, posti profondamente nelle regioni laterali del collo:
Scaleni anteriori: dai tubercoli anteriori processi trasversi C3-
C6 al tubercolo I costa.
Scaleni medi: dai tubercoli anteriori processi trasversi C2-C7 al
tubercolo I costa.
Scaleni posteriori: dai tubercoli anteriori processi trasversi C3-
C7 al tubercolo II costa.

MUSCOLI MASTICATORI
L'elevazione della mandibola avviene tramite i
muscoli massetere, temporale, pterigoideo interno
(mediale) e pterigoideo esterno o laterale (capo
superiore).
L'abbassamento della mandibola è effettuato tramite i
muscoli pterigoideo esterno o laterale (capo inferiore), i
muscoli sopraioidei
(digastrico, miloioideo e genioioideo) e, anche se di
norma non classificati tra i muscoli masticatori, i muscoli
sottoioidei.

MUSCOLI MASTICATORI
Il muscolo massetere ha la forma di un rettangolo appiattito ed è
costituito da due fasci di fibre, uno superficiale e uno profondo, che
si incrociano formando una X. Lo strato superficiale origina dall’arco
zigomatico e si inserisce sulla superficie esterna (laterale)
dell’angolo e del corpo della mandibola. Lo strato profondo, origina
dall’arcata zigomatica e si inserisce sull’angolo della mandibola
aderendo tenacemente alla branca montante
AZIONE: ELEVAZIONE DELLA MANDIBOLA

MUSCOLI MASTICATORI
Il muscolo temporale, di forma triangolare con l'apice rivolto verso
il basso, che occupa la regione laterale del cranio. È costituito da
più fasci di fibre (anteriori con andamento verticale, medi e
posteriori con andamento sempre più obliquo) che originano dalla
fossa temporale e dalla linea temporale inferiore, passano sotto il
ponte zigomatico, e si inseriscono, tramite un robusto tendine, al
processo coronoideo della mandibola.
AZIONE: ELEVAZIONE DELLA MANDIBOLA

MUSCOLI MASTICATORI
Muscolo pterigoideo esterno, origina con due capi, superiore dalla
faccia extracranica della grande ala dello sfenoide e inferiore dal
processo pterigoideo e tuberosita del mascellare. I due capi si portano
lateralmente e posteriormente per terminare sulla faccia mediale del
collo del condilo. La contrazione di entrambi gli pterigoidei esterni
porta avanti la mandibola, la contrazione singola ha movimenti di
lateralita.
Muscolo pterigoideo interno, origina dalla fossa pterigoidea e si porta
in basso di lato e posteriormente per avere inserzione sulla faccia
mediale dell’angolo e ramo mandibolare. La sua funzione è di elevare
la mandibola.

COMPARTIMENTO
VASCOLARE

ARTERIA LINGUALE
Arteria linguale, nasce dalla faccia anteriore
dell'arteria carotide esterna tra l'origine dell'arteria
tiroidea superiore e dell'arteria facciale, raggiunge
l'apice della lingua come arteria profonda della
lingua o arteria ranina, suo ramo terminale

ARTERIA FACCIALE
L'Arteria facciale o arteria mascellare esterna, è il ramo
collaterale più grosso della carotide esterna. Nasce
superiormente all'arteria linguale sopra il grande
corno dell'osso ioide. Risale lungo la parete laterale della
faringe appoggiata al muscolo costrittore superiore della
stessa ed incrocia il polo posteriore della ghiandola
sottomandibolare. ll ramo terminale, invece, è
rappresentato dall'arteria nasale laterale (o arteria dell'ala
del naso) che nasce al livello della radice del naso e decorre
sulla superficie laterale anastomizzandosi con l'arteria
dorsale del naso.

ARTERIA MASCELLARE INTERNA
o L’arteria mascellare (o mascellare interna) è il ramo
terminale più voluminoso dell’arteria carotide
esterna; nasce dietro il collo della mandibola e,
passando superficialmente o profondamente al capo
inferiore del muscolo pterigoideo esterno termina
nella fossa pterigopalatina; si divide in tre porzioni:
mandibolare, pterigoidea e pterigopalatina.

ARTERIA MASCELLARE INTERNA
La prima porzione, mandibolare, si porta orizzontalmente in avanti, fra
il collo della mandibola e il legamento sfenomandibolare
La seconda porzione, pterigoidea, decorre flessuosa nella fossa
infratemporale, sulla superficie laterale (o su quella mediale) del
muscolo pterigoideo esterno
La terza porzione, pterigopalatina, passa fra i due capi del muscolo
pterigoideo esterno e, scorrendo sulla tuberosita mascellare, penetra
nella fossa pterigopalatina
Ramo terminale dell’arteria mascellare è l’arteria sfenopalatina

ARTERIA TEMPORALE
SUPERFICIALE
L'arteria temporale superficiale nasce dall'arteria carotide esterna in
corrispondenza del collo del condilo della mandibola, sale parallela alla
carotide per giungere sulla radice posteriore del processo zigomatico,
decorre nello spessore della ghiandola parotide, al davanti del condotto
uditivo esterno e al di dietro dell'ATM. Superato il processo zigomatico,
decorre sulla fascia del temporale e tre o quattro centimetri al di sopra del
processo zigomatico si divide nei suoi rami terminali arteria frontale e il
ramo parietale.

COMPARTIMENTO NERVOSO

COMPARTIMENTO NERVOSO
Nervo olfattivo (I): emergenza, bulbo olfattivo, fuoriesce a livello della lamina cribrosa etmoide.
Nervo ottico (II): è un nervo esclusivamente sensoriale. Nella sua porzione intraorbitaria, sulla faccia laterale del
nervo ottico incontra l’arteria centrale della retina, ramo dell’arteria oftalmica. Fa ingresso nel cranio attraverso il foro
ottico.
Nervo oculomotore (III): nervo puramente motore, composto da fibre effettrici viscerali e da fibre motrici somatiche,
deputate alla innervazione dei muscoli estrinseci dell’occhio (il retto superiore, il retto mediale, il retto inferiore e
l’obliquo inferiore nonche del muscolo elevatore della palpebra superiore).
Nervo trocleare (IV): o nervo patetico, nervo motorio che innerva il muscolo obliquo superiore dell’occhio, il quale
provvede a ruotare l’occhio verso il basso ed esternamente.
Nervo abducente (VI): contribuisce al controllo della muscolatura estrinseca dell’occhio, innervando il muscolo retto
laterale.

COMPARTIMENTO NERVOSO
Nervo glossofaringeo (IX): nervo misto, fibre effettrici viscerali parasimpatiche recano stimoli secretori per parotide e
ghiandole salivari minori; fibre motrici somatiche per muscolo stilofaringeo e muscolo costrittore superiore del faringe;
fibre sensitive somatiche per area di padiglione auricolare; fibre sensitive viscerali per i recettori gustativi del 1/3
posteriore di lingua.
Nervo accessorio spinale (XI): importante per l’innervazione dello sternocleidomastoideo e del trapezio
Nervo ipoglosso (XII): nervo motore somatico per la muscolatura striata della lingua (muscoli ioglosso,
condroglosso, stiloglosso, genioglosso) e muscoli genioiodeo e tiroiodeo. Gli unici veri rami dell’ipoglosso sono i rami
linguali che innervano la muscolatura intriseca ed estrinseca della lingua. In caso di lesione omolaterale del nervo
ipoglosso, in posizione di riposo (sul pavimento buccale) la lingua appare mediana con la punta deviata verso il lato
sano, per azione del muscolo stilo-glosso che tira verso il lato sano. A lingua protrusa si osserva deviazione verso il
lato della lesione per azione del muscolo genio-glosso controlaterale che spinge l’emilingua all’infuori

NERVO TRIGEMINO
Nervo misto somatico costituito prevalentemente da fibre sensitive
somatiche e da un piccolo contingente di fibre motorie. Queste due
componenti emergono direttamente dal nevrasse come due radici
distinte: la radice sensitiva, più voluminosa, laterale rispetto a quella
motrice ed appiattita in senso anteroposteriore, mette capo al ganglio
semilunare del Gasser posto nella fossa cranica media presso l'apice
della piramide del temporale; la radice motrice, più piccola, mediale
rispetto a quella sensitiva, passa al di sotto del ganglio medesimo e si
unisce alla terza branca trigeminale.

NERVO TRIGEMINO
Branche:
• Nervo oftalmico: raggiunge la F.O.S dello sfenoide dove si
divide nei rami terminali naso ciliare, frontale, lacrimale
• Nervo mascellare: raggiunge il foro rotondo, raggiunge la FOI,
si continua con il nervo infraorbitario
• Nervo mandibolare penetra nel foro ovale dello sfenoide, grazie
al quale raggiunge la fossa infratemporale, i rami terminali
sono il nervo linguale e il nervo alveolare inferiore

COMPARTIMENTO
CERVICALE

COMPARTIMENTO CERVICALE
Livello Limite ant. Limite post. Limite sup Limite inf.
Ia Digastrico
controlat.
Ventre ant
musc.digastrico
Bordo inf.
mandibola
Osso ioide
Ib Ventre ant.
Musc.
digastico
Muscolo
stiloioideo
Bordo inf.
mandibola
II Muscolo
stiloioideo
SCM Basicranio Osso ioide
III Sternoioideo SCM Osso ioide Cricoide
IV Sternoioideo SCM Cricoide Clavicola
V SCM Trapezio SCM+trapezio Clavicola
VI SCM Osso ioide Incisura
sternale

COMPARTIMENTO ORALE

COMPARTIMENTO ORALE
La cavita orale: si estende dalla rima orale che la fa comunicare
con l’esterno, all’istmo delle fauci, che la mette in comunicazione
con il faringe. È formata da due porzioni: una anteriore, il
vestibolo, compreso tra labbra, guance e arcate gengivo-dentali
(in esso si apre il dotto della ghiandola parotide, all’altezza del
secondo molare superiore) e la cavita orale propriamente detta
delimitata da arcate dentali in avanti, istmo delle fauci indietro,
volta del palato in alto e in basso dal pavimento della bocca,
occupato in gran parte dalla lingua;

COMPARTIMENTO ORALE
Le guance: chiudono ai lati il vestibolo. Ai fini dell’anatomia microscopica,
dall’esterno all’interno: cute, sottocutaneo, tessuto adiposo, piano
muscolare composto principalmente dal muscolo buccinatore,
sottomucosa e la mucosa. Fa parte della guancia il caratteristico batuffolo
adiposo detto bolla di Bichat, che dalla regione delle guance si immette
nell’interstizio tra margine anteriore del massetere e quello posteriore del
buccinatore. Tale corpo adiposo, inguainato da una sottile fascia fibrosa
incompleta, si alza oltre il limite delle guance, in fossa temporale, ove si
confonde nel connettivo adiposo di questa regione.

COMPARTIMENTO ORALE
Il palato: costituisce ad un tempo volta di cavita buccale e il pavimento
delle fosse nasali. I due terzi anteriori, rigidi, costituiscono il palato
duro, formato dai due processi palatini del mascellare e
posteriormente dalle branche orizzontali delle due ossa palatine. Il
terzo posteriore è dato dal palato molle, o velo palatino o velo
pendulo, lamina muscolo-mucosa quadrilatera, cui il margine inferiore
presenta la sporgenza conoide dell’ugola. Da qui gli archi palato-glosso e
palato-faringeo accolgono la tonsilla palatina che, insieme a tonsilla
faringea, tonsilla tubarica, tonsilla palatina e tonsilla linguale, concorre a
formare l’anello linfatico del Waldeyer. La muscolatura del palato molle è
data dal muscolo tensore del velo palatino (V), dal muscolo elevatore del
velo palatino (X), dal muscolo azygos dell’ugola (X), dal muscolo palato-
glosso (X) e dal muscolo palato faringeo (X).

COMPARTIMENTO ORALE
Lingua: organo muscolo-mucoso, formato da una muscolatura intrinseca, data
dai muscoli longitudinali superiori ed inferiori, muscoli trasversi, muscoli sagittali
e da una muscolatura estrinseca rappresentata dai muscoli genio-glosso,
ioglosso, condro- glosso, stilo glosso. Sulla faccia inferiore della lingua, presenta
il frenulo della lingua che rappresenta quella piega che collega la lingua al
pavimento della cavita orale; ai lati del frenulo vi sono gli sbocchi dei dotti
escretori delle ghiandole salivari sottomandibolare e sottolinguale. Della
lingua distinguiamo due segmenti: il corpo o porzione anteriore e la radice o
porzione posteriore, separate da un solco a V aperta in avanti. Del corpo
descriviamo sulla faccia superiore le papille linguali filiformi, le più diffuse; le
papille fungiformi, dotate di calici gustativi; le papille fogliate, dotate di numerosi
calici gustativi; le papille circonvallate che disegnano la caratteristica V linguale

DENTIZIONE E
MALOCCLUSIONI

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE
o Incisivo centrale superiore ed inferiore: 1 radice
o Incisivo laterale superiore ed inferiore: 1 radice
o Canino superiore ed inferiore: 1 radice
o Primo premolare superiore: 2 radici
o Primo premolare inferiore: 1 radice
o Secondo premolare superiore: 1 radice
o Secondo premolare inferiore: 1 radice
o Primo molare superiore: 3 radici
o Primo molare inferiore: 2 radici
o Secondo molare superiore: 3 radici
o Secondo molare inferiore: 2 radici
o Terzo molare superiore: Da 3 radici
o Terzo molare inferiore:2 radici

ANATOMIA
La corona, parte del dente che si sviluppa fuori dalla gengiva; è
ricoperta dallo smalto dentale, il tessuto più duro dell'intero
organismo, al di sotto del quale troviamo la dentina. Il colletto è un
solco che divide la corona dalla radice. Radici che troviamo alla base
di ogni dente, composte esternamente da un tessuto chiamato
cemento, che ricopre la dentina nelle zone sub gengivali
Si nota all'apice un'apertura attraverso cui passano vasi e nervi che
si immettono nella cavità interna della corona occupata dalla polpa
dentaria. Infine ogni dente ha una camera pulpare dove trae
nutrimento e sensibilità.
Il tessuto di sostegno dei denti è chiamato parodonto ed è
composto da: osso alveolare, cemento, ligamento periodontale e più
esternamente da gengiva.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE PIANO SAGGITALE

CLASSIFICAZIONE


CLASSIFICAZIONE PIANO SAGGITALE
La Cuspide mesiovestibolare del I Molare
Superiore occlude nella piccola scanalatura del I
Molare inferiore, mentre la cuspide del Canino
Superiore è situata tra il Canino ed il I Premolare
Inferiore.
OCCLUSIONE CORRETTA
Il I Molare Superiore occlude mesialmente al I
Molare Inferiore, mentre il Canino Superiore
anteriormente a quello Inferiore.
L'arcata superiore è troppo in avanti.
Il I Molare superiore occlude distalmente al I
Molare inferiore, mentre il Canino superiore
posteriormente a quello inferiore.
L'arcata superiore è troppo indietro.
OCCLUSIONI NON CORRETTE

CLASSIFICAZIONE
overjet, distanza di senso sagittale tra il margine incisivo
degli elementi frontali superiori sugli incisivi inferiori; ha
valori normali compresi tra 2 e 4 mm;
overbite, definito come la distanza verticale tra il margine
incisivo degli elementi frontali superiori sugli incisivi inferiori;
valori normali tra i 2 e i 4 mm.
I molari ed i premolari chiudono
tra loro, ma i denti non si toccano.
I molari chiudono tra loro, ma i denti
anteriori superiori coprono troppo
quelli inferiori.
Morso normale

CLASSIFICAZIONE PIANO VERTICALE
Pur essendo le due arcate dentarie in contatto, uno o più denti dell'arcata
superiore non si contrappongono nel regolare rapporto vestibolo-linguale con
quelli dell'arcata inferiore sul piano trasversale.
LA LINEA MEDIANA SARÀ SPOSTATA
LA MANDIBOLA SARÀ DEVIATA

TERAPIA CHIRURGICA

PATOLOGIA DEL V NERVO CRANICO
Tre tipologie
Essenziale non riconosce una causa precisa, esordisce con
dolore violentissimo, folgorante, in crisi di brevissima durata, 15-
30 sec, unilaterale, interessa una sola branca, eccezionalmente
insorge all’improvviso spontaneamente o in seguito a semplici
stimoli fisiologici come starnutire, parlare, ammiccare, masticare
oppure scatenata da stimoli tattili in corrispondenza di trigger
zones innervate dal trigemino, frequenti alla radice del naso,
angolo della bocca, del forame infraorbitario, angolo esterno
delle palpebre, forame mentoniero. Scompare completamente
negli intervalli lasciando il paziente nell’angosciosa attesa dalla
successiva crisi dolorosa. Vi è mancanza di qualunque
partecipazione dei nervi motori cranici ed assenza di qualunque
alterazione permanente della sensibilita cutanea nell’estremita
cefalica.

PATOLOGIA DEL V NERVO CRANICO
La nevralgia secondaria o sintomatica, secondaria a lesioni
di organi o tessuti che si trovano nel territorio di innervazione
del trigemino (pulpiti, meningiti, otiti), a processi tossinfettivi
con sofferenza trigeminale (herpes zoster, influenza), a un
fattore meccanico (traumi cranici, malformazioni ossee,
aneurismi arteriosi), a forme nervose sistemiche (tabe, sclerosi
a placche). Si appalesa con dolore continuo, con crisi
prolungate da 15-20 min fino a qualche ora, più prolungate
della nevralgia essenziale in cui durano pochi secondi. Il
dolore non è folgorante come nell’essenziale. Non vi è un vero
e proprio intervallo di pieno benessere tra le crisi, al contrario
della nevralgia essenziale. Non è possibile evidenziare zone
trigger che scatenano dolore alla pressione. La compressione
di tali zone evidenzia o una iperestesia cutanea o una
accentuazione del dolore preesistente.

PATOLOGIA DEL V NERVO CRANICO
Nevralgie sindromiche il dolore trigeminale è associato a
segni di tipo paretico (sindromi trigeminali nevralgico paretiche)
per lo più a carico di altri nervi cranici e di plessi
neurovegetativi, tutti messi in sofferenza dal medesimo motivo
eziopatogenetico che è alla base della nevralgia del trigemino.
Si identificano nelle sindromi della loggia cavernosa,
dell’angolo ponto cerebellare, sindromi simpaticotrigeminali,
sindromi nevralgicoparetiche, sindrome tossiinfettive.

PATOLOGIA DEL V NERVO CRANICO
Nella nevralgia secondaria, il trattamento è riferito alla patologia di origine. In
presenza di nevralgia essenziale, il trattamento può essere farmacologico o
chirurgico. La terapia farmacologica prevede come l’utilizzo di clonazepam,
fenitoina, lamotrigina, ossicodone, gabapentin, pregabalin, morfina, codeina,
fentanil e carbamazepina. Il farmaco considerato di prima scelta nel trattamento
della nevralgia del trigemino è la carbamazepina mentre, nel caso di malattie
epatiche, si usa clonazepam associato o meno al gabapentin. Anche l’anestesia
locale con ropivacaina è una pratica utilizzata in associazione alla terapia
farmacologica. La terapia chirurgica consiste in alcune procedure percutanee quali
la termorizotomia trigeminale a radiofrequenza, la neurolisi selettiva con ausilio
di fluoroscopia mirata e la microcompressione con palloncino, ed un intervento in
open quale la decompressione micro vascolare. In alcuni casi si può ricorrere
alla radiochirurgia, seppur risulti meno efficace rispetto al trattamento chirurgico.

L'antro di Higmoro è:
A. la fossa infratemporale
B. la fossa pterigopalatina
C. la cavita all'interno del mascellare superiore
D. il seno frontale
E. il seno sfenoidale

L'antro di Higmoro è:
A. la fossa infratemporale
B. la fossa pterigopalatina
C. la cavita all'interno del mascellare superiore
D. il seno frontale
E. il seno sfenoidale

Quale di queste coppie di ossa forma il pavimento orbitario?
A. Mascellare-zigomatico
B. Etmoide-Lacrimale
C. Mascellare-Frontale
D. Mascellare-Etmoidale
E. Zigomatico-Etmoidale

Quale di queste coppie di ossa forma il pavimento orbitario?
A. Mascellare-zigomatico
B. Etmoide-Lacrimale
C. Mascellare-Frontale
D. Mascellare-Etmoidale
E. Zigomatico-Etmoidale

Quali di questi muscoli è innervato dal V pnc?
A. Buccinatore
B. Massetere
C. Orbicolare del labbro
D. Quadrato del mento
E. Triangolare delle labbra

Quali di questi muscoli è innervato dal V pnc?
A. Buccinatore
B. Massetere
C. Orbicolare del labbro
D. Quadrato del mento
E. Triangolare delle labbra

Quale di questi muscoli eleva la mandibola?
A. Temporale
B. Buccinatore
C. Zigomatico
D. Risorio
E. Muscolo procero

Quale di questi muscoli eleva la mandibola?
A. Temporale
B. Buccinatore
C. Zigomatico
D. Risorio
E. Muscolo procero

Quale di queste è il ramo terminale della a. facciale?
A. arteria angolare
B. arteria temporale superficiale
C. arteria nasale laterale
D. arteria labiale
E. arteria alveolare inferiore

Quale di queste è il ramo terminale della a. facciale?
A. arteria angolare
B. arteria temporale superficiale
C. arteria nasale laterale
D. arteria labiale
E. arteria alveolare inferiore

Di che dente stiamo parlando in figura?
A. 12
B. 22
C. 23
D. 24
E. 33

Di che dente stiamo parlando in figura?
A. 12
B. 22
C. 23
D. 24
E. 33

Quale di queste proiezioni è presente in questa TC?
A. Assiale
B. Sagittale
C. Coronale
D. Frontale
E. Para-assiale

Quale di queste proiezioni è presente in questa TC?
A. Assiale
B. Sagittale
C. Coronale
D. Frontale
E. Para-assiale

Per seconda classe scheletrica si intende:
A. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mascella è più in avanti della mandibola
B. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mandibola è più in avanti rispetto alla mascella
C. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mascella è sullo stesso piano della mandibola
D. Un rapporto tra le basi mascellari dove il mascellare è basculato
E. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mandibola è basculata

Per seconda classe scheletrica si intende:
A. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mascella è più in avanti della mandibola
B. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mandibola è più in avanti rispetto alla mascella
C. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mascella è sullo stesso piano della mandibola
D. Un rapporto tra le basi mascellari dove il mascellare è basculato
E. Un rapporto tra le basi mascellari dove la mandibola è basculata

Disallineamento trasversale delle arcate dentarie in uno o più siti delle stesse:
A. Open bite
B. Close bite
C. Deep bite
D. Over jet
E. Cross Bite

Disallineamento trasversale delle arcate dentarie in uno o più siti delle stesse:
A. Open bite
B. Close bite
C. Deep bite
D. Over jet
E. Cross Bite

Quante radici possiede un primo molare inferiore?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Quante radici possiede un primo molare inferiore?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

TRAUMI CRANIO-FACCIALI

Gassner R. et al. Cranio-maxillofacialtrauma: a 10 year review of 9543 cases with 21 067 injuries JCraniomaxillofac Surg 31, 51-61 2003
“Trauma is the
leading causa of
death in the first 40
years of life.”

EZIOLOGIA
o Incidenti stradali
o Violenza interpersonale
o Incidenti sportivi
o Incidenti lavorativi
o Incidenti domestici

EPIDEMIOLOGIA
o Più frequenti nei pazienti in eta pediatrica
o La testa è più grande del resto del corpo
o Le emorragie del paziente pediatrico sono più severe

ABCDE
Ⓐ Airway maintenance with cervical spine control
Ⓑ Breathing and ventilation
Ⓒ Circulation with hemorrhage control
Ⓓ Disability assessment of neurological status
Ⓔ Exposure and complete examination of the patient

PRIMO SOCCORSO
o Detergere cute e mucose dal sangue
o Rimuovere corpi estranei (dentiere, denti avulsi…) che possono essere inalati e mettere in
sicurezza cavo orale e orofaringe
o Controllare la posizione della lingua in caso di fratture mandibolari o in caso di perdita del
controllo volontario della muscolatura
o Mantenere le VADS pervie con l’utilizzo di mezzi artificiali o con l’utilizzo di un tubo nasofaringeo
o Supervisione continua del paziente

PRIMO SOCCORSO
Intubazione endotracheale
Tracheotomia
• Per prolungate ventilazioni artificiali
• Per facilitare l’anestesia prima del trattamento chirurgico
• Per assicurare una adeguata assistenza postoperatoria
Cricotiroidectomia
Controllo dell’emorragia
Riparazione dei tessuti molli lacerati

OSPEDALIZZAZIONE
Ospedalizzazione e determinazione delle priorita
o Trattamento chirurgico immediato nelle emergenze
o Monitorizzazione e studio delle urgenze
o Identificazione dei casi senza priorita

1. EMERGENZA
Situazioni che richiedono un intervento non prorogabile per la situazione di pericolo per il paziente

o Respiratorie
o Cardio-circolatorie
o Emorragiche
o Neurologiche
1. EMERGENZA
Situazioni che richiedono un intervento non prorogabile per la situazione di pericolo per il paziente

2. URGENZA
Situazioni non ad immediato pericolo di vita ma che richiedono
un pronto intervento chirurgico:
o di prima istanza
o di seconda istanza

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Testa collo
Asimmetrie
Contusioni, abrasioni, lacerazioni
Localizzazione? Strutture anatomiche?
Profondita?
Ferita sporca?
Dolore alla palpazione
Nervi cranici
VII
V1, V2, V3

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Esame intra ed extraorale:
o Presenza di ferite lacerocontuse extraorali
suggestive della direzione dell’urto
o Esposizione focolai di frattura
o Mobilita preternaturale elementi dentari
o Mobilita preternaturale mascellare e/o mandibola
o Presenza di ecchimosi mucose suggestive di
frattura
o Presenza di patologie aggiuntive

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Esame intra ed extraorale:
o Presenza di ferite lacerocontuse extraorali
suggestive della direzione dell’urto
o Esposizione focolai di frattura
o Mobilita preternaturale elementi dentari
o Mobilita preternaturale mascellare e/o mandibola
o Presenza di ecchimosi mucose suggestive di
frattura
o Presenza di patologie aggiuntive

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Tipologia di frattura
Completa
Incompleta

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Diretta
Indiretta

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Chiusa Esposta

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Composta Scomposta

TRAUMI CRANIO FACCIALI
Comminuta

TRAUMI DEL VOLTO
o Fratture nasali
o Fratture orbitarie
o Fratture Comz
o Fratture mandibolari
o Fratture mascellari
o Fratture complesse

FRATTURA OSSA PROPRIE DEL
NASO E CARTILAGINI NASALI
Traumi diretti al naso
Spostamento dei frammenti al lato
opposto del trauma
Nei traumi gravi lussazione e/o
frattura della cartilagine settale (rischio
di ematoma mucopericondrale)
Fratture più frequenti del distretto
maxillo facciale

FRATTURA OSSA PROPRIE DEL
NASO E CARTILAGINI NASALI

FRATTURA OSSA PROPRIE DEL
NASO E CARTILAGINI NASALI
TECNICA CHIRURGICA
Il trattamento delle fratture recenti semplici consta nella pressione
digitale per il riposizionamento dei frammenti ossei (riduzione
manuale) e successiva contenzione con docce metalliche o
gessetto per evitare successive deformazioni. Il trattamento degli
spostamenti laterali dei frammenti viene effettuato con le pinze di
Walsham per via endonasale e le pinze di Asch per il setto.

FRATTURE DEL PAVIMENTO
ORBITARIO

FRATTURE DEL PAVIMENTO ORBITARIO

FRATTURE DEL PAVIMENTO
ORBITARIO
o Il punto di minor resistenza del pavimento orbitario è compreso tra
la fessura orbitaria inferiore e il canale del nervo infraorbitario.
o Causata da forze che agiscono sulla cornice orbitaria inferiore
o Divisibile in frattura Blow in (con scoppio interno) e blow out
(con scoppio esterno), a sua volta divisibile in pura, per
meccanismi traumatici con bordo orbitario integro ed impura,
per traumi con con bordo orbitario
PURA IMPURA

FRATTURE DEL PAVIMENTO
ORBITARIO
E. O del paziente:
o Dolore
o Edema palpebrale
o Ecchimosi palpebrale
o Ecchimosi congiuntivale
o Paralisi muscolo retto inferiore ed obliquo inferiore
o Enoftalmo
o Anestesia V2

FRATTURE DEL PAVIMENTO
ORBITARIO
PRE POST

FRATTURE DEL PAVIMENTO
ORBITARIO
TECNICA CHIRURGICA
Esposizione, tramite approccio subciliare,
subpalpebrale o subtarsale, riduzione ,
riposizionamento del contenuto orbitario in
cavita, e contenzione mediante Mesh in titano
o dura madre.

FRATTURE DEL FRONTALE
I segni più frequenti sono edema ed ecchimosi
periorbitaria, talvolta associati a ptosi palpebrale.
Alterazione della morfologia del III superiore della
faccia con depressione della regione frontale e
lacerazione dei tessuti molli. Importanti
complicanze delle fratture delle ossa frontali
possono essere l’esoftalmo, la pneumo-orbita, il
pneumoencefalo e le fistole liquorali, che possono
associarsi ad altri temibili complicanze come
meningiti o encefaliti. Il principale esame
radiografico da eseguire è la TC in scansioni
assiali e coronali con ricostruzione 3D della
regione fronto-orbitaria.

FRATTURE NASO ETMOIDO
ORBITALI
La frattura naso-orbita-etmoide (N.O.E.) è la
frattura che coinvolge l'area di confluenza
dell’osso etmoide, del naso e dell’ orbita e
in alcuni casi anche dell’osso frontale con
conseguente coinvolgimento del
pavimento della base cranica anteriore. Le
fratture NOE spesso si associano alle fratture
delle ossa proprie del naso e, a seconda del
tipo di frattura (dislocazione dei frammenti
ossei) e del coinvolgimento o meno del canto
mediale orbitario, sono classificate in
fratture N.O.E. di tipo I,II,III.

FRATTURE NASO ETMOIDO
ORBITALI
Tipo I: vi è un unico frammento supportante il legamento
cantale, il quale è facilmente stabilizzato con miniplacche. Tali
fratture sono spesso incomplete o a legno verde.

FRATTURE NASO ETMOIDO
ORBITALI
Tipo II: Nelle fratture di tipo II il tendine cantale rimane
attaccato ad un frammento d’osso depiazzato ed è possibile
stabilizzarlo con un filo di sutura.

FRATTURE NASO ETMOIDO
ORBITALI
Nelle fratture di tipo III vi è un distacco del tendine del canto
mediale dell’orbicolare. Tali fratture possono essere
monolaterali o bilaterali, con o senza interessamento delle
ossa proprie del naso. Quando vi è il distacco del canto
mediale si ha un aumento della distanza intercantale
(distanza fra gli occhi, di norma 35 millimetri) con normale
distanza fra le pupille (distanza interpupillare) dal lato della
frattura. La depressione del complesso osso nasale- osso
frontale è caratteristica di questo tipo di frattura specie se
bilaterale e con il coinvolgimento delle ossa proprie del naso.

FRATTURE NASO ETMOIDO
ORBITALI

FRATTURE DEL COMZ

FRATTURE DEL COMZ

FRATTURE DEL COMZ
E. O del paziente:
o Edema tessuti molli
o Asimmetria regione orbito malare
o Emorragia subsclerale
o Enoftalmo
o Diplopia (incarceramento muscolo retto
inferiore ed obliquo inferiore)
o Limitazione apertura della bocca
o Epistassi
o Ipoestesia V2

FRATTURE DEL COMZ

FRATTURE DEL COMZ
TECNICA CHIRURGICA
Combinazione di incisioni:
o Subpalpebrale / Subtarsale / subciliare
o Terzo esterno del sopracciglio
o Incisione intraorale
Riduzione con elevatore dello Zigomo di
Gilles, o uncino di Ginestet
Contenzione mediante placche e viti

FRATTURE DEL COMZ

FRATTURE MANDIBOLARI

FRATTURE MANDIBOLARILINEE DI DEBOLEZZA MANDIBOLARI
o Nucleo sinfisario
o Nucleo parasinfisario
o Nucleo del margine inferiore
o Nucleo angolare
o Nucleo della spina dello spix
Sede:
o Condilo 33%
o Corpo 25%
o Angolo
o Sinfisi e parasinfisi
o Ramo
o Processo Alveolare
o Coronoide

Ricorda: massetere,temporale, pterigoideo interno e capo
superiore dello pterigoideo esterno spingono la mandibola
verso l’alto
Mentre i muscoli sovraioidei (digastrico, stiloioideo, miloioideo e
genioioideo) ed il capo inferiore dello pterigoideo esterno
spingono la mandibola verso il basso
FRATTURE MANDIBOLARI

E. O del paziente:
o Mobilita preternaturale monconi fratturativi
o Asimmetria facciale
o Malocclusione
o Alterazione delle vie aeree dovute a caduta
indietro della base della lingua (fratture
paramediane bilaterali)
o Morso aperto anteriore e laterale
o Deviazione della mandibola verso il lato
della frattura durante l’apertura della
bocca nelle fratture del processo
coronoide della mandibola
FRATTURE MANDIBOLARI

FRATTURE MANDIBOLARI
TERAPIA
Obiettivi:
o Occlusione stabile
o Restauro apertura
o Restauro completo dei movimenti
mandibolari
o Restauro funzione articolare
o Evitare disordini interni ATM
controlaterale
o Evitare disturbi della crescita
o Ripristino dell’estetica

FRATTURE MANDIBOLARI
Trattamento chirurgico:
o Approccio intraorale
o Approccio extraorale (in caso di presenza di ferite lacerocontuse)
Contenzione:
o Non cruenta: (6+2)
• Ferule
• Viti di Ito
• fili metallici
o Cruenta:
• placche e viti
• fili metallici
• materiali riassorbibili

FRATTURE MANDIBOLARI
Trattamento chirurgico:
o Approccio intraorale
o Approccio extraorale (in caso di presenza di ferite lacerocontuse)
Contenzione:
o Non cruenta: (6+2)
• Ferule
• Viti di Ito
• fili metallici
o Cruenta:
• placche e viti
• fili metallici
• materiali riassorbibili

FRATTURE MANDIBOLARI
TERAPIA
Obiettivi:
o Occlusione stabile
o Restauro apertura
o Restauro completo dei movimenti mandibolari
o Restauro funzione articolare
o Evitare disordini interni ATM controlaterale
o Evitare disturbi della crescita
o Ripristino dell’estetica

FRATTURE MANDIBOLARI
TERAPIA
Contenzione:
o Non cruenta: (6+2)
• Ferule
• Viti di Ito
• fili metallici
o Cruenta:
• placche e viti
• fili metallici

FRATTURE CONDILARI
ferite cutanee
bocca semiaperta
scialorrea
deviazione della linea interincisiva
malocclusione
esposizione dei monconi ossei
mobilita preternaturale di elementi dentali
limitazione dei movimenti mandibolari
ipo/anestesia della regione innervata dal nervo
alveolare inferiore
crepitii al movimento

FRATTURE CONDILARI
L’occlusione dentale può fornirci l’orientamento
riguardo la localizzazione della frattura. Con una
frattura unilaterale del processo condilare e la
conseguente riduzione dell’altezza della
regione del ramo, il clinico vedra un
precontatto ipsilaterale e un openbite
controlaterale. La linea mediana sara deviata
verso il lato della frattura. L’occlusione mostra
un contatto prematuro a destra con la deviazione
del mascellare verso il lato affetto, che è ciò che
più comunemente si riscontra in frattura condilare.
Fratture bilaterali con accorciamento e
dislocazione risultano in open bite anteriore
con minima deviazione della linea mediana.

FRATTURE CONDILARI
Obiettivo: ripristino della masticazione
la riduzione dei segmenti ossei nella loro
posizione anatomica;
la fissazione, che terra i segmenti ossei in
posizione fino al consolidamento;
Terapia conservativa (- blocco inter mascellare, -
fisioterapia) in caso di: - fratture non dislocate -
fratture con minima dislocazione - fratture in eta
giovanile senza una grave limitazione funzionale.
Terapia chirurgica in caso d’impedimento
irreversibile alla funzione articolare:
- perdita di altezza di ramo mandibolare >3mm;
- dislocazione condilare >30 gradi;
Depiazzamento del condilo; - presenza di corpi
estranei.

FRATTURE DEL
MASCELLARE SUPERIORE

FRATTURE DEL MASCELLARE SUPERIORE

FRATTURE DEL MASCELLARE
SUPERIORE
Parziali
o Margine alveolare
o Basserau
o Walter
o Lannelongue
o Richet
o Huet
Totali
o Le fort I
o Le Fort II
o Le Fort III

FRATTURE DEL MASCELLARE
SUPERIORE
B) Walter: linea orizzontale tipo Le Fort I, da
premolare a premolare + frattura interincisiva
C) Richet: Le Fort I monolaterale
D) Basserau: Le Fort I, associata a due linee di
frattura parallele che si estendono
sagittalmente da un incisivo laterale all’altro
E) Huet: lungo la regione canina, riunendosi
con l’omologa controlaterale, attraverso una
frattura del palato

FRATTURE DEL MASCELLARE
SUPERIORE
Disgiunzione del mascellare superiore
(Lannelongue)
Ha sede sulla linea mediana
Divide sagittalmente i due mascellari
dalla spina nasale anteriore alla spina nasale
posteriore

FRATTURE LF I
La frattura si estende dal setto nasale ai bordi
laterali dell'apertura piriforme, si dirige
orizzontalmente al di sopra degli apici
dentari, incrocia sotto la sutura zigomatico
mascellare e attraversa la sutura sfeno
mascellare fino ad interrompere i processi
pterigoidei dello sfenoide

FRATTURE LF I
La frattura si estende dal setto
nasale ai bordi laterali
dell'apertura piriforme, si
dirige orizzontalmente al di
sopra degli apici dentari,
incrocia sotto la sutura
zigomatico mascellare e
attraversa la sutura sfeno
mascellare fino ad
interrompere i processi
pterigoidei dello sfenoide

FRATTURE LF I
leggero gonfiore del labbro superiore
ecchimosi presente nel fornice superiore,
sotto gli archi zigomatici
malocclusione,
mobilita dentaria.
Le fratture a seguito di un impatto possono essere
quasi immobili, e si può percepire il
caratteristico stridore solamente applicando una
pressione sui denti dell'arcata superiore.
La percussione dei denti dell'arcata superiore rivela
un suono detto a pentola fessa.
È presente il segno di Guerin, caratterizzato da
ecchimosi nella regione dei vasi palatini maggiori.

FRATTURE LF II
Decorre dal terzo medio
delle ossa nasali in basso
da ciascun lato attraverso
i processi frontali del
mascellare superiore, le
ossa lacrimali, il margine
orbitario inferiore, il
forame infraorbitario, la
parete del seno
mascellare, il tuber
maxillae, i processi
pterigoidei nel terzo
medio

FRATTURE LF II
Decorre dal terzo medio
delle ossa nasali in basso
da ciascun lato attraverso
i processi frontali del
mascellare superiore, le
ossa lacrimali, il margine
orbitario inferiore, il
forame infraorbitario, la
parete del seno
mascellare, il tuber
maxillae, i processi
pterigoidei nel terzo
medio

FRATTURE LF II
Edema dei tessuti molli nel terzo medio del volto
Ecchimosi bilaterale orbitale
Emorragia bilaterale sottocongiuntivale
Epistassi
rinorrea di liquido cerebrospinale
diplopia
enoftalmo
gradino sul bordo infraorbitario, porzione
media del volto mobile
Anestesia o parestesia attraverso danno al nervo
infraorbitario

FRATTURE LF III
Disgiunzione cranio
facciale: decorre dalla
sutura fronto nasale alle
ossa nasali e lacrimali,
lungo le sottili pareti
orbitali dell’etmoide,
intorno al forame ottico,
e il lato mediale del
margine posteriore della
fessura orbitale
inferiore, proseguendo
per due vie: una in
basso fino al terzo
superiore dei processi
pterigoidei, l’altra in alto
fino alla parete laterale
dell’orbita.

FRATTURE LF III
Disgiunzione cranio
facciale: decorre dalla
sutura fronto nasale alle
ossa nasali e lacrimali,
lungo le sottili pareti
orbitali dell’etmoide,
intorno al forame ottico,
e il lato mediale del
margine posteriore della
fessura orbitale
inferiore, proseguendo
per due vie: una in
basso fino al terzo
superiore dei processi
pterigoidei, l’altra in alto
fino alla parete laterale
dell’orbita.

FRATTURE LF III
Separazione della sutura zigomatico-frontale
Allungamento del volto
Depressione dei livelli oculari
Enoftalmo
Incapacita a mantenere le palpebre aperte
Alterazione del piano occlusale

FRATTURE MASCELLARI
Esposizione
Riduzione
Contenzione Rigida

FRATTURE COMPLESSE

FRATTURE COMPLESSE

FRATTURE COMPLESSE

FRATTURE COMPLESSE

FRATTURE COMPLESSE

Domanda - SSM 2015
Nell'approccio ad un paziente che ha subito un trauma cranico maggiore qual è la prima azione da
compiere?
A. terapia antiedemigena
B. RX cranio
C. TC encefalo con mezzo di contrasto
D. applicare protocollo ABCDE (Airway Breathing Circulation Disability Exposure) secondo le norme ATLS
(Advanced Trauma Life Support)
E. elettroencefalogramma

Domanda - SSM 2015
Nell'approccio ad un paziente che ha subito un trauma cranico maggiore qual è la prima azione da
compiere?
A. terapia antiedemigena
B. RX cranio
C. TC encefalo con mezzo di contrasto
D. applicare protocollo ABCDE (Airway Breathing Circulation Disability Exposure) secondo le norme
ATLS (Advanced Trauma Life Support)
E. elettroencefalogramma

Domanda - SSM
La frattura di Le Fort I:
A. Non necessita mai di riduzione chirurgica
B. È una frattura trasversale della mandibola
C. È una frattura trasversale del mascellare superiore
D. Interessa sempre la cavita orbitaria
E. È una frattura sagittale della mandibola

Domanda - SSM
La frattura di Le Fort I:
A. Non necessita mai di riduzione chirurgica
B. È una frattura trasversale della mandibola
C. È una frattura trasversale del mascellare superiore
D. Interessa sempre la cavita orbitaria
E. È una frattura sagittale della mandibola

Domanda - SSM
Giunge in Pronto Soccorso un ragazzo di 24 anni che ha subito un incidente motociclistico con traumatismo
all'emivolto destro.
Clinicamente si osserva un'asimmetria nei movimenti oculari con diplopia nei movimenti di verticalita.
Quale tipo di frattura è più probabile abbia il paziente?
A. Frattura dell'osso frontale
B. Frattura della parete mediale dell'orbita
C. Frattura della parete laterale dell'orbita
D. Frattura del pavimento dell'orbita
E. Frattura dell’osso nasale

Domanda - SSM
Giunge in Pronto Soccorso un ragazzo di 24 anni che ha subito un incidente motociclistico con traumatismo
all'emivolto destro.
Clinicamente si osserva un'asimmetria nei movimenti oculari con diplopia nei movimenti di verticalita.
Quale tipo di frattura è più probabile abbia il paziente?
A. Frattura dell'osso frontale
B. Frattura della parete mediale dell'orbita
C. Frattura della parete laterale dell'orbita
D. Frattura del pavimento dell'orbita
E. Frattura dell’osso nasale

Domanda - SSM
Quale esame diagnostico fornisce il maggior numero di informazioni in questo caso?
A. Ecografia statica
B. TAC
C. RX tradizionale del cranio in posizione obliqua
D. Nessuno, è sufficiente la clinica per eseguire la diagnosi
E. Scintigrafia con leucociti marcati

Domanda - SSM
Quale esame diagnostico fornisce il maggior numero di informazioni in questo caso?
A. Ecografia statica
B. TAC
C. RX tradizionale del cranio in posizione obliqua
D. Nessuno, è sufficiente la clinica per eseguire la diagnosi
E. Scintigrafia con leucociti marcati

In quale frattura si manifesta l'enoftalmo?
A. Frattura della mandibola
B. Frattura dell'osso frontale
C. Frattura delle ossa nasali
D. Frattura del condilo
E. Frattura del pavimento dell'orbita

In quale frattura si manifesta l'enoftalmo?
A. Frattura della mandibola
B. Frattura dell'osso frontale
C. Frattura delle ossa nasali
D. Frattura del condilo
E. Frattura del pavimento dell'orbita

Che cos’è la frattura blow-out dell'orbita?
A. Una frattura del pavimento dell’orbita
B. Una frattura del tetto
C. Una frattura della lamina etmoidale
D. Una frattura della parete laterale
E. Una frattura della fessura sfenoidale superiore

Che cos’è la frattura blow-out dell'orbita?
A. Una frattura del pavimento dell’orbita
B. Una frattura del tetto
C. Una frattura della lamina etmoidale
D. Una frattura della parete laterale
E. Una frattura della fessura sfenoidale superiore

Nelle fratture della testa del condilo con dislocazione mediale, in massima apertura la mandibola devia:
A. Dal lato della frattura
B. Dal lato controlaterale alla frattura
C. Non devia
D. Non ha più il movimento di apertura
E. Tutte le risposte sono errate

Nelle fratture della testa del condilo con dislocazione mediale, in massima apertura la mandibola devia:
A. Dal lato della frattura
B. Dal lato controlaterale alla frattura
C. Non devia
D. Non ha più il movimento di apertura
E. Tutte le risposte sono errate

La presenza di un morso aperto anteriore post-traumatico è segno di:
A. Frattura della mandibola
B. Frattura malare
C. Frattura etmoidale
D. Frattura della coronoide
E. Frattura dell'arco zigomatico

La presenza di un morso aperto anteriore post-traumatico è segno di:
A. Frattura della mandibola
B. Frattura malare
C. Frattura etmoidale
D. Frattura della coronoide
E. Frattura dell'arco zigomatico

Il dislocamento dei monconi ossei in caso di frattura della mandibola è dovuto a:
A. Azione dei muscoli
B. Edema
C. Emorragia intrafocale
D. Suzione
E. Limitazione di apertura

Il dislocamento dei monconi ossei in caso di frattura della mandibola è dovuto a:
A. Azione dei muscoli
B. Edema
C. Emorragia intrafocale
D. Suzione
E. Limitazione di apertura

Un trauma diretto sulla regione mentoniera può causare il seguente tipo di frattura:
A. frattura orbitaria
B. frattura mascellare tipo Le Fort III
C. frattura dei condili mandibolari
D. frattura dello zigomo
E. frattura del vomere

Un trauma diretto sulla regione mentoniera può causare il seguente tipo di frattura:
A. frattura orbitaria
B. frattura mascellare tipo Le Fort III
C. frattura dei condili mandibolari
D. frattura dello zigomo
E. frattura del vomere

Cosa si intende per disgiunzione cranio-facciale?
A. frattura tipo Le Fort III
B. frattura tipo Lannelongue
C. frattura di Guerin-Wassmund
D. frattura tipo Le Fort I
E. frattura tipo Le Fort II

Cosa si intende per disgiunzione cranio-facciale?
A. frattura tipo Le Fort III
B. frattura tipo Lannelongue
C. frattura di Guerin-Wassmund
D. frattura tipo Le Fort I
E. frattura tipo Le Fort II

Quali muscoli sono responsabili della diplopia nelle fratture del pavimento orbitario?
A. retto inferiore e piccolo obliquo
B. retto superiore e grande obliquo
C. trasverso e retto inferiore
D. trocleare e abducente
E. orbicolare e m. di Muller

Quali muscoli sono responsabili della diplopia nelle fratture del pavimento orbitario?
A. retto inferiore e piccolo obliquo
B. retto superiore e grande obliquo
C. trasverso e retto inferiore
D. trocleare e abducente
E. orbicolare e m. di Muller

PATALOGIA MALFORMATIVA

MALFORMAZIONI
• Malformazioni semplici (della faccia)
• Malformazioni complesse (della faccia)
• Craniostenosi
• Anomalie
• Di tipo strutturale
• Di tipo funzionale
• Sindromi
• Aberrazioni cromosomiche
• Deformita
• Congenite e prenatali
• Perinatali

EZIOPATOGENESI
Congenite e prenatali
o Genetiche (sindromiche, anomalie cromosomiche, monogeniche
dominanti/ recessive/ x linked, mitocondriali, poligeniche…)
o Dismetaboliche (diabete, disordini endocrini…)
o Tossiche (i trimestre vs ii-iii trimestre, farmaci, fumo, alcol…)
o Infettive (rosolia, CMV, toxoplasmosi, sifilide…)

EZIOPATOGENESI
Perinatali
o Prematurita
o Problematiche pre-partum (ipertensione, gestosi, ipossia, distacco
di placenta, rottura uterina…)
o Problematiche intra-partum (trauma da parto…)
o Infettive (rosolia, CMV, toxoplasmosi, sifilide…)

LABIOPALATOSCHISI
Malformazione craniofacciale che comprende un gruppo
di disordini eterogenei interessanti labbra e cavo orale
o 1:1000 nati LPS
o M:F:2:1 (popolazione caucasica)
o Casi familiari 30% LPS -50% PS
o Forme sindromiche
o Forme isolate

LABIOPALATOSCHISISchisi subtotale del labbro

LABIOPALATOSCHISISchisi totale del labbro e del processo alveolare superiore

LABIOPALATOSCHISISchisi bilaterale del labbro e del processo alveolare superiore

PALATOSCHISISchisi del palato molle o duro
Fissurazione monolaterale o centrale del palato duro e
molle o del solo palato molle, senza interessamento
del labbro e dell’arcata gengivale superiore
Schisi sottomucosa: incompleta unione dei muscoli
palatini e mucosa integra e schisi dell’ugola (ugola
bifida)
Stafiloschisi: schisi dell’ugola e del palato molle
Uranoschisi: palato molle e duro
Palato primario e secondario
Primario: Area triangolare del palato duro anteriore al
forame incisivo (include i quattro incisivi). Palato
secondario: La parte restante di palato duro ed il
palato molle con l’ugola

PALATOSCHISISchisi del palato molle o duro
I due terzi anteriori, rigidi, costituiscono il palato
duro, formato dai due processi palatini del
mascellare e posteriormente dalle branche
orizzontali delle due ossa palatine. Il terzo
posteriore è dato dal palato molle, o velo palatino
o velo pendulo, lamina muscolo-mucosa
quadrilatera, cui margine inferiore presenta la
sporgenza conoide dell’ugola

PALATOSCHISICheilognatopalatoschisi totale monolaterale

PALATOSCHISICheilognatopalatoschisi totale bilaterale

PALATOSCHISI
20% pretermine
50% forme isolate per PS
30% forme isolate per LPS
20%
30%
50%
Labioschisi
Labiopalatoschisi
Palatoschisi

EPIDEMIOLOGIA
o Incidenza elevata in popolazioni di basso livello socio economico
o Prevalenza e incidenza variabile: Asia e America latina 3,6/1000 Sud Africa 0,3/1000
o I gruppi migranti mantengono un’incidenza più vicina all’area di provenienza

FATTORI DI RISCHIO
o Fumo materno aumenta del 20% il rischio di LPS e PS
o Alcool causa nota di sindrome fetoalcolica ma associazione incerta con malformazioni
craniofacciali
o Utilizzo dei multivitaminici riducono del 25% il rischio di malformazioni
o Solventi organici, anticonvulsivanti, talidomide sono fattori di rischio

FATTORI DI RISCHIO
o Infezioni virali possono attivare il fattore di trascrizione che regola l’interferon e favorire il rischio di
palatoschisi
o Mutazioni di fattori di regolazione trascrizionali FGF3-7-10-18 e FGFR1-2-3
o SUMO (small ubiquitin-like modifier) piccole molecole coinvolte nella modificazione post
traduzionale di molte proteine tra cui quelle implicate nello sviluppo del palato

ambiente genetica
Eziologia
comune
>20% malformazioni congenite associate Variabilita fenotipica

PROTOCOLLO TERAPEUTICO
o Prima visita multidisciplinare
o Ecografia renale e cerebrale
o Visita cardiologica
o Ecg ed ecocardiogramma

PROTOCOLLO TERAPEUTICO
PROBLEMATICHE:
o Alimentazione del neonato (nella palatoschisi e nella
labiopalatoschisi)
➢ placca endorale in resina acrilica
➢ evitare alimentazione prolungata con sondino nasogastrico
o Sviluppo del linguaggio

Famiglia
Centro di
sindromologia
Neuropsichiatra
infantile
Otorinolaringoiatra
Logopedista
Audiologo
Pediatra di base
Odontoiatra
Genetista
Chirurgo

PREPARAZIONE CHIRURGICA
ORTOPEDIA PRE-OPERATORIA
o Utilizzo di placche endorali per allineare i due monconi gengivali e prepararli all’intervento
ricostruttivo
o Controlli mensili per valutare la crescita palatale e apportare modifiche alle placche endorali

TERAPIA CHIRURGICA
o LABIOSCHISI
Nascita Visita team polispecialistico
3-6 Mesi Ricostruzione naso/labbro mono-bilaterale
o PALATOSCHISI
Nascita Visita team polispecialistico
6 mesi Ricostruzione palato
3 anni Eventuale correzione dell'insufficienza
velofaringea

TERAPIA CHIRURGICA
LABIOPALATOSCHISI
Nascita Visita team polispecialistico
3-4 mesi Ricostruzione naso, labbro mono-bilaterale e palatoplastica
7-9 mesi Ricostruzione del palato
3 anni Eventuale correzione dell'insufficienza velofaringea
8-10 anni Gengivoplastica con innesto dell'osso se necessario
16/18 anni Eventuale modellamento finale e/o eventuale chirurgia ortognatica

Domanda SSM
Si consideri un paziente con schisi monolaterale completa del palato primario e secondario associata a schisi
semplice del labbro e dell'alveolo gengivale.
Verra definita:
A. cheilognato schisi monolaterale
B. uranostafilouguloschisi monolaterale
C. cheilognatouranostafilouguloschisi monolaterale
D. stafilouguloschisi
E. ugulopalatoschisi bilaterale

Domanda SSM
Si consideri un paziente con schisi monolaterale completa del palato primario e secondario associata a schisi
semplice del labbro e dell'alveolo gengivale.
Verra definita:
A. cheilognato schisi monolaterale
B. uranostafilouguloschisi monolaterale
C. cheilognatouranostafilouguloschisi monolaterale
D. stafilouguloschisi
E. ugulopalatoschisi bilaterale

SINDROMI MALFORMATIVE
+ COMUNI

CRANIOSTENOSI
Normale Microcefalia

CRANIOSTENOSI
o Fusione precoce di una o più suture
o Sviluppo anomalo del SNC
o Ritardo mentale
o Classificazione utilizzata: di Tessier
Fattori di rischio:
Prematurita
Gravidanza multipla
Patologie metaboliche
Patologie ematologiche
Sostanze teratogene (idantoina, retinoidi)

CRANIOSTENOSI
Craniostenosi primarie
Scafocefalia: sutura sagittale
Plagiocefalia: sutura emicoronale
Trigonocefalia: sutura metopica
Brachicefalia: entrambe le suture coronali
Oxicefalia / Turricefalia: più suture craniche

CRANIOSTENOSI

SDR. FRANCESCHETTI
(TREACHER COLLINS)
o Autosomica dominante (GENE TCOF1, POLR1D)
o Autosomica recessiva (POLR1C)
o Difficolta uditive:
• Ipoplasia padiglione auricolare
• Atresia cute ed anomalie ossiculari
o Difficolta respiratorie:
• Ipoplasia zigomatica
• Ipoplasia mandibolare
• Schisi palatina
o Obliquita antimongolica linea palpebra

SDR. APERT
o Autosomica dominante
o Penetranza incompleta
o Mutazione fgfr2
o Brachicefalia
o Ipoplasia medio facciale
o Esoftalmo asimmetrico
o Ptosi palpebrale
o Acrocefalosindattilia

SDR. CRUZON
o Mutazione Fgfr3
o Turricefalia
o Ipertelorismo
o Esoftalmo
o Ipoplasia Facciale

SDR. PIERRE-ROBIN
o Micrognazia
o Retrazione lingua
o Palatoschisi
o Problemi di suzione, alimentazione, respirazione

SDR. SAETHRE-CHOTZEN
o Mutazione TWIST1
o Plagiocefalia
o Asimmetria facciale
o Strabismo
o Microtia
o Mento prominente

SDR. GOLDENHAR
Nota anche come displasia oculo-auricolo -
vertebrale
La presenza di anomalie auricolari è considerata
necessaria per la diagnosi
1/5.000-25.000 nati vivi
Triade di sintomi:
microsomia cranio-facciale
cisti oculari dermoidi
anomalie della colonna vertebrale.

SDR. DI ROMBERG
o Nota anche come emiatrofia facciale progressiva
o coinvolgimento dei territori cutanei muscolari e
ossei innervati dal trigemino
o Inizia solitamente dopo i 6 anni ed evolve con
poussees per 3-4 anni.

Quale sutura è colpita nella scafocefalia?
A. Sutura coronale
B. Sutura lambdoidea
C. Sutura metopica
D. Sutura sagittale
E. Sutura emicoronale

Quale sutura è colpita nella scafocefalia?
A. Sutura coronale
B. Sutura lambdoidea
C. Sutura metopica
D. Sutura sagittale
E. Sutura emicoronale

Una precoce fusione della sutura metopica sara caratterizzata da Sutura coronale
A. Plagiocefalia
B. Scafocefalia
C. Trigonocefalia
D. Brachicefalia
E. Oxicefalia

Una precoce fusione della sutura metopica sara caratterizzata da Sutura coronale
A. Plagiocefalia
B. Scafocefalia
C. Trigonocefalia
D. Brachicefalia
E. Oxicefalia

Una precoce fusione della sutura coronale sara caratterizzata da:
A. Plagiocefalia
B. Scafocefalia
C. Trigonocefalia
D. Brachicefalia
E. Oxicefalia

Una precoce fusione della sutura coronale sara caratterizzata da:
A. Plagiocefalia
B. Scafocefalia
C. Trigonocefalia
D. Brachicefalia
E. Oxicefalia

Domanda SSM
La classificazione di Tessier è relativa a:
A. tumori del cavo orale
B. agenesie dentali
C. schisi facciali
D. cisti e fistole laterali del collo
E. paralisi del nervo facciale

Domanda SSM
La classificazione di Tessier è relativa a:
A. tumori del cavo orale
B. agenesie dentali
C. schisi facciali
D. cisti e fistole laterali del collo
E. paralisi del nervo facciale

Domanda SSM
Un piccolo bambino di Haiti viene inviato in osservazione da una organizzazione umanitaria perche affetto da
microsomia craniofacciale.
Quale esame strumentale consente di studiare al meglio tale condizione?
A. Tomografia computerizzata
B. Ecografia
C. Risonanza magnetica
D. Tomografia computerizzata tridimensionale
E. Radiografia

Domanda SSM
Un piccolo bambino di Haiti viene inviato in osservazione da una organizzazione umanitaria perche affetto da
microsomia craniofacciale.
Quale esame strumentale consente di studiare al meglio tale condizione?
A. Tomografia computerizzata
B. Ecografia
C. Risonanza magnetica
D. Tomografia computerizzata tridimensionale
E. Radiografia

Domanda SSM
In quale delle seguenti sindromi è più frequente la palatoschisi?
A. Sindrome di Treacher-Collins
B. Sindrome di Sudeck
C. Sindrome di Saint
D. Sindrome di Volkmann
E. Sindrome di Whipple

Domanda SSM
In quale delle seguenti sindromi è più frequente la palatoschisi?
A. Sindrome di Treacher-Collins
B. Sindrome di Sudeck
C. Sindrome di Saint
D. Sindrome di Volkmann
E. Sindrome di Whipple

Domanda SSM
La sindrome di Crouzon:
A. È una condizione in cui è presente una turricefalia
B. È una acrocefalosindattilia
C. È una condizione in cui le caratteristiche sono piede a spatola e mano a cucchiaio
D. È una condizione in cui non vi è ritardo mentale
E. Tutte le precedenti

Domanda SSM
La sindrome di Crouzon:
A. È una condizione in cui è presente una turricefalia
B. È una acrocefalosindattilia
C. È una condizione in cui le caratteristiche sono piede a spatola e mano a cucchiaio
D. È una condizione in cui non vi è ritardo mentale
E. Tutte le precedenti

Domanda SSM
Un piccolo paziente presenta bilateralmente microtia, atresia del condotto uditivo, micrognatia mandibolare,
appiattimento delle ossa malari, palato ogivale con conseguente viso «a profilo di uccello».
Quale sindrome ricordano queste manifestazioni?
A. Sindrome di Crouzon
B. Sindrome di Lyell
C. Sindrome di Franceschetti
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Down

Domanda SSM
Un piccolo paziente presenta bilateralmente microtia, atresia del condotto uditivo, micrognatia mandibolare,
appiattimento delle ossa malari, palato ogivale con conseguente viso «a profilo di uccello».
Quale sindrome ricordano queste manifestazioni?
A. Sindrome di Crouzon
B. Sindrome di Lyell
C. Sindrome di Franceschetti
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Down

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Crouzon

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Crouzon

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Romberg

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Romberg

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Romberg

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Apert
E. Sindrome di Romberg

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Crouzon
E. Sindrome di Romberg

Domanda SSM
Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Pierre-Robin
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Crouzon
E. Sindrome di Romberg

Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Romberg
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Crouzon
E. Sindrome di Apert

Che sindrome vi ricorda il paziente nell’immagine?
A. Sindrome di Franceschetti
B. Sindrome di Romberg
C. Sindrome di Saethre-Chotzen
D. Sindrome di Crouzon
E. Sindrome di Apert

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE
TEMPORO-MANDIBOLARE

ANATOMIA
SUPERFICI ARTICOLARI DELL'ATM NON SONO RIVESTITE DA CARTILAGINE IALINA MA DA TESSUTO FIBROSO
DENSO.
LA CARTILAGINE IALINA È MOLTO RESISTENTE ALLE FORZE DI COMPRESSIONE MA HA SCARSA
DEFORMABILITÀ.
LO SVANTAGGIO DERIVANTE DALLA RESISTENZA DI QUESTO TESSUTO ALLO SCIVOLAMENTOVIENE
COMPENSATO DALLA PRESENZA DEL DISCO ARTICOLARE
FIBROCARTILAGINE
MEMBRANA SINOVIALE
DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE
MUSCOLI ELEVATORI:
• Pterigoideo interno
• Massetere – Temporale (innervati dal
nervo trigemino)
MUSCOLI ABBASSATORI:
- Muscolo digastrico
- Muscolo pterigoideo esterno
- Muscoli sopra-ioidei
ATM

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARELEGAMENTI
I legamenti collaterali uniscono i margini mediale e laterale
del disco ai poli del condilo.
Il legamento capsulare delimita completamente l'intera atm.
Il legamento temporo-mandibolare rinforza il versante
laterale del legamento capsulare.
Il legamento sfenomandibolare
(accessorio)
Il legamento stilomandibolare
(accessorio)
ha la funzione di limitare il movimento di protrusione.
CONTENIMENTO E LIMITAZIONE DELLA FUNZIONE
ARTICOLARE

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE
o Malocclusioni dentali
o Mancanza elementi dentali posteriori con riduzione
dell’altezza verticale posteriore
o Malformazioni dento-scheletriche
o Malattie sistemiche
o Stress con disturbi psicofisiologici
INCOORDINAZIONE
CONDILO-DISCALE
DISORDINI DEI MUSCOLI
MASTICATORI
EZIOPATOGENESI

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARESINTOMI
Triade sintomatologica fondamentale:
o Dolore orofacciale
o Rumori articolari
o Limitazione della cinetica mandibolare
SINTOMATOLOGIA ASSOCIATA
o Acufene
o Instabilita
o Otalgia
o Cefalea
o Fattori emozionali
.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE
La patogenesi si suddivide in
o patogenesi muscolare in caso di patologia
extracapsulare o sindrome miofasciale
o patogenesi articolare in caso di patologia
intracapsulare che a sua volta comprende
l’incoordinazione condilomeniscale, l’osteoartrosi
e la sublussazione.
.
L’incoordinazione condilo meniscale è determinata da una
parziale dislocazione anteromediale del disco articolare che
in posizione di massima intercuspidazione si trova davanti al
condilo.
Si distinguono due tipologie: click e lock.
Nel click abbiamo una ricattura del disco da parte del condilo.
Il lock è invece caratterizzato dalla persistente dislocazione
anteromediale del menisco che blocca il movimento di
trazione del condilo.
.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLAREDISORDINI CRANIO MANDIBOLARI
Sindrome disfunzionale con interessamento articolare o
dei muscoli masticatori o di entrambi. È la causa
principale di dolore orofacciale dopo quello
odontogeno. La prevalenza è superiore nelle donne.
Comprendono le alterazioni infiammatorie e
degenerative che interessano le articolazioni ed i
muscoli del sistema stomatognatico. L’eziologia è
multifattoriale, disegnando come cause più frequenti le
malocclusioni considerate il primum movens di una
dislocazione condilare in cavita glenoidea con
conseguente alterazione del carico articolare e
secondaria alterazione funzionale che determinano sia
una dislocazione mandibolare, sia una iperattivita
muscolare.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARELussazione dell’articolazione temporo-mandibolare
Si classificano in
o Statiche lussazioni permanenti che
riconoscono cause traumatiche e
non.
o dinamiche, recidivanti divise in
lussazioni bloccate quando l’atto
della lussazione non ritorna in sede
articolare e lussazioni non bloccate
quando l’atto della lussazione ritorna
in sede articolare → sublussazioni,
condilo-meniscale, limitazione
funzionale con dolore articolare ed il
caratteristico rumore tipo scroscio
durane i movimenti mandibolari,
recidivano con facilita e hanno
riduzione semplice.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE
Sublussazione o ipermobilita articolare.
Causata da eccessiva traslazione
condilare che in massima apertura
sopravanza l’eminenza articolare del
temporale, esita talora in lussazione con
blocco della mandibola in apertura.
Clinicamente presenta un click reciproco in
fase finale di apertura e in fase iniziale di
chiusura.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARE
Osteoartrosi. Un sovraccarico con alterazione
dell’equilibrio funzionale può determinare un processo di
adattamento che esita in un rimodellamento articolare.
Clinicamente si manifesta con rumore di schiocco
articolare dovuto ad improvviso cambiamento della
velocita di traslazione del condilo. Nelle fasi avanzate
abbiamo limitazione funzionale con dolore articolare e
caratteristico rumore di sabbia durante i movimenti
condilari.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLAREANCHITOSI DELL’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE
Si tratta dell’adesione fibrosa o ossea dei
componenti anatomici dell’articolazione con
conseguente riduzione o annullamento della
funzionalita cinetica mandibolare.
Le cause possono essere varie: infezioni,
patologie congenite, traumi cronici, che possono
condurre a quadri di artrite cronica, conducendo
alla sclerotizzazione del disco fibrocartilagineo
dell‘ATM.
La sintomatologia spicca una retrusione
mandibolare ed una tumefazione nella sede della
capsula articolare sclerotizzata. Nei casi di
anchilosi monolaterale si apprezza deviazione
mandibolare e della linea interincisiva verso
l’articolazione anchilosata ed appiattimento della
guancia dal lato opposto.

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-
MANDIBOLARETERAPIA
o Informazione ed educazione
o Terapia farmacologica
o Terapia ortopedico- funzionale
o Terapia chirurgica 5%
Artoplastica
80-95%
ARTOCENTESI

DISFUNZIONI ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE

Domanda SSM
Quale delle seguenti affermazioni sull’articolazione temporo-mandibolare è FALSA?
A. Il suo movimento avviene con l’azione dei muscoli masticatori e sopraioidei, tutti innervati dal nervo
facciale
B. Esiste un disco articolare
C. Produce un liquido sinoviale per la lubrificazione articolare
D. I condili sono orientati perpendicolarmente al piano della mandibola
E. Le disfunzioni necessitano prima di una terapia medica ed eventualmente dopo di una terapia chirurgica

Domanda SSM
Quale delle seguenti affermazioni sull’articolazione temporo-mandibolare è FALSA?
A. Il suo movimento avviene con l’azione dei muscoli masticatori e sopraioidei, tutti innervati dal
nervo facciale
B. Esiste un disco articolare
C. Produce un liquido sinoviale per la lubrificazione articolare
D. I condili sono orientati perpendicolarmente al piano della mandibola
E. Le disfunzioni necessitano prima di una terapia medica ed eventualmente dopo di una terapia chirurgica

OSTEONECROSI
ASSOCIATA A
TRATTAMENTO CON
BIFOSFONATI
MEDICATION-RELATED
OSTEONECROSIS OF
THE JAW
(BRONJ) (MRONJ)

BRONJ E MRONJ
o Un’area di osso esposto nel cavo orale a
livello mascellare/ mandibolare che non
guarisce dopo 8 settimane
dall’identificazione da parte di
personale sanitario;
o in soggetti che sono in terapia o hanno
assunto bifosfonati o denosumab;
o che non sono mai stati trattati con
terapia radiante nella regione testa-
collo.

BRONJ E MRONJ
Farmaci Coinvolti:
o Bifosfonati
o Antiangiogenetici
o Anticorpi monoclonali
o Indagini
o RX OPT
o TC
o Biopsia con colture microbiche

BRONJ E MRONJ

PATOLOGIE CISTICHE DEL
DISTRETTO MAXILLO FACCIALE

CISTI MASCELLARI

Cavita ripiena di liquido rivestita da una parete interna epiteliale e da un rivestimento esterno connettivale. Le
pseudocisti mancano di rivestimento epiteliale.
o Cisti odontogene
A) Non infiammatorie o disembriogenetiche
• Cisti dentigera o follicolare
• Cisti eruttiva
• Cheratocisti odontogena
• Cisti gengivale
• Cisti sialodontogena/calcificante
B) Infiammatorie
- Cisti radicolare
- Cisti residua
o Cisti non odontogena
• Cisti nasopalatina
• Cisti nasoalveolare
• Cisti mediana mandibolare
o Pseudocisti
• Cisti ossea solitaria
• Cisti aneurismatica
• Cisti o Lacuna di Stafne

CISTI ODONTOGENE NON
INFIAMMATORIE O
DISEMBRIOGENETICHE

Cisti follicolare
Piu frequente tra le cisti disembriogenetiche, la seconda più
comune fra tutte le cisti. È sempre associata alla giunzione
amelocementizia di un elemento dentario incluso. Origina dalla
proliferazione dei residui dell’epitelio dell’organo dello smalto.
• Localizzazione: più frequente in corrispondenza del III molare o
del mascellare superiore a livello dei canini.
• Radiologia: area osteolitica monoconcamerata a margini netti
che circonda la corona di un elemento dentario incluso, e la
componente radicolare è esclusa dalla neoformazione cistica.
• Istologia: cavita cistica rivestita da epitelio squamoso non
cheratinizzato.
• Trattamento: Enucleazione della cisti ed estrazione del terzo
molare incluso, o marsupializzazione con conservazione del
dente. Se non trattata, esiste il rischio di degenerazione maligna
dell’epitelio cistico.

Origina dai residui della lamina dentale. Tendenza a recidivare.
Localizzazione: livello mandibolare Cisti multiple compaiono nel 7% circa
dei pazienti , alcuni dei quali affetti dalla sindrome di Gorlin- Goltz, sindrome
del nevo baso cellulare, AD, caratterizzata da basaliomi cutanei,
cheratocisti odontogene multiple, coste bifide, protuberanze in regione
parietale e frontale, calcificazioni della falce cerebrale.
Clinicamente si differenziano dalle altre neoformazioni cistiche per il
drenaggio spontaneo di liquido, tumefazione, dolore, e talvolta trisma e
parestesia.
Radiologia: appare come area di radiotrasparenza per lo più
pluriconcamerata, generalmente ben delimitata, da tessuto osseo sano.
Istologia: delimitata da epitelio squamoso pluristratificato, paracheratosico.
(Per paracheratosi: permanenza dei nuclei nelle cellule dello strato corneo).
Trattamento: Enucleazione della cisti e curettage della cavita ossea residua.
Attenzione al tasso maggiore di recidiva (10-30%).
Cheratocisti odontogena
(tumore odontogeno cheratocistico)

Nei neonati dette anche Perle di Ebstein, si manifestano tipicamente sotto
forma di piccoli noduli bianchi o rosati, frequentemente multipli, di 1-5
mm di diametro
Localizzazione: rafe palatino mediano.
Trattamento: nessuno, tendono a scomparire e non recidivano
Normalmente queste lesioni regrediscono spontaneamente poco dopo la
nascita.
Negli adulti insorgono all’interno dei tessuti molli gengivali, tipicamente nella
quinta-settima decade di vita e originano probabilmente da resti della lamina
dentale.
Localizzazione: regione premolare mandibolare sotto forma di tumefazione
non dolente, di consistenza fluttuante. Sono caratterizzate da un lento
accrescimento e dopo trattamento chirurgico di enucleazione non tendono a
recidivare.
Trattamento: Enucleazione
Cisti gengivale

CISTI ODONTOGENE
INFIAMMATORIE

Cisti radicolare (periapicale)
Sono le più frequenti (60-75% dei casi), e si sviluppano dalla
radice di un dente non vitale, la cui polpa è necrotica. Originano
dai residui epiteliali di Malassez.
Localizzazione: mascellare superiore e nella porzione posteriore
della mandibola
Tipicamente asintomatica, da segno di se in caso d’infezione o
per il suo volume deformante e tipica è la sua diagnosi incidentale
a seguito di esecuzione di RX OPT a seguito a normali controlli
radiografici dentali.
Radiologia: omogenea uniloculare, con presenza di orletto
sclerotico perilesionale solitamente ben evidente.
Istologia: cavita cistica rivestita da epitelio squamoso non
cheratinizzato.
Trattamento: asportazione chirurgica e curettage con estrazione
del dente, o con devitalizzazione del dente e apicectomia delle
radici.

Cisti residua
Cisti residuata dopo l’estrazione del dente necrotico che
presentava una lesione periapicale, il cui rivestimeno cistico non è
stato rimosso oppure rimosso in maniera incompleta. Origina
anch’essa dai residui del Malassez.
Radiologia: area osteolitica monoconcamerata, con area di
osteoaddensamento perilesionale ben rappresentato.
Trattamento: asportazione chirurgica.

CISTI NON ODONTOGENE

Cisti naso palatina
Formata dai residui epiteliali dal dotto nasopalatino, è la più frequente fra tutte le forme
da sviluppo non odontogeno. Si presenta in prevalenza tra la quarta e la sesta decade di
vita.
Sede obbligata: zona interincisiva del mascellare superiore.
Radiologia: area di radiotrasparenza con aspetto di osteolisi omogenea con orletto
osteosclerotico perilesionale, localizzate tra le radici degli incisivi centrali superiori, che
risultano dislocate. Talvolta sviluppandosi verso la spina nasale anteriore assume il
cosiddetto aspetto a “cuore di carta da gioco”.
Unico segno clinico obiettivabile è la dislocazione degli incisivi centrali superiori che,
comunque risultano vitali. Ha uno sviluppo lento e solitamente non raggiunge grandi
dimensioni.
Istologia: PATOGNOMONICA presenza di epitelio di rivestimento pluristratificato e
respiratorio ciliato.

PSEUDOCISTI
(Sono prive di rivestimento epiteliale esterno e pertanto, vengono denominate pseudocisti.)

Cisti ossea solitaria traumaticaPatogenesi associata ad un trauma precedente con formazione di un ematoma all’interno della porzione midollare dell’osso
che si riassorbe dando luogo a uno spazio vuoto intraosseo. Presente soprattutto negli adolescenti di entrambi i sessi, più
frequentemente nella mandibola.
Non si osserva riassorbimento radicolare. La cavita aperta si presenta vuota o piena di fluido sanguinolento e l’emorragia
intracistica determina la guarigione della lesione con ricalcificazione completa entro 6 mesi.
Cisti o lacuna di StafneSi tratta di una lesione ellittica o rotondeggiante localizzata nella mandibola posteriore sotto il canale mandibolare. Costituisce
abitualmente un reperto casuale in corso d’indagini radiografiche dentali. Non è una vera e propria cisti. Appare come una
depressione aperta verso il lato linguale della corticale mandibolare e occupata tipicamente da un lobo accessorio della
ghiandola sotto mandibolare. Molto utile può risultare la TC, che evidenzia la lacuna sul lato linguale del corpo mandibolare.
Non necessita pertanto di alcun trattamento.

TUMORI ODONTOGENI BENIGNI
Derivano dai tessuti che danno origina al dente, ma non dal dente gia formato. Dal tessuto odontogeno possono derivare tre
tipi di tumori, neoplasie epiteliali, mesenchimali e miste. Sono lesioni intraossee e occasionalmente extraossee. Si accrescono
molte volte in assenza di sintomi. L’Rx continua ad essere l’esame di primo livello preferito per l’identificazione di tali lesioni.
Clinicamente sono rappresentate da gonfiore e tumefazione.
Classificazione
Tumori con epitelio odontogeno senza mesenchima odontogeno (originati dal tessuto epiteliale, in cui l’origine è
l’organo dello smalto
• ameloblastoma; ameloblastoma maligno; carcinoma ameloblastico
• tumore odontogeno epiteliale calcificante (tumore di Pindborg)
• Tumore adenomatoide odontogeno
Tumori con epitelio odontogeno e mesenchima odontogeno
• Odontoma
• Dentinoma
Tumori con mesenchima odontogeno con o senza epitelio odontogeno
• mixoma odontogeno
• fibroma cementificante

Ameloblastoma solido e multicistico
Ipotizzato come originante dalle dello smalto, costituito da epitelio odontogeno proliferante, ad aspetto follicolare o plessiforme.
Si presenta invece con frequenza significativamente superiore a carico della mandibola con un rapporto tra mandibola e
mascellare di circa 4:1. In fasi più avanzate appare come una lesione a lenta crescita che determina una progressiva tumefazione
del segmento osseo interessato, senza particolari sintomi dolorosi. È il tumore più frequente dopo l’odontoma. Diagnosticato
tra i 40 e i 50 anni.
Radiologia: osteolisi multiloculare, ben delineata con orletto osteosclerotico periferico. Nella forma multicistica si presenta con
aspetto a bolle di sapone.
Istologia: proliferazione di ameloblastomi all’interno di uno stroma fibroso più o meno lasso che assumono un aspetto follicolare o
plessiforme.
Si presenta localmente aggressivo
Trattamento: chirurgia con estensione di almeno 1,5 cm oltre il margine macroscopico della lesione.
Follow up che deve durare almeno 10 anni.

Tumore calcificante dell’epitelio odontogeno (tumore di
Pindborg)Tumore invasivo localmente, caratterizzato dalla presenza di nuclei giganti, cellule plurinucleate e cellule con diversi nucleoli.
Localizzazione: Mandibola e premolare/molare
Istologia: cellule poligonali formanti cordoni e tralci immersi una sostanza eosinofila omogenea tipo amiloide.
Radiografia: osteolisi con calcificazioni diffuse ed irregolari addossate ad un elemento dentario non erotto.
Trattamento: escissione con ampio margine osseo al fine di ridurre recidive, con adeguato follow up postoperatorio.
OdontomaCon caratteristiche tipiche degli amartomi, in quanto si presentano come delle masserelle formate da tessuti dentali più o meno
disorganizzati, ma senza gli aspetti proliferativi tipici dei tumori. Rappresentano il 30% circa dei tumori odontogeni. L’odontoma
complesso è una malformazione in cui sono presenti tutti i tessuti dentali, ma disorganizzati. L’odontoma composto rappresenta
invece una malformazione in cui i tessuti dentali sono meglio organizzati dando luogo a strutture più o meno simili a denti.
Neoformazione composta da tutte le componenti dentarie: smalto, dentina, cemento e polpa. Piu frequente neoplasia di origine
odontogena. Diagnosticata soprattutto nel secondo decennio di vita. Localizzato prevalentemente nella mandibola. Rappresenta
un ostacolo per il dente che cerchera di erompere.
Radiologia: la differente radiopacita dei tessuti che lo compongono crea un osteoaddensamento caratteristico a “mollica di pane”.
Trattamento: chirurgico

TERAPIA CHIRURGICA
Scollamento sottoperiosteo
Breccia ossea con trapano
Asportazione della cisti
Curettage ed eventuale estrazione di elementi dentali coinvolti

La cisti follicolare è classificata tra le cisti odontogene. La sua caratteristica:
A. non contiene al suo interno elementi dentari
B. è una cisti radicolare
C. è una pseudocisti
D. contiene al suo interno un elemento dentario non erotto
E. è una cisti aneurismatica

La cisti follicolare è classificata tra le cisti odontogene. La sua caratteristica:
A. non contiene al suo interno elementi dentari
B. è una cisti radicolare
C. è una pseudocisti
D. contiene al suo interno un elemento dentario non erotto
E. è una cisti aneurismatica

La caratteristica principale delle pseudocisti dei mascellari è:
A. Il riassorbimento delle radici dentali dei denti sovrastanti
B. L'aspetto policistico
C. La localizzazione mascellare
D. L'assenza di epitelio
E. La frequente suppurazione

La caratteristica principale delle pseudocisti dei mascellari è:
A. Il riassorbimento delle radici dentali dei denti sovrastanti
B. L'aspetto policistico
C. La localizzazione mascellare
D. L'assenza di epitelio
E. La frequente suppurazione

Una cisti radicolare si forma nel granuloma dentale:
A. dall'epitelio mucoso
B. dal cemento
C. dalla dentina
D. quando rimangono inclusi i residui del Malassez e questi diventano attivi
E. dalla gengiva

Una cisti radicolare si forma nel granuloma dentale:
A. dall'epitelio mucoso
B. dal cemento
C. dalla dentina
D. quando rimangono inclusi i residui del Malassez e questi diventano attivi
E. dalla gengiva

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA
MAXILLO FACCIALE

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA MAXILLO FACCIALEINNESTO CUTANEO
Area di cute composta di epidermide e derma che viene
completamente rimossa da un’area definita donatrice e viene
innestata in un’altra definita ricevente. Gli innesti cutanei, a seconda
che comprendano tutto il derma o una sua parte, si dividono in innesti
cutanei a spessore totale o a spessore parziale
Diviso in innesto a spessore parziale ed innesto a spessore totale. Nel
primo la guarigione avviene per epitelizzazione secondaria, nel
secondo per chiusura diretta.

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA MAXILLO FACCIALELEMBO
o Porzione di tessuto trasposto da una zona all’altra dell’organismo mantenendo una connessione per l’apporto
vascolare.
o I lembi random si caratterizzano per una vascolarizzazione sostenuta solo dal plesso vascolare dermico e
subdermico, per definizione lembi locali, in continuita con il campo chirurgico da ricostruire, con i limiti di un
arco di rotazione ridotto e la provenienza da zone vicine a quella da ricostruire. Un lembo cutaneo random,
porzione di cute e di tessuto sottocutaneo che viene trasposta da una zona all’altra dell’organismo pur
mantenendo una connessione con il corpo per l’apporto vascolare, viene considerato sicuro dal punto di vista
vascolare in quanto ha un rapporto lunghezza-larghezza 2:1,5:1.

CHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA MAXILLO
FACCIALEI lembi assiali si caratterizzano per una vascolarizzazione
costituita da un peduncolo artero-venoso ben definito dal
punto di vista anatomico; ne sono alcuni esempi il lembo
indiano basato sull’arteria sovratrocleare, il lembo delto-
pettorale basato sul ramo deltoideo dell’arteria
toracoacromiale ed il lembo inguinale, costituito dalla cute
della regione inguinale ed ipogastrica e vascolarizzato
dall’arteria iliaca circonflessa superficiale. Un lembo assiale
supera le limitazioni ricostruttive legate alla vascolarizzazione
dei lembi random per la sua vascolarizzazione non dalla rete
subdermica, ma da un asse vascolare ben definito
anatomicamente che consentisse l’allestimento di lembi
senza uno stretto rapporto lunghezza-larghezza.

CHIRURGIA
RICOSTRUTTIVA MAXILLO
FACCIALE
Ai fini della chirurgia ricostruttiva maxillo-facciale, un lembo
muscolo cutaneo, per mezzo della vascolarizzazione cosiddetta
dominante del muscolo, che presenta un decorso profondo al
muscolo stesso, nutre i tessuti sovrastanti quali muscolo, sottocute
e cute, per mezzo di vasi perforanti. I lembi muscolo-cutanei di più
frequente uso in chirurgia testa collo sono quelli di gran pettorale,
trapezio e latissimo del dorso.
Grande pettorale: Ramo pettorale dell’arteria toraco acromiale,
ramo dell’ascellare.
Latissimo del dorso: Arteria toraco-dorsale, ramo della
sottoscapolare, ramo ascellare
Mio fasciale di temporale: Arterie temporali profonde, anteriore e
posteriore
Lembo fascio-cutaneo di avambraccio: Arteria radiale, ramo della
brachiale e vena cefalica
lembo muscolare o muscolocutaneo di retto dell’addome: vasi
epigastrici profondi, rami dell’iliaca esterna
Lembo osteomuscolare di cresta iliaca: arteria e vena circonflessa
iliaca profonda, rami dell’arteria iliaca esterna
Lembo osseo di fibula: Arteria peroniera e vene comitanti

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA MAXILLO FACCIALE
Zona deficitaria Lembi utilizzati
Mandibula Cresta iliaca e fibula
Mascellare Temporale
Lingua Grande pettorale/avambraccio
Pelvi orale Platisma/Avambraccio/R.addome
Palato Bolla di Bichat
Labbra Lembi locali

GRAZIE per l’attenzione
HELPDESK DIDATTICO
www.accademiamedici.it






![CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE 2010[1]](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/6194d09b1254ae5fee4bd7b5/chirurgia-maxillo-facciale-20101.jpg)