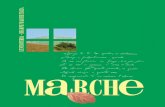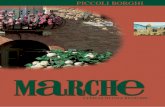Cartoguida Marche
description
Transcript of Cartoguida Marche

Augusto, nella gola del Furlo presso Acqualagna la galleriadi Vespasiano del 76 d.C., a Cagli il ponte Mallio, a Cantia-no in località Pontericcioli il ponte Grosso; lungo la Via Sa-laria ad Ascoli Piceno la porta Gemina e il ponte del Sole-stà). Di particolare interesse il gruppo equestre in bronzo
dorato rivenuto a Cartoceto diPergola e la scultura in bronzoattribuita a Lisippo ritrovatanelle acque antistanti Fano eattualmente esposta al GettyMuseum di Malibù in Califor-nia. Reperti della civiltà roma-na sono conservati nei museiarcheologici di cui molti stata-li (Ancona, Arcevia, Urbino, Pe-saro, Pergola, Cingoli, Urbisa-glia e Ascoli Piceno) e i nume-rosi parchi archeologici (Fos-sombrone, Sassoferrato, Ca-stelleone di Suasa, San Severi-no Marche, Urbisaglia, Falero-ne e Cupra Marittima).
Secondo Festo il Piceno fu co-sì chiamato perché i Sabini
che migrarono verso «Au-sculum», l’odierna Ascoli,avevano come insegna
un picchio, «picus», uc-cello sacro a Marte, po-satosi lungo il cammino
sul loro vessillo: da que-sto avrebbero preso il no-me di «Piceni» o «Picen-tes». La scoperta di nume-
rose necropoli disseminatetra il fiume Foglia a nord e il
Pescara a sud, in Abruzzo, harivelato l’esistenza, tra l’VIII eil I secolo a.C., di una «facies»culturale cui è stato dato il
nome di civiltà picena, protagonista delle vicende stori-che di parte dell’Italia Centrale fino alla definitiva conqui-sta dei territori da parte dei Romani. Le necropoli più in-teressanti e importanti, impreziosite da ricchi corredi ditombe a inumazione, sono state individuate, in particola-re, nel Pesarese a Novilara, nell’Anconetano a Numana eFabriano, nel Maceratese a Matelica e Pitino e nel Ferma-no a Belmonte Piceno. Ancona, dopo essere stata sede diuno stanziamento dell’età del Bronzo e poi importantecentro piceno, intorno al 390 a.C., accolse una colonia diesuli siracusani che, coabitando con i Piceni, impiantaro-no un florido emporio rivolto agli scambi con l’Oriente.Anche la vicina Numana, antico porto piceno, intrattenneimportanti rapporti con la civiltà greca. Tra il IV e il III se-colo a.C. le Marche centrosettentrionali fino all’Esino fu-rono occupate dalle tribù celtiche dei Galli senoni; i mag-giori insediamenti di questo popolo – che ha lasciatosplendidi oggetti di alta oreficeria oggi visibili nel Museoarcheologico nazionale delle Marche – sono stati registra-ti ad Arcevia, Senigallia, Osimo e Filottrano. Dopo la bat-taglia di «Sentinum», svoltasi nel 295 a.C. tra Galli e Sanniticontro romani e piceni, nell’area a cavallo tra Camerino eSassoferrato – l’antica «Sentinum» – i Romani occuparonoil territorio gallico e ne vollero sottolineare la specificitàculturale chiamandolo «agergallicus». Nel corso dei due se-coli successivi penetrarono nelresto della regione e fondaronola strada consolare Flaminia,che collega tuttora Roma conFano, e la Salaria, già strada pi-cena, che da Porto d’Ascoli as-sicurava ai Romani il sale delmare Adriatico. Testimonianzedelle colonie e municipi roma-ni sono ancora oggi visibili nelreticolato di alcune città (Pesa-ro, Fano, Senigallia, Jesi e Asco-li Piceno) e nei monumenti (adAncona l’arco di Traiano, lungola Via Flaminia a Fano l’arco di
e gli eredi della gran-de tradizione di Leo-nardo Castel lani(1896–1984) e Fran-cesco Carnevali dellaScuola del Libro diUrbino: Renato Bru-scaglia (1921–1999) eCarlo Ceci fino ad ar-rivare all’allievo Wal-ter Valentini. Moltedelle opere di questiartisti e dei maestridel Novecento italia-no sono conservatinel Palazzo Ricci aMacerata. Nelle Mar-che altri luoghi del-
l’arte contemporanea sono a Sassoferrato la GalleriaG.B. Salvi, ad Ancona la Pinacoteca civica, a Jesi la Pi-nacoteca civica, a Cagli il Torrione di Francesco di Gior-gio Martini. Una buona collezione di dipinti dell’Otto-cento è custodita invece nella Pinacoteca comunale diAscoli Piceno. Nelle Marche esiste la più alta concentrazione di ope-re d’arte veneta dopo il Veneto, grazie ai polittici diPaolo Veneziano, Jacobello del Fiore e Carlo Crivelli, al-le opere di Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Tiziano, Pa-squalino Rossi e Giovan Battista Tiepolo. Nel settoredell’arte come dimenticare che nelle Marche esiste
Cerignone, rocca di Fos-sombrone, rocca e Torrionea Cagli, rocca di Frontone)e per quelle civili (PalazzoDucale a Urbino e Urba-nia). I Della Rovere la-sciarono la loro improntanella rocca di Mondavio,nel Palazzo Ducale di Pe-saro – voluto da Alessan-
dro Sforza – e nella magnifica villa Imperiale di Pesaro, ela-borata da Girolamo Genga. Scendendo a Senigallia, la roc-ca e il Palazzo Ducale, di roveresca memoria, aprono lastrada alla scoperta delle rocche e castelli della provin-cia di Ancona: l’imponente rocca di Offagna ricorda le bat-taglie compiute dalla città dorica contro la vicina Osimo;a Falconara sono visitabili la rocca Priora, dal bel porta-le vanvitelliano e il castello nella parte alta. Nell’entroterraCorinaldo, soggetto ai Malatesta e poi allo Stato della Chie-sa, domina le valli del Cesano e del Misa con l’intatto cir-
Le Marche sono una terra ricca di arte, cultura e antichimestieri che si tramandano ancora oggi nelle botteghe ar-tigiane. È in queste tradizioni che risiede la forza del mo-dello economico regionale, imperniato sullo sviluppo del-la piccola e media impresa, diffusa in maniera capillare neltessuto storico delle Marche. Tra le tradizioni più antiche,la lavorazione della pelle, di cui Tolentino è l’autentica ca-pitale, nasce nel Medioevo e oggi può vantare una serie diindustrie della calzatura, del pellame e delle borse nel Ma-ceratese e nel Fermano. Celebre in tutto il mondo è anchela secolare lavorazionedella carta di Fabriano;nella città si trovano il Mu-seo della Carta e Filigrana– dove i lavoranti, comegli antichi maestri cartai,trasformano gli stracci incarta – e botteghe specia-lizzate per la vendita delleraffinate filigrane. La lavo-razione della carta è pre-sente anche a Pioracoche, come Fabriano, ha dasecoli sfruttato l’acquadel fiume limitrofo, il Po-tenza, per le proprie gual-chiere. Infine, a Urbino, lo-calità Miniera, è visitabileil Museum Graphia (mu-seo internazionale dellastampa). Un altro settorefiorente dell’artigianatoartistico regionale è quel-lo della lavorazione dellaterracotta, diffusa daMontottone nel Fermano,a Fratte Rosa nel Pesare-se, e della ceramica da Appignano nel Maceratese a Urba-nia, Urbino e Pesaro nell’omonima provincia. La maiolicanasce in età medievale e raggiunge lo splendore nel Rina-
scimento quando, grazie almecenatismo dei Della Ro-vere, tra Urbino, Urbania –già Casteldurante – e Pesa-ro, si sviluppa una delle piùfiorenti industrie italiane.In tutte le Marche è diffusala lavorazione del ferrobattuto: in città e nei borghiè facile imbattersi in unlampione o un balcone arti-gianale. Una delle zone piùfiorenti in tale settore è l’A-scolano, in particolare For-ce e Comunanza, dove i ra-mai di oggi continuano unatradizione secolare. LeMarche vantano anche una
ca, si tiene il Festival del-la Fisarmonica e il Pre-mio Internazionale persolisti e complessi dellostrumento. In una re-gione che vanta ben ol-tre 70 teatri storici, nonmancano di certo gli ap-puntamenti con questaforma d’arte: dalle ras-segne di teatro anticodi Urbisaglia e Falerone,che durano tutta l’esta-te, al teatro rinasci-mentale di Urbino in lu-glio e agosto, dal teatrod’avanguardia di Pol-verigi in luglio e Aman-dola in settembre, allarassegna estiva del Tea-tro alle Cave di Sirolo;dagli appuntamenti conl’arte drammatica delFestival nazionale deiGad di Pesaro alla rassegna I teatri invisibili di San Bene-detto del Tronto a settembre. A Civitanova si danza inestate con il Festival Internazionale Civitanova Danza. AFabriano si segnala il Festival Poiesis.
LO SPETTACOLO DELLA NATURA
Il mareIl mare Adriatico bagna tutte le province delle Marche; lun-go la costa si affacciano città che vantano un illustre e an-tico passato segnato dalla vocazione portuale e com-merciale. Partendo da Roma, Fano costituiva il primosbocco sul mare della Via Flaminia; Senigallia, posta allefoci del Misa, è sede di una importante fiera, la tradizio-nale Fiera di Sant’Agostino. Ancona fu porto piceno, gre-co e poi romano; Numana fu un ricco emporio in età picenae greca; Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto, congli altri centri delle province di Ascoli Piceno e Fermo, fu-
rono importanti porti pi-ceni e romani. Le città co-stiere della regione man-tengono ancora oggi la vo-cazione portuale. Ancona,per esempio, è un grandeporto commerciale, San Be-nedetto del Tronto insie-me a Fano, Civitanova Mar-che e Porto San Giorgio,guida la schiera dei centrinoti per le attività pesche-recce. Il rapporto privile-giato con il mare ha favori-
to nel tempo la nascita di una caratteristica tradizione cu-linaria e fin dall’Ottocento ha generato una naturale pre-disposizione all’accoglienza turistica, con l’affermarsidella “moda dei bagni di mare” introdotta dai ricchi bor-ghesi. Nel corso del tempo i centri costieri marchigianihanno realizzato numerose strutture balneari e sportivenonché alberghi lungo gli arenili e, dopo il boom del do -
poguerra, hanno accoltostabilmente parecchi turi-sti, italiani e stranieri. Ilmare delle Marche pre-senta infiniti e incantevoliaspetti. Il litorale è carat-terizzato da spiagge di sab-bia finissima o ghiaia che sialternano lungo tutta la co-sta, partendo da GabicceMare, spiaggia vegliata dal-l’alto dal monte San Bar-tolo e dal castello di Gra-dara, Pesaro, Fano, Marot-ta, Falconara M., Porto Re-canati, Porto Potenza Pi-cena, Civitanova Marche,Porto Sant’Elpidio, Casa-bianca di Fermo, Pedaso,Porto San Giorgio, CupraMarittima e Grottammarefino ad arrivare a San Benedetto del Tronto, nota per le al-tissime e numerosissime palme (circa 7000) di esoticabellezza. Particolarmente famosa è la spiaggia di Senigal-
lia, detta “spiaggia di vellu-to”, meta di viaggiatori findal XIX secolo. All’altezzadi Ancona e del promonto-rio del Cònero, unica pro-paggine appenninica chedall’Istria al Gargano si af-faccia sul mare, il litorale haconnotati aspri e selvaggi.Tra gli anfratti rocciosi l’ac-qua assume colorazioni az-zurrine, la cui trasparenzapermette di scorgere i fon-dali profondi. In questo trat-to di costa si aprono baiesegrete e i porticcioli in-cantevoli di Portonovo, Si-rolo e Numana, mete di tu-risti anche in primavera,quando il monte Cònero siricopre di ginestre, e in au-tunno, quando si ammantadei caldi colori del corbez-zolo (dal greco «kòmaros»).
I MUSEI DELLA COSTA
PAESI ALTI SUL MARE
La spiaggia di Gabicce Mare
I PARCHI A DUE PASSI DAL MARE
Dalle spiagge delle Marche è possibile risalire le valli escoprire l’incanto degli intatti paesi alti sul mare, borghiantichi, ricchi di tesori d’arte e beni monumentali qua-li chiese, conventi e palazzi storici. Si tratta di castelli me-dievali come Gabicce Monte, Casteldimezzo e Fioren-zuola di Focara oppure di borghi fortificati come Mon-dolfo con Marotta, Falconara Alta con Falconara Marit-tima, Montemarciano con Marina di Montemarciano,Sirolo, Numana, Recanati con Porto Recanati, Potenza Pi-cena con Porto Potenza Picena, Civitanova Alta con Ci-vitanova Marche, Sant’Elpidio a Mare con Porto Sant’El-pidio, Porto San Giorgio con la Marina, Fermo con Tor-re di Palme, Cupra Alta (o Marano) con Cupra Marittima,Grottammare Alta con Grottammare e San Benedetto delTronto con la Torre dei Gualtieri.
La diversa tipologia dellespiagge, la vicinanza allacollina e alla montagnapermettono di praticareattività sportive assai di-versificate: dalla vela algolf, dalle escursioni su-bacquee ai suggestivi per-corsi a cavallo, dallo scinautico alla mountainbike, dai tornei di beachvolley su spiagge di sab-bia finissima, al free clim-bing, arrampicati sullebianche falesie a picco sul mare Adriatico. A Vallugola, An-cona, Portonovo, Sirolo, Numana e Pedaso è anche pos-sibile praticare la pesca subacquea. Numerosi sono an-che i porti turistici: Gabicce Mare Loc. Vallugola, Pesaro,Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Civitanova Marche eSan Benedetto del Tronto. Un cenno particolare meritala Marina di Porto San Giorgio che, con i suoi 800 ormeggi,è il più importante porto turistico dell’Adriatico.
San Benedetto del Tronto,la “riviera delle palme”
Sono due i parchi regionali delle Marche che si affacciano di-rettamente sul mare. Tra Gabicce Mare e Pesaro è situato ilParco regionale del monte San Bartolo (tel. 0721400858), do-ve si possono effettuare visite guidate ed escursioni. Il par-co comprende una zona umida di rilevanza nazionale e ac-coglie durante l’inverno il gabbiano reale, il gabbiano coral-lino, la gavina e il cormorano. Il litorale è interrotto da piccolespiagge e anfratti rocciosi di rara bellezza. Il territorio del Parco regionale del monte Cònero (tel. 0719331161) è oc-cupato da boschi di leccio, di carpino e la vegetazione è ca-ratterizzata dalla macchia mediterranea. Il parco costituisceun eccellente punto di sosta e transito per uccelli migratoricome la poiana delle steppe, il falco pecchiaiolo e il falco dipalude. Numerose e affascinanti sono le escursioni natura-listiche e le gite a largo della costa. Da segnalare è anche laRiserva naturale regionale della Sentina (tel. 0735794278/279),situata tra Porto d’Ascoli a nord e il fiume Tronto a sud. Si pre-senta come un paesaggio di acqua e sabbia, in cui si alternanocordoni sabbiosi, zone umide e praterie salmastre dove tro-vano rifugio 143 specie di uccelli.La “Riviera del Cònero”
Per gli appassionati distoria del mare e dellamarineria sono visitabili:a Pesaro il Museo della ma-rineria pesarese “Washing-ton Pa tri gnani” (tel. 0721387474); a San Benedettodel Tronto il Museo delleanfore “G. Perotti” (tel.0735592177), il Museo itti-co (tel. 0735588850), il Mu-seo della civiltà marinara(tel. 073586855), la Pinaco-teca del Mare (tel. 0735794588) e a Cupra Maritti-ma il Museo malacologicopiceno (tel. 0735777550).
LO SPETTACOLO DELLA NATURA
La montagnaLa regione dal mare limpido e dalla spiaggia di vellutooffre straordinarie bellezze naturali anche nell’areamontana: la superba eleganza dei monti Sibillini con pae-saggio a tratti di carattere alpino; le grotte di Frasassidi spettacolare bellezza e le montagne ricoperte diestese aree boschive nel Montefeltro. La perla del pae-saggio montano marchigiano è il Parco nazionale deimonti Sibillini che si sviluppa per una lunghezza di cir-
me riserva naturale; la macchia di Montenero a Cingo-li e la valle dei Grilli, che si chiude nella gola di S. Eu-stachio, circondata dalle omonime grotte. Tra i comu-ni di Pieve Torina e Monte Cavallo, alle porte dei mon-ti Sibillini, si estende la Riserva naturale Montagna diTorricchio, riconosciuta come riserva biogenetica dalConsiglio d’Europa. L’abbazia cistercense di Chiara-valle di Fiastra è invece compresa nell’altra riserva na-turale, Abbadia di Fiastra, nota per il paesaggio agrarioche ha mantenuto nel corso del tempo segni e am-bienti di tipo medievale. (Per informazioni: Parco nazionale dei monti Sibillini,tel. 0737972711; Parco nazionale del Gran Sasso e mon-ti della Laga, tel. 086260521; Parco regionale del SassoSimone e Simoncello, tel. 0722770073; Parco regionaledella Gola della Rossa e di Frasassi, tel. 073186122; Ri-serva naturale Abbadia di Fiastra, tel. 0733201049; Ri-serva naturale Gola del Furlo, tel. 0721 700041; Riservanaturale Montagna di Tor ricchio, tel. 0737404512-517; Ri-serva naturale Ripa Bianca, tel. 0731619213; Riserva na-turale regionale del monte San Vicino e del monte Can-faito, tel. 0733637245).
Numerosi sono gli stabilimenti termali, adatti alla curadi diverse patologie. Nel Pesarese sono attive le TermePitinum a Macerata Feltria, già città romana, le Terme diMontegrimano nell’omonima località, le Terme di Raf-faello a Petriano e le Terme di Carignano, nei pressi di Fa-no. Nel cuore delle Marche a Genga, presso le grotte diFrasassi, si trovano le note Terme di San Vittore e, vici-no alla “Riviera del Cònero”, le Terme dell’Aspio. Nel Ma-ceratese sono rinomate le Terme di S. Lucia a Tolentinoe le Terme di Sarnano, alle porte dei monti Sibillini.Nelle province di Ascoli Piceno e Fermo si trovano ri-spettivamente Le Nuove Terme di Acquasanta nell’o-monima località, nota già al tempo dei Romani per le ac-que situate sotto il tracciato della Via Salaria, e lo Sta-bilimento Idropinico Palmense del Piceno a Torre di Pal-me, una delle terrazze sul mare del litorale fermano.
I MUSEI NATURALISTICI DELLE MARCHE
I LUOGHI DEL BENESSERE
Le grotte di Frasassi (nella foto a fianco), nel cuore del Par-co regionale della Gola della Rossa e di Frasassi e dell’o-monima gola scavata dal fiume Sentino, costituisconouno dei complessi carsici più interessanti e noti d’Italia.La cavità maggiore, detta Grotta grande del Vento, fu sco-perta nel 1971. Nel 1974 dopo essere state attrezzate, legrotte vennero aperte al pubblico e da allora attiranoogni anno migliaia di visitatori. All’interno piccoli laghi, sta-lattiti intarsiate, gigantesche stalagmiti si snodano in unsilenzioso itinerario ipogeo – dalla maestosa grotta chia-mata Abisso Ancona (alta 240 m) alla sala dei Duecento, al-la sala delle Candeline, alla sala dell’Orsa, alla sala del-l’Infinito – valorizzato da uno scenografico uso dell’illu-minazione. (Per informazioni: Consorzio Frasassi, tel.073290090/90080, www.frasassi.com).
Il viaggio attraverso i tesori ambientali delle Marche puòessere arricchito dalla sosta nei numerosi musei natu-ralistici e paleontologici presenti nel territorio: Apec-chio, Macerata Feltria, Piandimeleto e Piobbico nel Pe-sarese; Genga, Offagna, Ostra, e Serra San Quirico nel-l’Anconetano; Abbadia di Fiastra, Camerino, Macerata,Pioraco, Sarnano e Serravalle del Chienti nel Maceratese;Amandola, Fermo, Montefortino e Smerillo nel Ferma-no e Ascoli Piceno nell’omonima provincia.
IL MIRACOLO DELL’ACQUA E DEL TEMPO: LE MILLENARIE GROTTE DI FRASASSI
I monti Sibillini imbiancati dalla neve
LO SPETTACOLO DELLA MUSICA E DEI TEATRI
Musica e teatroConoscere le Marche significa anche fermarsi, nelle cittàd’arte e nei borghi antichi, in occasione dei tanti appun-tamenti con la musica e il teatro. La musica antica risuonanella provincia di Ancona con il Festival Cantar lontano,a Urbino, nel mese di luglio, con il Festival internaziona-le di musica antica, al quale sono affiancati corsi di spe-cializzazione nei vari strumenti e a Loreto, in aprile, conla ormai tradizionale Rassegna internazionale di musicasacra. Per la musica classica accanto alle proposte di ca-rattere internazionale offerte dalle stagioni liriche estive(luglio-agosto) dello Sferisterio a Macerata, del Rossini Ope-ra Festival (ROF) a Pesaro e dal Festival Pergolesi Sponti-ni, organizzato dall’omonima Fondazione di Jesi, nume-rosi sono gli appuntamenti. Sono da segnalare a Camerino,in agosto, il Camerino Festival, Rassegna internazionale dimusica e teatro da camera, a Fermo il Concorso ViolinisticoInternazionale “Andrea Postacchini” e nelle province di Fer-
mo e Ascoli il festival dimusica da camera Armo-nie della sera. A Recanati sirende omaggio al grandetenore Beniamino Gigli conle celebrazioni gigliane chesi tengono a marzo in oc-casione dell’anniversario
della nascita e a no-vembre in occasio-
ne dell’anniversa-rio della morte.A Senigallia sisvolge il Con-corso Organisti-co Internaziona-
le e a Grottam-mare il Festival Li-
szt. Da diversi annisi sono moltiplicate
le rassegne di musicaleggera e contempo-
ranea: a Fano si tiene lanota rassegna estiva Jazzby the sea, a Macerata, agiugno, Musicultura, il fe-stival della canzone popo-lare e d’autore. A Senigallia,in estate, si rievocano i mi-tici anni ’50 con il SummerJamboree. Ascoli Piceno eprovincia durante l’estatesi animano dei concerti diAscoli Piceno Festival, adAncona prosegue AnconaJazz, l’appuntamento più
antico della regione in questo settore; a San Severino sitiene a luglio il San Severi-no Blues Marche Festivale a San Benedetto delTronto in giugno il singo-lare Festival Leo Ferrè. Al-tro appuntamento impor-tante a livello musicale enon solo è il Festival Adria-tico Mediterraneo, che pro-pone concerti, spettacoliteatrali, esposizioni, in-contri, proiezioni, iniziati-ve e prevede la partecipa-zione di molti artisti pro-venienti da diversi paesi,diffondendo così la cultu-ra della pace e coopera-zione tra i popoli. NelleMarche, terra ricca di tra-dizioni, non potevano
mancare appuntamenti con la musica popolare: ad Api-ro nel mese di agosto si svolge il Festival internazionaledel folclore Terranostra, a Monsano sempre in agostogiungono i nomi più importanti della musica popolare efolk. A Castelfidardo, capitale mondiale della fisarmoni-
Tra le proposte più note figura laBiennale internazionale dell’umori-smo nell’arte di Tolentino (negli an-ni dispari), il tradizionale appunta-mento mondiale con l’arte satiricae umoristica contemporanea. AGrottammare tra luglio e agostosi svolge il Festival dell’Umori-smo Cabaret amore mio. Da se-gnalare anche le rassegne di tea-tro per ragazzi: in luglio I teatridel mondo a Porto Sant’Elpidio– il più importante appunta-mento italiano per il teatro del-l’infanzia – e la Rassegna na-zionale teatro della scuola di SerraSan Quirico (da aprile a maggio).
LA REGIONE DEI TEATRI
Nelle Marche si svolgono datempo manifestazioni spes-so uniche a livello naziona-le. A giugno la Mostra inter-nazionale del nuovo cinemadi Pesaro, in luglio, a SanBenedetto del Tronto, laRassegna nazionale del do-cumentario italiano LiberoBizzarri, in ottobre il FanoFilm Festival, per il cinemaindipendente italiano e stra-niero. La regione ha dedica-to la sua attenzione alla set-tima arte, il cinema, atti-vando il portale Marche Ci-nema e istituendo la Mar-che Film Commission. (Perinformazioni: www.cultura.marche.it).
TEMPO DI SORRISO
MARCHE E CINEMA
I MUSEI DELLA MUSICA
Oltre settanta teatri storici ospitano stagioni liri-che, sinfoniche, di danza e prosa. Le Marche sonostate definite la regione dei teatri, in gran partegioielli del Settecento e dell’Ottocento: grandi esfarzosi come quelli di Pesaro, Macerata e di Asco-li Piceno; preziosi perché conservano macchinariscenici d’epoca come quello di Offida. Teatri chesono autentici scrigni in miniatura come quello diMontegiorgio e il teatro della Rocca di Sassocor-varo. A Jesi il teatro G.B. Pergolesi è noto per la de-
corazione del soffitto eseguito da Felice Giani; a Fabriano nel teatro Gentile, l’acusticaè la migliore dei teatri delle Marche. A Fermo nel teatro dell’Aquila è stata allestita unasezione dedicata alla documentazione storica delle attività della struttura. Da segnalaresono i teatri Le Muse di Ancona, Misa di Arcevia, La Vittoria di Ostra, La Fortuna di Fa-no, il teatro Comunale di Cagli, in fastose forme neobarocche, il teatro La Fenice diOsimo e il Mercantini di Ripatransone.(Per informazioni: www.amatmarche.net).
Conoscere i grandi musi-cisti e cantanti significaindagare anche i luoghidove essi hanno vissu-to e amare i lorocimeli e docu-menti. Questoè possibile aPesaro, visi-tando la Ca-sa di Gioa-chino Rossi-ni e il Tem-pietto rossi-niano. A Maio-lati Spontini lavisita comprende ilMuseo Gaspare Spon-tini, già dimora del com-positore, la casa natale, latomba del maestro e il Par-co Celeste Erard voluto dal-la moglie del maestro. ARecanati un intero museoè dedicato al tenore Be-niamino Gigli ed è allestitonel Teatro Persiani. Si trat-ta della più grande rac-colta di cimeli e docu-menti originali dedicata aun artista lirico.
LO SPETTACOLO DELLA MUSICA E DEI TEATRI
Le rievocazioni storicheNello scenario di un territorio particolarmente ricco di be-ni culturali, le Marche tornano a vivere ogni anno la magiadel passato, fra corse a cavallo e sfilate in costume. Legiornate delle feste medievali spesso si caratterizzano perl’armonica unione di differenti forme artistiche: danza, mu-sica e teatro, che si fondono in un’affascinante combinazionedi tradizione e creatività. In provincia di Pesaro e Urbino al-cune manifestazioni si intrecciano alle vicende storichedelle signorie. A Piandimeleto, in luglio, il Palio dei Conti Oli-va celebra la vita di corte. A Urbino, la terza domenica d’a-gosto, si svolge la Festa del Duca, una rievocazione storicain costumi del Quattrocento con sfilate e gare a tema me-dievale. A Mondavio, in agosto, la Caccia al Cinghiale rievocauno dei passatempi preferiti dei Signori. A Gradara, luogodella passione di Paolo e Francesca, si rivive il Medioevo conl’Assedio al Castello. Non potevano mancare tre rievocazioniincentrate sui giochi: in agosto a Cagli si celebra il Palio del-l’Oca, con tanto di gigantesca scacchiera, a Fermignano si
la festa di SanVenanzio, patro-no della città. Laprima settimanadi luglio a SanSeverino Mar-che nel Palio deiCastelli gli atleticorrono portan-do alte torri pe-santi anche 70kg. Nello stessoperiodo si svol-ge a MoglianoMogliano 1744, afine luglio aMontecassianoha luogo il Paliodei Terzieri, inagosto a Calda-rola la Giostradelle Castella, aSan Ginesio la
Battaglia della Fornarina con il Palio di San Ginesio e la pri-ma domenica di settembre a Corridonia la Contesa della Mar-gutta. Singolari rievocazioni ottocentesche sono quelle, inagosto, di Cingoli 1848 in costume e carrozze d’epoca e laDisfida del Bracciale di Treia, che nella prima settimana d’a-gosto o nora il grande giocatore treiese Carlo Didimi im-mortalato dal la penna di Giacomo Leopardi nell’ode a lui de-dicata. Ad Ascoli Piceno, la prima domenica d’agosto, sisvolge una delle rievocazioni più note d’Italia la Quintana,dove oltre mille figuranti e cavalieri si battono contro un Mo-ro girevole e pesante. Nella provincia di Ascoli Piceno, nelmese di agosto, gli appuntamenti sono: ad Arquata delTronto Alla Corte della Regina, in costumi medievali, nellavicina Pretare la triennale Discesa delle Fate, a Spelonga latriennale Festa bella, rievocazione della battaglia di Le-panto e ad Acquaviva Picena il Palio del Duca. In provinciadi Fermo, la terza settimana di luglio, Sant’Elpidio a Mare sitrasforma in La città Medioevo e nella seconda domenica diagosto fa rivivere gli antichi fasti medievali con la Contesadel Secchio. In agosto si tiene a Servigliano il Torneo Ca-valleresco di San Clementino e a Grottazzolina I Giorni Di Az-zolino. Nota è il 15 agosto a Fermo “ La cavalcata dell’As-sunta”, con dieci cavalieri in costume che percorrono al ga-loppo le vie cittadine. Tra le celebrazioni in occasione di fe-ste religiose, vanno citate: la Domenica di Pentecoste L’Ar-mata di Pentecoste e Sciò la Pica di Monterubbiano, che rie-voca l’antica venuta nelle Marche dei Sabini al seguito di unpicchio posatosi su un vessillo; il Cavallo di Fuoco a Ripa-transone, la prima domenica dopo Pasqua, che regala nel-la notte fuochi artificiali particolarmente spettacolari. (Per informazioni: Associazione marchigiana rievocazionistoriche, www.rievocazionimarche.it).
A luglio nella città di Fano si rivivono con la Fano dei Ce-sari gli antichi fasti romani con cene a tema nei locali, cheper l’occasione si trasformano in autentiche taverne, sfi-late storiche, corse delle bighe accampamenti allestiti perospitare i legionari dell’esercito romano. Fano è anche lasede della più prestigiosa e antica manifestazione car-nevalesca della regione: giganteschi carri allegorici sfilanoper le vie della città con rogo finale del pupazzo, simbolodella festa (www.carnevaledifano.com). Oltre al Carnevaledi Ascoli Piceno, di S. Benedetto del Tronto, di Matelica,uno dei più noti e spettacolari è sicuramente il Carnevaledi Offida articolato in due momenti: Lu Bov Fint, il BoveFinto, il venerdì di Carnevale e il martedì grasso la Sfila-ta dei Vlurd. Tra le feste pagane si ricordano Halloween,la festa delle streghe a Corinaldo. A Urbania dal si orga-nizza la Festa Nazionale della Befana.
FESTE PAGANE E DI CARNEVALE
Le Marche hanno mantenuto intatte nel tempo alcune ma-nifestazioni legate a particolari festività religiose. La tra-dizione del Presepe, al quale sono stati dedicati tre musei(a Macerata, a Morrovalle e a Tolentino), è fortemente sen-tita nel territorio regionale: numerosi sono i Presepi arti-stici, meccanici e viventi, ambientati in luoghi altamentescenografici e suggestivi. Le principali rievocazioni dellaPassione del Venerdì Santo vengono rappresentate a Can-tiano, a Mogliano, a Loreto (Villa Musone) e a Pioraco. Sulterritorio frequenti sono le infiorate nel giorno del CorpusDomini. A Loreto, la notte del 9 dicembre, si celebra la sug-gestiva festa in ricordo della Venuta della Santa Casa. Glieventi religiosi legati al ciclo del grano sono la festa del Co-vo a Campocavallo di Osimo e la processione delle cane-strelle di Amandola.
FESTE RELIGIOSE
La Quintana si celebra la prima domenicad’agosto ad Ascoli Piceno
La Contesa del Secchio si svolge la seconda domenica diagosto a Sant’Elpidio a Mare
SHOPPING E BUONA CUCINA
Le Marche a tavolaDai sapori del pesce dell’Adriatico alle pietanze della tavoladella collina e della montagna, le Marche offrono un’in-credibile varietà di piatti tipici cucinati rispettando i ri-cettari e le antiche tradizioni. Molteplici sono le ricette dipesce, spesso uniche in tutta la costa; della zuppa di pesceo brodetto ne esistono varie versioni tra cui quella di San Benedetto del Tronto con peperoni verdi e quella di
Porto Recanati arricchita di zafferano nonchéquella di Fano. Lo stoccafisso all’ancone-
tana è una delle versioni italiane diquesto tipo di pesce più buo-
na e rinomata. Diffusa an-che la cucina di pesce di
acqua dolce in par-ticolare di trota,nella zona di Se-fro, nell’alta valledel Potenza o diUssita, ai piedi deimonti Sibillini. Il maiale rappre-senta il filo con-duttore della ga-stronomia del-
l’entroterra. Tra i gioielli regionali, in pochi lo sanno, la ce-lebre porchetta di maiale è nata proprio in questa regione.Maiale è sinonimo anche dei rinomati prosciutti di Car-pegna, di salame di Fabriano, di ciauscolo a Visso e nel Ma-ceratese, un tipo di salume da spalmare, e della coppa, uninsaccato marchigiano che ha per ingredienti quasi tuttele parti del maiale. Numerosi anche i tipi di formaggi rica-vati dal latte di pecora. La casciotta d’Urbino nell’area delMetauro e il diffuso pecorino, prodotto in tutte le aree mon-tane. Al confine tra Marche e Umbria, nell’area dei montiSibillini, diffusa è la cultura della lenticchia da abbinare azampone e cotechino nel periodo natalizio. Le Marchesono note anche per la coltivazione dei tartufi, sia bianchisia neri; le aree interessate sono l’alto Pesarese per en-trambi i tipi di tuberi, un piccolo centro dell’ascolano, Co-munanza, per il tartufo bianco e nel maceratese Castel-santangelo sul Nera per il tartufo nero. Ad Ascoli Piceno ap-
partiene l’oliva ascolana, uno dei piatti più noti della re-gione, simbolo della gastronomia picena, farcita di carne
e poi fritta. La tradizio-ne della pasta trova in-vece la sua massimaespressione nei mac-cheroncini di Campo-filone, sottilissimi ta-gliolini che si abbinanocon ragù di carne; allaseconda metà del Set-tecento risale invece lacelebre ricetta dei vin-cisgrassi, la caratteri-stica pasta fatta in casacomposta da sfoglie astrati farciti di carne,funghi e besciamella,
nelle due versioni anconetana e maceratese. Infine laschiera dei dolci, abbinati a vini liquorosi come il vino divisciola e il vin santo: i funghetti di Offida, i cavallucci di Api-ro e Cingoli, i salami di fichi diffusi un po’ ovunque, i cal-cioni, il bostrengo tipico del Pesarese, il torrone e la fro-stenga a Camerino, dolce natalizio farcito anche con uvet-ta, noci e fichi secchi e le infinite varietà di ciambelloni ecrostate con marmellata fatta in casa.
Da segnalare sono gli ap-puntamenti autunnali conle Fiere del tartufo aSant’Angelo in Vado, Ac-qualagna e Amandola. Unil lustre estimatore dellacasciotta d’Urbino DOP fuMichelangelo. Quandol’ar tista toscano risiedevanella sua casa di Urbania,un tempo Casteldurante,amava ricevere in dono lecasciotte prodotte con illatte di pecora della zonadel Metauro.
PER TUTTI I GUSTI
LE FESTE E I MUSEI DEL VINO
Numerosi nelle Marche sono i musei della civiltà contadina, che all’interno custodiscono gli strumenti del lavoroe gli ambienti quotidiani dove si svolgeva la vita della famiglia del mezzadro, tra questi è compresa la cucina. Ilpiù noto è il Museo di storia della mezzadria “Sergio Anselmi” a Senigallia. Segnaliamo inoltre il Museo diAmandola, dell’Abbadia di Fiastra nei pressi della omonima abbazia cistercense, di Fabriano, Montefiore dell’Aso,Montegiorgio (con riferimento alla cultura contadina picena), Montelupone, Morro d’Alba, Offida, Piandimeleto,Pieve Torina, Ripatransone e Sassoferrato. A Sant’Angelo in Vado è stato dedicato un museo ai Vecchi Mestieri. Trai musei più particolari, legati ad aspetti del lavoro dell’uomo nelle Marche del XIX e XX secolo, spicca il Museodella miniera di zolfo di Cabernardi, il Museo delle carbonaie a Cessapalombo, il Museo della carrozza di Maceratae il Museo del biroccio di Filottrano dedicato ai carri agricoli marchigiani dipinti in svariati colori.
I MUSEI DELLA CIVILTÀ CONTADINA
Le amarene di Cantiano
Il pesce è un elemento basilaredella cucina marchigiana
Il tartufo è protagonistanella stagione autunnale
In genere a ognuno dei numerosi vini DOC marchigianiè dedicata una fiera nel corso dell’anno o particolari iti-nerari nelle cantine. Il più noto tra i vini marchigiani è si-curamente il Verdicchio dei Castelli di Jesi, celebrato inottobre nell’antica Festa dell’Uva di Cupramontana, se-de del Museo Internazionale dell’Etichetta e di un’an-nessa enoteca comunale. Altre iniziative di rilievo anchenazionale sono il Verdicchio in festa a Montecarotto nelmese di luglio, mostra mercato dei vini delle Marche,mentre in autunno il Concorso Verdicchio d’oro a Staffo-lo, sede di un’enoteca comunale e del Museo Arte del Vi-no. Molto noto è anche il Verdicchio di Matelica. Tra i ros-si spiccano il Rosso Cònero, cui sono dedicate una festala prima settimana di settembre a Camerano e un sin-golare itinerario turistico-culturale intitolato Le strade delRosso Cònero. Il Rosso Piceno Superiore è celebratocon la Mostra Mercato dei Vini a Offida a settembre. Se-guono la Vernaccia di Serrapetrona (sagra in agosto), laLacrima di Morro d’Alba (sagra in maggio). Noti tra i bian-chi sono il Falerio dei Colli Ascolani, il Bianchello del Me-tauro e il Bianco dei Colli Maceratesi. Altri vini DOC so-no l’Esino, il Rosso Piceno, il Serrapetrona, le Terre di Of-fida, I Terreni di San Severino, il Pergola e il San Ginesio.Le Marche vantano anche 5 DOCG: la Vernaccia di Ser-rapetrona, il Conero Riserva, il Verdicchio di Matelica Ri-serva, i Castelli di Jesi Verdicchio Riserva e Offida. A set-tembre a Potenza Picena si organizza il Grappolo d’Oro.Alla “cultura del vino” sono dedicati: la Festa della sapaa Rosora, la Sagra dell’acquaticcio a Belforte del Chien-ti, la Sagra del vino cotto a Loro Piceno e la Festa del vi-no cotto a Lapedona (info: www.turismo.marche.it)
SHOPPING E BUONA CUCINA
Le mani sapienticittà, Jesi, dove sono diffuse le botteghe degli orafi, pre-senti anche a Fano e a Fossombrone. A Pietrarubbia è sta-to aperto il T.A.M. (centro Trattamento Artistico dei Metal-li), nell'estate del 1990 per iniziativa del Comune di Pietra-rubbia e in accordo con lo scultore Arnaldo Pomodoro. IlCentro svolge da anni un’importante attività formativa perla salvaguardia e la sperimentazione dell’attività artistico-artigianale legata al trattamento dei metalli, dalla sculturaall’oreficeria. È visitabile anche la mostra permanente delT.A.M., dove vengono esposte le opere più significative de-gli allievi del corso con tanto di mostra organizzata duran-te l’estate. A Offida, nell’Ascolano, l’arte del merletto a tom-bolo viene tramandata da almeno cinque secoli. In estatesi tiene una mostra dei capolavori realizzati dall’abilità del-le merlettaie. Nel Museo del merletto a tombolo sono espo-sti lavori antichi e moderni, appartenenti a corredi realiz-zati tra fine Ottocento e inizio Novecento. A Macerata pres-so il Laboratorio “La Tela” di Ginesi e Varagona viene anco-ra praticata l’arte della tessitura su telai manuali. In prossi-mità dell'Abbazia di San Michele Arcangelo a Lamoli, fra-zione del comune di Borgo Pace, nel museo dei colori natu-rali ci si occupa del recupero, della coltivazione e della la-vorazione delle foglie delle piante coloranti per produrredei colori vegetali e sperimentare la loro applicazione nellatintura dei tessuti. Nel settore tessile va segnalata intorno aCantiano e Mercatello sul Metauro, nel Pesarese, la produ-
zione di tappeti rustici inlana. Nota in tutto il mon-do è la lavorazione del mo-bile in particolare nel Pe-sarese, mentre abbastan-za diffusa è la pratica delrestauro del mobile anti-co, a Pollenza, Amandola,Fermo, Corinaldo e Ostra.Fiorente è anche la lavora-zione di strumenti musi-cali, dalle celebri fisarmo-niche di Castelfidardo, conrelativo Museo Internazio-nale, alle chitarre di Reca-nati, all’attività di liutaioad Ascoli Piceno. Nel Ma-ceratese, in particolare aMogliano, è diffusa la lavo-razione di giunco, viminee bambù che, intrecciati,danno vita a borse, conte-nitori di varia forma, so-prammobili e elementid’arredo.Nel Fermano, da Montap-pone a Massa Fermana, è il
regno della produzione del cappello, onorata da un museoa Montappone. Molto diffusa nelle Marche, da Cagli a Pesa-ro con Mastro de Pajaa, da Loreto a Recanati la lavorazionedi pipe in legno. Da non dimenticare, infine, la tradizionedella lavorazione della pietra, dal travertino che ancora og-gi caratterizza gli splendidi palazzi di Ascoli Piceno, a quel-la tipica nel Pesarese, da Sant’Ippolito a Cagli.
In estate numerosi sono gli appuntamenti con l’anti-quariato: dalla rassegna nazionale di Sarnano, da mag-gio a giugno, alla mostra mercato di Fermo, in luglio eagosto, dalla mostra regionale di Ostra, in agosto, al-l’Esposizione dell’Antiquariato, Restauro e ArtigianatoArtistico di Pollenza in luglio. Durante tutto l’anno,ogni mese, si tengono mostre mercato d’antiquariato aFano, Pesaro, Urbino, Ancona, Recanati, Sassoferrato,Tolentino, Ascoli Piceno, Grottammare e San Benedet-to del Tronto.
L’ANTIQUARIATO NELLE MARCHE
Il merletto a tombolo è una celebre tradizione regionale
Un artigiano lavora il rame
È un itinerario affascinante quello all’interno della provinciadi Pesaro e Urbino, nelle antiche terre della maiolica alla sco-
perta dei caratteristici piatti ama-tori, boccali, vasi da farmacia, cop-pe, albarelli e crespine, prodottiancora oggi dalle botteghe del ter-
ritorio. La prima tappa è costi-tuita dai Musei civici di Pesaroal cui interno si trova il Museodelle ceramiche – uno dei piùimportanti d’Italia con rariesemplari delle più celebri
fabbriche dal Rinascimentoal Settecento – e dalla Galleria
Nazionale di Urbino: il PalazzoDucale infatti ospita, tra gli altricapolavori, piatti urbinati delRinascimento. La vicina Urba-nia, già Casteldurante, offre due
collezioni di maiolica nel Museo civico, con cartoni e disegnidei ceramisti del Cinquecento e Seicento, uniche in Italia, enel Museo diocesano. A Pietrarubbia, Jesi, Loreto e Ascoli Pi-ceno si possono visitare altri musei dedicati alle ceramiche.
MAIOLICA DI CORTE
Urbania: Museo civico, maiolica del sec. XVI
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Testa di guerriero picenoproveniente da Numana
Nei teatri e anfiteatri di epoca romana delle Marchesi rappresentano sia antiche commedie di Plautoche suggestive tragedie greche. Durante il periodoestivo, vengono ospitate stagioni teatrali nella pro-vincia di Macerata presso l’anfiteatro romano(sec. I d.C.) dell’antica «Urbs Salvia», attuale Urbi-saglia, e nella provincia di Fermo nel teatro (sec. Id.C.) della romana «Faleria», oggi Falerone. En-trambi i luoghi sono inseriti in un parco archeolo-gico con relativo museo.(Per informazioni: www.amatmarche.net).
ANTICHE MUSE A CIELO APERTO
Un settore importante nel panorama dei beni culturali èquello dell’archeologia. Nelle diverse province del ter-ritorio sono stati istituiti 7 parchi archeologici: ForumSempronii, in località San Martino del Piano (Fossom-brone) in provincia di Pesaro e Urbino, Sentinum a suddi Sassoferrato e Suasa Senonum a Castelleone di Suasain provincia di Ancona, Septempeda a San SeverinoMarche e Urbs Salvia a Urbisaglia in provincia di Mace-rata, Falerius Picenus, in località Piane, a 2 km dall’o-dierna Falerone in provincia di Fermo, Cupra Maritimaa nord dell’abitato di Cupra Marittima in provincia diAscoli Piceno. Accanto ai parchi archeologici sorgono an-che i rispettivi musei.(www.cultura.marche.it – www.archeomarche.it).
PARCHI ARCHEOLOGICI
Urbisaglia, l’anfiteatro romano risalente al I secolo d.C.
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
I luoghi del silenzioDopo la caduta dell’Impero romano le Marche furono do-minate dall’Esarcato bizantino a nord di Ancona e daiLongobardi del ducato di Spoleto; divennero poi terradi contesa tra l’Impero e lo Stato della Chiesa, finchéquest’ultima ne divenne unica titolare. Il lungo periododi incertezza amministrativa e la lontananza dal centrodi potere papale, cioè Roma, favorirono nella regione ladiffusione, a partire dall’VIII-IX secolo, del monachesi-mo benedettino dai centri di Norcia e Farfa. I monaste-ri e le abbazie sorsero soprattutto lungo le principali viedi comunicazione romane – la Via Flaminia e la Via Sa-laria – e lungo le valli fluviali che dall’Adriatico risalgonoverso l’Appennino, come le valli dei fiumi Esino, Potenza,Chienti e Metauro. I benedettini lasciarono la loro im-pronta nelle chiese basilicali di S. Michele a Lamoli nel-l’alta valle del Metauro, di S. Vincenzo al Furlo lungo laVia Flaminia, di S. Firmano a Montelupone quasi alla fo-ce del fiume Potenza, dei Ss. Ruffino e Vitale ad Aman-dola, vicino al fiume Tenna alle falde dei monti Sibillini.I farfensi invece stabilirono il proprio insediamentonell’Ascolano giungendo dal Lazio lungo la Via Salaria:tra i luoghi di culto fondati il più importante è la chie-sa di Santa Vittoria di Santa Vittoria in Matenano. Gli uni-ci esempi appartenenti al filone cluniacense franco-bor-gognone sono invece S. Maria di Portonovo, ai piedi del
monte Cònero e S. Maria a Pie’ di Chienti a Montecosaro.Nella regione figurano anche due magnifici esempi diarchitettura cistercense romanico-gotica: a Chiaraval-le l’abbazia di S. Maria in Castagnola, fondata dai
monaci di Clairvaux enei comuni di Urbisagliae Tolentino l’abbazia diChiaravalle di Fiastra,fondata dai monaci dellaomonima chiesa milane-se e dedicata a Santa Ma-ria. Tra gli imponenti edi-fici a pianta centrale fi-gurano S. Ciriaco ad An-cona, sorto su un pree-sistente tempio grecodedicato a Venere Eu-plea e San Giusto in SanMaroto a Pieveboviglia-na.Le chiese di derivazionebizantina sono: S. Crocedei Conti a Sassoferrato,S. Vittore delle Chiuse aGenga e S. Maria delleMoje a Maiolati Spontinisituate a breve distanzal’una dall’altra, S. Clau-dio al Chienti, dispostasu due piani con la fac-ciata delimitata da duetorri angolari cilindriche.
Gli itinerari della fede nelle Marche seguono tre assi viari principali, dove sono se-gnalati abbazie, eremi francescani e santuari. La Via Flaminia e le sue varianti ar-rivano ad abbracciare la valle costel-lata di abbazie che da Ancona risa-lendo l’Esino conduce verso Roma.Senigallia è la città natale di papa PioIX e Corinaldo la terra di Santa MariaGoretti. L’altro asse viario è la ViaLauretana e le sue varianti che, dallaSanta Casa di Loreto, meta di pelle-grinaggi già dal XV secolo, arrivano al-l’itinerario romanico lungo la valledel Chienti, alla basilica di S. Nicola daTolentino e al cinquecentesco San-tuario di Macereto, circondato dallesplendide altezze dei monti Sibillini.Infine la Via Salaria e le sue varianticonducono nelle terre di papa Sisto V(Grottammare e Ripatransone), di SanGiacomo della Marca (Monteprando-ne) e dei farfensi, ricche di monu-menti romanici, eremi, abbazie e san-tuari, da Fermo e da Ascoli Piceno al-le terre del Parco nazionale dei mon-ti Sibillini. Tolentino, la basilica di S. Nicola
Fu San Romualdo, fondatore dell’or-dine camaldolese, a erigere nelle Mar-che la potente abbazia di S. Salvatore inValdicastro (1006 circa) vicino Fabriano,dove morì nel 1027, e a ispirare ai mo-naci di Fonte Avellana, alle falde delmonte Catria, la prima forma di vitaorganizzata. In questo appartato luogodi meditazione, immerso nei boschisolitari, frequentato e citato da Dantenel XXI Canto del Paradiso, nel 1035prese l’abito monastico Pier Damiani,probabile ospite anche dell’abbazia di S. Maria di Portonovo sul monte Cònero.(Per informazioni: Monastero di FonteAvellana, tel. 0721730261).
UN LUOGO DANTESCO. IL MONASTERO DI FONTE AVELLANA
L’eremo camaldolese di Fonte Avellana
Loreto, il santuario della Santa Casa meta di molti pellegrini
GLI ITINERARI DELLA FEDE
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Le città d’arteNelle Marche le città d’arte, circa un centinaio su due-centotrentanove comuni, sono l’espressione compiuta diun pluralismo culturale sedimentato da secoli, rintrac-ciabile nel frazionato sviluppo storico della regione. Nel-
la provincia di Pesaroe Urbino le maggioricittà raggiunsero lamassima importanzanel periodo rinasci-mentale: Fano e Grada-ra furono governate daiMalatesta. Urbino futeatro delle ambizioniumanistiche di Federicoda Montefeltro. Pesaro,Urbania – l’ex Castel-durante delle maioliche– e Senigallia, furonosedi della famiglia deiDella Rovere. Anconaha da sempre legato la
sua esistenza al porto, secondo per importanza solo a Ve-nezia, nel mare Adriatico. Nella parte più antica della cit -tà svetta labella catte-drale roma-nica di S. Ci-riaco e nu-merosi mo-numenti te-stimonianola felice sta-gione cultu-rale quattro -c e n t e s c a . A pochi chi-lometri daAncona, lacittà di Lo-reto, sede diuno dei san-tuari tra ipiù famosi evisitati delmondo, do-ve lavoraro-no Melozzoda Forlì, Lu-ca Signorel-li, Bramante,Sansovino eLorenzo Lot-
to. Vicina aLoreto èOsimo. Nel-l’entroterradi Ancona siapre la valledell’Esino,dominata daJ e s i ,l’«Aesis» ro-mana cir-condata daantiche mu-ra. Risalen-do la valle siragg iungeF a b r i a n oche, nota intutto il mondo per la lavorazione della carta, conserva in-tatto il suo aspetto medievale. Proseguendo in dire-zione Castelraimondo e Matelica si arriva a Camerino,in provincia di Macerata, protagonista di un’intensafioritura economica e artistica nel Quattrocento, sottola signoria dei Da Varano. Da Camerino si può proseguireper Tolentino, dove il cappellone della basilica di S. Ni-cola rappresenta in Italia uno dei maggiori esempi discuola giottesco-riminese. Poco distante da Tolentinola cittadina di San Severino Marche che, nata nei pres-si della romana «Septempeda», divenne tra Trecento eQuattrocento uno dei centri europei del gotico inter-nazionale, grazie ai fratelli Salimbeni. Macerata, è riccasoprattutto di arte rinascimentale, barocca e sette-centesca. Si incontra Fermo, uno dei centri più fioren-
ti nelle Marche dell’epocaromana e medievale. An-cora più a sud si trova Ri-patransone , piccologioiello ricco di repertiarcheologici e di monu-menti. A pochi chilome-tri Offida, dalle mura in-tatte, conserva ancora larocca e la maestosa ab-bazia S. Maria della Roc-ca. Il capoluogo di pro-vincia Ascoli Piceno te-stimonia, nei monumentiromani e medievali, lostraordinario passato se-gnato per sempre dal cal-do colore del travertino edalla Via Salaria, di cui re-stano alcune tracce, spes-so inglobate in edifici me-dievali.
Nelle terre dell’antico ducato di Urbino (provincia diPesaro e Urbino e in parte di Ancona fino a Senigallia),governato dai Montefeltro e poi dal 1508 dai Della Ro-vere, vi sono itinerari per conoscere i luoghi che co-stituirono lo sfondo alle vicende politiche e cultura-li delle famiglie ducali. Urbino, Pesaro, Urbania, Fos-sombrone e Senigallia conservano il Palazzo Ducale;Cagli, Mondavio e Sassocorvaro fanno parte dell’iti-nerario dedicato alle rocche, in gran parte rimodellateda Francesco di Giorgio Martini su ordine di Federi-co da Montefeltro. I musei da Urbino a Pesaro, da Ur-bania a Fossombrone, le chiese, come il convento diMontefiorentino, dove vi è una cappella quattrocen-tesca dei conti Oliva, e la pieve Collegiata di Merca-tello sul Metauro, svelano le opere d’arte nate dalleraffinate commissioni dei duchi.(Per informazioni: IAT di Urbino, tel. 07222613; IAT diFano, tel. 0721803534).Urbino, il Palazzo Ducale
Camerino, la porta Malatesta
Panoramica di Ascoli Piceno
Fabriano, il Loggiato di S. Francesco si affacciasulla piazza del Comune
Nel XV secolo Ascoli Piceno ebbe tra gli altri un «civis»illustre, l’artista veneto Carlo Crivelli, che costellòcon i suoi seguaci i centri del Fermano, dell’Ascolanoe del Maceratese di superbi polittici, animati da santiabbigliati in maniera raffinata e preziosa. Da Ascoli Pi-ceno (Duomo, Pinacoteca e Museo diocesano), l’itine-rario alla scoperta delle opere di Carlo Crivelli condu-ce in centri antichi e intatti come Montefiore dell’Asonella provincia di Ascoli Piceno e Massa Fermana nel-la provincia di Fermo e prosegue a Monte San Martino(chiesa di S. Martino), Corridonia (Pinacoteca parroc-chiale), Macerata (Pinacoteca comunale), nell’omoni-ma provincia, per poi giungere fino ad Ancona (Pina-coteca civica). (Per informazioni: www.cultura.marche.it).
SULLE TRACCE DI CARLO CRIVELLI
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Rocche e castelliNelle Marche, da «Mark» che in tedesco significa confine,la lontananza dal centro del potere imperiale favorì lanascita delle autonomie comunali che successivamente,tra Trecento e Quattrocento, generarono la costituzionedi stati e aree autonome rette da famiglie in perenne lot-ta tra loro. Queste vicende storiche spiegano la copiosa dif-fusione di rocche e castelli nella regione, a testimonianzadi un passato culturale vivace e aperto alle sperimentazionidei più validi e noti architetti militari del tempo. Nel territorio che oggi corrisponde alla provincia di Pesaroe Urbino furono i Malatesta ad accogliere per primi nuo-ve soluzioni difensive, avvalendosi per la rocca di Fano deiconsigli di Filippo Brunelleschi e dell’esperienza di Mat-teo Nuti. Furono seguiti dalla signoria degli Sforza a Gra-dara (già rocca malatestiana) e Pesaro (rocca Costanza,opera di Luciano Laurana). I Montefeltro si avvalsero aloro volta del genio di Francesco di Giorgio Martini perle opere difensive (rocca di Sassocorvaro, rocca di Monte
cuito delle mura; risalendo la valle del Misa, Arcevia e isuoi castelli tramandano atmosfere medievali; nella Val-lesina sono Jesi con i castelli del Verdicchio e poi Fabria-no, circondato dai suoi presidi, che restituiscono la sen-sazione di un fiero e battagliero passato. Alcuni dei castellipiù belli e suggestivi della regione si trovano a poca di-stanza tra loro in provincia di Macerata, dove i signori di
Camerino circondaronole loro città di un impo-nente sistema di castelli,fra questi si segnalano aCamerino la rocca d’Aielloe la rocca da Varano, a Ca-stelraimondo il castello diLanciano, a Caldarola ilcastello Pallotta e il palaz-zo dei Cardinali, attualesede comunale, a Tolenti-no il castello della Ranciae a Urbisaglia, la poderosarocca. Nell’Ascolano e nel-le sue adiacenze lungo laVia Salaria, si affaccianoArquata del Tronto con la
PASSIONE A GRADARA
Sono numerosi i castelli e palazzi marchigiani che ospitano iniziative, mostre o musei per-manenti. A Cagli il Torrione è sede del Centro di scultura contemporanea (opere di E. Mattiacci,J. Kounellis, H. Nagasawa ecc.), mentre la rocca di Sassocorvaro ospita il Museo “L’Arca del-l’Arte” nato per ricordare il salvataggio di migliaia di opere d’arte durante il secondo conflit-to mondiale. La rocca di Gradara conserva cicli pittorici rinascimentali, a Mondavio è allestitoil Museo di rievocazione storica e l’Armeria, Urbino ospita la Galleria Nazionale delle Marche,a Piobbico, presso il Palazzo Brancaleoni, si trova il Museo geo-paleontologico, naturalistico,antropico e ornitologico “Brancaleoni” e la mostra permanente dal titolo Abiti e gioielli di unanobile casata. A Senigallia la rocca ospita una mostra permanente sui Della Rovere. A luglio sisvolgono le Feste medievali a Offagna, la cui rocca è sede del Museo delle armi antiche. Il ca-stello della Rancia a Tolentino ospita il Museo Civico Archeologico Aristide Gentiloni Silverj emostre temporanee, la rocca di Acquaviva Picena è teatro del Palio del Duca e, come la roc-ca di Urbisaglia, è sede di un museo delle armi antiche. Castel di Luco è stato adibito a ristorante.
L’ARTE NELL’ARTE
Mondavio, la rocca costruita da Francesco di Giorgio Martini
Il castello della Rancia nel cuore della valle del Chienti
Offagna, l’imponente rocca
Panoramica di Arquata del Tronto dominata dalla rocca
Gradara, con la rocca e il suonucleo abitativo medievale, co-niuga passato e moderno gra-zie all’allestimento di impor-tanti mostre contemporanee.La città, “Capitale del Medioe-vo”, fa parte dei Borghi più bel-li d’Italia ed è stata insignitadella Bandiera Arancione. Luo-go ideale per festeggiare SanValentino nel mistero che an-cora avvolge la storia d’amoretra Paolo e Francesca narratada Dante Alighieri nell’Inferno.
Uno scorcio del tipico borgomedievale di Gradara
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Marche, museo diffusoI tesori dell’arte, le testimonianze delle civiltà delpassato e le mille curiosità di questa regioneantica sono conservati nei 400 musei e rac-colte d’arte, diffusi nelle Marche, dallacittà d’arte al piccolo centro storico.Uno dei principali musei marchigiani èla Galleria Nazionale delle Marche, si-tuata nel Palazzo Ducale a Urbino. Inquesto gioiello architettonico sono con-servati capolavori concepiti per la cittàe per questi spazi al tempo dei Monte-feltro (opere di Agostino di Duccio, Lu-ca Della Robbia, Luciano Laurana, Pierodella Francesca, Paolo Uccello, Giusto diGand e Raffaello) e dei Della Rovere(opere di Tiziano, Federico Barocci eClaudio Ridolfi). A pochi chilometri daUrbino il Museo civico di Urbania con-serva la più grande collezione di disegnidi Federico Barocci dopo quella degli Uf-fizi e due rari globi di Gerardo Merca-tore. A Pesaro nei Musei civici è visibi-le un’opera chiave del Quattrocentoitaliano, la monumentale Incoronazionedella Vergine di Giovanni Bellini; nel Museo archeologico Oli-veriano accanto ai reperti romani spiccano i materiali del-la civiltà picena, tra cui la celebre stele di Novilara, uno deiprincipali luoghi di insediamento di questa civiltà nelleMarche. Il Museo civico e la Pinacoteca di Fano, nello storicopalazzo Malatesta, ospitano la preziosa Madonna della Ro-sa di Michele Giambono e una ricca serie di tele di alcuni dei
maggiori artisti delSeicento: Guido Re-ni, Guercino, Do-menichino, SimoneCantarini, MattiaPreti e CorradoGiaquinto. Ad An-cona, a poca di-stanza dal Museoarcheologico na-zionale delle Mar-che – tappa fonda-mentale per cono-
scere la storia degli insediamenti della regione, dalla prei-storia al Medioevo – la Pinacoteca civica racchiude una se-rie di capolavori di Olivuccio di Ciccarello, Carlo Crivelli, Se-bastiano del Piombo, Tiziano, Lorenzo Lotto, Orazio Gen-tileschi, Andrea Lilli, Guercino, Carlo Maratta e Francesco
Podesti. Se Jesi è una delle mete fondamentaliper conoscere Lorenzo Lotto, la Pinacoteca ci-
vica di Fabriano restituisce il vivace climaartistico della città che diede i natali aGentile, il più illustre rappresentantedel gotico internazionale. A breve di-stanza da Fabriano si trova Matelica, do-ve il singolare Museo Piersanti rac-chiude tesori d’arte dal XIII al XIX se-colo, oggetti di arte sacra e mobili d’e-poca. Da Camerino, che nei suoi museiospita dipinti su tavola e sculture del XVsecolo, si prosegue per San SeverinoMarche la cui Pinacoteca custodisceun polittico di Paolo Veneziano, capo-lavori su tavola e affreschi dei fratelli Sa-limbeni e un polittico di Vittore Crivel-li. Nella Pinacoteca di Fermo sono cu-stodite, oltre a uno dei rari dipinti di Ru-bens presenti in Italia, l’Adorazione deipastori del 1601, Le storie di S. Lucia, ot-to tavolette di Jacobello del Fiore, ca-polavoro del gotico internazionale. Unavasta panoramica dell’arte italiana è
nella Pinacoteca civica di Ascoli Piceno: da Carlo Crivelli ei crivelleschi, il percorso si snoda con i capolavori di Simonede Magistris, Tiziano, Guido Reni, Orazio de Ferrari, LucaGiordano, Carlo Maratta, Guercino e Pelizza da Volpedo.
L’artista, nato a Venezia nel 1480 e morto a Loreto tra il 1556 e il 1557, lascia a Re-canati il polittico di S. Domenico (1508) e altri capolavori come la Trasfigurazione (1512c.) e l’Annunciazione (1532 c.), che si possono ammirare nella Pinacoteca civica. DaRecanati, l’itinerario lottesco si snoda in diversi centri della regione dove il maestrooperò fino alla sua morte. A Jesi, in Pinacoteca sono conservate opere di capitaleimportanza per il Rinascimento italiano, ovvero la Deposizione (1512), la pala di S.Lucia (1538), la Visitazione (1531-1534) e la Madonna delle Rose (1526). A Loreto, cheaccolse Lotto negli ultimi anni di vita, sono ospitate opere come la drammatica Pre-sentazione al tempio. Ad Ancona, la Pinacoteca ospita la monumentale Madonna conil Bambino e Santi (1532), mentre la Madonna del Rosario eseguita l’anno seguentesi trova in Pinacoteca a Cingoli. Le opere dell’artista sono conservate anche nellechiese per cui furono commissionate, come, nella provincia di Macerata, a MonteS. Giusto dove la chiesa di S. Maria in Telusiano racchiude la spettacolare Crocifis-sione e, a pochi chilometri, a Mogliano la chiesa parrocchiale custodisce l’Assunta(1548); uno stesso soggetto è nell’altare maggiore della chiesa di S. Francesco alle Sca-le di Ancona (1555). La radicata presenza nelle Marche di Lotto precede l’esperienzadi un altro grande artista veneto, Claudio Ridolfi che elesse tra Cinquecento e Sei-cento Corinaldo, in provincia di Ancona, come sua dimora e che costellò di dipin-ti i centri vicini, da Ostra a Pergola, da Arcevia a Mondolfo e Fabriano.Nella foto: Jesi, chiesa di S. Domenico, l’Arcangelo Gabriele di Lorenzo Lotto.(Per informazioni: www.lorenzolotto.info).
LO SPIRITO INQUIETO DEL RINASCIMENTO: LORENZO LOTTO NELLE MARCHE
Ascoli Piceno, polittico di Carlo Crivelli
LO SPETTACOLO DELLA CULTURA E DELL’ARTE
Forse non tutti sanno chenelle Marche esistono 500piazze nei centri storicidelle città d’arte e dei bor-ghi antichi; migliaia dichiese di cui 200 romani-che; 90 abbazie e impor-tanti santuari; 7 parchi ar-cheologici; 400 musei eraccolte d’arte su 239 co-muni; oltre 70 teatri stori-ci; 180 km di costa con 26località turistiche che siaffacciano sul mare Adria-tico. Cifre incredibili quin-di e una serie veramentenutrita di personaggi illu-stri. Federico II Hohen-staufen nacque a Jesi il 26 dicembre 1194; una delle ope-re più importanti del Rinascimento, scritta da Baldas-sare Castiglione tra il 1508 e il 1516, è Il Cortegiano am-bientato presso la corte del Duca di Urbino; PadreMatteo Ricci, colui che introdusse la cultura occiden-tale in Cina, nacque a Macerata il 6 ottobre 1552. Tregrandi compositori: Giovanni Battista Pergolesi, (Jesi1710 – Pozzuoli, 1736), Gaspare Spontini (Maiolati 1774– Maiolati 1851) e Gioachino Rossini (Pesaro 1792 – Pa-rigi 1868). Nelle Marche di Giacomo Leopardi sono na-ti a Camerino Ugo Betti (1892–1953), uno dei più gran-di drammaturghi italiani dopo Luigi Pirandello, a Ma-telica il romanziere Libero Bigiaretti (1906–1993), a Ur-bino lo scrittore Paolo Volponi (1924–1994) e a Cupra-montana Luigi Bartolini (1892–1963) poeta e il più gran-de incisore italiano del Novecento insieme a Giorgio Mo-randi. Le Marche vantano inoltre alcuni dei poeti più impor-tanti del panorama attuale: Eugenio De Signoribus,Umberto Piersanti, Gianni D’Elia, Guido Garufi e Fran-co Scataglini (1930 –1994). Un grande patrimonio let-terario è conservato nelle 315 biblioteche, di cui alcu-ne secolari come quella del monastero di Fonte Avellananel Pesarese e antiche come quella Oliveriana di Pesaroe della famiglia Leopardi a Recanati. Dai letterati agli ar-tisti, nella terra di Gentile da Fabriano, Bramante e Raf-faello sono nati e hanno operato alcuni tra i più gran-di maestri del Novecento: Scipione (1904–1933), Osval-do Licini (1894–1958), Corrado Cagli (1910–1976), Ed-gardo Mannucci (1904–1986). La tradizione artistica èlegata all’opera dei marchigiani Enzo Cucchi, EliseoMattiacci, Arnaldo e Giò Pomodoro (1930–2002), GinoDe Dominicis (1947–1998), Giuseppe Uncini (1929–2008)
Castelfidardo, il monumento in memoria di Enrico Cialdini
Pesaro, la sfera grande realizzata da Arnaldo Pomodoro
Lo sapevate che...
La Mole Vanvitelliana, nell’area portuale di Ancona
MARE E SPORT
ca 40 km e si estende oltre i confini con l’Umbria. Dallecime del monte Vettore (2476 m), monte Sibilla e mon-te Priora – i monti azzurri di Giacomo Leopardi – alle val-li del Fiastrone e alle gole dell’Infernaccio, la natura sifonde con le leggende della Sibilla, la profetessa vissu-ta nelle viscere del monte omonimo, del Guerrin Me-schino e del cadavere di Ponzio Pilato, che dà il nome al-l’unico lago naturale delle Marche, adagiato nel cuoredel monte Vettore. Lo sguardo si perde poi nel paesag-gio intorno, costellato dai profili dei centri storici, sor-ti ai piedi delle montagne, ognuno con la sua chiesa e ilsuo museo. Una piccola fascia del territorio della re-gione, con i comuni di Acquasanta Terme e Arquata delTronto, è compresa nel Parco nazionale del Gran Sas-so e monti della Laga. Ai confini con la Toscana il Par-co regionale del Sasso Simone e Simoncello, nel Mon-tefeltro storico, è noto per la grande faggeta di Pianac-quadio. Sulla rupe di Sasso Simone i Medici costruiro-no nel Cinquecento una città fortificata che rimase neltempo disabitata, poiché era troppo difficile raggiun-gerla. La provincia di Pesaro e Urbino è ricca di paesaggida fiaba, come la zona della pineta delle Cesane, fra Ur-bino e Fossombrone; il mas siccio del Furlo con la sug-gestiva gola, riconosciuta come Riserva naturale statale;l’Alpe della Luna dopo Mercatello sul Metauro e il com-prensorio dei monti Catria e Nerone, ricco di gole e ar-cate naturali. In provincia di Ancona si trova il Parco re-gionale della Gola della Rossa e di Frasassi, con areerupestri attraversate dalle due omonime gole, mete diaquile reali, falchi pellegrini e gufi reali. Nei pressi di Fa-briano è attivo il Centro di Educazione Ambient ale di Val-leremita. Da vedere nel Maceratese il monte San Vicino,con le secolari faggete di Canfaito, area riconosciuta co-
disputano la prima domenica dopo Pasqua il Palio della Ra-na e la prima domenica di settembre Il Gran Premio del Bi-ciclo Ottocentesco. A Serra Sant’Abbondio la seconda do-menica di settembre si svolge il famoso Palio della Rocca.Nella provincia di Ancona le rievocazioni più note nel me-se di luglio sono: a Corinaldo, la terza domenica, La Conte-sa del Pozzo della Polenta con sfilata in costume; a Filottrano,la Contesa dello Stivale che ricorda un episodio della guer-ra fra la cittadina e la vicina Osimo; a Offagna, la Contesa del-la Crescia, durante le feste medievali. Fabriano, il 24 giugno,nel ricordare il santo protettore Giovanni Battista, cui è de-dicato il Palio, celebra l’arte cittadina del ferro battuto nel-la finale Sfida del Maglio; a Jesi, in maggio, il Palio di San Flo-riano rievoca il vassallaggio alla città dei castelli vicini, i no-ti colli del Verdicchio. In provincia di Macerata, a Cameri-no, la Corsa alla Spada si svolge a maggio in occasione del- I LUOGHI DEI DUCHI
sua rocca, di origini duecentesche, che domina la valle el’antica via romana all’ombra dei monti Sibillini, Castel diLuco vicino Acquasanta Terme dall’insolita forma circo-lare, l’imponente forte Malatesta di Ascoli Piceno e il ca-stello di Acquaviva Picena modificato nel Quattrocento daBaccio Pontelli.
una delle tele lasciate da Rubens in Italia, si tratta del-l’Adorazione dei pastori di Fermo, commissionata nel1601 dai Filippini della città. Quest’ordine religioso inol-tre, vale la pena di ricordarlo, ha completamente co-stellato l’intera regione di oratori e chiese spesso di fa-stoso stile barocco. In pochi sanno che nelle Marche furono combattute duestoriche battaglie: ai tempi dei Romani vanno ricon-dotte la battaglia di Sentinum (295 a.C.) che oppose i Ro-mani, vincitori, ai Galli senoni e segnò l’inizio dellapenetrazione dei Romani nella regione; l’altra è la bat-taglia del Metauro che vide nel 207 a.C. i Romani trion-fare sui Cartaginesi di Asdrubale. E in tempi più vicinia noi ricordiamo la battaglia di Castelfidardo, che op-pose vittoriosamente nel 1860 le truppe sabaude aquelle dello Stato Pontificio, evento ricordato dal mo-numento a Enrico Cialdini. Nella regione si trova una delle ville rinascimentalipiù belle d’Italia: la Villa Imperiale, voluta da France-sco Maria I Della Rovere, realizzata dall’architetto,scenografo e pittore Girolamo Genga, nelle colline di Pe-saro.Un altro complesso architettonico unico nel suogenere è la Mole Vanvitelliana progettata dall’archi-tetto Luigi Vanvitelli: a pianta pentagonale, situata nel-l’area portuale di Ancona.(Per approfondimenti: www.cultura.marche.it).
Siti archeologici
La Carta Musei Marche è un nuovo strumento di inte-grazione tra la struttura museale e il territorio e per-mette di visitare oltre cento musei e siti archeologici,offrendo sconti e agevolazioni negli orari di aperturaanche per eventi e mostre.(www.cultura.marche.it, www.cartamusei.marche.it).
LA CARTA MUSEI MARCHE
Pinacoteca comunale di Ancona: Tiziano,Madonna in gloria, detta Pala Gozzi.
Le case-residenze museo delle Marche hanno la funzio-ne di veicolare la cultura e l'identità della regione. Leprincipali dimore dei cittadini illustri, che hanno reso fa-mosa la loro terra nel mondo, sono oggi aperte ai visita-tori, interessati ai luoghi, che hanno ospitato questegrandi personalità .(Per ulteriori approfondimenti: www.cultura.marche.it).
CASE MUSEO
MARCHE FRANCESCANE
Museo di Ancona, Bronzi dorati di Pergola Le Marche sono statefortemente influenzatedalla figura di SanFrancesco d’Assisi, lacui presenza risale al1208. Nel 1282 la provinciadella Marca vantava ben85 conventi. Il Fran ce -sca nesimo ha quindi se -gnato la storia culturalee re ligiosa delle Marche.(www.francescanesimomarche.it)