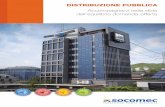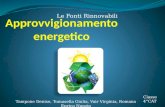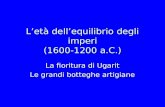Basi, missione, intervento · • mantenimento dell’equilibrio ecologico. Politica di sicurezza 6...
-
Upload
nguyenkhue -
Category
Documents
-
view
217 -
download
0
Transcript of Basi, missione, intervento · • mantenimento dell’equilibrio ecologico. Politica di sicurezza 6...
La protezione civileBasi, missione, intervento
Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra
Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP 1222-1-i
Edizione2008
II
Disponibilità
Edizione onlineInternetDownload nel formato Acrobat Reader http://www.protpop.chRispettare il copyright
Numero di Distribuzione eesemplari controllo
Edizione cartaceaEsemplari personali– Nuovi militi della protezione civile in occasione del 1 Centro di
reclutamento reclutamento– Militi della protezione civile già incorporati 1 Ufficio cantonale– Istruttori a tempo pieno 1 responsabile della
protezione civile
Esemplari per l’amministrazione– Ufficio cantonale responsabile della protezione 151) Ufficio cantonale
civile responsabile della– Centro d’istruzione della protezione civile 30 protezione civile
Esemplari per informazione– Segretariati generali dei Dipartimenti federali 3 ciascuno– Direzione della politica di sicurezza DPS 2– Federazione svizzera dei funzionari di polizia 2– Federazione svizzera dei pompieri 2– Segretariato del Servizio sanitario coordinato 2– Federazione svizzera dei samaritani 2– Croce Rossa Svizzera 2– Associazione dei Comuni svizzeri 2– Unione svizzera per la protezione civile 2– Servizio di documentazione del DDPS 2– Archivio federale 1
1) Per l’ufficio e per altri organi cantonali, a libera discrezione.
}
}
II
Impressum:
La protezione civile: basi, missione, interventoEdizione 2008 1222-1-i
Editore:Ufficio federale della protezione della popolazioneIstruzione3003 Berna
Concetto e articolazione:Ufficio federale della protezione della popolazioneIstruzione
Impaginazione e stampa:Ziegler Druck- und Verlags-AG, Winterthur
© Ufficio federale della protezione della popola-zione, 3003 Berna: tutti i diritti sono riservati
Per ordinare la pubblicazione:UFCL, Distibuzione pubblicazioni, 3003 BernaFax 031 325 50 58E-mail [email protected] www.bundespublikationen.chNo art. 408.998.i
11.07 2500 860176710
III
Prefazione
La pubblicazione «La protezione civile: basi, missione, intervento» è un documen-to di informazione e consultazione e può essere impiegato quale sussidio didattico.Fornisce ai militi di protezione civile di tutta la Svizzera le conoscenze di base sullaprotezione della popolazione e sulla protezione civile.
Include i temi dell’istruzione generale (IG) e dell’istruzione specialistica (IS).
Nel segno della polivalenza, permette di introdurre i militi della protezione civile ai se-guenti cinque settori: aiuto alla condotta, protezione e assistenza, protezione dei beniculturali, sostegno e logistica.
Per semplificare il testo, è stata utilizzata la forma maschile per entrambi i sessi.
Berna, gennaio 2004 UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
IV
Indice
Capitolo
1 Politica di sicurezza 1
1.1 Rischi e pericoli ...............................................................................................11.2 Sicurezza attraverso la cooperazione .............................................................41.3 Strumenti della politica di sicurezza ................................................................51.3.1 Politica estera .................................................................................................51.3.2 Esercito ...........................................................................................................51.3.3 Politica economica ..........................................................................................51.3.4 Approvvigionamento economico del Paese.....................................................61.3.5 Protezione dello Stato e polizia .......................................................................61.3.6 Informazione e comunicazione........................................................................71.3.7 Protezione della popolazione ..........................................................................7
2 Protezione della popolazione 9
2.1 Partner della protezione della popolazione e rispettivi compiti ......................102.1.1 Polizia ...........................................................................................................102.1.2 Pompieri........................................................................................................102.1.3 Sanità pubblica .............................................................................................102.1.4 Servizi tecnici ................................................................................................102.1.5 Protezione civile ............................................................................................112.2 Condotta civile...............................................................................................112.2.1 Struttura di un’organizzazione d’intervento comunale o regionale.................122.2.2 Organizzazione d’intervento regionale o cantonale .......................................132.3 Allarme/diffusione di istruzioni di comportamento
all’attenzione della popolazione ....................................................................14
3 Protezione civile 17
3.1 Missione........................................................................................................173.2 Organizzazione .............................................................................................173.3 Aiuto alla condotta ........................................................................................193.3.1 Personale e compiti.......................................................................................193.3.2 Analisi della situazione..................................................................................213.3.3 Telematica.....................................................................................................243.3.4 Protezione ABC.............................................................................................263.3.5 Coordinamento logistico................................................................................29
V
3.4 Protezione e assistenza ................................................................................303.4.1 Assistenza.....................................................................................................303.4.2 Compiti dell’assistenza..................................................................................303.4.3 Personale e compiti.......................................................................................313.5 Protezione dei beni culturali ..........................................................................323.5.1 In generale ....................................................................................................323.5.2 Misure di protezione......................................................................................323.5.3 Personale e compiti.......................................................................................333.5.4 Collaborazione con i partner .........................................................................333.5.5 Distintivo internazionale di protezione...........................................................343.6 Sostegno.......................................................................................................353.6.1 Personale e compiti.......................................................................................353.7 Logistica........................................................................................................363.7.1 Personale e compiti.......................................................................................363.7.2 Elemento logistico .........................................................................................373.8 Materiale/Veicoli ............................................................................................383.9 Costruzioni di protezione...............................................................................393.9.1 In generale ....................................................................................................393.9.2 Rifugio...........................................................................................................393.9.3 Impianto di protezione...................................................................................41
4 Conoscenze di base 45
4.1 Introduzione ..................................................................................................454.2 Analisi della situazione..................................................................................454.2.1 Carte e scale topografiche ............................................................................454.2.2 Stimare le distanze........................................................................................464.2.3 Osservare e trasmettere ...............................................................................474.3 Telematica.....................................................................................................484.3.1 Radiocomunicazione SE-125 ........................................................................484.3.2 Traffico radio .................................................................................................484.4 Protezione ABC.............................................................................................504.5 Protezione e assistenza ................................................................................514.5.1 Protezione nel rifugio ....................................................................................514.5.2 Messa in esercizio del rifugio in caso di pericolo imminente .........................524.5.3 Stress............................................................................................................534.6 Sostegno.......................................................................................................554.6.1 Lotta antincendio...........................................................................................554.6.2 Conoscenza dei nodi.....................................................................................604.6.3 Regolazione del traffico.................................................................................66
VI
5 Lotta contro i sinistri 73
5.1 Sinistro quotidiano ........................................................................................745.2 Sinistro importante ........................................................................................745.3 Catastrofe e altre situazioni d’emergenza .....................................................755.4 Diffusione dell’allarme e chiamata in servizio ................................................765.5 Chiamata della protezione civile....................................................................785.6 Direzione d’intervento in caso di sinistri ........................................................795.7 Organizzazione della zona sinistrata.............................................................795.7.1 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe circoscritta ..........805.7.2 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe estesa.................81
6 Diritti e doveri 82
6.1 Obbligo di prestare servizio di protezione civile ............................................826.2 Diritti..............................................................................................................826.3 Doveri ...........................................................................................................83
Appendici 85
1 Funzioni e distintivi indicanti il grado .............................................................852 Segni convenzionali (estratto) .......................................................................873 Modulo di notifica (esempio) .........................................................................884 Promemoria sull’allarme................................................................................895 Protezione della popolazione in caso di pericolo imminente .........................906 Uso della maschera di protezione .................................................................927 Comportamento in caso d’incidente ..............................................................948 Aiuto d’emergenza ........................................................................................969 Iter d’istruzione............................................................................................10010 Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
(LPPC) ........................................................................................................10211 Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) .....................................................119
Glossario ........................................................................................................130
Indice analitico ............................................................................................135
1 Fonti:Rapporto completo n° d’ordinazione 97.667 i: richiedere all’indirizzoOpuscolo riassuntivo n° d’ordinazione 97.668 i: UFCL/EDMZ, 3003 Berna
www.vbs.admin.ch
Politica di sicurezza
1
1 Politica di sicurezzaLa Svizzera persegue i suoi obiettivi in materia di poli-tica di sicurezza con una strategia di sicurezza attra-verso la cooperazione nazionale e internazionale.
1.1 Rischi e pericoliLe persone sono vieppiù esposte a rischi e pericoli legati all’impiego di tecnologiesempre più sofisticate, alla crescente densità demografica e alla maggiore vulnerabilitàdella società moderna. Questa tendenza minaccia sia il singolo individuo che lo Stato.
I pericoli di natura non militare e la violenza al di sottodella soglia bellica sono considerevolmente aumentati.
Principali pericoli e minacce per la Svizzera:
• Aumento di conflitti interni. Possibili cause:– tensioni etniche – disparità economiche– divergenze ideologiche e religiose– ambizioni politiche di singoli gruppi
Politica di sicurezza
2
• Proliferazione incontrollata di armi di distruzione dimassa e di sistemi d’arma a lunga gittata,per es. armi chimiche
• Pressioni economiche e limitazione della libertà dicommercio
• Minaccia nei confronti dell’infrastruttura informatica edi comunicazione
• Terrorismo, estremismo violento, spionaggio, crimi-nalità e crimine organizzato,per es. allarme carbonchio negli USA
• Divario sociale, penuria di basi vitali e migrazioni in-controllate
3
• Catastrofi naturali,per es. – inondazioni
– frane– terremoti
• Catastrofi tecnologiche,per es. – aumento della radioattività dopo incidenti
in centrali nucleari– incidenti durante trasporti chimici
• Conflitti armati:Diversi accordi permettono di controllare almeno inparte la corsa agli armamenti. Ciò nonostante ven-gono continuamente prodotte armi sempre più effi-caci.
Politica di sicurezza
4
1.2 Sicurezza attraverso la cooperazioneLa gamma delle minacce e dei pericoli è ampia e com-plessa. Ci si interroga perciò su quale sia la migliorestrategia per proteggere il nostro Paese. La Svizzeranon è più in grado di affrontare da sola questi rischi.Per garantire la sicurezza interna, è necessario combi-nare tutti gli strumenti della politica di sicurezza internae rafforzare la collaborazione internazionale.La strategia della Svizzera in materia di politica disicurezza è improntata alla cooperazione.
Il rapporto sulla politica di sicurezza 2000 definisce tre compiti strategici:
Promovimento della pace e gestione delle crisiDiplomazia preventiva, azioni umanitarie, impiego dipersonale civile e militare, aiuto alla ricostruzione ecooperazione allo sviluppo.
Prevenzione e gestione dei pericoli esistenzialiPriorità: protezione delle persone in caso di cata-strofi naturali e tecnologiche, protezione di infra-strutture indispensabili alla sopravvivenza (energia,comunicazione, ecc.), lotta al terrorismo e al crimineorganizzato.
DifesaLa Svizzera dev’essere in grado di proteggere lapopolazione, il territorio e lo spazio aereo dalla mi-naccia o dall’uso di violenza.
5
1.3 Strumenti della politica di sicurezzaGli strumenti per gestire i compiti legati alla politica di sicurezza sono sette:
1.3.1 Politica esteraLa politica estera è uno strumento fondamentale perperseguire i nostri obiettivi di politica di sicurezza. I com-piti che deve perseguire sono i seguenti:• Promovimento della pace, diplomazia preventiva e
gestione delle crisi• Politica dei diritti umani• Diritto internazionale umanitario• Cooperazione allo sviluppo, cooperazione con l’Eu-
ropa dell’Est ed aiuto umanitario• Politica di neutralità• Disarmo e controllo degli armamenti
1.3.2 EsercitoI compiti dell’esercito in materia di politica di sicurezzasono i seguenti:• Contributi a sostegno della pace e alla gestione del-
le crisi• Sicurezza del territorio e difesa• Contributi alla prevenzione ed alla gestione dei peri-
coli esistenziali
1.3.3 Politica economicaLa politica economica (estera) contribuisce alla stabili-tà globale adottando le seguenti misure• rafforzamento della collaborazione economica inter-
nazionale• garanzia di un sistema economico mondiale aperto• miglioramento delle possibilità di accesso ai mercati• adesione ad accordi contrattuali• mantenimento dell’equilibrio ecologico
Politica di sicurezza
6
1.3.4 Approvvigionamento economicodel Paese
Va garantito l’approvvigionamento del Paese con benie servizi vitali nel caso in cui l’economia, a causa dicircostanze esterne, non fosse più in grado di prov-vedervi.
1.3.5 Protezione dello Stato e poliziaSono gli strumenti che garantiscono la sicurezza inter-na. La sicurezza interna è messa in pericolo quandosono minacciate le basi democratiche o lo stato di di-ritto, il funzionamento regolare delle istituzioni statali ola sicurezza della popolazione.
La protezione dello Stato (coordinata dalla Confede-razione in collaborazione con i Cantoni) serve a com-battere la violenza di portata strategica che minacciala sicurezza dello Stato e della popolazione.
La polizia (Cantoni, in parte Confederazione) è sub-ordinata principalmente alla sovranità dei Cantoni e sioccupa di• lottare contro la violenza di portata non strategica• garantire la sicurezza pubblica, l’ordine e la tranquil-
lità• combattere la criminalità
7
1.3.6 Informazione e comunicazioneGli organi d’informazione dello Stato provvedono affin-ché: • il bisogno di informazioni della popolazione sia sod-
disfatto• le decisioni e le misure delle autorità in materia di po-
litica di sicurezza siano rese note con chiarezza siain Svizzera che all’estero
• la disinformazione sia rettificata da informazioni cor-rette e obiettive
Vale la regola: fornire sempre informazioni veritiere,tempestive e chiare.
In situazioni normali, le informazioni delle autoritàvengono diffuse dai mass media civili.
In situazioni particolari e straordinarie, il Consigliofederale ricorre alla Centrale d’informazione dellaCancelleria federale e – nel campo dell’allarme edelle disposizioni tecniche – alla Centrale nazionaled’allarme per informare direttamente la popolazione.
1.3.7 Protezione della popolazione(Vedasi capitolo 2)
Protezione della popolazione
9
2 Protezione della popolazioneLa protezione della popolazione è uno dei sette strumenti che la Svizzera ha a disposi-zione per gestire i compiti legati alla politica di sicurezza.Si tratta di un sistema integrato costituito da cinque organizzazioni partner: polizia,pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile.I Cantoni sono responsabili di tutti i mezzi riuniti sotto il tetto della protezione dellapopolazione.
La Protezione della popolazione è un sistema integra-to civile e finalizzato ad intervenire in caso di eventi piùgravi dei sinistri quotidiani, ovvero in caso di:• Catastrofi
– naturali (per es. terremoti)– tecnologiche (per es. aumento della radioattività)
• Situazioni d’emergenza– pericolo su vasta scala per la salute pubblica– emergenza nel campo dell’immigrazione – gran parte dei mezzi d’informazione fuori servizio
• Violenza al di sotto della soglia bellica– ricatto esercitato sulla Svizzera– estremismo/ terrorismo
• Conflitti armati– conflitto armato in un paese confinante con o sen-
za impiego di armi di distruzione di massa– conflitto armato in Svizzera
Lo scopo della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazione ele sue basi vitali in caso di catastrofe, altre situazioni d'emergenza e conflitto armato.Essa contribuisce inoltre a far fronte a eventi di questo tipo e a limitarne i danni.(Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, articolo 2)
Nessun preallarme o preallarme di poco tempo
Preallarme di diversi anni
Protezione della popolazione
10
2.1 Partner della protezione della popolazione e rispettivi compiti
2.1.1 PoliziaLa polizia è responsabile di mantenere l’ordine e la si-curezza. Rientra fra i mezzi di primo intervento.Compiti della polizia cantonale: prevenzione, aiuto,perseguimento penale, regolazione e sorveglianza deltraffico, segnaletica stradale, assistenza amministrati-va ed esecutiva, adozione di misure immediate in casodi catastrofi ed incidenti.
2.1.2 PompieriI pompieri sono responsabili di salvataggio e lotta con-tro i sinistri in generale, compresa la lotta antincendioe contro i sinistri ordinari. Intervengono anche in casod’emissioni tossiche, fuoriuscite di carburanti e conta-minazioni radioattive.Sono un mezzo di primo intervento.
2.1.3 Sanità pubblicaLa sanità pubblica, compreso il servizio sanitario disalvataggio, fornisce prestazioni mediche alla popola-zione ed ai corpi d’intervento. Vi rientrano anche lemisure di prevenzione ed il sostegno psicologico.Il servizio sanitario di salvataggio è un mezzo di primointervento.
2.1.4 Servizi tecniciI servizi tecnici garantiscono l'approvvigionamento conelettricità, acqua e gas, la raccolta dei rifiuti, i collega-menti stradali e la telematica oppure ripristinano lanormalità applicando le misure d’emergenza dispostedalle autorità.
11
2.1.5 Protezione civileLa protezione civile è responsabile, soprattutto in casodi catastrofi ed altre situazioni d’emergenza, di• mettere a disposizione l’infrastruttura di protezione
ed i mezzi per dare l’allarme alla popolazione• assistere le persone in cerca di protezione ed i sen-
zatetto• proteggere i beni culturali• eseguire lavori di ripristino• prestare interventi a favore della comunità• offrire sostegno agli organi di condotta e alle altre
organizzazioni partner• prestare servizi logistici
2.2 Condotta civileIn caso di sinistri quotidiani, la condotta delle opera-zioni spetta alla direzione d’intervento dell’organizza-zione partner competente (di regola ai mezzi di primointervento dei pompieri e/o della polizia).In caso di sinistri importanti, è necessario coordinarele organizzazioni partner che partecipano all’interven-to. La condotta spetta ad una direzione d’interventogenerale formata da specialisti delle organizzazionipartner o dell’amministrazione, scelti in funzionedell’evento. (Vedasi anche capitolo 5, paragrafo 5.6, Condotta del-l’intervento in caso di sinistro)Un organo di condotta politicamente legittimato assu-me il coordinamento e la condotta delle operazioni incaso di sinistri d’ampia portata che richiedono unintervento duraturo di più organizzazioni partner.Questo organo è responsabile di dirigere le operazionie prepara le decisioni per l’autorità cui compete la re-sponsabilità generale.
Protezione della popolazione
12
2.2.1 Struttura di un’organizzazione d'intervento comunale o regionale
L’organo di condotta è formato da:• i rappresentanti delle autorità, il capo dello stato maggiore e il suo sostituto, i rap-
presentanti dell’amministrazione• i capi dei diversi settori di competenza (rappresentanti delle organizzazioni part-
ner) e i capi dell’aiuto alla condotta (in primo luogo nei settori analisi della situazionee telematica). Questi membri sono designati ed istruiti per la funzione che devonoassumere.
Il responsabile della direzione degli interventi entra in certi casi a far parte dell’or-gano di condotta. È anche possibile far capo a specialisti.
Esecutivo
DirezioneAmministrazione
d’intervento
Forze d’intervento Aiuto alla
Organo di condotta condotta
Ordine e Salvataggio e Salute e Infrastruttura Protezione,sicurezza lotta contro i sanità tecnica assistenza e
sinistri sostegno
Sanità Servizi ProtezionePolizia Pompieri pubblica tecnici civile
La protezione della popolazione e le sue organizzazioni partner
13
L’aiuto alla condotta comprende i settori informazione, analisi della situazione, tele-matica, protezione ABC e coordinamento logistico. Viene prestato dal personale dei mezzi di primo intervento, dell’amministrazione e dialtre organizzazioni partner, in particolare della protezione civile.
L'organo di condotta è responsabile di:(Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile, LPPC)Articolo 4:a. informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure alle pos-
sibilità e alle misure di protezione esistenti;b. dare l’allarme e diffondere presso la popolazione le istruzioni sul comportamento da
adottare;c. assicurare la condotta;d. coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;e. garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la prontezza operativa e
il rinforzo con materiale e personale della protezione della popolazione in vista di unconflitto armato.
2.2.2 Organizzazione d’intervento regionale o cantonaleL’organo di condotta regionale o cantonale entra in azione se un sinistro colpisce piùcomuni o regioni, oppure se un evento improvviso comporta una situazione straordi-naria. Questo organo assume la condotta, coordina i mezzi ed adotta le misure per far frontealla situazione a livello comunale o regionale.
Protezione della popolazione
14
2.3 Allarme/diffusione di istruzioni di comportamento all’attenzione della popolazione
ObiettivoIn caso di catastrofi, altre situazioni d’emergenza o conflitto armato, ogni cittadino deveessere allarmato per tempo ed informato sul comportamento che gli permette di pro-teggersi, limitare i danni ed agire in modo opportuno.Per esempio, in caso di fenomeni meteorologici pericolosi o di pericolo di valanghe, èpossibile diffondere le istruzioni di comportamento all’attenzione della popolazione viaradio e per mezzo di altri media.
PrincipiLa popolazione viene allarmata tramite sirene fisse emobili. Le istruzioni di comportamento, la fine del pericolo non-ché l'allentamento o la revoca delle misure vengonocomunicati via radio e per mezzo di altri media.
Compiti e competenzeLa Confederazione mette a disposizione i sistemi perdare l’allarme alla popolazione e ne garantisce il buonfunzionamento. I Cantoni devono essere sempre pron-ti a ricevere messaggi e missioni ed a trasmetterli agliorgani competenti. I Cantoni ed i comuni garantisconoche sia sempre possibile dare l’allarme alla popola-zione.
Procedura d’allarmePer raggiungere subito e in ogni momento la popola-zione via radio, la Società svizzera di radiotelevisione(SSR) ha elaborato il sistema ICARO.
Il promemoria sull’allarme (vedasi anche elenco telefo-nico) figura nell’appendice 4:«Allarme della popolazione»eil promemoria «Protezione della popolazione in caso dipericolo imminente» figura nell’appendice 5.
Segnali d’allarme:
• Allarme generale• Allarme acque
Sirena fissa
Sirena mobile
15
Schema ICAROLa Società svizzera di radiotelevisione (SSR) diffonde per radio i messaggi d’allarme ele istruzioni sul comportamento da adottare. Grazie al dispositivo d’emergenza ICARO(Informazione Catastrofe Allarme Radio Organizzazione), la SSR può diffondere subitoed in ogni momento i comunicati delle autorità in caso di situazioni particolari e straor-dinarie. I programmi radiofonici in corso vengono interrotti. Tutte le centrali d’interventodella polizia cantonale sono collegate al sistema ICARO.
Protezione civile
17
3 Protezione civile
3.1 MissioneLa protezione civile è prevalentemente un mezzo di secondo intervento del sistemaintegrato della protezione della popolazione. Non costituisce quindi un mezzo di primointervento, ma un elemento che offre sostegno alle organizzazioni partner. Vieneimpiegata soprattutto per rinforzare le altre organizzazioni partner in caso di catastrofie situazioni d’emergenza di ampia portata e lunga durata.I suoi compiti sono definiti nell’articolo 3 della legge federale sulla protezione dellapopolazione e sulla protezione civile.
3.2 OrganizzazioneÈ compito dei comuni e dei Cantoni individuare i rischiesistenti sul loro territorio ed adottare le misure pre-ventive appropriate.L’organizzazione della protezione civile si basa sul-l’analisi dei pericoli nonché sulle condizioni e le struttu-re topografiche cantonali, regionali o comunali. Essapuò quindi variare.I Cantoni ed i comuni stabiliscono il loro fabbisogno dipersonale tenendo conto del potenziale di reclutamen-to disponibile. La gestione ed il controllo del personalespettano ai Cantoni.
Nella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner:Capoverso ela protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le persone incerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condotta e lealtre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pubblica utili-tà.
Protezione civile
18
Il seguente modello d’organizzazione prevede cinque settori.
I cinque settori vengono presentati nelle pagine seguenti.
Funzioni e distintivi indicanti il grado vedasi appendice 1Iter di formazione vedasi appendice 9
19
3.3 Aiuto alla condottaL’organo di condotta può svolgere i suoi compiti solocon il sostegno dell’aiuto alla condotta.A tale scopo, la protezione civile mette a disposizionepersonale dei seguenti settori: analisi della situazio-ne, telematica, protezione ABC e coordinamentologistico.Il settore delle informazioni compete invece alle auto-rità che impiegano, di regola, professionisti delle orga-nizzazioni partner polizia e pompieri o dell’ammini-strazione.
3.3.1 Personale e compitiL’aiuto alla condotta viene prestato da assistenti di sta-to maggiore che hanno seguito una formazione poli-valente soprattutto in materia di analisi della situazionee telematica (nell’ambito dell’istruzione specialistica).Gli assistenti di stato maggiore vengono assegnati al-l’organo preposto all’analisi della situazione o a quellopreposto alla telematica secondo le necessità. Il loro posto di lavoro si trova di regola nel centro dianalisi della situazione o nel centro telematico dell’or-gano civile di condotta.L’assistente di stato maggiore svolge compiti molto im-pegnativi. Nei limiti delle istruzioni impartite dal suosuperiore, l’assistente di stato maggiore si occupa di• garantire l’esercizio di un centro per l’analisi della
situazione• seguire tutte le fasi di sviluppo della situazione (ri-
cerca /valutazione /diffusione)• elaborare il quadro della situazione nel posto di con-
dotta• creare, rendere operative le reti di collegamento e
garantire la loro manutenzione
Inoltre, collabora ai seguenti compiti:• elaborare piani e preparativi d’intervento• garantire l’infrastruttura necessaria per l’analisi della
situazione nell’ubicazione di condotta
Aiuto allacondotta
Analisi dellasituazione
Telematica
Protezione ABC
Coordinamentologistico
Protezione civile
20
• prestare servizi finalizzati alla situazione e conformialle esigenze e produrre sussidi per l’analisi dellasituazione
• offrire assistenza nel campo delle informazioni• preparare, mettere in esercizio i mezzi telematici o
di trasmissione e provvedere alla loro manutenzione• svolgere ulteriori compiti quali: servizio staffetta e
corrieri, gestione e controllo del flusso delle infor-mazioni, svolgimento del servizio nel posto di con-dotta
• eseguire lavori di logistica specifica
A livello giuridico, amministrativo e formativo, gli assistenti di stato maggiore sono sub-ordinati alla protezione civile, mentre a livello operativo principalmente all’organo civiledi condotta. L’istruzione degli assistenti di stato maggiore compete ai Cantoni, mentrequella dei capi dei vari settori dell’aiuto alla condotta (capo analisi della situazione, capotelematica, capo protezione ABC, capo coordinamento logistico) alla Confederazione.
21
3.3.2 Analisi della situazione 2
L’analisi della situazione come base permanentedel processo di condottaI processi di condotta sono impossibili senza «analisidella situazione» e «comunicazione». L’analisi dellasituazione costituisce quindi un settore fondamentaleper l’aiuto alla condotta. Il suo compito è fornire pre-stazioni finalizzate alla situazione e alla condotta.Il ciclo d’elaborazione della situazione è strettamentecorrelato al ciclo della condotta.Si tratta di un processo continuo in cui le informazionigrezze raccolte vengono valutate e trasformate in mes-saggi da diffondere presso gli organi che li utilizzeran-no come elementi rilevanti per la condotta.
Partner nell’analisi coordinata della situazioneL’analisi coordinata della situazione è la sintesi dellasituazione sul luogo dell’evento e di quella nei singolisettori (dicasteri, campi tecnici) delle organizzazionipartner nonché degli organi di condotta intervenuti perfar fronte alla situazione. Essa presuppone una colla-borazione finalizzata alla situazione e alla missione ditutti gli organi preposti all’analisi della situazione dellediverse organizzazioni partner della protezione dellapopolazione.
In caso di sinistri quotidiani, collaborano con gli or-gani di analisi della situazione dei mezzi di primo inter-vento.
2 Ulteriori informazioni: ANSIT /Promemoria analisi della situazione, edito dal Gruppo di lavoro promemoria«Analisi della situazione» (ANSIT) /Partner della protezione della popolazione
Aiuto alla
condotta
Analisi dellasituazione
Telematica
ProtezioneABC
Coordinamentologistico
Collaborazione nel cam-po dell’analisi dellasituazione in caso disinistri quotidiani• polizia• pompieri• organizzazioni sanitarie
di salvataggio e sanitàpubblica
Definizione del termine«situazione»Situazione in cui si trovamomentaneamente unacomunità per quanto ri-guarda le sue basi vitali ele procedure per far frontealla situazione.Si distingue tra:• situazione normale, • situazione particolare, • situazione straordinaria.
Protezione civile
22
In caso di sinistri importanti, la collaborazione nelcampo dell’analisi della situazione viene eventualmen-te ampliata con mezzi supplementari.
In situazioni particolari e/o straordinarie, la collabo-razione nel campo dell’analisi della situazione vieneampliata innanzi tutto con organi della condotta civilee, a seconda del caso, con organi del corpo delle guar-die di confine e /o dell’esercito.
Compiti nell’ambito della lotta contro i sinistri
Assistenti di stato maggiore addetti all’analisi della situazioneNell’ambito di operazioni per far fronte a un sinistro, ilcapo dell’analisi della situazione può affidare i seguen-ti compiti agli assistenti di stato maggiore (i Cantonipossono adeguare questo mandato di prestazioni alleloro esigenze): • garantire l’esercizio del centro di analisi della situa-
zione ed il ciclo di elaborazione della situazione• prestare servizi finalizzati alla situazione e conformi
alle esigenze nonché produrre sussidi per l'analisidella situazione
• garantire la tenuta di un quadro della situazione sem-pre aggiornato e finalizzato alla condotta
Collaborazione nel cam-po dell’analisi dellasituazione in caso dieventi importantiampliata per es. con:• specialisti• amministrazione• servizi comunali• aziende tecniche• protezione civile• ev. condotta civile
Collaborazione nel cam-po dell’analisi della situa-zione in situazioni parti-colari e/o straordinarieampliata con:• condotta civile• corpo delle guardie di • confine• esercito
23
Capo analisi della situazioneNell’ambito delle operazioni per far fronte a un evento,il capo dell’analisi della situazione deve svolgere i se-guenti compiti (i Cantoni o gli organi civili di condottapossono adeguare questo capitolato degli oneri alleloro esigenze):• Dirigere l’analisi coordinata della situazione a livello
comunale o regionale, in situazioni particolari e stra-ordinarie
• Appurare e/o realizzare le priorità nel campo del-l’analisi della situazione
• Coordinare il piano d’elaborazione della situazionea livello comunale o regionale
• Coordinare il ciclo di elaborazione della situazione(ricerca di informazioni, valutazione e diffusione)
• Fornire prestazioni e prodotti finalizzati alla situa-zione e conformi alle esigenze
• Garantire la tenuta di un quadro della situazionesempre aggiornato e finalizzato alla condotta
• Creare gradualmente la situazione prioritaria per laprotezione della popolazione (BREL)
• Elaborare valutazioni della situazione concrete,eventualmente in collaborazione con rappresentan-ti di organizzazioni partner e /o specialisti
• Coordinare l’elaborazione del quadro della situazione e la valutazione della situazione
Prodotti dell’analisi della situazione presso l’ubicazione dell’organo civile di condotta comunale o regionaleI prodotti standard elaborati nell’ambito dell'analisi della situazione sono i seguenti:giornale d'intervento, carta di condotta rapporto sulla situazione, dispositivo, compen-dio dei mezzi e carta informativa. Questa gamma può essere completata con altri pro-dotti finalizzati alla situazione e conformi alle esigenze (dispositivo delle informazioni,compendio delle operazioni di salvataggio, ecc.).
Modulo di notificaPer annotare tutte le informazioni che affluiscono in un caso effettivo, si utilizza di re-gola il modulo di notifica (analogo a quello utilizzato dal servizio informazioni dell’eser-cito).(Vedasi appendice 3)
Protezione civile
3.3.3 TelematicaLa telematica costituisce un altro settore per l’aiuto allacondotta. Questo settore va coordinato non appenaentrano in azione più organizzazioni partner.Fra i suoi compiti principali rientrano la pianificazione,la realizzazione e la messa in esercizio di mezzi e col-legamenti telematici. In caso d’intervento, è necessaria un’ubicazione dicondotta generale per i partner della protezione dellapopolazione. Il personale addetto alla telematica pre-para l’ubicazione generale secondo i piani (mandati diprestazione) e provvede all’esercizio e alla manuten-zione dei collegamenti.
RadiocomunicazioneLa protezione civile quale partner della protezione dellapopolazione fa parte della Rete radio nazionale di sicu-rezza POLYCOM e dispone di relativi terminali. Questiterminali vengono utilizzati di regola dagli assistenti distato maggiore appositamente istruiti. In casi eccezio-nali, anche il personale non istruito può utilizzare questiapparecchi dopo aver seguito un’istruzione immediatain materia di interventi radio di breve durata.
Posa di lineeOltre alle linee telefoniche fisse (rete fissa) esistono quel-le da campo. La protezione civile è una delle organizza-zioni partner che posano linee da campo. Essa disponedi grandi quantità di cavo avvolto su bobine da 200 metri.Il cavo può essere utilizzato sia per linee a batteria locale(BL) che per linee telefoniche urbane.Rispetto alla comune telefonia, la posa di linee per-mette l’esercizio e la manutenzione delle linee senzadipendere da operatori esterni. Inoltre, i collegamentifunzionano anche quando la rete pubblica è sovracca-rica o interrotta.È pure possibile prolungare con cavo di campagna lelinee fisse già esistenti. Le linee da campo vengono posate da militi della pro-tezione civile appositamente istruiti (assistenti di stato-maggiore) nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza edi costruzione.
Aiuto allacondotta
Analisi dellasituazione
Telematica
ProtezioneABC
Coordinamentologistico
24
25
Ulteriori mezzi telematiciIn caso di necessità, gli assistenti di stato maggioresono in grado di utilizzare gli apparecchi radio delle al-tre organizzazioni partner della protezione della popo-lazione nonché di garantirne l'esercizio e la manuten-zione a loro favore.
Per stabilire i collegamenti sono disponibili centralitelefoniche, i cosiddetti impianti di commutazione perutenti (ICU). Il settore della telefonia offre numerosimodelli di apparecchi telefonici diversi.
I posti di condotta all'interno delle costruzioni di prote-zione sono dotate di installazioni standard che soddis-fano le esigenze attuali della telematica, a favore deipartner della protezione della popolazione.Nei posti di condotta è anche possibile stabilire colle-gamenti radio tramite la rete radio nazionale di sicu-rezza POLYCOM.
Protezione civile
26
3.3.4 Protezione ABCIl servizio di protezione ABC è un altro importante tas-sello d’aiuto alla condotta. A differenza dei settori ana-lisi della situazione e telematica è rappresentato uni-camente dal Capo della protezione ABC nell’ambitodell’aiuto alla condotta.Le funzioni di «persona competente in radioprotezio-ne» e di «ricercatore A» sono rappresentate in seno aimezzi d’intervento delle organizzazioni d’intervento co-munali e regionali.
Compiti nel caso di aumento della radioattività in tempo di paceSe in tempo di pace avvengono incidenti che causanoun aumento della radioattività, è possibile affidare i se-guenti compiti al settore della protezione ABC: • Misurare l’intensità di dose locale• Sorvegliare la dose cui sono esposte le forze d’inter-
vento, le persone mobilitate e la popolazione• Accertare la contaminazione radioattiva• Offrire consulenza all’organo di condotta e alla dire-
zione d’intervento locale in qualità di persone com-petenti in radioprotezione delle organizzazioni disoccorso
• Collaborare nell’istruzione delle forze d’intervento edelle persone tenute ad entrare in servizio, primadell’intervento
Aiuto allacondotta
Analisi dellasituazione
Telematica
ProtezioneABC
Coordinamentologistico
27
Compiti (supplementari) durante il servizio attivo• Collaborare nell’istruzione sulle misure personali di
protezione ABC dopo la chiamata al servizio attivo• Sorvegliare la situazione ABC e ordinare le misure di
protezione preventive• Valutare gli effetti di esplosioni A• Accertare, misurare e rappresentare la contamina-
zione del terreno• Rilevare e identificare gli aggressivi C impiegati• Valutare gli effetti di armi ABC e ordinare misure
tecniche
Per contaminazioni con armi batteriologice, il servizio di protezione ABC può svolge-re solo pochi specifici compiti limitati dall’equipaggiamento in dotazione. Nel caso dipiccoli eventi radiologici e di incidenti chimici, il servizio di protezione ABC non vie-ne di regola attivato.
Mezzi della protezione ABCPersonale:Il capo protezione ABC rappresenta il settore dellaprotezione ABC in seno all’organo di condotta. Egli ri-veste il ruolo di superiore tecnico degli specialisti ABC.Dopo aver seguito l’istruzione generale e quella specia-listica (preferibilmente il corso tecnico per assistenti distato maggiore), acquisisce le competenze in radio-protezione nelle organizzazioni di soccorso (istruzionesupplementare) e frequenta il corso quadri per capi-servizio protezione ABC. La persona competente in radioprotezione è incorpo-rata nelle organizzazioni partner dell’organizzazioned’intervento comunale o regionale dove svolge diversicompiti di radioprotezione.Il ricercatore A è a disposizione delle diverse orga-nizzazioni partner, soprattutto per effettuare misura-zioni in caso di aumento della radioattività.
Protezione civile
28
Materiale:La maschera di protezione ABC è l’accessorio prin-cipale dell’equipaggiamento di protezione ABC deimiliti della protezione civile. Protegge chi l’indossadall’assunzione (tramite le vie respiratorie e digerenti)di sostanze radioattive, aggressivi C e microrganismipiù grandi. Le modalità d’uso della maschera di prote-zione sono descritte nell’appendice 6.Ad ogni Cantone è stato fornito un certo numero ditenute di protezione SA 99 da indossare per presta-re interventi speciali in caso di contaminazioni ABC.Queste tenute proteggono i militi delle formazioni d’in-tervento dal contatto con sostanze radioattive, infetteo velenose.
La Confederazione ha messo a disposizione dei Can-toni due strumenti di misurazione da utilizzare incaso di aumento della radioattività: il dosimetro elettro-nico EDOS 99 e l’apparecchio universale RA 99, per lamisurazione della contaminazione e la sorveglianzadella radioattività.Questi apparecchi vengono assegnati dai pool alle or-ganizzazioni d’intervento comunali e/o regionali in baseal concetto di radioprotezione adottato dai singoli Can-toni.
29
3.3.5 Coordinamento logisticoIl coordinamento logistico costituisce un altro settoreper l’aiuto alla condotta.Non appena entrano in azione più organizzazioni part-ner, è necessario coordinare il loro intervento.Il settore del coordinamento logistico coordina i prov-vedimenti e gli elementi logistici quando le organizza-zioni partner non sono più in grado di gestire autono-mamente la loro logistica specifica*).
Il capo del coordinamento logistico dirige questosettore. È la persona di contatto per tutte le questionilegate alla logistica e il rappresentante della logistica inseno all’organo di condotta. Per svolgere con efficien-za il suo compito, lavora in stretta collaborazione conle organizzazioni partner e in modo particolare con laprotezione civile, i servizi tecnici e l’amministrazione.
In caso di necessità, la protezione civile fornisce pre-stazioni di logistica alle organizzazioni partner e, senon è stato disposto altrimenti, si assume la responsa-bilità del coordinamento logistico nell’ambito dell’aiutoalla condotta.
*) Logistica specifica delle organizzazioni partnerPer logistica specifica s’intende la logistica delle singo-le organizzazioni partner.
Aiuto allacondotta
Analisi dellasituazione
Telematica
Protezione ABC
Coordinamentologistico
Esempi d’aiuto alla condotta prestato dalsettore del coordina-mento logistico• Procurare veicoli e mac-
chinari edili e metterli adisposizione per l’inter-vento
• Organizzare la distribu-zione di viveri e pasti
• Collaborare all’organiz-zazione dello smaltimen-to di materiali diversi
• Impiegare gli elementi lo-gistici in modo conformealle esigenze
• Procurare beni e orga-nizzare la loro distribu-zione
• Organizzare gli alloggi
Protezione civile
30
3.4 Protezione e assistenzaIn caso di sinistri e situazioni straordinarie, si deve pri-ma di tutto prestare aiuto alla popolazione minacciatao bisognosa d’assistenza.
3.4.1 AssistenzaL’assistenza implica tutte le misure atte ad accogliere,alloggiare, nutrire, vestire e curare le persone nonchéa provvedere al loro benessere. Per benessere s’intende «il migliore stato psicofisico esociale possibile».I compiti assistenziali si basano soprattutto sull’inizia-tiva personale. Si cerca quindi di rafforzare il senso diautonomia e responsabilità delle persone in cerca diprotezione.
3.4.2 Compiti dell’assistenzaI compiti del servizio d’assistenza possono variare a di-pendenza dell’evento o della situazione d’emergenza.Possibili compiti affidati all’assistenza:• Assistenza alle persone in cerca di protezione (per
es. senzatetto, persone evacuate, turisti bloccati sulposto, stranieri in cerca di protezione)
• Assistenza psicologica alle vittime, alle formazionid’intervento e ai loro familiari (per es. collaborazionein un careteam o in funzione di addetto all’aiuto psi-cologico d’urgenza)
• Assistenza generale alle autorità e ai servizi d’inter-vento (per es. collaborazione a perlustrazioni o allaregolazione del traffico)
• Sostegno alla sanità pubblica (per es. collaborazionealle cure infermieristiche in ricoveri e ospedali oppu-re al servizio ambulanze [144])
Protezione eassistenza
Sezioneassistenza
Sezioneassistenza
31
3.4.3 Personale e compitiL’assistenza è formata da una o più sezioni, in basealla grandezza dell’organizzazione.
Nei limiti delle istruzioni impartite dal suo superiore,l’addetto all’assistenza si occupa di:• assistere le persone minacciate o bisognose d’aiuto• stare vicino alle persone in pericolo• prestare cure in base alle istruzioni del personale
qualificato
Inoltre, collabora ai seguenti compiti:• elaborare piani e preparativi d’intervento• equipaggiare e gestire i posti collettori e d’assistenza• accogliere, registrare e assistere persone in cerca di
protezione• assistere la sanità pubblica• offrire assistenza generale alle autorità e alle forma-
zioni d’intervento• eseguire lavori di logistica specifica
Ulteriori informazioni:Documento tecnico per l’assistenza in caso di cata-strofi e altre situazioni d’emergenza, UFPP, rev. 2005Opuscolo «Aiuto psicologico d’urgenza», UFPP 2006(UFCL 408.991)
Caposezione
Capogruppo
Addettoall'assistenza
Protezione civile
32
3.5 Protezione dei beni culturaliLa Convenzione dell'Aia del 1954 costituisce la baselegale internazionale per la protezione dei beni cultu-rali. Gli stati firmatari sono tenuti a garantire la sicurez-za dei beni culturali in tempo di pace (inventari, docu-mentazioni e conservazione protetta) e il loro rispettoda parte degli eserciti in tempo di guerra. La Svizzeraha aderito alla Convenzione nel 1962 ed emanato unalegge federale in materia nel 1966.
3.5.1 In generale
Beni culturaliI beni culturali sono beni mobili e immobili pregiati delnostro patrimonio culturale quali: monumenti architet-tonici, artistici o storici (sia sacri che profani), luoghiarcheologici, complessi architettonici d’interesse stori-co o artistico, opere d’arte, manoscritti, libri e altri og-getti.
PericoliI beni culturali sono minacciati non solo da eventualiconflitti armati, ma anche da pericoli naturali o tecno-logici, furti, atti vandalici e metodi di conservazioneinadeguati (umidità).
3.5.2 Misure di protezioneGli oggetti più pregiati sono registrati nell’Inventariosvizzero dei beni culturali d’importanza nazionale e re-gionale. Accanto alle basi legali, l’Inventario costituisceil primo tassello per la protezione dei beni. Conoscerel’ubicazione e la denominazione dei beni permette, in-fatti, di pianificare ulteriori misure di protezione.
I beni culturali mobili sono documentati con fotografie,brevi documentazioni e indicazione delle dimensioni(lunghezza � larghezza � profondità). Le collezioni di archivi e biblioteche sono registrate sumicrofilm. Ciò permette di custodire i pezzi originali inun luogo sicuro e di conservare le informazioni sumicrofilm.
Le misure per proteggereil nostro patrimonio cultu-rale vanno adottate giàoggi.
Protezione deibeni culturali
Specialisti(Gruppo)
Specialisti(Gruppo)
33
In occasione di restauri, vengono spesso realizzate documentazioni di sicurezza sull’edificio. Queste comprendono piani, descrizioni dei materiali usati, informazioni sugliinterni e sull’arredo nonché fotografie.Le documentazioni di sicurezza rendono possibile la ricostruzione dell’edificio in casodi danni o distruzione.Si tratta di individuare i potenziali pericoli per i beni culturali e di adottare le misure perlimitare eventuali danni. In caso di trasloco di beni culturali mobili, si elabora un piano d’evacuazione che tieneconto del numero di oggetti da trasferire e delle esigenze che deve soddisfare la nuo-va sede. Per mettere in salvo collezioni ed archivi preziosi sono stati costruiti rifugi perbeni culturali.L’analisi dei potenziali pericoli potrebbe imporreun’evacuazione di beni culturali. Per questo motivo, iluoghi di conservazione ideali (accesso, condizioniclimatiche) sono già stati designati ed equipaggiati inmodo funzionale. Quando i beni subiscono danni, siricorre subito ai depositi di fortuna.
3.5.3 Personale e compitiIl capo della protezione dei beni culturali (C PBC) diri-ge il servizio. In base alla grandezza della protezione civile, può con-tare su un certo numero di specialisti PBC istruiti persvolgere i seguenti compiti:• coadiuvare il C PBC a pianificare le misure di prote-
zione (inventari, documentazioni di sicurezza)• elaborare i piani d’intervento• valutare l’idoneità dei depositi d’emergenza• ev. dirigere i volontari che partecipano alle operazioni• offrire consulenza e assistenza ai servizi d’intervento
in caso di danni
3.5.4 Collaborazione con i partnerSe i beni vengono danneggiati dal fuoco o dall’acquanonostante tutte le precauzioni adottate, il servizio della protezione dei beni culturali offre la sua con-sulenza ai pompieri e agli altri partner intervenuti. Aquesto scopo vengono elaborati piani d’intervento peri beni culturali più preziosi.
Protezione civile
34
3.5.5 Distintivo internazionale di protezione
I beni culturali protetti vengono contrassegnati per es-sere facilmente riconoscibili. Il distintivo internazionaleè uno scudo blu oltremare e bianco, appuntito verso ilbasso.
Per ordine del Consiglio federale, lo scudo della PBCviene applicato a tutti i beni culturali d’importanza na-zionale ed ai rifugi per i beni culturali. Solo singoli og-getti possono essere contrassegnati con questo scudo.Per ragioni d’ordine militare, è impensabile contras-segnare con lo scudo interi insediamenti come città,paesi o insiemi di edifici.
Scudo semplice = Protezione generale
Il Vaticano è l’unico bene culturale della Terra sotto pro-tezione speciale.
Triplo scudo = Protezione speciale
Per la protezione dei beni culturali fanno stato soprattutto la Legge federale per laprotezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1966 (LPBC, RS 520.3) el’Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1984(OPBC, RS 520.31).Ulteriori informazioni: Opuscolo «La protezione dei beni culturali (PBC) – Una missioneglobale», UFPP 2005
35
3.6 SostegnoIl sostegno è il settore con il ventaglio di compiti piùampio. Interviene soprattutto per assistere, da solo o incollaborazione, le altre quattro organizzazioni partnerdella protezione della popolazione, soprattutto in casodi eventi di ampia portata, catastrofi ed altre situazionid’emergenza.
In caso di sinistri naturali come alluvioni, tempeste, va-langhe, il settore sostegno viene impiegato anche per ilavori di ripristino che vanno eseguiti rapidamente perescludere eventuali danni secondari. Vi rientrano an-che lavori di consolidamento e sgombero.
3.6.1 Personale e compitiA seconda della grandezza della protezione civile, ilsettore sostegno è formato da una o più sezioni di pio-nieri.I pionieri devono essere in grado di utilizzare gli at-trezzi ed il materiale a loro assegnati.Essi vengono impiegati per:• eseguire lavori finalizzati a limitare i danni• adottare misure transitorie in caso di infrastrutture
distrutte• collaborare ai lavori di ripristino• eseguire lavori generali di sostegno Inoltre, collaborano ai seguenti compiti:• elaborare piani e preparativi d’intervento• realizzare costruzioni ausiliarie per limitare i danni• pompare l’acqua da scantinati e sottopassaggi• sgomberare strade, piazze, alvei, ecc.• adottare misure di sbarramento• offrire sostegno generale ai pompieri, alla polizia,
alle aziende comunali, ecc.• eseguire lavori di ripristino di ogni genere• eseguire lavori di logistica specifica
Sostegno
Sezionesostegno
Sezionesostegno
Protezione civile
36
3.7 LogisticaPer logistica s’intendono le misure atte a garantire l'esercizio delle ubicazioni, la messa a disposizione dibeni di sussistenza, l’impiego di mezzi di trasporto e dimacchinari da costruzione, la manutenzione e la pre-parazione del materiale ed il vitto.
3.7.1 Personale e compitiIl sergente maggiore è responsabile soprattutto di ga-rantire il buono svolgimento del servizio. Si occupa diadottare i regolamenti ed i provvedimenti atti ad age-volare la vita quotidiana sul posto.Un sergente maggiore particolarmente abile può ancheessere nominato capo della logistica della protezionecivile.Il sergente maggiore assiste inoltre il comandante del-la protezione civile nello svolgimento di attività legatealla pianificazione dei corsi di ripetizione, all’entrata inservizio ed al licenziamento. Infine, assume compiti inerenti alla salvaguardia del valore di impianti e mate-riale.
Il furiere (contabile) è un esperto in materia d’approv-vigionamento. Si occupa soprattutto di pianificare e or-ganizzare la sussistenza, acquistare i beni necessari etenere la contabilità. Di regola, viene nominato anchecapo dell’approvvigionamento
Il capocucina organizza il vitto in collaborazione con ilfuriere. È responsabile innanzi tutto di dirigere la cuci-na e preparare correttamente i pasti.
Il sorvegliante del materiale è responsabile per l’in-ventario, la custodia, determinati lavori di manutenzio-ne e la preparazione del materiale della protezionecivile. Ha facoltà di allestire un deposito del materialesul luogo d’intervento.
Logistica
Elementologistico
Elementologistico
Compiti logistici della protezione civile:• Garantire i trasporti, la
sussistenza e la contabi-lità
• Procurare i beni di sussi-stenza
• Inventariare, custodire,preparare il materiale eprovvedere alla sua ma-nutenzione
• Provvedere alla manu-tenzione e alla messa inesercizio degli impianti odelle ubicazioni
37
Il sorvegliante d’impianto esegue i lavori di manu-tenzione secondo le prescrizioni. Provvede affinché leinstallazioni tecniche dell’impianto funzionino corretta-mente e siano sempre pronte all’uso. In caso effettivo,garantisce l’esercizio tecnico degli impianti di protezio-ne e ripara eventuali guasti.
3.7.2 Elemento logisticoL’elemento logistico si assume soprattutto i compiti logistici della protezione civile. Puòanche essere impiegato a favore delle organizzazioni partner.In caso d’intervento, è possibile formare i seguenti gruppi specialistici ad hoc:• Gruppo specialistico impianti
sergente maggiore e sorvegliante/i d’impianto• Gruppo specialistico materiale
sergente maggiore e sorveglianti del materiale• Gruppo specialistico trasporti
sergente maggiore e personale ausiliario (conducenti)• Gruppo specialistico acquisti
furiere, sergente maggiore e distaccati• Gruppo specialistico contabilità
furiere e distaccati• Gruppo specialistico sussistenza
furiere, capo/i cucina e distaccati
È possibile distaccare militi della protezione civile incorporati in altre sezioni per svol-gere compiti in seno agli elementi logistici.
Ulteriori informazioni:Documento tecnico «Logistica della protezione civile», Ufficio federale della protezionedella popolazione, marzo 2003
38
3.8 Materiale /Veicoli
In generaleLa protezione civile disponedi un vasto assortimento dimateriale per svolgere i suoicompiti. Il comando della pro-tezione civile è responsabiledell’operatività.
VeicoliDi regola, la protezione civilenon dispone di veicoli propri.In caso d’intervento, i veicoliper trasportare il personaleed il materiale vengono pro-curati di volta in volta. Servo-no soprattutto veicoli per trai-nare i rimorchi della protezio-ne civile e per il trasporto delpersonale.
Protezione civile
39
3.9 Costruzioni di protezione
3.9.1 In generaleLe costruzioni protette sono state concepite soprattutto per proteggere la popolazionee per garantire la prontezza dei mezzi della protezione della popolazione in caso diconflitto armato, in particolare quando vengono utilizzate armi di distruzione di massa.Queste costruzioni offrono una protezione di base dagli effetti diretti e indiretti di moltearmi.In caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza (terremoto, pericolo di valanghe,contaminazione radioattiva, ecc.), è possibile utilizzare le costruzioni di protezionecome alloggi di fortuna.
3.9.2 RifugioOggi sono disponibili rifugi con filtri antigas e ventilazione artificiale per circa il 95%della popolazione svizzera, ossia per circa 7 milioni di abitanti.
Protezione civile
40
Il rifugio e i suoi elementi
ChiusaLa chiusa permette di entrare e di uscire senza chel’aria esterna penetri nel rifugio.È quindi possibile accedere al rifugio e uscirne anchequando l’aria esterna è contaminata.
Involucro e chiusure del rifugio La resistenza meccanica del rifugio è garantita da uninvolucro (pavimento, pareti e soletta) in calcestruzzoarmato con uno spessore di 25 – 30 cm.Affinché l’involucro presenti dappertutto la stessa resi-stenza, le aperture vengono chiuse mediante porte ecoperchi blindati, sempre di calcestruzzo armato.In questo modo il rifugio resiste a pressioni superiori a1 bar (= 10 t per m2). Inoltre, le pareti di calcestruzzo armato riducono a meno del 5 % l’intensità di un’even-tuale radiazione radioattiva che agisce dall’esterno.
Uscita di sicurezzaOgni rifugio dispone di un’uscita di sicurezza (uscita disoccorso o cunicolo d’evasione) per uscire dal rifugioquando l’entrata non è più utilizzabile a causa di un ef-fetto esterno.L’uscita di soccorso conduce direttamente all’esternolungo la facciata dell’edificio.Se l’altezza di gronda dell’edificio supera i 4 metri, sideve costruire un cunicolo d’evasione. In caso di di-struzione, ciò permette di evacuare l’edificio all’esternodella zona ingombra di macerie.
3.9.3 Impianto di protezioneGli impianti di protezione sono destinati alle organizzazioni della protezione della po-polazione e comprendono i posti di comando, gli impianti d’apprestamento ed i centrisanitari protetti. Vengono utilizzati in primo luogo per garantire la condotta e la pron-tezza operativa dei mezzi della protezione della popolazione. I posti di comando servo-no alla condotta e all’aiuto alla condotta. Gli impianti d'apprestamento accolgono il per-sonale ed una parte del materiale delle formazioni.
Le basi legali sulle costruzioni di protezione figurano nelle appendici 10 e 11.
41
Impianto di ventilazioneIl rifugio dispone di un impianto di ventilazione pergarantire l’apporto dell’aria fresca necessaria per larespirazione.L’impianto di ventilazione comprende:• presa d’aria (situata di regola nel telaio del coperchio
blindato)• valvola antiesplosione e prefiltro• apparecchio di ventilazione (VA)• filtro antigas
Latrine e allacciamenti idriciIn linea di principio, viene installata una latrina ogni 30 posti protetti. Di regola, vengono impiegate latrine a secco.In parte esistono anche gabinetti ad acqua e docce.
Protezione civile
42
Posto di comando (PC)
Il posto di comando è concepito come luogo di lavoroed alloggio protetto della protezione civile. È equipag-giato con installazioni tecniche di trasmissione ed at-trezzato per il lavoro dei membri di stato maggiore.
Il posto di comando può essere utilizzato come ubica-zione dell’organo civile di condotta.
43
Impianto d'apprestamento (IAP)
L’impianto d’apprestamento è concepito come alloggioper la truppa e deposito del materiale.Funge da base per gli interventi poiché il materiale im-magazzinato nell’impianto di protezione è semprepronto all’intervento.Comprende anche dormitori, locali di soggiorno e unacucina.
Assume un ruolo importante quale piazza d’organizza-zione della protezione civile e centro per il sostegnologistico.
Protezione civile
44
Centro sanitario protetto
Il centro sanitario protetto è un impianto del servizio sanitario equipaggiato con sala operatoria, farmacia,laboratorio ed altre installazioni tecniche. Quando èoperativo, consente di eseguire anche semplici inter-venti chirurgici. Serve al Cantone per garantire l’ap-provvigionamento sanitario alla popolazione, soprattut-to in caso di conflitti armati. Di norma, un centro sani-tario dispone di oltre 128 posti letto per pazienti. Leubicazioni designate e la loro utilizzazione si basanosui piani cantonali. È possibile utilizzarle come alloggidi fortuna per le persone evacuate ed i senzatetto.
Conoscenze di base
45
4 Conoscenze di base
4.1 IntroduzioneIn base all’articolo 3 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (vedasi appendice 10), la protezione civile deve svolgere molteplici compiti.A seconda del tipo d’intervento, ogni milite della protezione civile deve essere in gradodi svolgere anche compiti di altri settori, indipendentemente dalla sua funzione (assi-stente di stato maggiore, addetto all’assistenza o pioniere).
4.2 Analisi della situazioneCompiti che rientrano nel campo dell’aiuto alla condot-ta sono ad esempio:• orientarsi su una carta topografica• orientarsi sul terreno• allestire uno schizzo• redigere e trasmettere un messaggio• trasmettere un messaggio via radio
4.2.1 Carte e scale topograficheVengono utilizzate soprattutto carte dell’Ufficio federa-le di topografia.Le carte più comuni per orientarsi sul terreno sono inscala:1:25000 1 cm sulla carta = 250 m nella realtà1:50000 1 cm sulla carta = 500 m nella realtà1:100000 1 cm sulla carta = 1 km nella realtàEsistono anche carte in scala più grande che per-mettono di visualizzare il maggior numero di dettagli(per es. piani comunali in scala 1:5000).
Conoscenze di base
46
CoordinateÈ possibile definire e indicare qualsiasi punto sulla carta.Nelle carte nazionali figura la rete delle coordinate. Le coordinate sono cifre di sei numeri. Le prime trecifre corrispondono ai chilometri, le tre finali ai metri.Le coordinate 600 000 / 200 000 coincidono esatta-mente con l’ubicazione del vecchio osservatorio astro-nomico di Berna.I chilometri variano da sud a nord tra 75 nel canton Ti-cino e 295 nel canton Sciaffusa; da ovest a est tra 485nel canton Ginevra e 834 nel canton Grigioni.
Segni convenzionaliGli elementi del paesaggio sono rappresentati sullacarta per mezzo di simboli o segni, i cosiddetti segniconvenzionali.
Nota:(Nell’appendice 2 figura un estratto dei segni conven-zionali utilizzati da tutti i partner della protezione dellapopolazione.)
4.2.2 Stimare le distanzePer stimare approssimativamente una distanza sul ter-reno esistono due metodi semplici:• Metodo della media:• Si stima quanto un oggetto dista al minimo e quanto
al massimo da un punto. La media dei due risultaticorrisponde alla distanza approssimativa.
• Metodo del pollice:• Con il braccio teso e il pollice rivolto verso l’alto gira-
tevi in direzione di un oggetto che si trova sul terre-no. Ora guardate sopra il pollice, prima con l’occhiodestro poi con quello sinistro e stimate la distanza trala posizione del pollice visto con l’occhio destro equella del pollice visto con l’occhio sinistro. Moltipli-catela per dieci e troverete a quale distanza è situa-to approssimativamente l’oggetto.
Segno convenzionale
Nelterreno
Strada di seconde categoria
47
4.2.3 Osservare e trasmetterePer essere efficace, la condotta deve basarsi sui risul-tati di osservazioni, sopralluoghi e ricognizioni. Le os-servazioni sono però utili solo se trasmesse in modosemplice e chiaro.L’osservatore trasmette• messaggi orali o scritti utilizzando segnali acustici e
visivi predefiniti• in modo spontaneo, chiaro, comprensibile e tempe-
stivoLe minacce incombenti vanno annunciate subito.
Schema di notificaPer semplicità, tutti i partner della protezione della po-polazione dovrebbero trasmettere i messaggi secondolo stesso schema.Modello di un modulo di notifica vedasi appendice 3.
PlanskizzePiano
Tracciare schizziGli schizzi possono completare i messaggi.Si distingue fra due tipi di schizzi:
• Piano: mostra una zona ben delimitata vista dall’alto(unidimensionale); simile a una carta topografica
• Veduta: mostra una zona ben delimitata dal punto divista dell’osservatore (bidimensionale); simile aduna fotografia
Schizzo
Conoscenze di base
48
4.3 Telematica
4.3.1 Radiocomunicazione SE-125
MaterialeOltre all’apparecchio radio con i suoi accessori, per laradiocomunicazione servono anche il materiale perprendere appunti, un’antenna di riserva (di regola SEA80 K) e le batterie di riserva. Può essere impartita unabreve istruzione sull’uso degli apparecchi.
Piano di rete radioIn caso d’intervento radio, viene distribuito e spiegatoagli utenti il piano di rete radio con le informazioni at-tuali. Vi devono figurare soprattutto i nominativi e i ca-nali radio.
Controllo di funzionamentoIl personale istruito esegue il controllo di funzionamen-to prima dell’intervento e conformemente alle istruzioniper l’uso. Vanno controllati gli elementi di ricetrasmis-sione, gli accessori e lo stato delle batterie.
4.3.2 Traffico radioGli apparecchi radio SE 125 dispongono di un solo ca-nale operativo (sistema simplex). Si può quindi tras-mettere solo con una stazione radio alla volta. Di rego-la, le altre stazioni ascoltano la conversazione. Le con-versazioni radio devono perciò essere brevi e chiare edi messaggi redatti in modo conciso.
49
Controllo degli apparecchi SE 125 prima di occupare le postazioni radio
• Controllo di funzionamento trasmissione, ricezione, accessori, batterie(eseguito da personale istruito)
• Antenna allungabile completamente estratta e direzionata verso l’alto
• Piano di rete radio il proprio nominativo e quello degli altriutenti sono noti
• Canale radio impostazione corretta del canale sull’ap-parecchio secondo il piano di rete radio
• Interruttore principale posizione ON (puntino rosso)con squelch inserito
• Materiale e accessori radio completi• Missione e postazione radio note
Regole di conversazioneLe regole minime da rispettare sono le seguenti:
• Chiamare (secondo il piano di rete radio) «Stazione opposta alla propria»Esempio: «Posto d’assistenza da PC fronte»
• Invitare la stazione opposta a parlare «Rispondere»
• Confermare la ricezione «Capito»Quindi conversare liberamente
• Terminare il collegamentoe liberare la rete «Terminato»
4.4 Protezione ABCI compiti di protezione ABC vengono svolti da specia-listi istruiti in materia.Ogni milite della protezione civile dovrebbe perlomenosapere come si usa la maschera di protezione.(Vedasi appendice 6)
Conoscenze di base
50
51
4.5 Protezione e assistenza
4.5.1 Protezione nel rifugioIn caso di catastrofi ed altre situazioni d’emergenza odi conflitto armato, le autorità possono ordinare la pre-parazione e l’occupazione dei rifugi e, se necessario,l’obbligo di soggiornare negli stessi. Queste misurevengono ordinate nell’ambito della diffusione delleistruzioni sul comportamento da adottare.
Dopo aver occupato un rifugio, si deve arredarlo e or-ganizzare il soggiorno. Le procedure da seguire devono essere note non soloagli addetti all’assistenza, ma a tutti i militi della prote-zione civile.(Vedasi appendice 5)
4.5.2 Messa in esercizio del rifugio in caso di pericolo imminenteIn caso di pericolo imminente, si ordina alla popolazione – tramite comunicato radio –di mettersi al sicuro nei rifugi (generalmente utilizzati come cantine). Le misure da adot-tare sono le seguenti:
1. Ascoltare costantemente la radio (RSI 1 o radio locale)
Conoscenze di base
52
AttivitàRispettare le istruzioni sul com-portamento da adottare chevengono trasmesse per radio
AttivitàSgomberare tutti gli oggetti chesi possono spostare facilmentee depositarli fuori del rifugio
• Chiudere il coperchio blindato
• Alloggiare gli animali in un locale adiacente al rifugio
• Controllare che tutti gli abitanti dell’immobile si trovino nel rifugio
• Solo se l’ordine è stato trasmesso per radio: chiudere la portablindata ed accendere l’apparecchio di ventilazione secondo le istru-zioni per l’uso (affisse presso l’apparecchio)
• In caso di necessità, si potrà utilizzare la toilette più vicina al rifugio
Ulteriori istruzioni verranno trasmesse per radio.
2. Fare posto
3. Altre misure
IndicazioniScegliere un luogo che per-metta una buona ricezioneradio (in vicinanza della por-ta blindata o dell’apparec-chio di ventilazione).In certi casi la buona rice-zione radio è garantita soloall’esterno del rifugio, nel-l’edificio.
Indicazioni• Tenere libero l’accesso al
rifugio• Controllare che sia possi-
bile utilizzare le porte blin-date, il coperchio blindatoe l’apparecchio di ventila-zione
53
4.5.3 StressDurante un intervento, il milite della protezione civile può essere sottoposto ad unostress che supera i suoi limiti di sopportazione.Egli deve perciò essere in grado di riconoscere i principali sintomi ed effetti dello stress.
Definizione del termine «stress»Lo stress è dovuto all’interazione fra un individuo e le cir-costanze.Lo stress è causato da pressioni esterne o interne che,in base alla percezione di una persona, mettono alla pro-va o superano le risorse individuali o generali (capacitàdi sopportazione). Il divario fra queste pressioni e la ca-pacità di sopportazione individuale genera lo stress.(Lazarus & Launier,1991; Folkman, 1948)
Sintomi comporta-mentali
• Abuso di nicotina, alcool e pastiglie
• Difficoltà di concentra-zione
• Rendimento discon-tinuo
• Assenze (giorni di malattia)
• Conflitti• Litigi, aggressioni• Ritiro, isolamento
Sintomi psichici edemotivi
• Calo di concentra-zione e di memoria
• Paura• Irritabilità• Insicurezza• Calo d’autostima• Stato depressivo• Aggressività• Angoscia
Sintomi fisici
• Mal di testa• Fiacchezza• Crampi• Tensione• Nervosismo, agita-
zione motoria• Esaurimento fisico• Palpitazioni• Ipertensione
Lo stress può causare sintomi fisici, psicologici, emotivi e comportamentali. Per esempio:
Conoscenze di base
54
I fattori che innescano lo stress sono detti stressori. Questi possono essere interni oesterni. Gli stressori interni vengono prodotti nella persona, mentre quelli esterni dal-l’ambiente che la circonda.
Assistere ad un grave incidente può rappresentareun’esperienza traumatica.Sono reazioni del tutto normali. Anche il cordoglio e ladisperazione sono normali reazioni provocate da unadisgrazia.Ci sono due modi per combattere lo stress:• interventi diretti sull’individuo colpito,• misure per prevenire le cause dello stress.Gli interventi diretti sull’individuo sono:• Modificare la valutazione personale, relativizzare nel
confronto con gli altri• Ridurre l’agitazione
(per es. con tecniche di rilassamento)• Aumentare la resistenza fisica tramite cibo, sonno e
distrazioni.• Lasciare sfogare i sentimenti personali
(per es. pianto, rabbia)Le misure per prevenire i fattori stressanti sono:• Migliorare le condizioni di lavoro• Migliorare la struttura organizzativa
(per es. orario di lavoro)• Favorire i contatti sociali• Risolvere i problemi
Stressori interni• Insoddisfazione personale• Obiettivi personali
(professionali, sociali, privati)• Valori e rappresentazioni morali• Aspetti normativi importanti per l’individuo
Stressori esterni• Aspettative esterne• Mole di lavoro• Grado di difficoltà• Compiti poco chiari• Responsabilità• Condizioni sociali, econo-
miche e culturali
55
4.6 Sostegno
4.6.1 Lotta antincendio
Genesi di un incendioPer comprendere le misure di prevenzione e di lotta antincendio è indispensabile sapere come funziona un processo di combustione. L’incendio si sviluppa solo se sonosoddisfatte queste tre condizioni:• Presenza di sostanza combustibile (solida, liquida
o gassosa).• Apporto continuo di ossigeno proveniente di regola
dall’aria.• Raggiungimento della temperatura d’accensione
della sostanza combustibile (per es. legno 220 –320°C, alcool 425 °C). Più bassa è la temperaturad’accensione di una sostanza, maggiore sarà il peri-colo d’incendio.
Spegnimento di un incendioPer spegnere un incendio si cerca di eliminare almenouno dei tre presupposti per la combustione. • Eliminazione del combustibile:• Operazione non sempre facile da eseguire per il
rischio di generare nuovi incendi!• Eliminazione dell’ossigeno:• La maggior parte delle sostanze combustibili si spen-
gono se si riduce il tenore di ossigeno nell’aria. Chiu-dendo porte e finestre o coprendo il fuoco con unacoperta di spegnimento si limita l’apporto di aria.
• Eliminazione dell’energia:• Una sostanza s’incendia solo se raggiunge la tem-
peratura d’accensione. Raffreddandola si cerca diportare la temperatura al di sotto di questa soglia.
Oss
igen
o
Temperatura d’accensione
Sostanza combustibile
Eliminazionedell’ossigeno
Eliminazionedell’
energia
Eliminazione del combustibile
Oss
igen
o
Temperatura d’accensione
Sostanza combustibile
Genesi di un incendio
Conoscenze di base
56
Classificazione degli incendiGli incendi vengono suddivisi in classi (A, B, C, D) in base alla sostanza combustibile.Questa distinzione permette di scegliere il mezzo di spegnimento più adeguato.
Classe Sostanze combustibili
Incendio di materiali solidi, soprattutto di natu-ra organica, la cui com-bustione produce fiammee braciEsempi: legno, carta, tes-suti, carbone
Incendio di liquidi o solidi liquefattibiliEsempi: benzina, nafta,petrolio, grassi, vernici,solventi, cere
Incendio di gasEsempi: acetilene, butano,metano, propano
Incendio di metalliEsempi: metalli leggericome magnesio e allu-minio, le loro leghe,sodio e potassio.
Estintore portatileappropriato
ad acquaa polvere tipo ABC(a schiuma)
a polvere tipo ABCa schiuma(a CO2)
a polvere tipo ABCa CO2
a sabbiaa polvere antincendiometalli
57
Comportamento in caso d’incendio
ALLARMARE – SALVARE – SPEGNERE
ALLARMARE
• Chi chiama? (cognome, nome, numero di telefono)• Dove è successo? (via, numero civico, piano)• Cosa è successo? (incendio, esplosione)• Quante persone sono state coinvolte/ferite?• Aspettate eventuali altre domande della centrale d’allarme!
SALVARE
• Salvate le persone e gli animali• Chiudete porte e finestre• Abbandonate il luogo dell'incendio passando per le vie di fuga
(uscite, scale, uscite di soccorso); non usate gli ascensori• Se le trombe delle scale ed i corridoi sono invasi dal fumo,
restate nei locali, chiudete la porta ed attendete i pompieri (segnalate la vostra presenza ad una finestra chiusa)
SPEGNERE
• Domate le fiamme con i mezzi disponibili (estintore portatile, coperta di spegnimento, pompa a secchio, idrante a muro)
• Non cercate di spegnere le fiamme se vi mettete in pericolo• Indicare l’incendio ai pompieri che giungono sul luogo
INCENDIO IN GALLERIAComportamento corretto
• Accostate• Spegnete subito il motore• Lasciate la chiave nell’accensione• Scendete subito dal veicolo e recatevi al rifugio, all’uscita
d’emergenza o al portale più vicino
118
Conoscenze di base
58
Mezzi di spegnimentoÈ possibile spegnere rapidamente i principi d’incendio con mezzi e provvedimentisemplici.
• Pompa a secchioLa pompa a secchio è costituita da un supporto, unapompa con canna di 5 metri ed una lancia con ugelliintercambiabili a getto o nebulizzanti. Il secchio è ab-binato alla pompa. La pompa a secchio è il mezzoideale per spegnere focolai e piccoli incendi poiché èsubito pronta all’uso. In caso d’impiego, posizionare la pompa a secchio inmodo che l’utente possa avanzare verso il fuoco senza essere ostacolato dal fumo e dal calore.Se possibile, formare squadre di spegnimento di almeno tre persone.
• Coperta di spegnimentoStendete rapidamente la coperta di spegnimento.Avvolgete le mani nei suoi angoli per proteggervi dalfuoco e posatela lentamente sul principio d’incendiocon un movimento rotatorio che parte dal vostro cor-po. Evitate un ulteriore afflusso d’aria.Non rimuovete la coperta finché il focolaio non ècompletamente spento o fino all’arrivo dei pompieri.
• Estintore portatile• Il prodotto estinguente deve essere adatto al tipo
d’incendio da domare. Seguite le istruzioni che figu-rano sull’estintore. In caso di dubbio, informatevipresso il fabbricante o il fornitore sulle possibilità d’impiego.Il buon funzionamento dell’estintore è garantito solose viene periodicamente controllato da un tecnico.
59
Regole di spegnimento
Spegnete gli incendi nella direzione
del vento
Incendio esteso:spegnete iniziando davanti e in
basso
Incendio alimentato da combustibileche scorre o gocciola:
spegnete dall'alto verso il basso
Incendio di pareti:spegnete dal basso verso l'alto
Impiegate più estintoricontemporaneamente, e mai uno allavolta
Badate che l'incendio non siriaccenda
������ ��������
Conoscenze di base
60
4.6.2 Conoscenza dei nodiI nodi assumono un’importanza spesso trascurata nella nostra vita quotidiana. Sappia-mo quanto può essere irritante un oggetto che si slaccia in un momento sbagliatoperché il nodo non è stato eseguito in modo corretto. Nella vita quotidiana, utilizziamo i nodi per allacciarci le scarpe, chiudere il sacco dellaspazzatura, legare oggetti sul portabagagli dell’automobile, fissare un telone su unacatasta di legna, prolungare una fune, riparare una stringa, ecc.I nodi vecchi o nuovi per legare in modo sicuro gli oggetti sono centinaia se non ad-dirittura migliaia.Qui di seguito descriviamo l’esecuzione di alcuni nodi che fino ad oggi si sono prestatimolto bene anche per gli scopi della protezione civile.
61
Nodo piattoIl nodo piatto è usato soprattutto per congiungere due corde.Attenzione: i due capi della corda devono trovarsi dalla stessa parte del nodo (figura 4)!
1 2
3 4
62
Nodo del muratoreÈ il nodo più semplice ed adatto per fissare corde attorno a grandi tronchi e pali. Siscioglie facilmente anche quando è molto stretto in seguito a forti tensioni. È importanteavvolgere la corda attorno al cappio (A) per almeno tre quarti della circonferenza (B),affinché il nodo non si sciolga in caso di movimento (C).
Conoscenze di base
Nodo del muratore e mezzo colloQuesti due nodi combinati permettono ditrainare e sollevare tronchi.
1 2
3 4
5
63
Nodo da tessitoreIl nodo da tessitore serve a congiungere corde o funi e per terminare legature.
1 2
3 4
64
Nodo da battelliereI due tipi di nodo da battelliere sono i nodi d’avvolgimento più comuni (per es. per fis-sare la fune ad un palo o delimitare una zona).a) Nodo da battelliere da infilare sull’oggetto
Conoscenze di base
1 2
3
66
4.6.3 Regolazione del traffico
In caso d’ingorghi del traffico, i militi della protezione civile che partecipano all’inter-vento sono tenuti a regolare la circolazione nei punti pericolosi.
Principi• Solo i militi istruiti possono regolare il traffico.• Le guardie del traffico della protezione civile rego-
lano la circolazione di tutti gli utenti della strada.• Le guardie del traffico sono tenute a regolare la cir-
colazione fino all’arrivo della polizia o al ripristinodella normalità.
• Gli utenti della strada sono tenuti a rispettare i se-gnali e le indicazioni delle guardie del traffico dellaprotezione civile.
Equipaggiamento delle guardie del trafficoL’equipaggiamento delle guardie del traffico comprende:• un giubbotto fluorescente di colore arancione• due bracciali fluorescenti• due gambaletti fluorescentiDi notte e se le condizioni atmosferiche lo esigono, leguardie del traffico devono utilizzare anche una torciarossa. La torcia rossa serve normalmente solo comesegnale d’arresto e in casi eccezionali anche per darevia libera a veicoli fermi.
Conoscenze di base
67
Segnalazioni delle guardie del traffico
Rallentare (movimento del braccio verso l’alto e verso il basso)
Rallentamento del traffico proveniente da davanti:Avambraccio sinistro pie-gato verso l’esterno
Rallentamento del traffico proveniente da sinistra:Avambraccio sinistro pie-gato a lato del corpo
Rallentamento del traffico proveniente da destra:Avambraccio destro pie-gato a lato del corpo
Segnale per i pedoni
Avanzare per i pedoniprovenienti da destra eda sinistra:Cenno del braccio tesodavanti al corpo tenendo o non tenendo alzatol’altro braccio.(Tenere alzato l’altro brac-cio aumenta la sicurezza.)
68
Via libera
Via libera nelle due dire-zioni corrispondenti se il traffico scorre;
Stop del traffico pro-veniente da davanti e dadietro:Braccia allargate lateral-mente
Via libera nella rispettivadirezione:Cenno con il braccio destroo sinistro
Conoscenze di base
Svolta a sinistra davanti alla guardia del traffico(spalla sinistra rivolta verso chi svolta a sinistra)
69
Stop del traffico prove-niente da davanti e da dietro:Braccia allargate lateral-mente
Stop
Stop prima della dira-mazione per il traffico intutte le direzioni:Braccio alzato
Stop dei veicoli pro-venienti da dietro:Braccio teso lateralmente
Stop del traffico prove-niente da destra e dadietro: Braccia allargatead angolo retto
Via libera per i veicoliche svoltano a sinistra:Cenno con il braccio sini-stro verso il corpo
Via libera per i veicoliche procedono diritto oche svoltano a destra:Cenno di procedere diritto
Conoscenze di base
70
Segnalazioni permanovre con vei-coli a motore
Cambiamenti di dire-zione: Braccio destro o sinistroesteso lateralmente:Girare il volante a destrao a sinistra finché il braccio non viene abbas-sato
Avanzare e retrocedere
Avanzare (1):Movimento degli avam-bracci dal basso versol’alto, dalla posizione orizzontale fino alle spalle(palmo delle mani rivoltoverso l’alto)
Retrocedere (2):Movimento degli avam-bracci dal basso verso l’alto, al massimo fino allaposizione orizzontale (palmo delle mani rivoltoverso il veicolo)
1 2
71
Arrestare
Mani allargate lateralmente all’altezza del capo: Indicare la distanza ravvicinando lentamente le mani
Mani chiuse sopra il capo:Stop
73
Lotta contro i sinistri
5 Lotta contro i sinistriLa missione della protezione della popolazione consiste nel proteggere la popolazionee le sue basi vitali nonché i beni culturali soprattutto in caso di catastrofi e altre situa-zioni d’emergenza.
Importanza statistica delle catastrofi in Svizzera
Catastrofi naturali : ~ 60 %
Emergenze sociali : ~ 30 %
Catastrofi tecnologiche : ~ 10 %
EpidemieTerremoti
Movimentitellurici
Inondazioni
Temporali
Tempeste
Valanghe
Ondate di freddo
Cedimenti di dighe
Incidenti in CN
Migrazioni
Siccità / Caldo
Le catastrofi che si sono verificate in Svizzera negliultimi anni confermano queste scelte operative.
74
Lotta contro i sinistri
5.1 Sinistro quotidianoSi tratta di sinistri che i mezzi locali o regionali di pri-mo intervento (polizia, pompieri e organizzazioni sani-tarie di salvataggio) sono in grado di fronteggiare dasoli.
Quando si verifica un sinistro quotidiano si deve an-nunciare:• Che cosa è successo, quando e dove
(numero di feriti, ora, luogo, ev. coordinate)• Condizioni meteorologiche
(visibilità, nuvolosità, precipitazioni, vento)• Vie d’accesso (ev. possibilità d’atterraggio)• Possibilità per chiedere ulteriori informazioni
(numero di telefono e di cellulare, collegamento radio)I mezzi di primo intervento, detti anche organizzazionia luce blu, sono sempre pronti ad intervenire e posso-no essere chiamati in qualsiasi momento tramite i nu-meri d'emergenza.
5.2 Sinistro importanteSi tratta di sinistri geograficamente circoscritti cherichiedono la collaborazione di diverse organizzazionid’intervento come pure di aiuti esterni, ma di cui simantiene il controllo.Le organizzazioni partner intervengono con mezzimodulari. La struttura di base del sistema modulare èincentrata sui sinistri quotidiani. I mezzi d’interventovengono quindi rinforzati in funzione del tipo e dellagravità del sinistro.
Notifica di sinistroChiamate d’emergenza:Polizia 117Pompieri 118Pronto soccorso autoambulanze 144(ev. tramite il 117)REGA 1414Dal telefonino:Numero di chiamata inter-nazionale(Europa) 112
Selezionando il 112 dallarete mobile, siete automa-ticamente collegati con ilposto di polizia più vicino
Dalle cabine telefoniche aprepagamento, i numeri112, 117, 118 e 144 sonogratis e raggiungibili senza inserire monete ocarte di credito.
75
5.3 Catastrofe e altre situazioni d’emergenza
La catastrofe è un evento d’origine naturale o tecnolo-gica (oppure un grave incidente) che causa un numerodi danni tale da rendere insufficienti i mezzi in perso-nale e materiale della comunità colpita.
La situazione d’emergenza è causata da sviluppi so-ciali o avarie tecniche che non è possibile fronteggiarecon le procedure ordinarie, poiché il personale e il ma-teriale della comunità colpita sono insufficienti.Esempi:• Pericoli su vasta scala per la salute pubblica come
– epidemie– siccità e ondate di caldo– incidenti biologici
• Emergenza nel campo dei profughi: immigrazionemassiccia
• Gran parte dei mezzi d’informazione fuori servizio
76
Lotta contro i sinistri
5.4 Diffusione dell’allarme e chiamata in servizio
In caso di sinistro quotidiano, la centrale d’intervento della polizia cantonale chia-ma in servizio i mezzi di primo intervento.Il personale dei mezzi di primo intervento viene mobilitato via telefono (SMT, siste-ma di mobilitazione per telefono), pager, cellulare (natel) o radio.
In caso di sinistro importante, il capo intervento (della polizia o dei pompieri) puòmobilitare, tramite la centrale d’intervento della POLCANT, i seguenti mezzi supple-mentari:• Pompieri del centro di soccorso, Servizio chimico• Protezione civile• Mezzi supplementari della sanità pubblica• Aziende tecniche (gas, acqua, elettricità, traffico, smaltimento rifiuti, telematica)
In caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza, si mobilitano anche:• Elementi di riserva• Organizzazioni e aziende private• Esercito
*) POLCANT = Polizia cantonale**) OCC = Organo comunale
di condotta
**) ORC = Organo regionale di condotta***)OrgCantCond = Organo cantonale di condotta
77
A5-Broschüre auf 2
Sinistro
POLCANT*)Centrale d'intervento
117 / 118 / 112
PartiOCC/
ORC**)
InteroOCC/ORC
Pompieri
Elementiprotezione civile
S san di salv
Pompieri
S san di salv
Protezione civile
Servizi tecnici
Aziende privatetenute a
prestare aiuto
Polizia
Servizi tecnici
Polizia
OrgCantCond***) Esercito
Lotta contro i sinistri
5.5 Chiamata della protezione civileI militi della protezione civile mobilitati per far fronte aun sinistro devono entrare in servizio secondo le istru-zioni delle autorità.I Cantoni regolano la procedura di chiamata della pro-tezione civile.
I mezzi tecnici disponibili per la chiamata possono es-sere i seguenti:• SMT o pager per chiamare in servizio, tramite la cen-
trale d’intervento, i militi della protezione civile subitodisponibili
• telefono o altri mezzi di fortuna per chiamare in ser-vizio, tramite il comando della protezione civile, ilgrosso dei militi PCi
La chiamata include le seguenti informazioni:• Data /Ora• Luogo d’entrata in servizio (se non predefinito)• Equipaggiamento (i militi delle formazioni subito di-
sponibili conservano l’equipaggiamento al loro domi-cilio)
• Durata dell’intervento (se possibile)
Di regola, i militi delle formazioni subito disponibili en-trano in servizio nei luoghi predefiniti.Per es. impianti della protezione civile, sede dei pom-pieri, ecc.
I militi della protezione civile mobilitati più tardi entranoin servizio su una piazza d’organizzazione dove ven-gono equipaggiati, organizzati e preparati per l’inter-vento previsto.
Le basi legali concernenti la chiamata figurano nelleappendici 10 e 11.
Diffusione dell’allarme = avvertire, rendere attenti,chiedere l’aiuto di un’istitu-zioneChiamata = ordine d’entrata per adem-piere l’obbligo di servirenell’esercito o nella prote-zione civile
78
79
5.6 Direzione d’intervento in caso di sinistri
Anche la direzione d’intervento ha una struttura modu-lare.In una situazione normale, vale a dire in caso di sinistriquotidiani, la direzione d'intervento spetta di regolaalla polizia o ai pompieri.Il capointervento è responsabile di coordinare le misu-re d’assistenza e di salvataggio nella zona sinistrata.
In caso di eventi d’ampia portata, la condotta spetta auna direzione d’intervento generale formata da rap-presentanti delle organizzazioni partner coinvolte e, senecessario, anche da specialisti e personale dell’am-ministrazione.Il capointervento generale è responsabile di tutte le for-mazioni che operano nella zona sinistrata.
5.7 Organizzazione della zona sinistrataIn caso di sinistro e soprattutto in caso di sinistro d’ampia portata o di catastrofe, i mez-zi che operano nella zona sinistrata devono essere coordinati ed organizzati in modoefficiente.
L’organizzazione della zona sinistrata ed i segni convenzionali per le installazioni sonostati unificati per tutti i partner della protezione della popolazione.(Segni convenzionali vedasi appendice 2)
80
Lotta contro i sinistri
5.7.1 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe circoscritta(per es. incidente ferroviario, caduta di un areo, incidente chimico)
veic
i
Feuerwehr
Sbarramento esterno
Sbarramento interno
Sbarramento di sicurezza
Asse di salvataggio
C
C
oppure ORC
ABC
OCC
dirint
81
5.7.2 Organizzazione della zona sinistrata in caso di catastrofe estesa(per es. maltempo, inondazioni, terremoto)
C = Sostanze chimichepomp = Pompieri
OCC = Organo comunale di condottaORC = Organo regionale di condotta
82
Diritti e doveri
6 Diritti e doveriI diritti e i doveri dei militi della protezione civile sono regolati dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4.10.2002 e dall’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5.12.2003. Gli articoli più importantidella legge sono elencati nella seguente tabella. La legge e l’ordinanza figurano nelleappendici 10 e 11.
6.1 Obbligo di prestare servizio di protezione civile
6.2 Diritti
Articolo LPPC OPCi
Persone tenute a prestare servizio di protezione civile art. 11
Eccezioni art. 12
Durata art. 13
Obbligo di prestare servizio ampliato in caso di conflitto armato art. 14
Volontariato art. 15 art. 1
Riserva di personale art. 18
Proscioglimento anticipato art. 20 art. 2
Esclusione art. 21 art. 3
Articolo LPPC OPCi
Soldo, vitto, alloggio e trasporto art. 22
Soldo art. 4
Indennità per perdita di guadagno art. 23
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare art. 24
Assicurazione art. 25
83
6.3 Doveri
I numeri RS indicati in calce nella legge agevolano la ricerca dei vari atti giuridici inInternet. Selezionate la Raccolta sistematica del diritto federale (RS) nel sito www.admin.ch (documentazione) e digitate un numero RS nel campo di ricerca.
Articolo LPPC OPCi
Obblighi art. 26
Obbligo di entrare in servizio art. 7
85
Funzioni e distintivi indicanti il grado Appendice 1
In caso di necessità, i Cantoni possono definire ulteriori funzioni.I soldati della protezione civile possono essere promossi ad appuntati, i caporali a ser-genti e i tenenti a primi tenenti.
Settore Funzione Grado
Funzioni diAiuto alla condotta • Assistente di stato maggiore • Soldato della PCi
baseProtezione e assistenza • Addetto all’assistenza • Soldato della PCi
Sostegno • Pioniere • Soldato della PCi
Aiuto alla condotta • Istruttori dei terminali
• POLYCOM
• Ricercatore A • Soldato della PCi
• Persona competente in radioprotezione
Protezione e assistenza • SanitarioSpecialisti • Addetto all’assistenza • Soldato della PCi
• psicologica immediata
Protezione dei beni • Specialista PBC • Soldato della PCiculturali
Logistica • Sorvegliante del materiale • Soldato della PCi
• Sorvegliante d'impianto
Comando PCi • Comandante PCi • Colonnello, tenentecolonnello, maggiore o capitano
• Sost comandante PC • Maggiore, capitanoo primo tenente
Aiuto alla condotta • Capo analisi della situazione
• Capo telematica• Tenente
• Capo protezione ABC
• Capo coordinamento logistico
• Capogruppo telematica • Caporale
Quadri Protezione e assistenza • Caposezione assistenza • Tenente
• Capogruppo assistenza • Caporale
• Capogruppo servizio sanitario
Protezione dei beni • Capo protezione dei beni • Tenenteculturali culturali
Sostegno • Caposezione sostegno • Tenente
• Capogruppo sostegno • Caporale
Logistica • Capo elemento logistico • Sergente maggiore• Addetto alla contabilità e • Furiere
all’ordinario• Capocucina • Caporale
AppuntatoAppuntato CaporaleCaporale SergenteSergente
FuriereFuriere Sergente maggioreSergente maggiore
TenenteTenente PrimotenentePrimotenente CapitanoCapitano
MaggioreMaggiore Tenente colonnelloTenente colonnello ColonnelloColonnello
86
Funzioni e distintivi indicanti il grado
87
Segni convenzionali (estratto) Appendice 2
Segno Significato Segno Significato
1 Posto di comando(ubicazione di condotta) 11 Deposito del materiale
2 Asse d'intervento,di salvataggio,d’approvvigionamento, ecc.
12 Nido dei feriti(civile)
3Postazione di condotta(ubicazione del capo interventopolizia/comandante della piazzadisastrata)
13 Posto d'informazione
4 Posto collettore deicadaveri di animali
14 Sorveglianza(confini di settore)
5 Posto collettore dei morti 15 Posto di consegna dellasussistenza
6 Posteggio veicoli 16 Posto collettore deglioggetti trovati
7 Porta 17 Piazza d'atterraggio perelicotteri
8Piazza di decontaminazione, piazza di disintossicazione
18 Centro d'informazione
9 Posto di soccorso sanitario 19 Deviazione
10 Posto collettore 20Posto collettore deisenzatetto(posto d’assistenza)
Fonte: Regolamento 52.2/IV Documenti militari – Segni convenzionali civili
i
i
OCC
veic
M
ABC
88
Modulo di notifica (esempio) Appendice 3
Data / Ora Mittente Mezzo di trm
ubic oss Destinatario Priorità di trm
Visto
Constatazioni
QUANDO ? Data / Ora
CHI ? Operatori / Apparecchi / Mezzi
fa COSA? Attività / Evento / Conseguenze
COME ? Spiegazione / Stato
DOVE ?da dove a dove ?
Luogo / Coordinamentoa partire da/in direzione di
AMBIENTE ? Pericoli / Condizioni meteoPopolazione / Autoritàcomunicazioni / Informatica / Economia
Osservazioni / Valutazione del mittente
Fontecon stima della sua attendibilità
Aspetti sconosciuti, lacune,in particolare contraddizioni
Interpretazionepropria lettura del significato
Futuroprocedimento ulteriore
Fonte: ANSIT appendice 4
90
Protezione della popolazione in caso di pericolo imminente
In caso di pericolo imminente, la popolazione viene allarmata conformemente al pro-memoria sull’allarme e riceve le istruzioni sul comportamento da adottare via radio. A dipendenza del tipo di pericolo, la popolazione deve cercare riparo nell’edificio (p. es.in caso di lieve aumento della radioattività o di contaminazioni di sostanze chimiche), incantina (p. es. in caso di forte aumento della radioattività) oppure nel rifugio (p. es. incaso di ricatto o di conflitti armati).Nei casi particolari (p. es. quando vi è pericolo di inondazione), verrà diramato l’ordinedi abbandonare temporaneamente la zona minacciata.Le seguenti misure completano le istruzioni diffuse via radio.
Protezione nell’edificio (p. es. nell’appartamento)• Chiudere porte e finestre• Disinserire gli impianti di ventilazione e di climatizzazione• Ascoltare ininterrottamente la radio e attenersi alle istruzioni sul comportamento• Informare gli altri abitanti dell’immobile• Non telefonare (sovraccarico della rete)
Protezione in cantina (o nel rifugio adibito a cantina)Prima di lasciare l’abitazione• Chiudere porte e finestre• Disinserire gli apparecchi elettrici e chiudere le condotte del gas• Spegnere i fuochi (camini, candele)• Informare gli altri abitanti dell’immobile• Non telefonare (sovraccarico della rete)• Preparare una riserva d'acqua (almeno 3 litri per persona), un po’ di viveri e una radiolina da portare seco• Preparare gli animali domestici da portare al riparoUna volta raggiunta la cantina• Ascoltare ininterrottamente la radio (cercare un punto con buona ricezione) e attenersi alle istruzioni sul com-
portamento• Chiudere porte e finestre
Protezione nel rifugio preparatoOsservazioni preliminari• Quando viene diramato l’ordine di occupare i rifugi, la popolazione
si reca nei rifugi attribuiti dall’organizzazione di protezione civile• L’organizzazione di protezione civile può obbligare gli utenti
dei rifugi a sgomberare e arredare i rifugi secondo le sue istruzioni• Nelle aziende agricole si devono inoltre adottare le misure previste dalle
«Norme per la protezione ABC nell’agricoltura UFAG 2005» (n. 730.951, UFCL, Distribuzione 3003 Berna)Prima di lasciare l’abitazione• Preparare il bagaglio d’emergenza (vedi retro)• Chiudere porte e finestre• Disinserire gli apparecchi elettrici e chiudere le condotte del gas• Spegnere i fuochi (camini, candele)• Informare gli altri abitanti dell’immobile• Non telefonare (sovraccarico della rete)• Gli animali domestici vanno lasciati in locali adiacenti al rifugio. Mettere a disposizione cibo e acqua a suffi-
cienza.
Una volta raggiunto il rifugio• In ogni rifugio l’occupazione e il soggiorno sono diretti da una persona designata dall’organizzazione di pro-
tezione civile. Le disposizioni emanate dal responsabile devono essere rispettate.• Quando la situazione lo permette, dietro ordine delle autorità, di giorno la popolazione può lasciare il rifugio
a turni per un periodo limitato. Scopo di questa "rotazione” è di fare approvvigionamento di viveri, provvede-re all’igiene personale e accudire il bestiame.
• Le autorità possono esonerare temporaneamente determinate categorie di persone dall’obbligo di occupareil rifugio per svolgere attività d’importanza vitale.
Appendice 5
Chi non si trova nell’abitazione deve comportarsi come segue: • Sul posto di lavoro: seguire le istruzioni del datore di lavoro• All’aperto: cercare riparo nell’abitazione più vicina• Nell’automobile: spegnere la ventilazione, chiudere la finestra, ascoltare la
radio, raggiungere l’abitazione più vicina per cercare riparo • Sui mezzi di
trasporto pubblici: seguire le istruzioni del personale
91
Anordnungen des Arbeitgebers befolgen
Per personaNecessario: Consigliato:– coperta o sacco a pelo– articoli da toeletta e carta igienica– sacchi per rifiuti (di plastica)– stoviglie e posate (possibilmente infrangibili)– biancheria intima, calze e calzini, fazzoletti– ev. medicamenti prescritti– documenti personali e altri documenti– denaro in contanti– viveri d'emergenza:
ß alimenti per almeno 2 giorni, non deperibili econsumabili senza cottura
ß chi segue una dieta alimentare deve portare secoprovviste appropriate per una settimana
– tuta da ginnastica o abiti peril tempo libero, pullover, pigiama
– scarpe da ginnastica o pantofole
La riserva d'acqua nel rifugio viene organizzata secondo le istruzioni dell'organizzazione di protezione civile.
Per neonato / bambino piccoloNecessario: Consigliato:– cartellino di riconoscimento da appendere al collo
con nome, cognome, data di nascita e indirizzo– lettino portatile per lattanti o parte superiore amovibile
della carrozzina– pannolini (usa e getta) per una settimana
alimenti per una settimana adatti da preparare senzacottura o latte condensato
– articoli per l'igiene dei neonati e biberon
– giocattoli– sedativi e analgesici
Per economia domesticaNecessario: Consigliato:– occorrente per scrivere, corda– radiolina con auricolare e batteria di riserva
– lampada tascabile con batteria di riserva
– farmacia tascabile, accessori per
– giochi, libri, rivistecucire
–
92
1. In generaleVisto che il filtro di protezione ABC non protegge da tutti i gas velenosi, la maschera diprotezione ABC può essere impiegata solo in modo limitato.Prima dell’impiego, i militi vanno istruiti sulle sue modalità d’uso.
2. Preparare la maschera• Trattare gli oculari con l’antiappannante• Avvitare il filtro protettivo• Adattare la lunghezza dei tiranti• Controllare l’ermeticità3. Mettere la maschera• Trattenere il respiro• Chi porta gli occhiali deve toglierseli• Aprire il sacco portatile o la tasca• Estrarre la maschera• Mettere la maschera• Espirare• Eseguire i controlli ABCD:
– A oculari centrati sugli occhi– B tiranti aderenti alla nuca e non attorcigliati– C contorni aderenti alla pelle– D ermeticità con il filtro protettivo chiuso
• Chiudere il sacco portatile o la tasca
Uso della maschera di protezione
Inserire eventualmente lelenti degli occhiali conforme-mente alle istruzioni nell’astuccio delle lenti
Maschera di protezione con pezza di pulizia e antiappannante
Sacco portatile /Tasca
Appendice 6
4. Riporre la maschera• Levare la maschera• Asciugare l’interno del facciale con la pezza di pulizia• Riporre la maschera e chiudere il sacco portatile o la
tasca
5. Manutenzione della mascheraDopo ripetuto uso, se molto sporca o quando cambia ilportatore
• Smontare la maschera
• Pulire con una pezza di pulizia umida i seguenti pezzi(con alcol 70% quando cambia il portatore):
– facciale
– molla di fissaggio
– corpo della valvola d’espirazione
– membrana d’espirazione
– corpo della valvola d’aspirazione
– membrana d’aspirazione
Dopo il rimontaggio
• Trattare gli oculari con l'antiappannante
• Avvitare il filtro protettivo, mettere la maschera, chiu-dere il filtro e controllare l'ermeticità
93
94
Comportamento in caso d’incidente
Promemoria d’emergenza (Esempio)
Nota:Il promemoria d’emergenza deve presentare le dimensioni di una carta di credito (8,5 � 5,4 cm). Va riposto nel portamonete o nella tasca sul braccio sinistro assieme alpacchetto di fasciatura individuale (PFI) e al documento tecnico «Primi soccorsi».
*) Comportamento in caso di incidente• Valutare la situazione• Individuare ulteriori pericoli• Rendere sicuro il luogo dell’incidente, allontanare
i feriti dalla zona di pericolo• Prestare i primi soccorsi, mettere in atto le MISV• Chiamare la polizia / il S san: schema di notifica• Trattenere i testimoni fino all’arrivo della polizia• Informare l’istanza preposta• Attendere i soccorsi, ev. indirizzarli verso il luogo dell’incidente,
rilasciare informazioniSchema di notifica
CHI? Nome di chi ha segnalato l’incidenteCHE COSA? Tipo di incidenteDOVE? Luogo dell’incidenteQUANDO? Ora dell’incidenteQUANTI? Numero di feriti, genere di feriteALTRO? Pericoli particolari
Nota:In caso d’incidente è importante appurare esattamente la dinamica e redigere un rap-porto d’infortunio (vedi pagina seguente).Chi assiste ad un incidente anche senza essere direttamente coinvolto può essereinterpellato come testimone.
Promemoria d’emergenza Promemoria d’emergenza(recto) (possibili contenuti) (verso)
• Medico tel: ....................... • Comportamento in caso d’incidente*) e/o• Ospedale tel: ....................... • Ubicazioni importanti e/o• Pompieri tel: 118 • Collegamenti interni importanti e/o• Polizia tel: 117 • Atterraggio elicotteri e/o• Rega tel: 1414 • Chi si deve informare? e/o• Pronto soccorso • ecc.
autoambulanze tel: 144• Pronto soccorso
internazionale tel: 112• PC responsabile tel: .......................
Osservare
Pensare
Agire
Appendice 7
Rapporto di malattia / infortunio (Esempio)
Servizio: ......................................................................................................................
Data: ....................................................... Luogo: ....................................................
Cognome/Nome: .................................... No. AVS: .................................................
NPA/Domicilio ........................................ Indirizzo: .................................................
1. MALATTIA
Sintomi: .......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. INFORTUNIO
Luogo dell’infortunio: ...................................................................................................
Data: ........................................................... Ora: ................................................
Dinamica dell’infortunio: ..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Testimoni: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Primi soccorsi prestati da: ..........................................................................................
Osservazioni del medico: ..........................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Firma del milite: ...........................................................................................................
Redatto da ................................................................. il: .......................................
95
96
Aiuto d’emergenza
AAirway
BBreathing
CCirculation
DDefibrillation
Valutare la respirazione
Liberare le vie aeree
Sollevare il mento
Inclinare delicatamente il capo
2 insufflazioni
30 x compressioni della gabbia toracica
2 insufflazioni
Analisi
del ritmo
5
cicli
30:2
30:2
continuare
Provocare
lo shock
AED
disponibile
Defibrillazione
Continuazione da parte di: altri soccorritori,
servizio di salvataggio, medico
Interruzione in caso di: segnidi vita,
soccorritore spossato o in pericolo
Allertare (tel. 144)
Prendere o richiedere AED*
Controllare lo stato di coscienza
e i segni vitali spontanei?
Valutare il paziente
– lesioni alla schiena
– emorragia
– lesioni interne
Misure
– posizione
– emostasi
– protezione
– altre misure
– assistenza
Allertare
Ripetere ABCD
segni vitali spontanei
ABCD-
Schema
no
si
nessun segno vitale spontaneo
nessun segno vitale spontaneo
nessun segno vitale spontaneo
segni vitali spontanei
segni vitali spontanei
AED non
disponibile
* AED:
Automated External Defibrillator
Appendice 8
97
• Adagiare il paziente sul dorso su una superficie piana e dura, se possibile togliere gli indumenti dalla gabbia toracica
• Inginocchiarsi accanto alla spalla del paziente• Cercare la zona di compressione
(nella metà inferiore dello sterno)• Posare il palmo della mano sulla zona di compressione,
tenere le braccia tesse e perpendicolari al torace• Comprimere energicamente e regolarmente il torace di
4–5 cm, quindi rilasciare subito e completamente• Eseguire 30 compressioni toraciche alternate
a 2 insufflazione• Praticare finché non si rilevano segni spontanei di vita o
finché non arrivano i soccorritori professionisti
Appendice 9
mili
ti
spec
ialis
ti
quad
ri
max
14
gior
ni(in
4 a
nni)
Co
rsi d
i rip
etiz
ion
e
annu
alm
ente
alm
eno
2 gi
orni
max
7 g
iorn
i
dura
ta s
uppl
.
max
7 g
iorn
i
Co
rsi d
i per
fezi
on
amen
to
101
102
LPPC
Legge federalesulla protezione della popolazione e sulla protezione civile(LPPC)
del 4 ottobre 2002 (Stato 1º maggio 2007)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto l’articolo 61 della Costituzione federale1;visto il messaggio del Consiglio federale del 17 ottobre 20012,decreta:
Titolo primo: Oggetto
Art. 1La presente legge disciplina:
a. la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nella protezione della popolazione;b. la protezione civile.
Titolo secondo: Protezione della popolazioneCapitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione
Art. 2 ScopoLa protezione della popolazione ha lo scopo di proteggere la popolazione e le sue basivitali in caso di catastrofe, in situazioni d’emergenza e in caso di conflitto armato non-ché di contribuire a limitare e superare gli effetti di eventi dannosi.
Art. 3 Organizzazioni partnerNella protezione della popolazione collaborano le seguenti organizzazioni partner:
a. la polizia, responsabile del mantenimento dell’ordine e della sicurezza;b. i pompieri, responsabili del salvataggio e della lotta contro i sinistri in generale;c. i servizi della sanità pubblica, compreso il soccorso d’urgenza, incaricati di forni-
re le prestazioni mediche alla popolazione;d. i servizi tecnici, responsabili del funzionamento dell’infrastruttura tecnica, in par-
ticolare dell’approvvigionamento di elettricità, acqua e gas, dello smaltimento deirifiuti e della disponibilità delle vie di comunicazione e della telematica;
e. la protezione civile, incaricata di proteggere la popolazione, assistere le personein cerca di protezione, proteggere i beni culturali, sostenere gli organi di condot-ta e le altre organizzazioni partner nonché di svolgere lavori di ripristino e di pub-blica utilità.
RU 2003 41871 RS 1012 FF 2002 1535
Appendice 10
Art. 4 Organi di condottaLe autorità competenti istituiscono organi di condotta per lo svolgimento dei seguenticompiti:
a. informare la popolazione in merito ai pericoli che la minacciano come pure allepossibilità e alle misure di protezione esistenti;
b. avvertire, dare l’allarme e impartire alla popolazione istruzioni sul comportamento;c. assicurare le attività di condotta;d. coordinare i preparativi e gli interventi delle organizzazioni partner;e. garantire, tempestivamente e in funzione della situazione, la disponibilità opera-
tiva e il rinforzo con personale e materiale della protezione della popolazione invista di un conflitto armato.
Art. 5 Compiti della Confederazione1 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione può coordinare l’intervento o, all’occorren-za, assumere la condotta in caso di eventi che colpiscono più Cantoni, l’intero Paese ole zone limitrofe dei Paesi confinanti.2 Il Consiglio federale assicura il coordinamento nel settore della protezione della po-polazione e il coordinamento di quest’ultima con altri strumenti della politica di sicurez-za.3 Esso adotta misure per rafforzare la protezione della popolazione in vista di conflittiarmati.
Art. 6 Compiti dei Cantoni1 I Cantoni disciplinano in particolare l’istruzione, la condotta tempestiva e conforme allasituazione nonché l’intervento delle organizzazioni partner nella protezione della popo-lazione.2 Essi disciplinano la collaborazione intercantonale.
Art. 7 Collaborazione tra Confederazione e CantoniNell’ambito delle loro competenze, Confederazione e Cantoni collaborano in particola-re nei settori dello sviluppo concettuale della protezione della popolazione, dell’infor-mazione e della collaborazione internazionale.
Art. 8 Ricerca e sviluppo1 La Confederazione si occupa, in collaborazione con i Cantoni, della ricerca e dellosviluppo nel settore della protezione della popolazione, segnatamente per quanto con-cerne l’analisi delle minacce, la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza e leminacce di carattere politico-militare.2 Essa sostiene la collaborazione nazionale e internazionale nel campo della ricerca edello sviluppo in materia di protezione della popolazione.
103
104
LPPC
Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione
Art. 9 Istruzione degli organi di condotta1 L’istruzione di base e il perfezionamento (istruzione) dei membri degli organi di con-dotta sono rette dalle prescrizioni cantonali.2 Il Consiglio federale disciplina l’istruzione degli organi di condotta necessaria al rin-forzo della protezione della popolazione in vista di conflitti armati.
Art. 10 Sostegno da parte della ConfederazioneLa Confederazione:
a. coordina la collaborazione nel campo dell’istruzione tra le organizzazioni partnere con l’esercito;
b. sostiene i Cantoni nell’istruzione degli organi di condotta;c. organizza corsi d’istruzione destinati agli organi di condotta;d. può accordarsi con i Cantoni in merito all’organizzazione di corsi d’istruzione;
i costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi;e. assicura l’istruzione del personale responsabile della formazione degli organi di
condotta;f. permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare ai
costi d’istruzione;g. gestisce un’infrastruttura d’istruzione.
Titolo terzo: Protezione civile
Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civileSezione 1: Principi
Art. 11 Persone tenute a prestare servizio di protezione civileÈ tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso ma-schile dichiarato abile a tale servizio.
Art. 12 Eccezioni1 Le persone tenute a prestare servizio militare o servizio civile non sottostanno all’ob-bligo di prestare servizio di protezione civile.2 Le persone congedate dal servizio militare non sono tenute a prestare servizio di protezione civile se hanno prestato almeno 50 giorni di servizio militare.3 Le persone congedate dal servizio civile non sono tenute a prestare servizio di prote-zione civile.
Art. 13 Durata1 L’obbligo di prestare servizio nella protezione civile inizia nell’anno in cui il milite com-pie i 20 anni e dura fino alla fine dell’anno in cui compie i 40 anni.
Appendice 10
2 Il Consiglio federale può:a. prolungare l’obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell’anno in cui
il milite compie i 50 anni;b. ridurre l’obbligo di prestare servizio al massimo sino alla fine dell’anno in cui il
milite compie i 35 anni.
Art. 14 Estensione dell’obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armatoIn caso di conflitto armato il Consiglio federale può inoltre obbligare a prestare serviziodi protezione civile:
a. gli uomini soggetti all’obbligo militare che sono stati prosciolti dall’obbligo di pre-stare servizio militare o civile;
b. gli uomini prosciolti dal servizio militare o civile.
Art. 15 Volontariato1 Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:
a. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile;b. gli uomini soggetti all’obbligo militare prosciolti dall’obbligo di prestare servizio
militare o civile;c. gli uomini prosciolti dall’obbligo di prestare servizio militare o civile;d. le cittadine svizzere, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni;e. gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall’anno in cui compiono i 20 anni.
2 I Cantoni decidono in merito all’ammissione dei volontari. Non vi è diritto all’ammissione.3 Le persone che prestano volontariamente servizio nella protezione civile hanno glistessi diritti e gli stessi doveri dei militi della protezione civile.4 I volontari sono prosciolti dall’obbligo di prestare servizio su domanda. Di regola de-vono tuttavia prestare almeno tre anni di servizio di protezione civile.
Art. 16 ReclutamentoL’esercito e la protezione civile procedono al reclutamento comune dei militi.
Art. 17 Attribuzione dei militi1 Di principio i militi della protezione civile sono a disposizione del loro Cantone didomicilio.2 D’intesa con i rispettivi Cantoni, i militi possono essere attribuiti a un Cantone diverso
da quello in cui sono domiciliati.3 Il Cantone di domicilio decide in merito all’attribuzione dei militi.
Art. 18 Personale di riserva1 I Cantoni hanno la facoltà di attribuire militi al personale di riserva.2 I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere formati e non hanno dirittodi servire nella protezione civile.
105
106
LPPC
Art. 19 Proscioglimento di membri delle autoritàAl momento dell’entrata in funzione, vengono prosciolti dall’obbligo di prestare serviziodi protezione civile:
a. i membri del Consiglio federale;b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;c. i membri dell’Assemblea federale;d. i membri del Tribunale federale;e. i membri degli esecutivi cantonali;f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;g. i membri permanenti degli esecutivi comunali.
Art. 20 Proscioglimento anticipato1 I militi necessari a un’organizzazione partner possono essere prosciolti anticipata-mente dal servizio di protezione civile.2 Il Consiglio federale disciplina la procedura.3 I Cantoni decidono in merito al proscioglimento anticipato.
Art. 21 EsclusioneI militi condannati a una pena detentiva possono essere esclusi dal servizio di prote-zione civile.
Sezione 2: Diritti e doveri
Art. 22 Soldo, vitto, alloggio e trasporto1 Chi presta servizio di protezione civile ha diritto a soldo e vitto gratuito.2 Ha diritto inoltre:
a. al trasporto gratuito, con mezzi pubblici, per l’entrata in servizio e il proscioglimento,nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
b. all’alloggio gratuito, se non può alloggiare al proprio domicilio.
Art. 23 Indennità per perdita di guadagnoChi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un’indennità per perdita di guada-gno secondo le disposizioni della legge federale del 25 settembre 19523 sulle indennitàdi perdita di guadagno.
Art. 24 Tassa d’esenzione dall’obbligo militareNel calcolo della tassa d’esenzione dall’obbligo militare secondo la legge federale del12 giugno 19594 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare vengono computati tutti iservizi d’istruzione e gli interventi prestati per i quali è previsto il versamento del soldoe dell’indennità per perdita di guadagno.
3 RS 834.14 RS 661
Appendice 10
Art. 25 AssicurazioneChi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM).
Art. 26 Obblighi1 I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio loro impartiti.2 I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizicorrispondenti. Essi devono adempiere anche compiti fuori servizio, in particolare quel-li relativi ai preparativi dei servizi d’istruzione e degli interventi della protezione civile.
Sezione 3: Chiamata e controlli
Art. 27 Chiamata in caso d’intervento1 Il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi di protezione civile:
a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza che colpiscono diversi Cantoni ol’intero Paese;
b. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza nelle zone limitrofe di un Paese con-finante;
c. in caso di conflitto armato;d. per interventi di pubblica utilità a livello nazionale.
2 I Cantoni possono chiamare in servizio i militi di protezione civile:a. in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza;b. per svolgere lavori di ripristino;c. per interventi di pubblica utilità.
3 I Cantoni disciplinano la procedura di chiamata in caso d’intervento.
Art. 28 ControlliI controlli relativi ai militi di protezione civile incombono ai Cantoni.
Capitolo 2: Doveri di terzi
Art. 29 Singoli1 Ognuno è tenuto a rispettare le misure prescritte e le istruzioni sul comportamentodiramate in caso d’allarme.2 Chi presta aiuto nell’ambito di un intervento della protezione civile è assicurato secon-do la LAM6.
107
5 RS 833.16 RS 833.1
108
LPPC
Art. 30 Proprietari di edifici abitativi e locatari1 I proprietari di edifici abitativi e i locatari provvedono alla preparazione e all’esecuzionedelle misure loro prescritte.2 Se viene ordinata l’occupazione dei rifugi, mettono gratuitamente a disposizione dellaprotezione civile i posti protetti non utilizzati.
Art. 31 Uso di proprietà in tempo di paceI proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessarialla protezione civile. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.
Art. 32 Uso di proprietà in caso di catastrofi e in situazioni d’emergenza o in caso diconflitto armato
In caso di catastrofi e in situazioni d’emergenza o in caso di conflitto armato, la prote-zione civile ha il diritto di requisire alle stesse condizioni dell’esercito.
Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile
Art. 33 Istruzione di baseAl più tardi tre anni dopo il reclutamento, i militi di protezione civile seguono un’istru-zione di base della durata di almeno due settimane e al massimo di tre settimane.L’istruzione di base può essere completata con un corso per specialisti di una setti-mana al massimo.
Art. 34 Istruzione dei quadriI militi ai quali è previsto di affidare una funzione di quadro seguono, per assumere talefunzione, un corso per quadri di almeno una settimana e di due settimane al massimo.
Art. 35 PerfezionamentoI militi con funzioni di quadro e di specialista possono essere chiamati a seguire corsidi perfezionamento della durata massima complessiva di due settimane su un periododi quattro anni.
Art. 36 Corsi di ripetizioneUna volta conclusa la formazione di base, i militi sono convocati ogni anno a un corsodi ripetizione di almeno due giorni e al massimo di una settimana. I quadri e gli specia-listi possono inoltre essere chiamati ogni anno a prestare al massimo una settimana dicorso supplementare.
Art. 37 Servizio nell’amministrazione della protezione civile1 In caso di bisogno imperativo, i militi possono essere chiamati a prestare servizionell’amministrazione della protezione civile.2 Il servizio prestato in seno all’amministrazione della protezione civile vale come corsodi ripetizione secondo l’articolo 36.
Appendice 10
Art. 38 Convocazione al servizio d’istruzione1 I Cantoni disciplinano la convocazione per le prestazioni di servizio secondo gli articoli33 – 37.2 L’organo federale responsabile della protezione civile disciplina la convocazione aiservizi d’istruzione e ai corsi di perfezionamento secondo l’articolo 39 capoverso 2.3 La convocazione al servizio d’istruzione è inviata ai militi almeno sei settimane primadell’inizio del servizio.4 Il milite della protezione civile inoltra la richiesta di differimento del servizio all’organoche lo ha convocato.
Art. 39 Sostegno da parte della Confederazione1 La Confederazione istituisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un’istruzioneunificata.2 Essa istruisce i comandanti della protezione civile e i loro sostituti nonché i quadri edeterminati specialisti del sostegno alla condotta e della protezione dei beni culturali.3 La Confederazione può convenire con i Cantoni l’organizzazione di corsi d’istruzione.I costi dei corsi di competenza dei Cantoni sono a carico di questi ultimi.
Art. 40 Istruzione di personale insegnante1 La Confederazione assicura l’istruzione del personale insegnante della protezionecivile.2 Essa permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare acorsi d’istruzione.
Art. 41 Infrastruttura per l’istruzioneLa Confederazione gestisce un’infrastruttura per l’istruzione.
Art. 42 Soppressione di centri d’istruzione della protezione civile1 In caso di soppressione di un centro d’istruzione della protezione civile, con conse-guente cambiamento d’utilizzazione o alienazione, i sussidi federali devono essere rim-borsati.2 Se un centro della protezione civile viene soppresso in seguito a riforme o all’introdu-zione di nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati. I sussidi federali versati per l’acquisto di terreni devono essere rimborsati per quanto il terreno sia alienato con utile.
109
110
LPPC
7 [CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6,2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 al. 1]. Ora: l’art. 8 cpv.2 lett. m della L dell’8 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0).8 [CS 6 523; RU 1957 1040, 1960 267, 1961 1226, 1965 917, 1972 160, 1973 651, 1974 1949, 1975 1209, 19931054, 1995 1818, 1997 1630 2779 n. II 35, 1999 704 n. II 15, 2001 267 art. 33 n. 3, 2002 326 328 all. 2 n. 1. RU2007 1469 all. 3 n. 1]. Ora: l’art. 29 cpv. 2 dell’O del 1º nov. 2006 sulle dogane (SR 631.01).
Capitolo 4: Materiale e sistemi telematici e d’allarme
Art. 43 ConfederazioneLa Confederazione è responsabile:
a. dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione;b. dei sistemi telematici della protezione civile;c. dell’equipaggiamento e del materiale degli impianti di protezione;d. del materiale unificato della protezione civile.
Art. 44 Esenzione dai daziIl materiale della protezione civile che la Confederazione importa dall’estero (prodottisemifabbricati e prodotti finiti) è equiparato per quanto riguarda i dazi al materiale bel-lico secondo l’articolo 14 numero 17 della legge federale del 1° ottobre 19257 sulle do-gane e l’articolo 22 dell’ordinanza del 10 luglio 19268 della legge sulle dogane.
Capitolo 5: Costruzioni di protezioneSezione 1: Rifugi
Art. 45 PrincipioOgni abitante deve disporre di un posto protetto raggiungibile in tempo utile dalla suaabitazione.
Art. 46 Obbligo di costruire1 I proprietari d’immobili sono tenuti a realizzare ed equipaggiare i rifugi in tutti i nuovi edi-fici abitativi, negli istituti e negli ospedali nonché a occuparsi della loro manutenzione.2 I Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici equipaggiati nelle zone in cui non visono posti protetti a sufficienza.3 I Cantoni possono obbligare i proprietari e i possessori di beni culturali mobili e im-mobili ad adottare o tollerare misure edilizie per la protezione di tali beni.
Art. 47 Gestione, contributi sostitutivi1 Per garantire un’offerta equilibrata di posti protetti, i Cantoni gestiscono la costruzio-ne di rifugi in base alle prescrizioni federali.2 I proprietari di edifici abitativi che non realizzano un rifugio privato devono versare con-tributi sostitutivi. I contributi sostitutivi vengono impiegati in primo luogo per il finanzia-mento dei rifugi pubblici comunali. Se tutti i rifugi richiesti sono realizzati o finanziaria-mente garantiti mediante contributi sostitutivi, i contributi rimanenti possono esseredestinati ad altre misure nel campo della protezione civile.
Appendice 10
3 Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i Cantoni decidono in che misura devonoessere realizzati rifugi oppure versati contributi sostitutivi.4 I Cantoni determinano l’ammontare dei contributi sostitutivi in base alle prescrizionidella Confederazione.5 I contributi sostitutivi restano di proprietà dei Comuni che li hanno ricevuti. Il Cantonedisciplina l’utilizzazione dei contributi sostitutivi versati alle strutture organizzative re-gionali e cantonali.
Art. 48 Permessi di costruzione1 I permessi di costruzione possono essere accordati solo quando gli organi competentihanno deciso in merito all’obbligo di costruire un rifugio.2 Per garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di costruzione dei rifugi, i Cantonipossono esigere che il proprietario della costruzione fornisca una garanzia.
Art. 49 SoppressioneI Cantoni possono sopprimere i rifugi conformemente alle prescrizioni della Confedera-zione.
Sezione 2: Impianti
Art. 50 Impianti di protezioneSono impianti di protezione:
a. i posti di comando;b. gli impianti d’apprestamento;c. i centri sanitari protetti;d. gli ospedali protetti.
Art. 51 ConfederazionePer ottenere un’efficienza operativa uniforme, la Confederazione disciplina la realizza-zione, l’equipaggiamento, la manutenzione, il rinnovamento e il cambiamento diutilizzazione degli impianti di protezione.
Art. 52 Cantoni1 I Cantoni determinano il fabbisogno di impianti di protezione conformemente alle pre-scrizioni della Confederazione.2 Essi provvedono alla realizzazione, dell’equipaggiamento, della manutenzione e delrinnovamento dei posti di comando, degli impianti d’apprestamento e dei centri sanitariprotetti, conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
Art. 53 Enti ospedalieriGli enti ospedalieri provvedono alla realizzazione, all’equipaggiamento, della manuten-zione e del rinnovamento degli ospedali protetti, conformemente alle prescrizioni dellaConfederazione.
111
112
LPPC
9 RS 0.518.521
Art. 54 Proprietari di sbarramenti idriciI proprietari di sbarramenti idrici provvedono alla realizzazione, della manutenzione edel rinnovamento delle installazioni edilizie facenti parte del sistema d’allarme acqua,conformemente alle prescrizioni della Confederazione.
Art. 55 Soppressione1 Gli impianti di protezione possono essere soppressi solo previa autorizzazione del-l’organo federale responsabile della protezione civile.2 Se vengono soppressi impianti di protezione che soddisfano le esigenze minime (art.56), i sussidi federali devono essere rimborsati.3 Se gli impianti di protezione vengono soppressi in seguito a riforme o all’introduzionedi nuove strutture organizzative, i sussidi federali non devono essere rimborsati.
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 56 Esigenze minimeIl Consiglio federale determina le esigenze minime per le costruzioni di protezione.
Art. 57 Efficienza operativaI proprietari e i possessori devono provvedere affinché, su ordine della Confederazio-ne, le costruzioni di protezione possano essere rese operative.
Art. 58 Esecuzione sostitutivaSe le misure prescritte non vengono adottate, l’autorità federale o cantonale compe-tente vi provvede a spese del proprietario o del possessore.
Capitolo 6: Distintivo internazionale e carta d’identità della protezione civile
Art. 591 Il personale e il materiale della protezione civile come pure le costruzioni di protezio-ne sono contrassegnati con il distintivo internazionale della protezione civile.2 Con il distintivo possono inoltre essere contrassegnate:
a. singole persone che, rispondendo a un appello delle autorità competenti, adem-piono compiti di protezione civile sotto la loro direzione;
b. nello svolgimento della loro attività amministrativa, persone di uffici federali, can-tonali e comunali con compiti attinenti alla protezione civile.
3 Ai militi della protezione civile è rilasciata la carta d’identità per il personale della pro-tezione civile.4 Il distintivo e la carta d’identità sono conformi ai modelli che figurano nel Protocolloaggiuntivo dell’8 giugno 19779 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sulla pro-tezione delle vittime di conflitti armati internazionali (Protocollo I)
Appendice 10
Capitolo 7: Responsabilità per danni
Art. 60 Principi1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni sono responsabili di qualsiasi danno causa-to illecitamente a terzi durante i servizi d’istruzione o altre prestazioni di servizio da par-te del personale insegnante o dei militi della protezione civile, per quanto non possanoprovare che il danno sia dovuto a forza maggiore o a colpa della parte lesa o di terzi. 2 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono solidalmente dei danni che de-vono risarcire. Il Consiglio federale disciplina la ripartizione dei costi tra le autoritàtenute al risarcimento.3 Le persone danneggiate non possono far valere alcun diritto nei confronti del perso-nale insegnante o dei militi colpevoli.4 In caso di esercizi della protezione civile cui partecipano organizzazioni partner e l’eser-cito, la responsabilità per danni è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.5 Se la protezione civile interviene in caso di conflitto armato, le disposizioni del pre-sente capitolo relative alla responsabilità per danni non sono applicabili.6 Se a una fattispecie sono applicabili altre disposizioni di responsabilità civile, questeultime prevalgono sulla presente legge.
Art. 61 RegressoLa Confederazione, i Cantoni e i Comuni che hanno risarcito il danno hanno diritto diregresso contro il personale insegnante o i militi della protezione civile che hanno cau-sato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
Art. 62 Responsabilità per danni nei confronti della Confederazione, dei Cantoni edei Comuni
1 Il personale insegnante e i militi della protezione civile sono responsabili per i dannicausati direttamente alla Confederazione, ai Cantoni o ai Comuni violando i propridoveri intenzionalmente o per negligenza grave.2 Essi sono responsabili del materiale loro assegnato e rispondono dei danni e delleperdite arrecati intenzionalmente o per negligenza grave.3 I contabili sono responsabili della contabilità, del denaro e dei mezzi loro affidati,nonché del loro impiego conforme alle prescrizioni. Essi rispondono dei danni arrecatiintenzionalmente o per negligenza grave.4 Gli organi di controllo incaricati della tenuta dei conti rispondono allo stesso modo incaso di violazione dei loro doveri.
Art. 63 Determinazione del risarcimento1 L’ammontare del risarcimento è stabilito, per analogia, in base agli articoli 42, 43 capo-verso 1, 44 capoverso 1, 45 a 47, 49, 50 capoverso 1 e 51 a 53 del Codice delle obbli-gazioni10.
113
10 RS 220
114
LPPC
2 In caso di responsabilità da parte del personale insegnante o di militi della protezionecivile è inoltre tenuto debitamente conto del loro comportamento in servizio, delle lorocondizioni finanziarie e del tipo di servizio.
Art. 64 Danneggiamento o perdita di oggetti personali1 Il personale insegnante e i militi della protezione civile si assumono i costi derivantidalla perdita e dal danneggiamento di oggetti di loro proprietà. La Confederazione, iCantoni e i Comuni versano un’equa indennità se il danno è causato da un incidentedurante il servizio o costituisce la diretta conseguenza dell’esecuzione di un ordine.2 In caso di responsabilità del danneggiato, l’indennità può essere ridotta in misura ade-guata. In tal caso, se l’uso dell’oggetto personale in questione era necessario per ra-gioni di servizio, se ne terrà debitamente conto.
Art. 65 Prescrizione1 Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comunisecondo gli articoli 60 e 64 si prescrive in un anno dal giorno in cui il danneggiato haavuto conoscenza del danno, e in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui si è verifi-cato il danno.2 Il diritto di regresso della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni secondo l’artico-lo 61 si prescrive in un anno dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza deldanno e dell’identità dell’identità del responsabile, e in ogni caso in cinque anni dalgiorno in cui si è verificato il danno.3 Se il diritto al risarcimento o il diritto di regresso risulta da un reato per il quale il dirit-to penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest’ultimo.4 Gli articoli 135 a 142 del Codice delle obbligazioni11 sono applicabili per analogia allaprescrizione e alla sua interruzione. È considerata azione anche la richiesta di risarci-mento inviata per scritto alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni.
Capitolo 8: Protezione giuridica e procedimento
Art. 6612 Pretese non pecuniarieIn caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell’autorità canto-nale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammis-sibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 67 Pretese pecuniarie1 I Cantoni designano le autorità chiamate a decidere, a livello cantonale e comunale,sulle pretese di risarcimento e sulle azioni di regresso per danni occorsi durante i ser-vizi di protezione civile cantonali e comunali. Contro la decisione di queste ultime è am-missibile il ricorso all’organo federale responsabile della protezione civile.
11 RS 22012 Nuovo testo qiusta il n. 47 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal1º gen. 2007 (RS 173.32).
Appendice 10
2 L’organo federale responsabile della protezione civile decide in merito alle pretese dirisarcimento e alle azioni di regresso per i danni occorsi durante i servizi di protezionecivile organizzati o svolti dalla Confederazione.3 L’organo federale responsabile della protezione civile decide sulle pretese di naturapecuniaria della Confederazione o nei confronti di essa quando sono fondate sulla pre-sente legge e non concernono la responsabilità per danni.4…13
Capitolo 9:14 Disposizioni penali
Art. 68 Infrazioni alla legge1 È punito con la detenzione, l’arresto o la multa chiunque intenzionalmente:
a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiu-ta di dar seguito a una convocazione o alla chiamata, si allontana dal serviziosenza esserne autorizzato, non rientra dopo un’assenza autorizzata, abusa di uncongedo concessogli o si sottrae in altro modo all’obbligo di prestare servizio;
b. disturba servizi d’istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola omette in pericolo le persone che prestano servizio di protezione civile;
c. incita pubblicamente a rifiutare di servire nella protezione civile o di eseguire lemisure ufficialmente ordinate.
2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa. Nei casi di lieve entitàl’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare, la prima volta, a un’azionepenale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.3 È punito con l’arresto o con la multa chiunque:
a. in qualità di persona soggetta all’obbligo di servire nella protezione civile si rifiu-ta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli;
b. in qualità di persona in servizio nella protezione civile viene meno agli ordini diservizio;
c. disattende ordini o regole di comportamento relativi all’allarme;d. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta
d’identità per il personale della protezione civile.4 Nei casi di lieve entità l’autorità cantonale o comunale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il colpevole.5 Sono fatti salvi il perseguimento penale e l’azione civile in virtù di altre leggi.
115
13 Abrogato dal n. 47 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effeto dal 1º gen.2007 (RS 173.32).14 A partire dal 1º gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conver-sione dell’art. 333 cpv. 2–6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
116
LPPC
Art. 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive1 Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni emanate in esecuzione della presen-te legge è punito con la multa e, inoltre, nei casi gravi o in caso di recidiva, con l’arre-sto.2 Nei casi di lieve entità o se l’autore ha agito per negligenza, l’autorità cantonale o co-munale competente può rinunciare a un’azione penale; può limitarsi ad ammonire il col-pevole.
Art. 70 Perseguimento penale1 Il perseguimento e il giudizio degli atti per cui la presente legge commina una penaspettano ai Cantoni.2 Tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere devono esserecomunicate, in copia integrale e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confedera-zione; quest’ultimo informa l’organo federale responsabile della protezione civile.
Titolo quarto: Disposizioni comuniCapitolo 1: Finanziamento
Art. 711 La Confederazione si assume i costi derivanti:
a. dal reclutamento dei militi di protezione civile;b. dall’istruzione da essa organizzata in virtù della presente legge e dall’infrastrut-
tura necessaria a questo scopo;c. dagli interventi dei militi di protezione civile in caso di chiamata da parte del
Consiglio federale;d. dalle attività di sua competenza nei settori di cui all’articolo 7;e. dalle attività di ricerca e sviluppo di sua competenza;f. dalle misure secondo l’articolo 43;g. dal rinforzo della protezione civile in vista di conflitti armati;h. dagli interventi in caso di conflitto armato.
2 Essa si assume inoltre i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione, l’equi-paggiamento, il rinnovamento, il cambiamento di utilizzazione o la soppressione di impianti di protezione e rifugi per beni culturali.3 Essa versa un contributo forfettario annuale per la manutenzione degli impianti diprotezione al fine di garantirne l’efficienza operativa in caso di conflitto armato.4 Essa può sostenere finanziariamente le attività svolte da organizzazioni pubbliche oprivate nel campo della protezione civile.5 La Confederazione non si assume:
a. i costi per l’acquisto di terreni e le indennità per l’utilizzazione di terreni pubblici eprivati;
b. le tasse cantonali e comunali;c. i costi per la manutenzione ordinaria degli impianti di protezione.
Appendice 10
Capitolo 2: Trattamento di dati personali
Art. 72 Trattamento di dati1 Per svolgere i compiti ad esso assegnati dalla presente legge, l’organo federale respon-sabile della protezione civile può trattare i dati personali riguardanti i militi della protezionecivile.2 Esso ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema di gestione delpersonale dell’esercito (L militare del 3 feb. 199515, art. 146 cpv. 3).
Art. 73 Comunicazione di dati1 Gli organi cantonali addetti ai controlli trasmettono all’organo federale responsabiledella protezione civile i dati relativi ai militi della protezione civile, per quanto questisiano necessari all’adempimento dei compiti secondo la presente legge.2 Essi comunicano inoltre i dati all’assicurazione militare16, il quale li utilizza nello svol-gimento dei suoi compiti secondo la LAM17.3 Su richiesta e in casi particolari, l’organo federale responsabile della protezione civilepuò comunicare i dati personali concernenti i militi della protezione civile necessari perla tenuta dei controlli ad altri organi federali nonché a organi cantonali e comunali inca-ricati di svolgere compiti nel campo della protezione della popolazione o della prote-zione civile.
15 RS 510.1016 Nuova espr. giusta in n. II cpv. 1 lett. c della LF del 18 mar. 2005 sul trasferimento della gestione dell’assicu-razione militare all’INSAI, in vigore dal 1º lug. 2005 (RU 2005 2881 2883; FF 2004 2493).17 RS 833.1
117
118
LPPC
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 74 VigilanzaIl Consiglio federale esercita la vigilanza.
Art. 75 Disposizioni esecutive1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.2 Esso può delegare competenze legislative all’organo federale responsabile della pro-tezione civile.3 Per il resto, l’esecuzione spetta ai Cantoni.
Art. 76 Diritto previgente: abrogazioneLe seguenti leggi federali sono abrogate:1. Legge federale del 17 giugno 199418 sulla protezione civile;2. Legge federale del 4 ottobre 196319 sull’edilizia di protezione civile.
Art. 77 Referendum ed entrata in vigore1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data d’entrata in vigore: 1° gennaio 200420
18 [RU 1994 2626, 1995 1227 allegato n. 9, 1996 1445 allegato n.14]19 [RU 1964 486, 1978 50 n. II, 1980 1786, 1985 1649 n.II, 1994 2667]20 DCF del 30 ott. 2003 (RU 2003 4205).
Ordinanza sulla protezione civile(OPCi)
del 5 dicembre 2003 (Stato 5 dicembre 2006)
Il Consiglio federale svizzero,visto l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021 sulla protezionedella popolazione e sulla protezione civile (legge, LPPC),ordina:
Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civileSezione 1: Principi
Art. 1 Servizio volontario nella protezione civile(art. 15 LPPC)
1 Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve inoltrareuna domanda scritta all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile.2 Le persone la cui domanda di servizio volontario è stata accolta sono di regola reclu-tate conformemente all’ordinanza del 10 aprile 20022 sul reclutamento. Chi ha già par-tecipato ad un reclutamento non deve ripetere la procedura.3 Il servizio volontario nella protezione civile vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all’ammissione.4 Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa.
Art. 2 Proscioglimento anticipato(art. 20 LPPC)
1 Su richiesta di un’organizzazione partner e fatto salvo il capoverso 3, possono essereprosciolti anzitempo dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
a. i membri professionisti delle organizzazioni partner;b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di
catastrofe ed altre situazioni d’emergenza.2 L’organizzazione partner deve inoltrare la domanda di proscioglimento anticipato all’ufficio cantonale responsabile della protezione civile secondo le istruzioni dell’Ufficiofederale della protezione della popolazione (Ufficio federale) che definiscono le pro-fessioni autorizzate. La domanda deve essere corredata dal consenso del milite.3 Chi non serve più alle organizzazioni partner viene nuovamente incorporato nella pro-tezione civile.
119
RU 2003 51471 RS 520.1 2 RS 511.11
OPCi
120
Art. 3 Esclusione(art. 21 LPPC)
1 Chi si rifiuta di prestare servizio di protezione civile o di assumere i compiti attribuitiglie che è quindi stato condannato a pene detentive complessivamente superiori a trentagiorni, è escluso dall’obbligo di prestare servizio.2 È inoltre escluso dall’obbligo di prestare servizio chiunque è stato condannato da untribunale penale per un delitto o un crimine che rende la sua presenza inaccettabile nel-la protezione civile.3 La persona esclusa che dimostra una condotta irreprensibile può, se lo domanda, es-sere riammessa al servizio di protezione civile, al più presto quattro anni dopo averscontato la pena; in caso di sospensione condizionale della pena, al più presto alla sca-denza del periodo di prova. L’ufficio cantonale responsabile della protezione civile ha lafacoltà di consultare i rapporti di polizia sulla condotta della persona interessata al finedi decidere in merito alla riammissione.
Sezione 2: Diritti e doveri
Art. 4 Soldo(art. 22 LPPC)
1 Danno diritto al soldo:a. i servizi di protezione civile prestati in seguito ad una chiamata giusta l’articolo 27
della legge;b. i servizi di protezione civile prestati giusta gli articoli 33–37 della legge;c. i corsi d’istruzione giusta l’articolo 39 capoverso 2 della legge.
2 Il soldo si basa sui gradi nella protezione civile; l’ammontare del soldo è paragona-bile agli importi fissati nell’esercito. Il Dipartimento determina le funzioni, i gradi e il soldo.3 Un periodo di servizio di almeno otto ore dà diritto al soldo. I militi prosciolti anticipa-tamente dal servizio hanno diritto al soldo fino al giorno del proscioglimento.4 Il soldo per prestazioni periodiche di servizio di almeno due ore consecutive è pagatoin occasione dell’ultima prestazione durante l’anno civile. Ogni periodo di otto ore o unarimanenza di almeno due ore danno diritto a un soldo giornaliero completo.5 I militi che beneficiano del congedo secondo l’articolo 10 e quelli congedati per il finesettimana hanno diritto al soldo.6 I militi prosciolti durante il congedo hanno diritto al soldo fino al giorno della partenzain congedo compreso.7 Il diritto al soldo si prescrive ad un anno dalla fine della relativa prestazione di ser-vizio.
Appendice 11
121
Capitolo 2: Convocazione e controlli
Art. 5 Effettivi di reclutamento(art. 16 LPPC)
I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competen-te il numero dei militi di protezione civile necessari per ogni funzione di base, nonché ladata e il luogo dell’istruzione di base.
Art. 6 Adempimento dei servizi d’istruzioneUn servizio d’istruzione è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il90 % del tempo indicato nel programma d’istruzione.
Art. 7 Obbligo di entrare in servizio(art. 27 e 38 LPPC)
In caso di convocazione, i militi della protezione civile sono tenuti ad entrare in serviziosecondo le disposizioni dell’autorità responsabile della convocazione.
Art. 8 Malattia o infortunio prima dell’entrata in servizioChi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l’ufficio responsabile della convocazione e inviare allo stesso il libretto di servizio e uncertificato medico in busta chiusa.
Art. 9 Differimento del servizio(art. 38 cpv. 4 LPPC)
1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in ser-vizio, inoltrare all’autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di dif-ferimento della prestazione di servizio. La domanda deve essere motivata. Non vi è di-ritto al differimento.2 L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.3 Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l’obbligo di entrare in servizio.
Art. 10 Congedo1 I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell’entrata in ser-vizio, inoltrare una domanda scritta di congedo all’autorità responsabile della convoca-zione. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al congedo. 2 L’autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.3 Il responsabile del servizio decide in merito alle domande di congedo inoltrate per iscritto durante il servizio.
Art. 11 Prestazioni di servizio a favore del datore di lavoroNon sono ammesse prestazioni di servizio a favore del datore di lavoro. Fa eccezioneil personale professionista impiegato presso gli uffici cantonali e comunali responsabilidella protezione civile.
OPCi
122
Art. 12 Servizio nell’amministrazione della protezione civile(art. 37 LPPC)
1 Tale servizio è da ritenersi imperativo quando l’amministrazione della protezione civi-le deve far fronte ad un sovraccarico straordinario di lavoro o quando le attività da svol-gere richiedono conoscenze tecniche particolari.2 La Confederazione si assume interamente i costi legati al servizio presso l’ammini-strazione federale della protezione civile.
Art. 13 Trattamento dei dati nel PISAIl comando di reclutamento mette a disposizione degli uffici cantonali responsabili del-la protezione civile i dati relativi al reclutamento tramite il sistema di gestione del per-sonale dell’esercito (PISA).
Capitolo 3: Materiale
Art. 14 Acquisizione, distribuzione e proprietà(art. 43 LPPC)
1 L’Ufficio federale è responsabile per l’acquisizione e la sostituzione del materialegiusta l’articolo 43 della legge per catastrofi particolari e situazioni d’emergenza nell’ambito di competenza della Confederazione, nonché in caso di conflitto armato.Esso emana le rispettive istruzioni. 2 I Cantoni disciplinano la distribuzione ai comuni del materiale acquisito dalla Confe-derazione.3 Il materiale finanziato e fornito dall’Uffico federale è di proprietà del destinatario.4 L’Ufficio federale può prendere accordi con tutti o alcuni Cantoni in merito all’assun-zione di compiti di competenza dei Cantoni.5 L’Ufficio federale procura e amministra, giusta l’articolo 43 della legge, il materialemesso a disposizione dei Cantoni a titolo di prestito per scopi d’istruzione.
Art. 15 RequisizioneI comandanti della protezione civile coordinano le domande di requisizione delle orga-nizzazioni partner.
Art. 16 Manutenzione e controllo periodico1 I Cantoni assicurano la manutenzione del materiale acquisito dalla Confederazionesecondo le prescrizioni emanate dall’Ufficio federale.2 Essi controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione del materia-le acquisito dalla Confederazione secondo le prescrizioni emanate dall’Ufficio federale.
Appendice 11
123
Capitolo 4: Costruzioni di protezioneSezione 1: Rifugi
Art. 17 Numero di posti protetti(art. 45 LPPC)
1 Il numero di posti protetti da realizzare in caso di nuove costruzioni è definito come segue:
a. per appartamenti e pensionati: due posti protetti ogni tre locali;b. per ospedali, case per anziani e di cura: un posto protetto per letto di paziente.
2 I mezzi locali non sono presi in considerazione nel calcolo. Non si tiene conto delle fra-zioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.3 Dal numero di posti protetti da realizzare in una nuova costruzione secondo il capo-verso 1 vengono dedotti i posti protetti eccedenti in rifugi che soddisfano le esigenzeminime in edifici situati su un terreno appartenente allo stesso proprietario.4 Per il calcolo del numero di posti protetti su un terreno appartenente allo stesso pro-prietario si accertano:
a. i posti protetti esistenti conformi alle esigenze minime;b. il numero di posti protetti per i quali sono stati versati contributi sostitutivi.
5 Se le spese supplementari riconosciute derivanti dal rifugio prescritto superano delcinque per cento il costo totale della costruzione, il numero dei posti protetti va propor-zionalmente ridotto. Se, di conseguenza, il loro numero scende al di sotto di cinque, ilproprietario dell’immobile deve versare contributi sostitutivi secondo l’articolo 47 capo-verso 2 della legge.
Art. 18 Eccezioni1 I Cantoni possono decidere che in casi particolari non sia costruito alcun rifugio. Ciòvale in particolare per:
a. edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni den-samente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
b. edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a cinque;c. edifici realizzati secondo gli standard «Minergie» nel rispetto delle norme SIA.
2 I Cantoni possono inoltre disporre che in edifici isolati, abitati solo saltuariamente, nonsiano realizzati rifugi. I Cantoni possono esentare i proprietari di questi edifici dall’ob-bligo di costruire un rifugio.
Art. 19 Rifugi in comune1 I Cantoni possono ordinare che i rifugi prescritti dall’articolo 17 capoverso 1 lettera aper singoli edifici siano raggruppati in rifugi in comune.2 I rifugi in comune devono essere costruiti al più tardi tre anni dopo l’inizio dei lavori dicostruzione del primo edificio interessato.3 Prima dell’inizio dei lavori di costruzione si deve versare, per ogni edificio, una garan-zia equivalente all’ammontare dei contributi sostitutivi.
OPCi
124
Art. 20 Attribuzione della popolazione e gestione della costruzione di rifugi(art. 47 cpv. 1 LPPC)
1 I Cantoni si adoperano affinché ogni abitante disponga di un posto protetto nelle im-mediate vicinanze del suo domicilio.2 Essi determinano, secondo le disposizioni dell’Ufficio federale, delle zone di valuta-zione per l’attribuzione della popolazione ai rifugi e la gestione degli stessi. 3 Il fabbisogno di posti protetti è considerato coperto se all’interno di una zona di valu-tazione sono disponibili, per tutta la popolazione con dimora fissa, posti protetti in rifu-gi conformi alle esigenze minime definite nell’articolo 37. I posti protetti disponibilisecondo l’articolo 17 capoverso 1 lettera b non vengono dedotti dal numero di postiprotetti da realizzare. L’Ufficio federale determina quali altri posti protetti non vengonoconsiderati nel calcolo.
Art. 21 Contributi sostitutivi(art. 47 LPPC)
1 I contributi sostitutivi vanno versati prima dell’inizio dei lavori di costruzione.2 Essi risultano dai costi suppletivi medi dovuti alla realizzazione di un rifugio, calcolatiperiodicamente dalla Confederazione in base ai dati raccolti presso gli uffici cantonaliresponsabili della protezione civile.3 I Cantoni pubblicano annualmente l’ammontare dei contributi sostitutivi.
Art. 22 Utilizzazione dei contributi sostitutivi(art. 47 LPPC)
1 I contributi sostitutivi sono destinati:a. alla realizzazione, all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e alla
salvaguardia del valore dei rifugi pubblici;b. ad altre misure di protezione civile.
2 I Cantoni tengono un controllo dei contributi sostitutivi percepiti e di quelli utilizzati.Essi disciplinano l’amministrazione dei contributi sostitutivi. Su relativa richiesta auto-rizzano l’impiego dei mezzi disponibili.
Art. 23 Prescrizione del diritto d’imposizione di contributi sostitutivi1 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive a dieci anni dall’inizio dei lavori di costruzione.2 La prescrizione non decorre o rimane sospesa durante una procedura d’opposizioneo ricorso e fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio inSvizzera.3 La prescrizione è interrotta:
a. ogni volta che un atto ufficiale inteso ad accertare o a esigere il contributo sosti-tutivo sia reso noto a una persona tenuta a pagarlo;
b. ogni volta che una persona tenuta a pagare il contributo sostitutivo riconoscaespressamente il debito.
Appendice 11
125
4 Il diritto d’imposizione di contributi sostitutivi si prescrive in ogni caso a quindici annidall’inizio dei lavori di costruzione.
Art. 24 Prescrizione del diritto di riscossione di contributi sostitutivi1 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono a dieci annidall’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.2 La sospensione e l’interruzione si basano sull’articolo 23 capoversi 2 e 3.3 Le richieste di versamento relative a contributi sostitutivi si prescrivono in ogni caso aquindici anni dall’entrata in vigore della rispettiva decisione di riscossione.
Art. 25 Approvazione dei progetti1 I Cantoni regolano l’approvazione dei progetti di rifugi.2 L’approvazione dei progetti di rifugi da realizzare in edifici appartenenti alla Confede-razione e di rifugi per beni culturali incombe all’Ufficio federale.
Art. 26 Equipaggiamento dei rifugi(art. 46 cpv. 1 LPPC)
1 I proprietari devono equipaggiare i loro rifugi con il materiale che permette di soggior-narvi per un periodo prolungato; è fatto salvo il capoverso 3.2 L’equipaggiamento dei rifugi realizzati dopo il 1° gennaio 1987 deve essere disponibi-le in occasione del controllo finale.3 Il Dipartimento può ordinare l’equipaggiamento dei rifugi realizzati prima del 1° gen-naio 1987 e conformi alle esigenze minime.
Art. 27 Controllo finale di rifugi nuovi e rimodernati e di rifugi per beni culturali1 I Cantoni disciplinano il controllo dei rifugi nuovi, dei rifugi rimodernati e dei rifugi perbeni culturali conformemente alle istruzioni tecniche dell’Ufficio federale, che descrivo-no le caratteristiche dei rifugi.2 L’Ufficio federale controlla i rifugi nuovi, i rifugi rimodernati e i rifugi per beni culturaliubicati in edifici di proprietà della Confederazione.
Art. 28 Controllo periodico dei rifugi 1 I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi conformi alle esigenze minime e dei rifugi per beni culturali in base alle disposi-zioni dell’Ufficio federale.2 L’Ufficio federale controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzionedei rifugi e dei rifugi per beni culturali situati in edifici appartenenti alla Confederazione.
Art. 29 Soppressione(art. 49 LPPC)
1 I Cantoni possono autorizzare la soppressione di rifugi che non soddisfano più le esi-genze minime.
OPCi
126
2 I rifugi conformi alle esigenze minime possono essere soppressi secondo le disposi-zioni dell’Ufficio federale se:
a. ostacolano eccessivamente o impediscono la ristrutturazione di edifici esistenti;b. sono ubicati in una zona molto minacciata.
3 Se vengono soppressi rifugi pubblici che soddisfano le esigenze minime, i sussidi federali ottenuti per la loro costruzione devono essere restituiti.4 L’Ufficio federale decide in merito alla soppressione di rifugi in edifici appartenenti allaConfederazione e di rifugi per beni culturali.5 Se un rifugio viene soppresso senza autorizzazione, il Cantone fissa un termine ra-gionevole entro il quale il proprietario deve ripristinarlo. Se il tempo messo a disposi-zione non viene sfruttato, il Cantone dispone la risistemazione a spese del proprietario.
Sezione 2: Impianti di protezione
Art. 30 Tipo, dimensioni, numero e utilizzazione degli impianti di protezione(art. 50 LPPC)
L’Ufficio federale emana delle istruzioni tecniche in cui definisce tipo, dimensioni, nu-mero e utilizzazione (occupazione da parte delle organizzazioni partner) degli impiantidi protezione.
Art. 31 Ospedali protetti e centri sanitari protetti(art. 53 LPPC)
1 I Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto nonché possibilità di cura negli ospedaliprotetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione.2 Su richiesta dei Cantoni, la Confederazione può aumentare i sussidi per ospedali pro-tetti e centri sanitari protetti fino a coprire al massimo lo 0,8 % della popolazione.3 In casi debitamente motivati, segnatamente quando è necessario a causa della suddi-visione amministrativa del Cantone oppure della situazione topografica o logistica dell’oggetto, la Confederazione può erogare sussidi per un tasso di copertura superiore0,8 % della popolazione.3
Art. 32 Impianti di protezione combinati per i governi cantonaliGli impianti di protezione combinati destinati ai governi cantonali sottostanno alle stes-se disposizioni tecniche e finanziarie degli altri impianti di protezione.
Art. 33 Approvazione dei progetti(art. 51 LPPC)
1 I Cantoni esaminano il progetto e inoltrano all’Ufficio federale la domanda d’approva-zione unitamente alla domanda di assunzione delle spese suppletive.
3 Introdotto dall’art. 15 dell’O del 27 apr. 2005 sul servizio sanitario coordinato, in vigore dal 1º giu. 2005 (RS 501.31).
Appendice 11
127
2 L’Ufficio federale decide in merito ai progetti concernenti nuove costruzioni, rimoder-namenti, modifiche, cambi di destinazione e soppressioni di impianti di protezione. 3 Esso può rifiutare di assumere una parte o la totalità delle spese suppletive se:
a. la domanda per l’assunzione delle spese suppletive contiene indicazioni errate oincomplete;
b. la documentazione inoltrata non permette di prendere in esame la domanda;c. per lo stesso oggetto è già stato richiesto e approvato un indennizzo in base ad
un’altra norma di legge;d. le condizioni non sono state rispettate; l’inosservanza dev’essere constatata
mediante decisione passata in giudicato.4 e 5 …4
6 Il diritto all’assunzione delle spese suppletive da parte della Confederazione decadese i lavori di costruzione non sono iniziati entro due anni dall’accettazione della do-manda.7 L’assunzione delle spese suppletive può essere rinnovata per altri due anni su do-manda motivata inoltrata prima dello scadere del termine. In questo caso sono deter-minanti le disposizioni valide al momento della proroga.
Art. 34 Controllo finale di impianti di protezione nuovi e rimodernati1 L’Ufficio federale esegue il controllo degli impianti di protezione nuovi e di quelli rimo-dernati.2 Esso può delegare parzialmente o completamente questo controllo ai Cantoni.
Art. 35 Controllo periodico degli impianti di protezione1 I Cantoni controllano periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione degliimpianti di protezione conformemente alle istruzioni tecniche dell’Ufficio federale chedescrivono il relativo procedimento.2 Provvedono alla manutenzione del loro impianto di protezione combinato destinato algoverno cantonale ed assicurano la sua prontezza operativa. L’Ufficio federale eseguedei controlli periodici.
Art. 36 Sussidi forfettari(art. 71 cpv. 3 LPPC)
1 L’Ufficio federale fissa l’ammontare dei sussidi forfettari annui volti a garantire la pron-tezza operativa degli impianti di protezione in caso di conflitto armato.2 Se il controllo periodico dell’impianto rileva dei difetti, il versamento del sussidio for-fettario può essere tenuto in sospeso fintanto che non sono stati eliminati. 3 L’Ufficio federale può rifiutare di versare i sussidi forfettari se:
a. il Cantone non adempie i suoi doveri secondo l’articolo 35;b. i proprietari non adempiono i loro doveri secondo l’articolo 38;
4 Abrogati dal n. II 41 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federalealla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1º gen. 2007 (RU 2006 4705).
OPCi
128
c. le condizioni non vengono rispettate; l’inosservanza dev’essere constatata me-diante decisione passata in giudicato.
4 e 5 …5
Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 37 Esigenze minime per nuove costruzioni di protezione(art. 56 LPPC)
1 Le nuove costruzioni di protezione devono garantire la cosiddetta protezione di basedagli effetti delle armi moderne, in particolare:
a. dagli effetti delle armi nucleari a una distanza dal nucleo dell’esplosione tale chel’onda d’urto non superi la pressione di 100 chilopascal (kPa);
b. dagli effetti delle armi convenzionali quando l’impatto è vicino alla costruzione;c. contro la penetrazione di aggressivi chimici e biologici.
2 In caso di rimodernamento di costruzioni di protezione esistenti, possono essere ap-plicate norme meno severe di quelle statuite al capoverso 1 lettera a.3 L’Ufficio federale fissa nelle istruzioni tecniche le esigenze minime per l’equipaggia-mento delle costruzioni di protezione.
Art. 38 Manutenzione(art. 57 LPPC)
I proprietari provvedono alla manutenzione delle costruzioni di protezione conforme-mente alle disposizioni dell’Ufficio federale.
Art. 39 Utilizzazione estranea alla protezione civileLe costruzioni di protezione possono essere utilizzate per scopi estranei alla protezio-ne civile soltanto a condizione che sia possibile renderle operative al più tardi immedi-atamente dopo la decisione di potenziare la protezione della popolazione in vista di unconflitto armato.
Capitolo 5: Responsabilità per danni
Art. 40 Ripartizione dei costi(art. 60 cpv. 2 LPPC)
1 Confederazione e Cantoni rispondono in parti uguali per danni secondo l’articolo 60capoverso 2 della legge.2 I Cantoni regolano la ripartizione dei costi tra loro e i Comuni.
5 Abrogati dal n. II 41 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federalealla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1º gen. 2007 (RU 2006 4705).
Appendice 11
129
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 41 Esecuzione, emanazione di prescrizioni, controlli(art. 75 cpv. 2 LPPC)
1 L’Ufficio federale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza, sempre chedetta esecuzione non incomba ai Cantoni e ai Comuni.2 Nella misura in cui non è stata affidata al Dipartimento, l’emanazione delle necessa-rie prescrizioni di natura giuridica, tecnica e amministrativa compete all’Ufficio federale.3 Nell’ambito della protezione civile, all’Ufficio federale è data facoltà di controllare l’esecuzione da parte dei Cantoni e Comuni.
Art. 42 Diritto previgente: abrogazioneSono abrogate:
a. l’ordinanza del 19 ottobre 19946 sulla protezione civile;b. l’ordinanza del 29 novembre 1996 7 concernente il personale di riserva della
protezione civile;c. l’ordinanza del 19 ottobre 19948 concernente il calcolo forfettario dei sussidi
federali per la protezione civile;d. l’ordinanza del 27 novembre 19789 sull’edilizia di protezione civile;e. l’ordinanza del 19 ottobre 199410 concernente il campo e il grado di protezione
delle costruzioni di protezione civile;f. l’ordinanza del 19 ottobre 199411 concernente le classi di funzione e il soldo nella
protezione civile;g. l’ordinanza del 19 ottobre 199412 sui controlli nella protezione civile;h. l’ordinanza del 19 ottobre 199413 concernente l’esonero dal servizio di protezione
civile;i. l’ordinanza del 19 ottobre 199414 sull’elenco del materiale della protezione civile.
Art. 43 Entrata in vigoreLa presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
6 [RU 11999944 2646, 11999977 2779 n. II 33 2833 art. 67, 11999988 2677, 11999999 4 art. 28 cpv. 1, 22000022 723 all. 2 n. 6]7 [RU 11999977 199, 11999999 1380]8 [RU 11999944 2739, 11999966 208 art. 3 lett. a, 11999988 2831]9 [RU 11997788 1896, 11998855 1672, 11999922 1198, 11999944 2671]
10 [RU 11999944 2676]11 [RU 11999944 2683, 11999988 2624, 11999999 1235]12 [RU 11999944 2688, 11999988 2678]13 [RU 11999944 2741, 11999955 787, 11999988 220]14 [RU 11999944 2763, 11999988 2832, 22000011 1899]
130
Glossario
I seguenti termini costituiscono la terminologia nel campo dell’analisi della situa-zione valevole per tutte le organizzazioni partner della protezione della popolazione.
Termine: Definizione:
Aiuto alla condotta Insieme delle misure volte a sostenere la direzione d'inter-vento e/o l'organo di condotta nei seguenti settori: informa-zione, analisi della situazione, telematica, protezione ABC e coordinamento logistico.
Analisi coordinata della Sintesi della situazione sul luogo dell’evento e di quella neisituazione singoli settori (dicasteri, campi tecnici) delle organizzazioni
partner e degli organi di condotta intervenuti per far frontealla situazione.
Autorità Organo politico responsabile di tutte le attività. Si tratta diun elemento della struttura di base.
Base Ubicazione di cui dispone un mezzo d'intervento, equipag-giata ed arredata per alloggiare il personale, immagazzi-nare il materiale ed effettuare la manutenzione.
Basi vitali Insieme degli elementi necessari per la sopravvivenza dellapopolazione:approvvigionamento con alimenti, energia e materie prime,buon funzionamento dell’economia, libero accesso ai mer-cati internazionali, infrastruttura nazionale e transfrontalierapossibilmente intatta.
Capointervento Persona responsabile di dirigere le operazioni di soccorso e salvataggio sul luogo.
Capointervento Persona responsabile di dirigere tutte le formazioni interve-generale nute nella zona sinistrata.
Careteam Squadra di sostegno psicologico per le persone traumatiz-zate dalle conseguenze di un sinistro.
Carta di condotta Rappresentazione degli aspetti della situazione importantidal punto di vista della condotta.
131
Termine: Definizione:
Catastrofe Sinistro (evento di origine naturale o tecnologica o graveincidente) che causa un numero di danni tale da rendereinsufficienti i mezzi in personale e materiale della comunitàcolpita.
Comunicato ufficiale Istruzione di comportamento redatta da uffici amministrativiautorizzati e diffusa da diversi media, che non si può modi-ficare nel contenuto e nella forma.
Condotta Insieme delle misure volte a coordinare ed impiegare imezzi in modo conforme alla situazione.
Condotta delle retrovie Elemento responsabile delle attività di condotta che nondevono essere svolte per forza sul posto, come l’adozionedi provvedimenti nel campo dell’assistenza o della logistica.
Conflitto armato Minaccia per l’esistenza della popolazione, delle sue basivitali e dei beni culturali, costituita dall’uso di armi e violen-za nell’ambito di interventi militari che mettono in pericolol’esistenza e l’identità della Svizzera.
Contaminazione Stato di contaminazione di un materiale causato da sostan-radioattiva ze radioattive.
Coordinamento logistico Coordinamento delle misure e dei mezzi d’intervento logi-stici quando vengono impiegate più organizzazioni partner.
Dose Unità di misura per valutare i rischi che le radiazioni ioniz-zanti comportano per la salute.
Elementi logistici Elementi della protezione civile che si occupano della logi-stica.
Informazione all’atten- Notizie giornalistiche ufficiose fondate su informazioni zione della popolazione tecniche fornite dagli organi competenti o su altre fonti.
Intensità di dose Dose radioattiva emessa in un determinato luogo e in un ambientale certo intervallo di tempo, divisa per la durata dell’intervallo
di tempo.
Istruzione sul compor- Comunicato ufficiale che spiega il comportamento da tamento da adottare adottare in vista di un pericolo imminente.
Logistica specifica Logistica di una determinata organizzazione partner.
132
Termine: Definizione:
Logistica Misure adottate per garantire l’esercizio delle ubicazioni, lamessa a disposizione di beni d’approvvigionamento, l’impie-go di mezzi di trasporto e macchinari edili, la manutenzionee la preparazione del materiale nonché la sussistenza.
Mezzi Personale, materiale, equipaggiamento e veicoli a disposi-zione di un’organizzazione partner.
Mezzi di secondo Mezzi d’intervento (uno o più) mobilitati per rinforzare ed intervento assistere i mezzi già operativi o per dare loro il cambio.
Mezzo d’intervento Organizzazione partner della protezione della popolazionein grado di far fronte ad un sinistro con strutture e mezzipropri.
Mezzo di primo Organizzazione pronta ad intervenire in ogni momento eintervento che può essere allarmata tramite un numero d’emergenza.
Notizia Affermazione di una persona, un documento, un supportodati o un media ritenuta importante ai fini della condotta.
Organo d’analisi della Personale di una direzione d'intervento, di un mezzo situazione d'intervento o di un organo di condotta incaricato di svolge-
re compiti nel campo dell'analisi della situazione nella fasedi pianificazione e durante l'intervento.
Organo di condotta Elemento responsabile della condotta che aiuta le autoritàa preparare le decisioni.
Pericolo Evento o sviluppo d’origine naturale, tecnologica o politico-militare che può danneggiare le persone e le loro basi vitalio minacciare la sicurezza politica della Svizzera.
Politica di sicurezza Tutte le misure adottate dallo Stato per prevenire e affron-tare pericoli diretti e indiretti come le catastrofi naturali etecnologiche o l’aggressione strategica contro la Svizzera,la sua popolazione e le basi vitali.
Resistenza Capacità di un’organizzazione partner di prestare un inter-vento duraturo nel campo della condotta, del personale, delmateriale e della logistica.
Settore d’attività Settore circoscritto in cui opera una determinata organizza-zione partner della protezione della popolazione in base adun mandato di prestazioni
Settore specialistico Campo d'attività ben delimitato nell'ambito dell’aiuto allacondotta.
133
Termine: Definizione:
Sinistro importante Sinistro che richiede la collaborazione di diverse organizza-zioni d’intervento come pure di aiuti esterni, ma di cui simantiene il controllo.
Sinistro quotidiano Sinistro che i mezzi di primo intervento comunali o regionaliriescono a fronteggiare autonomamente.
Situazione Situazione in cui si trova momentaneamente una comunitàper quanto riguarda le sue basi vitali e le procedure per farfronte agli eventi. Si distingue tra situazione normale, situazione particolare esituazione straordinaria.
Situazione d’emergenza Situazione causata da sviluppi sociali o avarie tecniche cuinon è possibile far fronte con le procedure ordinarie, poichéil personale e il materiale della comunità colpita non sonosufficienti.
Situazione normale Situazione in cui le procedure ordinarie sono sufficienti perfar fronte ai problemi che si pongono.
Situazione particolare Situazione in cui le procedure ordinarie non sono sufficientiper svolgere determinati compiti.A differenza della situazione straordinaria, le autorità agi-scono solo in alcuni settori.In questi casi, si presenta spesso la necessità di concen-trare rapidamente i mezzi e semplificare le procedure.
Situazione prioritaria Presenta continuamente e in sintesi la situazione dellaper la protezione della popolazione e delle sue basi vitali – in funzione alle normepopolazione (BREL) di qualità e ai valori stabiliti a livello giuridico, o concordati
attualmente, nonché all’accettanza del rischio da parte del-la società – e indica pure luoghi di permanenza e il compor-tamento della popolazione.Comprende dunque tutti gli aspetti relativi all’esistenza ealla sicurezza dell’esistenza collettiva.
Situazione straordinaria Situazione in cui i mezzi dei diversi settori e le procedureordinarie non sono più sufficienti per far fronte agli eventi,ad esempio in caso di catastrofi, di situazioni d’emergenzache interessano l’intero paese oppure di conflitti armati.
Strategia Piano dettagliato delle procedure necessarie per raggiun-gere un obiettivo in considerazione dei fattori che potreb-bero contribuire al successo delle operazioni.
Telematica Combinazione di telecomunicazione e informatica.
134
Termine: Definizione:
Temperatura Soglia di temperatura al di sopra della quale una sostanzad’accensione o una miscela di gas esplosivi s’incendiano.
Tempo di preallarme Intervallo che intercorre fra i primi segnali premonitori el’evento vero e proprio.
Ubicazione di condotta Installazione di condotta fissa, improvvisata o mobile, equi-paggiata per offrire protezione e condizioni di lavoro favore-voli alla direzione d’intervento o all’organo di condotta.
Valutazione della Valutazione dei possibili sviluppi di una situazione e delle situazione possibili conseguenze sull'intervento.
Violenza al di sotto Conflitti violenti fra singole persone, gruppi o organizzazionidella soglia bellica che non rientrano fra i conflitti armati veri e propri.
135
Indice analitico
Aaiuto alla condotta 13, 120amministrazione 11analisi della situazione 19, 120
coordinata 21, 120approvvigionamento economico
del Paese 6assistenza 30
compiti 30, 31personale 31
autorità 120
Bbene culturale 32
Ccantone 13capo
analisi della situazione 23coordinamento logistico 29cucina 36protezione ABC 27
cartatopografica 45
catastrofe 76, 80, 121centro sanitario 47centro di analisi 22chiamata 78ciclo di elaborazione della situazione 22classificazione degli incendi 56comportamento
in caso d’incendio 57comune 12comunicazione 7condotta 121
civile 11Confederazione 6conflitto armato 9, 121conoscenze dei nodi 60controllo
di funzionamento 48
coordinamento logistico 29, 121coperta di spegnimento 58costruzione di protezione 39costruzione di linee 24
Ddirezione
d’intervento 79d’intervento generale 70
distintivi indicanti il grado 86distintivo internazionale di protezione 34
EEDOS 99 28elemento logistico 37, 121equipaggiamento di protezione ABC 28esercito 5esplosione A 27estintore portatile 56, 58
Ffunzionamento a batteria locale 24funzioni 85furiere 36
Gguardia del traffico 66
IICARO 14, 15impianto
d’apprestamento 43di commutazione d’utente 25di protezione 41
incendioclasse 56genesi 55
informazione 7, 121intervento radio 48inventario svizzero dei beni culturali 32istruzioni di comportamento 121
136
Llinea
a batteria locale 24da campo 24posa 24
logistica 36, 122specifica 29, 121
Mmaschera di protezione 28materiale 38mezzo 122
di primo intervento 76, 122di spegnimento 58
modulo di notifica 23, 88
Nnodo 60
Oorganizzazione
d'intervento 12organo di condotta 12, 122
Ppartner della protezione
della popolazione 10piano di rete radio 48pioniere 35politica
di sicurezza 1, 122economica 5estera 5
polizia 10POLYCOM 25pompa a secchio 58pompieri 10posto
collettore 31d’assistenza 31di comando 42
promemoriad’emergenza 94
protezioneABC 13, 19, 50dello Stato e polizia 6
protezione civile 15organizzazione 15
protezione dei beni culturali 32protezione della popolazione 9protezione e assistenza 30, 51
RRA 99 28radio 14, 89radioattività 26radiocomunicazione 24, 52rapporto
sulla politica di sicurezza 4regione 12, 13, 17regolazione del traffico 66regole
di conversazione 49di spegnimento 59
ricercatore A 26, 27rifugio per beni culturali 33
Ssanità pubblica 10, 30, 31schizzo 47segni convenzionali 46, 87sergente maggiore 36servizio
d’assistenza 30tecnico 10
sinistroimportante 76, 123fronteggiamento 22, 74quotidiano 76, 123
sirenafissa 14mobile 14
sistema integrato 9situazione 123
d’emergenza 75, 123normale 123
137
particolare 123straordinaria 123
sorvegliante del materiale 36sostegno 35, 55stima della distanza 46
metodo del pollice 46metodo della media 46
stress 53strumenti di misurazione 28
Ttelematica 19, 24, 48, 123tenuta di protezione SA 28, 92traffico 66
radio 48
Uuso della maschera di protezione 92
Vveicoli 38
Zzona sinistrata 80