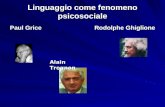Alain De Benoist - Jùnger, Heidegger e il nichilismo
Click here to load reader
description
Transcript of Alain De Benoist - Jùnger, Heidegger e il nichilismo

Intervento di Alain de Benoist al convegno “Junger e il nichilismo”
tenutosi a Milano nel novembre del 2000
Jùnger, Heidegger e il nichilismo
Ernst Junger e Martin Heidegger, come tutti sanno, hanno aperto a cinque anni dì distanza un dialogo sul nichilismo, dialogo allacciato attraverso due testi particolarmente importanti, apparsi negli anni cinquanta in occasione del loro rispettivo 60°anniversario1. Lo studio e la comparazione di questi testi è particolarmente interessante nella misura in cui permettono di meglio apprezzare ciò che, su questo argomento fondamentale, divide due autori che sono stati frequentemente accostati l’uno all’altro e che hanno per parecchi decenni mantenuto una forte relazione intellettuale tra loro. Ne offriremo qui una breve presentazione.
Nel suo approccio, che si presenta con andamento deliberatamente “medico” (comprende una “diagnosi” e una “terapia”) Junger afferma dapprincipio che porre rimedio al nichilismo implica il darne una “buona definizione”. Riprendendo l’opinione di Nietzsche, che vedeva nel nichilismo il processo attraverso e in cui «i valori supremi si svalutano» (Volontà di potenza), afferma che questo si caratterizza essenzialmente con la svalutazione, e poi con la scomparsa dei valori tradizionali, al cui primo posto situa allora i valori cristiani.
Reagisce in seguito contro l’idea che il nichilismo sarebbe essenzialmente un fenomeno caotico. «Ormai è chiaro, scrive, che il nichilismo può senz’altro combinarsi armonicamente con sistemi d’ordine di grandi dimensioni, e che anzi è la regola che esso sia attivo e dispieghi la sua forza in tali sistemi. L’ordine è per il nichilismo un terreno fertile, che esso rimodella per i propri fini. [...] L’ordine non solo è ben accetto al nichilismo, ma fa parte del suo stile» (pp. 48-52; it. pp. 61-64). In questo senso, il nichilismo non è la decadenza. Non va di pari passo con la rilassatezza (morbidezza), ma produce piuttosto «individui che vanno per la loro strada come ferrei automi, imperturbabili perfino quando la catastrofe li spezza» (p. 57; it. p. 68). Allo stesso modo, il nichilismo non è una malattia. Non ha nulla di morbido. Lo si trova, al contrario, «legato alla salute fisica — soprattutto laddove esso è perseguito con decisione» (p. 54; it. p.65). Il nichilismo è, in compenso, essenzialmente riduttore: la sua tendenza più costante è quella di «ridurre il mondo, con le sue intricate, molteplici tendenze, a un comune denominatore» (p. 65; it. p. 74). Facendo passare la società «dalla comunità morale alla coesione automatica» (p. 63), coniuga il fanatismo, l’assenza di qualsiasi sentimento morale e la “perfezione” dell’organizzazione tecnica.
Queste osservazioni sono caratteristiche. Mostrano che, allorquando evoca il nichilismo, Junger si riferisce innanzitutto al modello dello Stato totalitario, e più specificatamente a quello dello Stato nazionalsocialista. Il III Reich corrisponde, in effetti, a quello stato sociale in cui gli uomini sono sottomessi ad un ordine assoluto, ad una organizzazione “automatica”, mentre la svalutazione di qualsiasi morale tradizionale va di pari passo con una incontestabile esaltazione della “salute”.
La domanda che ci si può allora porre è quella di sapere se ciò che Junger sta descrivendo è veramente il nichilismo. Non si tratta piuttosto, semplicemente, del totalitarismo — di questo Leviatano totalitario, che ha posto la tecnica al proprio servizio e che genera un mondo che sembra tratto dal «paesaggio dei cantieri?
Junger, d’altro canto, professa un certo ottimismo che traspare già nel titolo del suo testo: Oltre la linea (oltrepassamento della linea). Evocando Nietzsche e Dostoevskij, constata che la loro critica del nichilismo non ha loro impedito di mostrarsi relativamente ottimisti, sia che il nichilismo possa

essere superato «in un qualche futuro» (Nietzsche), sia che costituisca in qualche modo «una fase necessaria all’interno di un movimento orientato a scopi ben precisi» (Dostoevskij). Junger riprende qui un’idea che gli è familiare: dopo il peggio non può venire che il meglio. O, più esattamente: una tendenza spinta fino all’estremo si inverte necessariamente nel proprio contrario. Diceva così, negli anni trenta, che bisognava «perdere la guerra per vincere la nazione». È in questo spirito che cita Bernanos: «la luce comincia a risplendere quando il buio è più fitto che mai. Ciò che depone a sfavore del nemico è proprio la sua assoluta superiorità» (pp.37-38; it. p. 53). Ora, la sensazione di Junger è che il peggio sia passato, che «la testa abbia superato la linea», cioè che l’uomo abbia cominciato ad uscire dal nichilismo. Questa affermazione deriva, là ancora, dalla sua assimilazione del nichilismo al totalitarismo. Come scrive Julien Hervier, «se Junger crede al superamento dello zero assoluto, il crollo delI’ hitlerismo, incarnazione trionfante del nichilismo morale, non è di secondaria importanza» (prefazione, p.13)2.
Nel suo saggio, Junger si applica dunque essenzialmente a descrivere lo stato del mondo così come è, allo scopo di valutare la possibilità che si sia già passati dall’altra parte della “linea”. La sua conclusione può, d’altronde, parere modesta. Di fronte al nichilismo propone di ricorrere ai poeti e all’amore (“Eros”). Chiama alla dissidenza individuale, alla “autentica anarchia”. (Nel 1950 non ha ancora inventato la figura dell’Anarca). «Innanzitutto, scrive. Bisogna trovare la sicurezza nel proprio cuore. Allora il mondo cambierà».
L’approccio di Heidegger è ben differente. Il suo testo, scritto in risposta a quello di Junger, vuole essere innanzitutto una critica — amichevole beninteso, e che sottolinea la considerazione che porta al suo interlocutore, ma che mira nondimeno a sostituire alla sua analisi un altro punto di vista.
La modifica del titolo è di per sé già rivelatrice. Mentre Junger ha scelto di dissertare «sulla linea» nel senso di «oltre la linea» (Uber die Linie), Heidegger intende pronunciarsi «sulla linea» nel senso di «a proposito della linea» (Uber «dia Linie»), segnando così subito la propria convinzione che la linea non è ancora stata superata e il proprio desiderio di suscitare un interrogativo sulle ragioni per cui non può ancora esserlo. Alla topografia trans lineam di Junger, Heidegger dichiara esplicitamente di voler aggiungere (e a parecchi riguardi opporre) una topologia de linea: «Lei guarda e procede al di là della linea; io mi accontento solo di volgere lo sguardo sulla linea da lei rappresentata. L’una cosa è d’aiuto reciproco all’altra»(p. 203; it. P. 115).
Heidegger comincia a contestare che si possa, come Junger cerca di fare, dare una buona “definizione” del nichilismo. «Se restiamo all’immagine della linea, scopriamo che essa percorre uno spazio che, a sua volta, è determinato da un luogo. Il luogo raccoglie. La raccolta mette al sicuro il raccolto nella sua essenza. Dal luogo della linea risulta la provenienza dell’essenza del nichilismo e del suo compimento» (p. 200; it. p. 111). L’interrogarsi sul compimento del nichilismo di cui il mondo intero è diventato teatro — di modo che il nichilismo è ormai lo «stato normale» dell’umanità -, impone dunque di cercare di situare questo ((luogo della linea» che accenna all’essenza del nichilismo. Per Heidegger, porre la questione della situazione dell’uomo in rapporto al movimento del nichilismo esige una «determinazione di essenza». Comprendere il nichilismo implica che il pensiero sia ricondotto alla considerazione della sua essenza.
La risposta verrà presto data. Deriva dalla filosofia di Heidegger, di cui sì suppongono qui conosciute le linee essenziali. Il nichilismo rappresenta, agli occhi di Heidegger la conseguenza e il compimento di una lenta dimenticanza dell’Essere, che comincia con Socrate e Platone, continua nel cristianesimo e la metafisica occidentale e trionfa nei tempi moderni. L’essenza del nichilismo «sta nella dimenticanza dell’essere» (p. 247; it. p, 161). Il nichilismo è la dimenticanza dell’essere giunta al suo compimento. Sta in questo il regno del nulla.

La dimenticanza dell’Essere significa che l’Essere si nasconde, che rimane in disparte sottratto al pensiero dell’uomo, quiescenza che è anche protettrice, pronta ad una manifestazione: «È in questo raccoglimento che consiste l’essenza della dimenticanza». La dimenticanza è il celamento dell’Essere presente a favore dell’essente-presente. Nella metafisica occidentale, Dio è lui stesso l’assente supremo. La metafisica non conosce che la trascendenza, cioè il pensiero dell’essente. Perché non solo gli è vietato di accedere all’Essere, ma pure di provare la propria essenza.
Heidegger precisa ancora che è nel «regno della volontà» che si compie l’essenza del nichilismo. In questo caso viene preso in considerazione, beninteso, il pensiero di Nietzsche. Sappiamo che per Heidegger, la filosofia dell’autore di Zarathustra non è, a dispetto dei suoi meriti, che del platonismo rovesciato nella misura in cui non riesce a uscire dall’ambito del valore. La volontà di potenza, analizzata da Heìdegger come «volontà di volontà», cioè volontà che vuole porsi in maniera incondizionata, non è che un modo di apparire dell’essere dell’assente, e in questo senso un’altra forma della dimenticanza dell’Essere. «È infatti proprio dell’essenza della volontà di potenza, scrive Heidegger, impedire che il reale su cui essa esercita la sua potenza appaia in quella realtà che essa stessa essenzialmente è (wesO» (p. 205; it. p. 117). Nietzsche ha un bel dichiarare che «Dio è morto», resta nell’ombra di questo Dio di cui proclama la morte.
Ora, è nella misura in cui Junger resta lui stesso sotto l’orizzonte del pensiero di Nietzsche che si trova anch’esso nel mirino della critica di questo pensiero fatta da Heidegger.
Heidegger torna qua sul celebre libro di Junger, L’operaio, apparso nel 1932. Sottolinea che la Figura (o la Forma, Gestalt) del Lavoratore corrisponde ben precisamente alla Figura di Zarathustra all’interno della metafisica della volontà di potenza. La sua venuta manifesta la potenza in quanto volontà di fermare il mondo, in quanto «mobilitazione totale». Ne L’operaio, Junger osservava: «La tecnica è il modo con cui la Figura del Lavoratore mobilita il mondo». Il Lavoro si svolge su scala planetaria nel senso della volontà di potenza.
Beninteso, Heidegger non ignora che lo sguardo posato da Junger sulla tecnica si è evoluto. Junger ha innanzitutto avuto la rivelazione dell’importanza della tecnica attraverso un’esperienza concreta: la “battaglia di materiali” della Prima Guerra mondiale. Ha allora provato, a ragione, il sentimento che il regno della tecnica avrebbe inaugurato una nuova età dell’umanità. Ha assimilato questo regno al dominio della Figura del Lavoratore, immaginandosi che una tale Figura non potesse che opporsi su scala mondiale a quella del Borghese. Su questo punto, Junger si è sbagliato, ed in seguito ha riconosciuto il suo errore. Infine anche la sua stessa opinione sulla tecnica si è modificata — forse influenzato dai lavori di suo fratello, Friedrich Georg (La perfezione della tecnica, 1946; trad. it. di Matilde De Pasquale, La perfezione della tecnica, Settimo Sigillo, Roma 2000). Dopo il 1945 Junger ha chiaramente messo in rapporto il nichilismo con il “titanismo” di una tecnica che, in quanto volontà di dominio del mondo, dell’uomo e della natura, segue il proprio corso (3) senza che nulla possa arrestarla La tecnica non obbedisce che alle sue proprie regole, poiché la sua legge più profonda consiste nell’equivalenza tra il possibile e l’auspicabìle: tutto ciò che può essere tecnicamente realizzabile sarà effettivamente realizzato.
Heidegger loda senza riserva il modo con cui Junger, in Dia totale Mobilmachung (La mobilitazione totale) (1931), poi ne L’operaio, ha saputo descrivere ciò che si trova «alla luce del progetto nietzscheano dell’assente come volontà di potenza». Gli fa anche credito di aver finalmente realizzato che il regno del lavoro tecnico vive nell’ambito di un «nichilismo attivo» che si sviluppa oramai su scala planetaria. Nello stesso tempo, tuttavia, gli rimprovera di non aver afferrato in che cosa il «progetto nietzscheano» continua a impedire il pensiero dell’Essere, e sottolinea che L’operaio «rimane un’opera che ha la sua patria nella metafisica» (p. 212; it. p. 124).

Ciò che Heidegger, in effetti, rimprovera a Junger, è di essere restato al di là della propria evoluzione, nel mondo della Figura e del valore. La Forma, definita da Junger come questo «essere calmo» che si mette in mostra mettendo il mondo in forma secondo uno stile segnato dalla propria impronta, non è in effetti altro che una «potenza metafisica». La Forma, sottolinea Heidegger, «consiste nella compagine essenziale di un’umanità che, come subiectum, è a fondamento di tutto l’ente. Non è I’egoità di un uomo singolo, l’elemento soggettivo dell’egoità, a formare la soggettività estrema che emerge nel compimento della metafisica e che è esposta nel pensiero di quest’ultima, ma è la presenza prefigurata e preformata di una specie d’uomo (di un tipo)» (pp. 212-21 3; ìt. p. 125).
Non prendere più parte al nichilismo non significa dunque ancora dire di restare fuori dal nichilismo. Il modo con cui Junger, per «uscire» dal nichilismo, propone di mettersi «all’ascolto della terra», di tentare di sapere «che cosa vuole la terra», nel momento in cui denuncia il carattere tellurico e titanico della tecnica, è a questo riguardo rivelatore.
Junger scrive: «L’istante in cui la linea sarà passata porterà una nuova dedizione dell’essere, e cos, comincerà a risplendere ciò che realmente è». Heìdegger risponde: «Parlare di una “dedizione dell’essere” rimane allora un espediente, e del tutto problematico, perché l’essere consiste nella dedizione, in modo tale che questa dedizione non è mai soltanto qualcosa che può aggiungersi all’”essere”» (p. 229; it. p. 142).
Heidegger non crede per nulla che la «linea-zero» sia oramai dietro a noi. Ai suoi occhi, il “compimento” del nichilismo non rappresenta assolutamente la fine. «Il compimento del nichilismo, scrive, tuttavia, non è già la sua fine. Con il compimento del nichilismo si inizia solo la fase finale del nichilismo. C’è da presumere che la sua zona, poiché è dominata da una condizione normale e dal suo consolidamento, sia insolitamente ampia. Per questo la linea-zero, dove il compimento giunge alla fine, non è in fondo ancora visibile» (pp. 209-210; it. p. 122Y Ma aggiunge anche che è ancora un errore ragionare, così come fa Junger, come se la «linea-zero» fosse un punto esterno all’uomo, che l’uomo potrebbe «superare». L’uomo è lui stesso la fonte della dimenticanza dell’essere. È lui stesso la «zona di linea». «Pensata come segno che delimita la zona del nichilismo compiuto, precisa Heidegger, la linea non è in nessun caso qualcosa che sta davanti all’uomo come un che di oltrepassabile. Ma allora cade anche la possibilità di un trans lineam e perciò di un attraversamento» (p. 233; it. p. 147-148).
Ma allora, se qualsiasi tentativo di «superare la linea» resta «in balia di un rappresentare che appartiene all’ambito in cui domina la dimenticanza dell’essere» (p. 247; it. p. 161), come può l’uomo sperare di finirla con il nichilismo?. Heidegger risponde: «Invece di volere oltrepassare il nichilismo, dobbiamo prima raccoglierci nella sua essenza. Questo raccoglimento (Einkehr) nella sua essenza è il primo passo mediante il quale lasciamo il nichilismo alle nostre spalle» (p. 247; it. p. 162).
Heidegger condivide l’opinione di Junger secondo cui il nichilismo non è assimilabile al male o ad una malattia. Ma dà un’altra portata a questa constatazione. Quando afferma che «l’essenza del nichilismo non è niente di nichilistico» (p. 207; it. p. 119), vuole dire che la zona di maggior pericolo è anche quella della salvezza. È in questo senso che il nichilismo, l’in-sane, può anche fare cenno verso l’in-demne.
«Entrare in raccoglimento» nell’essenza del nichilismo significa offrirsi la possibilità di una appropriazione (Verwindung) della metafisica. L’appropriazione della metafisica è, in effetti, anche l’appropriazione della dimenticanza dell’essere — e quindi possibilità di un non-velamento, possibilità di uno svelamento della verità (aléthéia). Junger scriveva che «la difficoltà di definire il

nichilismo sta nel fatto che è impossibile per la mente giungere a una rappresentazione del niente» (p. 47; it. p. 59). Heidegger cita questa frase per sottolineare la vicinanza dell’Essere e dell’essenza del nulla. Per lui ne deriva che è attraverso una meditazione sul nulla che comprenderemo che cosa ne è del nichilismo, e che solo quando avremo compreso che cosa ne è del nichilismo che potremo superare la dimenticanza dell’Essere. «lI niente, anche quando lo pensiamo solo nel senso di una completa negazione di ciò che è presente, fa parte, in quanto è assente, dell’essere-presente come una delle sue possibilità. Pertanto, se nel nichilismo domina il niente, se l’essenza del niente appartiene all’essere, e se l’essere è il destino del trascendimento, allora l’essenza della metafisica si rivela come il luogo essenziale del nichilismo» (p. 236; it. p. 150).
Il luogo dell’essenza del nichilismo compiuto è dunque da ricercare «là dove l’essenza della metafisica dispiega le sue possibilità estreme e in esse si raccoglie» (ibid.; it. p. 151). Finalmente, scrive Heidegger, «l’oltrepassamento del nichilismo esige il raccoglimento nella sua essenza, raccoglimento col quale diviene caduco il volere oltrepassare. Il superamento della metafisica chiama il pensiero in un’ingiunzione più iniziale» (p. 250; it. p. 164)
Tuttavia, per far saltare la “barriera” che ci impedisce di entrare in raccoglimento nell’essenza del nichilismo, bisogna ancora disporre di una parola suscettibile di dare accesso al pensiero dell’Essere. Bisogna, in altri termini, abbandonare la lingua della metafisica — che è ancora quella della volontà di potenza, del valore e della Forma — poiché questa lingua, precisamente, ne vieta l’accesso. «Mi accontento di presumere che il solo modo in cui potremmo meditare sull’essenza del nichilismo sia quello di imboccare innanzitutto la via che conduce a una localizzazione dell’essenza dell’essere. Solo per questa via è possibile localizzare la questione del niente. Sennonché, la questione dell’essenza dell’essere si estingue se essa non abbandona il linguaggio della metafisica, perché il rappresentare metafisico impedisce di pensare la questione dell’essere » (it. p. 139).
Ora, è proprio questo che Heidegger rimprovera a Junger: gli rimprovera dì interrogarsi sul nichilismo a partire da una affermazione e da un’idea che restano tributaria dell’essenza della metafisica. Nella misura in cui continua ad esprimersi e a pensare nella lingua della metafisica, che è dimora dell’essenza del nichilismo, Junger si toglie tutte le possibilità di risolvere il problema che ha posto. «In che linguaggio, domanda Heidegger, parla lo schema fondamentale del pensiero che prefigura un attraversamento della linea? Il linguaggio della metafisica della volontà di potenza, della forma e del valore deve essere salvato al di là della linea critica? E in che modo, se proprio il linguaggio della metafisica e la metafisica stessa, sia essa del Dio vivente o del Dio morto, hanno costituito in quanto metafisica il limite che impedisce il passaggio oltre la linea, cioè l’oltrepassamento del nichilismo?» (pp. 224-225; it. p. 138).
Non possiamo dunque penetrare l’essenza del nichilismo fino a quando continuiamo ad esprimerci nel suo linguaggio. Perciò Heidegger chiama a una «mutazione del Dire», a una «muta nella relazione all’essenza della parola». Chiama al Dire che è richiesto per la dimenticanza dell’Essere. Questo Dire capace, perché corrisponde all’essenza dell’Essere, di aprire al pensiero l’accesso di questa essenza, lo chiama il «Dire del pensiero», precisando che «questo dire non è l’espressione del pensiero, ma il pensiero stesso, il suo cammino e il suo canto» (p. 249; it. p. 164). Bisogna, conclude, fare la prova del Dire che è quello del Pensiero fedele. Bisogna «lavorare al cammino».
Come concludere? Ho parlato di un “dialogo” tra Junger e Heidegger a proposito del nichilismo, ma questo termine non è il più adatto. Heidegger e Junger partono sovente da premesse analoghe, ma giungono a conclusioni in parte opposte. Sono entrambi d’accordo per stimare che il nichilismo trovi nella tecnica moderna il suo più valido appoggio, ma non se ne fanno la stessa idea. Per Junger, la tecnica è innanzitutto di essenza “titanica”, mentre per Heidegger è della metafisica realizzata. Ju7nger vede nel nichilismo l’opposto dei valori del valore. Junger si limita a sapere se

l’uomo, nel suo rapporto col nichilismo, ha «oltrepassato la linea». Heidegger invita ad interrogarsi su che cosa significa “superamento”. In effetti, Heidegger si basa sull’opera di Junger per andare più lontano e più in profondità, per allargare l’orizzonte di riflessione, per invitare il pensiero a mutare. Junger proponeva ai «ribelli» un «ricorso al bosco». Heidegger invita a imboccare un sentiero che conduce alla schiarita, a questa «radura» in cui la verità (alèthéia), il non celamento, esce infine dalla dimenticanza, cioè da questo velamento millenario che ha governato la storia dell’Europa, e il cui compimento planetario gli ingiunge oggi di doverne pensare l’uscita.
Note----------------------------------------------------------------
1-Ernst Junger, «Uber die Linie». In Antaile Martin Heidegger zum 60. Geburtstag, Vittorio Klostermann, Frankfurt/M. 1950. pp. 245-283: Martin Heidegger. «Uber die Linie», in Arrnin Mohler (Hrsg.). Freundschaftliche Begegnungen. Festschrif tfur Ernst .Junger zum 60. Geburtstag. Vittorio Klostermann. Frankfurt/M. 1955. Il testo di Junger è stato ripubblicato separatamente. dallo stesso editore, in una versione leggermente ampliata: Uber die Linie, Vittorio Klostermann. Frankfurrt/M. 1950, 45 p. (ed. fr.: Sur /’homme et le temps. Essais. vol. 3: Le noeud gordien. Passage de la ligne. Rocher. Monaco 1958, trad. Henri Plard; 20 ed. ampliata con una introduzione di Junger e una prefazione di Julien Hervier: Passage de la ligne. Passeur-Cecopof, Nantes 1993; 3 ed. :Christian Bourgois. Paris 1997, 104 p.) Il testo di Heidegger è stato pure lui ripubblicato separatamente senza modifiche, ma con un nuovo titolo: Zur Seinsfrage. Vittorio Klostermann. Frankfurt/M. 1956 (ed. fr.: «Contribution à la question de l’Etre». in Martin Heidegger. Questions I, Gallimard, Paris 1968, pp. 195-252, trad. Gérard Granel). In Italia i due testi sono stati riuniti in uno stesso volume: Ernst Junger e Martin Heidegger, Oltre la linea, Adelphi. Milano 1989. trad. di Franco Volpi e Alvise La Rocca. Il riferimento alle pagine qui citate è quello delle ultime edizioni francesi. N d T.: Ove possibile (le traduzioni francese e italiana non sempre corrispondono e le introduzioni non sono le stesse) èstato indicato anche il riferimento alle versione italiana.
2- In seguito Junger ha parzialmente rivisto questo ottimismo: «Dopo la disfatta, dicevo sostanzialmente: la testa del serpente ha già superato la linea del nichilismo, ne è uscita, e la seguirà ben presto il corpo intero, e entreremo ben presto in un clima spirituale migliore, ecc. In effetti ne siamo lontani» (intervista con Frédéric Towarnicki, in Martin Heidegger, L’Herne. Paris 1983, p. 149). Più fondamentalmente, Junger pensa che siamo in un’epoca di transizione —un interregno — e che questa sia la ragione per cui non bisogna disperarsi: «Da parte mia, presagisco che il XXI secolo sarà migliore del XX» (Entretien avec Julien Hervier, Gallimard, Paris 1986. p. 156).
3- In effetti, anche nei confronti di questo carattere “titanico” della tecnca. Junger resta ambiguo. Da un lato oppone volentieri i titani agli dei, e si inquieta del progresso del titanismo (l’«afflusso di energia»). Ma scrive anche: «Si avrebbe tendenza a temere che i titani non possano recare che sfortuna, ma Holderlin stesso non è di questo parere. Prometeo è il messaggero degli dei e l’amico degli uomini; in Esiodo l’età dei titani corrisponde all’età dell’oro”. (introduzione, p. 26). Il XXI secolo, secondo lui, vedrà allo stesso tempo uno sviluppo senza precedenti della tecnica e una nuova “spiritualizzazione”.






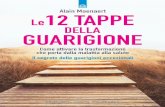
![english.mart.trento.itenglish.mart.trento.it/UploadDocs/1470_Inventario_ANS.doc · Web viewMittenti: [Vincenzo] Accame, Alain Arias-Misson (4) (più 2 minute di risposta di Paolo](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/5e36336219313b27bf314c72/web-view-mittenti-vincenzo-accame-alain-arias-misson-4-pi-2-minute-di-risposta.jpg)



![[E-Book - ITA] Alain de Benoist - L'Operaio Fra Gli Dei e i Titani](https://static.fdocumenti.com/doc/165x107/577ccf131a28ab9e788ed143/e-book-ita-alain-de-benoist-loperaio-fra-gli-dei-e-i-titani.jpg)