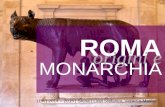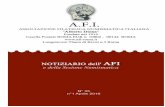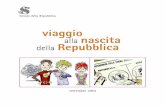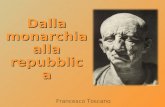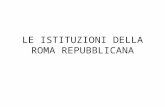2 GIUGNO 1946 – LA REPUBBLICA (DALLA MONARCHIA ALLA ... · (DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA) ......
Transcript of 2 GIUGNO 1946 – LA REPUBBLICA (DALLA MONARCHIA ALLA ... · (DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA) ......
2 GIUGNO 1946 – LA REPUBBLICA
(DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA)
Il 2 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati alle urne per
decidere sulla forma di Stato da dare alla nostra nazione dopo la
disastrosa guerra che tanti lutti e distruzioni aveva causato in
tutto il territorio nazionale.
Definire storica quella data è il minimo che si possa fare in
quanto costituì uno dei momenti più importanti della nostra
storia.
Cambiò radicalmente la forma di stato, da Monarchia a
Repubblica, non a seguito di una rivoluzione o di fatti di sangue,
ma per volere del popolo italiano, a seguito di un referendum, cui
parteciparono anche le donne, alle quali per la prima volta nella
storia d’Italia, fu concesso l’esercizio del voto.
Furono giorni di grande euforia, ma anche di grandi tensioni,
soprattutto per alcune contestazioni che riguardavano il conteggio
dei voti - si parlò di imbrogli - ed il quorum per assegnare la
vittoria - maggioranza dei voti validi o sul numero dei votanti?
Vediamo allora che cosa successe.
Seguirò questa traccia.
SOMMARIO :
1. PRINCIPALI AVVENIMENTI CHE HANNO PRECEDUTO
IL 2 GIUGNO 1946.
2. REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 1946.
3. PROIEZIONE FILMATO “Dalla Monarchia alla Repubblica”.
INTERVALLO
4. CAMBIAMENTO DEI SIMBOLI.
5. STESURA DELLA CARTA COSTITUZIONALE
6. TRATTATO di PACE.
7. VIAGGIO di DE GASPERI NEGLI STATI UNITI
D’AMERICA NEL 1947
8. PIANO MARSHALL (1947)
9. ELEZIONI POLITICHE DEL 18 APRILE 1948.
10. DAL 18 APRILE 1948 AI GIORNI NOSTRI.
PRINCIPALI AVVENIMENTI
CHE HANNO PRECEDUTO IL 2 GIUGNO 1946.
Vediamo quali sono stati i principali avvenimenti che hanno
preceduto quel 2 giugno del 1946.
Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcarono in Sicilia (ricordo che
eravamo in guerra dal 10 giugno del 1940).
Il 25 luglio, 15 giorni dopo, il Gran Consiglio del fascismo aveva
sfiduciato Mussolini, Capo del Governo, il quale, recandosi il
giorno dopo dal Re per riferire su quanto accaduto, venne
arrestato e condotto in località segrete.
Il Re dette l’incarico al Maresciallo Badoglio di formare un nuovo
governo, cosa che avvenne in pochi giorni.
I primi di settembre gli alleati sbarcano in Calabria e proseguono
l’avanzata verso nord, mentre i tedeschi occupano il centro nord.
L’otto set., come detto, Il neo governo italiano ottiene dagli alleati
un Armistizio e subito dopo anche l’autorizzazione a formare un
nuovo Esercito per combattere al loro fianco. ( le Forze Armate
italiane, sempre più numerose, prendono parte alla guerra di
liberazione assieme agli alleati ed ai partigiani che fanno sentire il
loro peso principalmente al Nord).
Il 9 set. il Re ed il Governo lasciano Roma e si trasferiscono in
territorio già liberato, a Brindisi.
Lo stesso giorno gli alleati sbarcano a Salerno, mentre il 12 viene
liberato Mussolini, il quale fonda, al nord, la Repubblica Sociale
Italiana che, ovviamente, combatte a fianco dei tedeschi.
L’avanzata degli alleati non ha sosta, Napoli si ribella a fine
settembre ed il sud, a fine anno, è quasi tutto liberato fino
all’altezza di Cassino, dove una potente linea difensiva dei
tedeschi li blocca.
Iniziano anche le azioni dei partigiani al centro nord.
Superata la resistenza a Cassino nella primavera del 1944, il 4
giugno del 44 viene liberata Roma, nel mese di agosto Firenze ed
a novembre vi è ancora una volta una sosta sulla linea che va da
Viareggio a Rimini, la famosa linea Gotica.
A febbraio del 45 riprendono le operazioni che portano alla
liberazione dell’Italia il 25 aprile, alla morte di Mussolini ed al
suicidio di Hitler.
E’ evidente che dopo quattro anni di guerra l’Italia è piena di
macerie, la popolazione ridotta alla fame, le famiglie in grave crisi
economica e, soprattutto, affettiva per la perdita di parenti, amici
ecc.
Teniamo conto che ci sono molti dispersi ed i prigionieri debbono
ancora tornare in patria.
Vediamo adesso quali sono gli avvenimenti più significativi dal
punto di vista politico..
Il giorno dopo l’Armistizio ( ricordo l’8 set. del 43) nasce
ufficialmente il CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, organo
politico, di cui fanno parte i capi della maggior parte dei partiti
politici estromessi da Mussolini dalla vita politica italiana
durante tutto il periodo della dittatura.
I principali attori in questa formazione sono i partiti della sinistra,
principalmente socialisti e comunisti , i democristiani, i liberali, i
repubblicani ed altre formazioni minori.
A gennaio del 44 si riuniscono a Bari un centinaio tra le più alte
personalità italiane del mondo culturale e politico per individuare
le linee essenziali che lo sviluppo della politica deve avere in
Italia. Il primo obbiettivo è la nuova forma di stato che l’Italia deve
assumere, attraverso un referendum.
Repubblica fu l’unanime verdetto, la cui carta fondamentale
doveva essere scritta da un’Assemblea Costituente da eleggere a
suffragio universale nello stesso giorno del Referendum.
Nell’aprile dello stesso anno il governo si trasferì a Salerno e qui si
ebbe una riunione importante del CLN, dove si stabilì, su
proposta di Togliatti, che alla forma di Stato si sarebbe pensato
dopo la liberazione dell’Italia, liberazione che in quel momento era
considerata prioritaria su qualsiasi altra azione.
Si fece anche un accordo con la corona (il Re era stato più volte
consigliato di abdicare, ma non ne aveva voluto sapere,
nonostante fosse quanto mai compromesso con il fascismo, sia
per aver dato l’incarico a Mussolini dopo la marcia su Roma nel
22 e sia per non aver fatto nulla per evitare la guerra).
Si arrivò al solito compromesso all’italiana.
Il Re avrebbe ceduto al figlio Umberto i vari poteri, ma non la
corona. Venne così trovata la formula della Luogotenenza. Tale
passaggio di poteri sarebbe avvenuto, come infatti avvenne, al
momento della liberazione di Roma, 4 giugno 1944.
Subito dopo quella data cambiò anche il governo.
Si ebbe il governo Bonomi, formato dai principali partiti che in
quel momento erano presenti nel CLN, Cioè socialisti, comunisti e
democristiani.
Subito dopo la liberazione dell’Italia la guida del governo viene
affidata a Parri che la tenne fino a novembre dello stesso anno
(1945) .
Da quel momento e per sette anni, i vari governi che si
susseguirono furono guidati da Alcide De Gasperi.
Il potere del governo si va sempre più rafforzando dopo la
liberazione di Roma e la questione istituzionale assurge a
problema fondamentale della Nazione subito dopo il 25 aprile del
1945, cioè subito dopo la liberazione dell’Italia.
Naturalmente anche i vari partiti intensificarono la loro azione nel
paese.
Come obbiettivo non vi era soltanto la scelta tra Repubblica e
Monarchia, ma anche la rappresentanza presso l’Assemblea
Costituente e, dopo la nascita della Repubblica, traguardo che si
dava per certo, l’ascesa al potere.
Furono soprattutto i partiti socialista e comunista, assieme ai
sindacati, ad assumere un ruolo sempre più importante nella vita
del paese a cominciare dalla potente spinta che davano al governo
per definire al più presto possibile la data del referendum.
Non mancarono gli scioperi, mentre la ricostruzione cominciava
in modo consistente , ma caotico, la borsa nera prendeva sempre
più piede.
Insomma la situazione esigeva che si definissero al più presto gli
elementi fondamentali dello Stato per dare ai cittadini sicuri punti
di riferimento e, soprattutto, la certezza di un ritorno alla legalità.
Dopo diverse contestazioni da parte della Corona e dei
Monarchici, che ritenevano non giusta una consultazione
elettorale mentre molti italiani erano ancora fuori dalla Nazione
perché prigionieri e parte dell’Alto Adige e del Friuli non votavono
perché non era ancora stato ben definita la posizione giuridica di
quelle zone dagli alleati, il governo sottopose al Luogotenente, che
a malincuore lo firmò, un decreto nel quale erano convocate, il 2
giugno 1946, le elezioni per il referendum istituzionale e per
l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente.
Con lo stesso decreto furono definiti i rapporti tra governo ed
Assemblea Costituente. Fu stabilito che : durante il periodo della
costituente e fino alla convocazione del parlamento a norma della
nuova costituzione, il potere legislativo resta delegato al governo,
ad eccezione di alcune importanti e specifiche leggi come quelle
costituzionali, quelle relative alle consultazioni elettorali ed
all’approvazione di trattati internazionali che invece, spettano
all’Assemblea Costituente.
Sembrava che tutto cominciasse a filare liscio. Ma non fu così.
Il 9 maggio il Re Vittorio Emanuele III abdicò in favore di Umberto
II e lasciò l’Italia, trasferendosi in Egitto.
Questo gesto che portava al trono Umberto II, persona garbata,
rispettosa delle Istituzioni, senza pesanti responsabilità nei
riguardi del fascismo e della guerra, fece rinascere le speranze dei
monarchici, mentre nei partiti a spiccato indirizzo repubblicano
cominciarono a sorgere dubbi sulla vittoria finale, ritenuta certa
fino a quel momento.
Furono, pertanto, intensificati i comizi, gli incontri dei leaders con
la base. La propaganda fu accentuata anche a mezzo stampa
(tutti i giornali che “tifavano” per la Repubblica furono mobilitati
con in testa il Corriere della Sera).
Per far fronte ad eventuali colpi di mano dei monarchici, il
Ministro degli Interni, il socialista Romita, fervente repubblicano,
fece adottare numerose misure cautelative, tra cui quella di
“fortificare” il Viminale ( è la sede del Ministero degli Interni).
Il “Vento del Nord”, così era stato definito il grande movimento dei
partiti che propugnavano la Repubblica, cominciò a spirare
ancora più forte.
Ma anche il Re ed i suoi seguaci non stettero con le mani in
mano.
Il Sovrano cominciò a girare per tutte le grandi città, specialmente
al sud, dove ricevette calorose accoglienze.
Distribuì onorificenze ai combattenti ed ai civili che si erano
distinti durante la guerra. Concesse persino numerosi titoli
nobiliari.
Per lui spirava il “vento del sud”.
Fra gli atti più significativi dal punto di vista Istituzionale, oltre a
quelli relativi alle elezioni, che il Sovrano compì durante il suo
Regno vi fu la promulgazione , il 15 maggio, dello Statuto che rese
autonoma la Sicilia.
Tale Statuto, fatto redigere da un’apposita commissione, fu
concesso per evitare la secessione dell’Isola per opera dei
movimenti separatisti, organizzatisi in partiti politici, che
tanta importanza assunsero, a partire dal luglio del 43 nell’isola.
Insomma, la situazione generale in tutta l’Italia, per i vari motivi
di cui si è parlato in precedenza, non era affatto tranquilla; vi era
una notevole tensione latente, ma alla fine, tutto sommato, le
elezioni si svolsero in un clima abbastanza sereno.
Adesso vediamo il filmato, che in un certo qual modo ripercorre
gli avvenimenti che ho appena descritto. Vi è il grande vantaggio
che vedrete molte personalità che in quel periodo ebbero un
notevole peso nella scrittura della nostra storia.
PROIEZIONE FILMATO “Dalla Monarchia alla Repubblica”.
Prima di proseguire desidero evidenziare un aspetto che nel
filmato viene un po’ trascurato e che ritengo di notevole
importanza.
Alle 18 del 10 giugno 1946 il Presidente della Corte di Cassazione,
cui spettava la proclamazione del risultato delle elezioni, si limitò
a dare solamente il totale dei voti, per la Repubblica circa 12
milioni e per la Monarchia circa 10 milioni. Ma non proclamò la
Repubblica.
Disse che vi erano delle contestazioni e, pertanto, avrebbe dato il
verdetto definitivo il 18 giugno. Bel Pasticcio, perchè si entra in
un periodo di assoluta mancanza di poteri.
La Monarchia non esisteva più per volere degli italiani, ma la
Repubblica non era stata proclamata. Quale Bandiera innalzare
sul Quirinale?
Ma De Gasperi, capo del governo, insisteva presso il Re affinché
gli cedesse i poteri e lasciasse l’Italia. Ma il Re, freddo , ma
cortese, rispondeva che era necessario attendere le decisioni finali
della Corte di Cassazione.
Intanto la sinistra, specialmente quella più radicale, cominciava a
mobilitarsi, il paese era irrequieto, si temevano tumulti. E questa
situazione preoccupava non poco il Governo, che continuava ad
insistere perché il Re lasciasse l’Italia. Si trattava, ma non si
perveniva ad una soluzione concordata.
La tensione cominciò a salire. I rapporti tra il governo e la casa
Savoia si deteriorarono sempre più.
La sera dell’11 vi fu un consiglio dei Ministri molto agitato.
Ma ancora una volta De Gasperi riuscì a calmare le acque, acque
che però si agitarono, e di molto, il giorno dopo, il 12.
Napoli era in rivolta, scatenata a favore del Re. Sembra che la
rivolta sia partita da una protesta verso la sede comunista che
aveva esposto una bandiera rossa con a fianco il Tricolore con
una donna turrita al posto dello scudo Sabaudo. Ci furono anche
dei morti. Fu affisso un manifesto in cui si inneggiava alla
Monarchia ed a Masaniello e nel pomeriggio fu assaltata una delle
sedi del partito comunista. Fu un giorno terribilmente tragico.
Mentre a Napoli erano sorte le barricate, il Ministro della Real
Casa, Falcone Lucifero, consegnava, alle ore 13, a De Gasperi, un
messaggio del Re il quale si diceva pronto ad accettare il responso
popolare, ma dopo che la Cassazione ne avesse ufficialmente
proclamato il risultato.
A questo punto viene indetto, la sera, un nuovo consiglio dei
Ministri, che, alla fine, sancisce che i poteri di Capo dello Stato
non sono più del Re, che praticamente adesso è un semplice
cittadino, ma del Presidente del Consiglio.
Questa decisione viene comunicata al Re la mattina del 13,
mentre si trovava a casa di conoscenti dove aveva trascorso la
notte.
Quella notte molti uomini politici e funzionari dello stato non
dormirono a casa loro, soffiavano venti di golpe sia da parte dei
monarchici, sia da parte degli estremisti di sinistra.
A questo punto i consiglieri del Re elaborarono 4 ipotesi di
soluzioni:
- scontro aperto dichiarando decaduto il governo;
- aspettare il verdetto della Cassazione, in una situazione
Istituzionale ibrida;
- aspettare il verdetto della Cassazione con un proclama al
paese nel quale si mettesse in evidenza “l’arbitrio e
l’usurpazione del governo” ;
- partenza del Re senza abdicazione e senza passaggio di poteri,
proclama al paese , come nell’ipotesi precedente, e rifiuto di
considerare legittimamente e genuinamente risolta la
questione istituzionale.
Queste proposte vennero sottoposte al Monarca, il quale scelse la
quarta. Era la meno traumatica fra tutte quelle che gli avevano
proposto.
Questa soluzione, in fondo, si confaceva al carattere di questo
Savoia, uomo alieno da gesti di forza che avrebbero potuto
comportare ulteriore spargimento di sangue alla Nazione.
Si recò al Quirinale, stese il proclama, salutò tutti i suoi
collaboratori e la guardia ed alle 15 si recò all’aeroporto di
Ciampino da dove partì per l’esilio.
Lo spauracchio della guerra civile lentamente comincia
ad allontanarsi e gli animi si distendono.
De Gasperi fu visto, cosa mai accaduta in precedenza, con una
sigaretta in mano.
Ma non era ancora tutto finito.
La stessa sera del 13 l’agenzia giornalistica Ansa pubblica il
proclama del Re nel quale si afferma, tra l’altro, ………..che il
governo, in spregio alle leggi ed al potere indipendente e sovrano
della Magistratura- ricordo che la Cassazione non aveva ancora
proclamato la vittoria della Repubblica – ha compiuto un gesto
rivoluzionario, assumendo con atto unilaterale ed arbitrario,
poteri che non gli spettano e mi ha posto nell’alternativa di
provocare spargimento di sangue o di subire la violenza.
Umberto prosegue nel suo proclama dicendo che ha compiuto
questo gesto nel supremo interesse della Patria e conclude
sciogliendo dal giuramento
prestato tutti i componenti delle Forze Armate e rivolgendo un
deferente saluto ai caduti ed ai combattenti.
A questo proclama De Gasperi reagì indignato in quanto il
responso delle urne era stato chiaro, ma soprattutto, perché si
tendeva ancora una volta a dividere, piuttosto che a unire, gli
italiani.
Un commento in tal senso fu pubblicato sui vari giornali.
Come abbiamo visto, la Repubblica è nata, ma non fu affatto un
parto facile ed indolore. È importante, però, affermare che il Re
venne privato dei suoi poteri non da una guerra o da una
rivoluzione, ma da un responso popolare.
Gli avvenimenti che seguirono non furono pochi, mi soffermerò su
alcuni che considero fondamentali e precisamente:
- cambiamento dei simboli a cominciare dalla nostra Bandiera;
- nascita della Costituzione;
- trattato di pace, non dimentichiamo che da poco l’Italia aveva
perso la guerra;
- visita negli Stati Uniti d’America di De Gasperi;
- piano Marshall;
- votazioni politiche dell’aprile del 1948;
- trattato di pace,
- fatti salienti dal 1948.
CAMBIAMENTO DEI SIMBOLI
Esiliata la Monarchia, i primi cambiamenti avvennero nei simboli
della neonata Repubblica Italiana.
La nostra nuova Bandiera
Per prima cosa fu cambiata la nostra Bandiera, il simbolo dei
simboli. Naturalmente fu tolto lo stemma Sabaudo ed il suo posto
fu lasciato libero. Il tricolore, verde, bianco e rosso venne scelto
come simbolo della nostra Patria, l’Italia repubblicana.
Si pose però un problema per i marinai. Chi andava per mare
aveva sempre visto la nostra Bandiera con uno scudo al centro.
Inoltre, la nostra nuova
Bandiera era uguale a quella Messicana, con la quale si sarebbe
potuta confondere.
Si decise allora di stampare, sulla parte bianca, i quattro stemmi
delle quattro repubbliche marinare, che, come sapete, erano
Venezia, Genova, Pisa ed Amalfi.
Questa soluzione lasciava la nostra Bandiera, vista da lontano,
formalmente simile alla precedente, distinguendola sempre da
quella messicana, ma molto diversa nella sostanza.
Ecco perché sulle navi della nostra Marina Militare non vi è il
semplice Tricolore, ma quello con al centro gli stemmi della
quattro Repubbliche marinare.
Sulle navi mercantili e sulle barche da diporto, invece, lo stemma
al centro non ha la corona turrita ed il leone di San Marco al
posto della spada ha un libro aperto.
Il Tricolore , però, nel prosieguo della nostra storia, ha avuto degli
alti e bassi nella sensibilità degli italiani. Ma negli ultimi anni,
grazie ad un’azione decisa e sentita da parte del precedente
Presidente della Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, il Tricolore è
tornato di attualità nell’animo della maggior parte degli italiani e
molte famiglie lo tengono in casa, esponendolo nelle grandi
occasioni.
Non poco hanno contribuito a questa diffusione il ripristino della
Festa Della Repubblica il 2 giugno di ogni anno con la parata
militare ed i grandi successi che l’Italia ha riportato in molti
settori dello sport, non ultimo quello di aver conquistato la Coppa
del Mondo di calcio.
L’Inno di Mameli
Secondo simbolo cambiato fu l’Inno Nazionale. La Marcia reale
venne accantonata ed, inizialmente, nel 43, il governo Badoglio
elevò ad Inno Nazionale l’Inno del Piave. Ma l’Assemblea
Costituente, nel 46, non ebbe dubbi su quale dovesse essere
l’inno più idoneo a rappresentare gli italiani: “l’Inno di Mameli” o
“Fratelli d’Italia”, come lo vogliamo chiamare.
Ricordo che il titolo originario dei versi era “Il canto degli italiani”.
Questo fu un cambiamento radicale.
Quell’Inno, nato nel 1847, praticamente a Genova, quando fu
intonato da più di trentamila persone in occasione dei
festeggiamenti del centenario della cacciata degli austriaci dalla
città ligure, e cantato da tutti i patrioti durante le guerre del
nostro risorgimento ed in tutte le manifestazioni patriottiche,
diventava il simbolo di una nazione finalmente libera e
democratica, anche se non completa nei suoi confini.
Nelle successive vicende della nostra storia, perse però un po’ di
popolarità, come era avvenuto per il Tricolore.
Fortunatamente per noi, anche per l’Inno Nazionale, il precedente
Presidente della nostra Repubblica, Carlo Azelio Ciampi, ha
ridestato l’interesse degli italiani verso questo “Simbolo”, che
racchiude in sé l’essenza della storia moderna d’Italia e ci fa
sentire tutti fratelli.
Grazie a questa sensibilità del nostro Presidente, ad alcuni
avvenimenti che hanno visto protagonisti numerosi italiani nel
mondo ed ad un impegno nelle scuole si riscopre il nostro Inno
Nazionale e con esso si comincia ad usare la parola Patria,
sostituita da molti, spessissimo, dalle parole “Paese”, “Nazione”.
E’ stato il nostro Presidente CIAMPI a togliere la ruggine all’Inno
Nazionale , invitandoci a considerare “Fratelli d’Italia”, come
veramente lo aveva immaginato il suo autore, “Il canto degli
italiani”.
Formula del giuramento
Anche la formula del giuramento per tutte le categorie di persone
tenute, per il loro incarico, a prestare giuramento, cambiò
radicalmente.
Nell'anno 1848, proclamato da Carlo Alberto lo Statuto
costituzionale fondamentale del Regno, la formula del giuramento
era la seguente : "Io giuro di essere fedele a S.S. R M. ed ai suoi
Reali precessori, di osservare lealmente lo Statuto, le leggi dello
Stato e di adempiere a tutti li doveri che sono inerenti alla mia
qualità di militare col solo scopo del bene inseparabile del Re e
della Patria".
La formula del giuramento cambiò notevolmente con l’avvento
della Repubblica. Si giurava fedeltà, infatti, alla Repubblica
Italiana ed al suo Capo.
Cito a memoria “Giuro di essere fedele alla repubblica Italiana ed
al Suo Capo, di osservarne lealmente le leggi e di adempiere a
tutti i doveri del mio Stato al solo scopo del bene della Patria”
Da allora ha subito qualche variazione.
Ecco quella attuale: "Giuro di essere fedele alla Repubblica
italiana, di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con
disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della
Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni".
L’Emblema
Altro simbolo: l’emblema dell’Italia repubblicana.
Nel 46 venne indetto un concorso che, attraverso diverse fase, si
concluse solamente nel maggio del 48 quando, dopo
l’Approvazione dell’Assemblea Costituente nel gennaio dello
stesso anno ed alcuni , ulteriori piccoli ritocchi , l’allora
Presidente provvisorio della Repubblica
Enrico De Nicola firmò il decreto legislativo n. 535 con il quale
consegna all’Italia il suo emblema.
Esso è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata ed
i rami di ulivo e di quercia.
La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio
iconografico ed è sempre associata all’Italia.
La stella, poi, rappresenta per i militari, l’appartenenza alle Forze
Armate.
La ruota dentata d’acciaio, simbolo dell’attività lavorativa, ci
ricorda il primo articolo della nostra Costituzione “L’Italia è una
Repubblica democratica fondata sul lavoro”.
Il ramo d’ulivo simboleggia la volontà di pace e la quercia incarna
la forza e la dignità del nostro popolo.
Abbiamo poi il simbolo della testa di una “donna turrita” che fu
addirittura stampato, accanto allo stemma sabaudo, nella scheda
elettorale del referendum istituzionale.
Questo simbolo lo troviamo anche in alcune banconote ed in una
fortunata e longeva serie di francobolli.
Stesura della COSTITUZIONE
Lo Statuto Albertino, che dal 1848 aveva costituito la legge
fondamentale dello Stato era ancora formalmente in vigore, anche
se le leggi fasciste erano state abolite sin dal luglio del 1943. Negli
ultimi 23 anni si erano consumati un ventennio di dittatura
fascista ed una sconfitta militare tra le più sanguinose che
l’umanità ricordi. L’avvento della Repubblica cambiò il modo di
fare politica, cambiò il sistema istituzionale, cambiarono le
aspirazioni e le speranze degli italiani, ma si sviluppò anche una
guerra, sia pure non guerreggiata, per la conquista del potere i
cui artefici furono il partito comunista guidato da Togliatti da una
parte e la democrazia cristiana che aveva a capo De Gasperi,
dall’altra.
Definita con il referendum la forma di stato da adottare, si doveva
procedere adesso a porre le basi per la costruzione di un’Italia
diversa dalla precedente , in cui i valori della democrazia , della
libertà, della giustizia e della solidarietà, fossero posti alla base
della nuova società a cui la maggioranza degli italiani aspirava.
Per fare questo si era deciso di dar vita, eleggendola, ad
un’Assemblea Costituente.
Come ho accennato in precedenza le votazioni per eleggere questa
Assemblea avvennero contestualmente a quelle per il referendum,
il 2 giugno, parliamo sempre del 1946.
I Deputati da eleggere erano 556. Ecco il risultato. Democrazia
Cristiana 207, Partito Socialista 115, Partito Comunista 104,
Unione Democratica Nazionale 41, Uomo Qualunque 30, Partito
Repubblicano 23, Blocco
Nazionale della Libertà 16, Partito d’Azione 7. Il resto, 13
deputati, andò ad un nutrito numero di partiti minori, per la
precisione erano 8.
L’Assemblea si mise subito al lavoro.
Dopo la proclamazione ufficiale dei risultati della consultazione
elettorale da parte della Corte di Cassazione il 18 giugno, l’Italia
diventa ufficialmente una Repubblica per scelta del suo popolo.
Il 25 giugno vi fu l’inaugurazione dell’Assemblea e viene eletto il
presidente , nella persona di Saragat.
Il giorno 28 fu la volta del Presidente provvisorio della Repubblica
nella persona di Enrico de Nicola, grande giurista napoletano, il
quale, com’era suo costume non accettò subito, ma lo fece dopo la
tenace insistenza di alte personalità tra cui Benedetto Croce.
L’Assemblea era pronta ad operare e lo fece subito con la nomina
di diverse commissioni cui furono affidati specifici compiti, come
la stesura delle regole, chiamiamole così, di determinati settori.
La costituzione comincia a nascere e non pochi sono i contrasti.
Uno in particolare portò quasi allo scontro. La definizione dei
rapporti tra stato e chiesa.
I democristiani , con De Gasperi ( era il Capo del Governo ),
volevano si facesse riferimento ai Patti Lateranensi, a differenza
dei partiti della sinistra, che, invece, propugnavano un generico
riferimento alla libertà di religione. Alla fine fu accettata la
soluzione democristiana e fu votata anche dai comunisti, guidati
da Togliatti, per evitare scissioni nella Nazione per motivi religiosi.
(Togliatti, non voleva, inoltre, inimicarsi troppo la Chiesa).
Il termine dei lavori fu procrastinato per due volte ed alla fine fu
deciso dalla stessa Assemblea che la costituzione dovesse essere
definitivamente approvata entro la fine del 1947. Infatti
l’approvazione del testo definitivo si ebbe il 22 dicembre del 1947,
fu promulgata il giorno 27 dal Presidente provvisorio della
Repubblica de Nicola ed entrò in vigore il primo gennaio del 1948.
L’Italia aveva la sua legge fondamentale.
Era costituita da 139 articoli, dei quali i primi 12 riguardano i
principi fondamentali.
Negli Art. dal 13° al 47° sono indicati i diritti ed i doveri dei
cittadini, mentre nei rimanenti Articoli è indicato l’ordinamento
della Repubblica nelle sue diverse articolazioni, Parlamento ,
Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni, ecc..
L’impianto della Costituzione, per quanto riguarda la
governabilità del paese , a parere di molti illustri giuristi, non fu
dei migliori in quanto si privilegiarono i poteri del parlamento
rispetto a quelli del governo ed ai parlamentari si dette la facoltà
di espletare il proprio compito senza limiti di mandato. In ultima
analisi la nostra è una Repubblica parlamentare. Il parlamento è
sovrano.
Tutto ciò significava che il parlamentare può cambiare “Bandiera”
spostando le varie forze in parlamento e, quindi, la possibilità
di far cadere il governo che, per governare, deve avere la fiducia
del parlamento.
Questa impostazione ha prodotto parecchi disastri, in quanto fino
al 2001 l’Italia ha avuto, in media, un governo ogni anno o poco
più.
La maggior parte degli Articoli furono approvati con larga
maggioranza, ma il loro contenuto è il frutto, spesso, di
compromessi.
Infatti, la Costituzione Italiana nasce dalla confluenza dei diversi
valori di cui sono portatori i vari partiti.
All’idea democratica che li unisce tutti si aggiungono i valori
dell’antica tradizione liberale italiana, quelli propri del socialismo
dei partiti della sinistra ed infine quelli della dottrina sociale della
Chiesa a cui si ispirava la democrazia cristiana.
Ciò nonostante l’impianto della nostra Costituzione è da
considerare di altissimo valore giuridico, sociale e politico e fissa
una serie di principi in cui tutti, a qualsiasi parte politica
appartengono, si possono riconoscere.
Inoltre, i costituenti, in un certo qual modo, conferirono una certa
rigidità alla Costituzione, che può essere modificata solamente
con un apposito procedimento parlamentare, molto più lungo e
complesso rispetto a quello riguardante le normali leggi.
Entrata in vigore la Costituzione l’Assemblea Costituente
procedette alla convocazione della consultazione elettorale politica
e scelse come data il 18 aprile.
Ebbe inizio una campagna elettorale fra le più accese in quanto
era in gioco il futuro dell’Italia.
A fianco della Russia, come propugnavano i partiti di sinistra con
in testa i comunisti, od a fianco degli Stati Uniti d’America come
invece volevano i partiti del centro e della destra, primo fra tutti il
partito della Democrazia Cristiana?
E’ vero che le grandi potenze avevano deciso che l’Italia rimanesse
nel campo occidentale, ma è altrettanto vero che se il popolo
italiano avesse scelto, a seguito di libere elezioni, di essere
governata dai comunisti e, quindi, di entrare nella sfera
d’influenza dell’Unione Sovietica, con moltissime probabilità, io
dico sicuramente, gli Stati Uniti non avrebbero contrastato questa
volontà popolare con la forza.
Il risultato è noto a tutti. Non sto ad esaminare quali furono i
fattori principali che fecero pendere la bilancia da parte dei
democristiani.
Certamente un ruolo decisivo lo ebbe, a mio parere, , la cultura
liberale e cattolica del nostro popolo.
Infine,l’11 maggio, seguendo i canoni stabiliti dalla nuova e fresca
Costituzione, venne eletto il nuovo Presidente della Repubblica,
Presidente e non Presidente Provvisorio, nella persona di Luigi
Einaudi.
Si conclude in tal modo un grande e faticoso processo
democratico che collocò l’Italia, in tal modo, dopo anni di
dittatura, tra le grandi democrazie del mondo.
TRATTATO di PACE
Il trattato di pace tra l’Italia e le potenze vincitrici della 2^ guerra
mondiale ha un nome assolutamente fuori luogo. L’Italia non
trattò, ma subì le condizioni che le vennero imposte.
Tra le tante cose che il Governo, retto da De Gasperi, doveva
affrontare, in un momento delicatissimo della nostra storia, vi
furono anche le preoccupazioni per addivenire ad un trattato di
pace il più possibile “leggero” per la nostra Nazione e per il nostro
popolo.
Gli sforzi fatti dal Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi
furono notevoli, soprattutto per limitare i danni nel settore della
Venezia Giulia.
Ma alla fine gli alleati, soprattutto per la feroce spinta della
Russia, che voleva l’annessione di Trieste alla Jugoslavia, su
proposta della Francia, decisero per la costituzione di un
territorio libero di Trieste, sotto la giurisdizione dei vincitori.
Memorabile fu il discorso che tenne il 10 agosto del 1946 alla
conferenza della pace di Parigi il nostro Presidente del Consiglio
Alcide De Gasperi.
Fu un discorso dignitoso, ma nello stesso tempo denunciava le
contraddizioni dei vincitori che in un primo momento avevano
affermato che nella definizione dei confini degli stati sconfitti si
sarebbe tenuto conto della maggioranza etnica della popolazione
residente.
Così non era stato per le popolazioni della Venezia Giulia.
Il discorso di De Gasperi fu apprezzato dalle potenze occidentali,
mentre dura fu la reazione dei Russi.
Il delegato Russo Viscinski, per confutare le tesi sostenute da De
Gasperi, pronunciò un discorso violento ed insultante.
Disse tra l’altro:
”…………non è vero che Trieste sia italiana. Trieste è stata fondata
dagli slavi,…………………….Non è vero che l’Esercito italiano ha
abbattuto l’impero Austro-Ungarico. Esso fu vinto dai russi nel
1916…………….”.
E concluse con questa frase quanto mai offensiva:
“tutti sanno che gli italiani sono molto più bravi a scappare che a
combattere”.
Il Governo Italiano pretese il testo ufficiale del discorso del
delegato russo, ma quando lo ebbe questa frase non c’era più.
Ci siamo dovuti assoggettare alla perdita della Venezia Giulia, ma
anche a quella di Trieste e non solo.
L’Italia, Inoltre, perse, oltre alle colonie, qualcosa anche ad ovest
a favore della Francia, mentre riuscì a tenere l’Alto Adige
promettendo una forte autonomia alle popolazione di quella
regione. Infine, ci furono imposti limitazioni nella formazione delle
nostre Forze Armate, ed il pagamento di tributi ai vincitori
sottoforma di risarcimenti ecc..
Quando il trattato venne portato all’Assemblea Costituente, cui
spettava la ratifica, aspra fu la reazione di tutti i parlamentari ed
accesa la discussione, soprattutto per la mancata assegnazione di
Trieste all’Italia.
Alla fine il comunista Togliatti, dopo aver avuto un incontro con
Tito, Capo degli slavi, propose di cedere Gorizia per avere Trieste.
Togliatti fu salutato dai partiti della sinistra come il risolutore
dell’importante problema, da alcuni addirittura come il salvatore
della Patria.
Ma la reazione di tutte le forze politiche non di sinistra fu
violenta. Niente baratti, soprattutto con la cessione
dell’italianissima Gorizia.
Così l’Assemblea rigettò a larga maggioranza la proposta di
Togliatti.
Se si fosse accettata questa soluzione oggi avremmo Trieste, ma
non Gorizia. Le abbiamo, invece, tutte e due.
Alla fine, con le necessarie riserve si accettarono le condizioni
poste all’Italia, condizioni che successivamente saranno riviste.
Prima fra Tutte quella riguardante Trieste che nel 1954
ritorna, come doveva essere sin dall’inizio, pienamente italiana.
Prima di chiudere questo periodo ,cioè quello che va dal 46 al 48
desidero accennare a due altri importanti avvenimenti.
La visita di De Gasperi negli Stati Uniti d’America ed il piano
Marshall, elaborato da questa Nazione.
VIAGGIO di DE GASPERI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA
Ricordo che siamo in un periodo storico dell’Italia, ma soprattutto
dell’Europa, molto ma molto delicato.
Bisogna fare la più importante delle scelte: Unione sovietica e,
quindi, oriente, oppure Stati Uniti d’America e, pertanto,
occidente.
Il Capo del Governo De Gasperi, espressione della Democrazia
Cristiana, propendeva per l’occidente, mentre Togliatti ed un po’
meno i socialisti, vedevano nel comunismo affermatosi
nell’Unione Sovietica, con una rivoluzione e non con una
consultazione elettorale come è avvenuto per la scelta della forma
istituzionale in Italia, la panacea di tutti i mali del mondo.
Questa contrapposizione, naturalmente, vede una certa spinta
delle due citate nazioni nei confronti del popolo italiano.
Come più volte è stato detto, la situazione economica dell’Italia e
degli italiani era veramente critica. Il nostro territorio, nei suoi
elementi basilari come fabbriche, ferrovie, strade, abitazioni,ecc. ,
era disastrato.
Politicamente, venendo da un ventennio di dittatura e da una
guerra perduta l’Italia non aveva amici ed era sempre guardata
con sospetto.
Bisognava trovare risorse per la ricostruzione, occorreva rompere
l’isolamento politico; insomma, bisognava muoversi, specialmente
in direzione di quelle nazioni democratiche, come gli Stati Uniti
d’America, nel cui territorio vivevano un consistente numero di
italiani emigrati agli inizi del secolo, che avevano dimostrato un
certo interesse per il nostro Paese.
L’occasione per un contatto ufficiale tra il governo italiano e
quello americano venne data da un invito fatto a De Gasperi dalla
rivista “TIME” a prendere parte a Cleveland ad un convegno dal
titolo “Cosa si attende il mondo dagli Stati Uniti”.
Si discusse a lungo dell’opportunità di accettare o meno l’invito.
Ogni dubbio, però, fu fugato dall’invito ufficiale che il governo
americano fece al nostro Capo del Governo.
Ai primi di gennaio del 1947 De Gasperi si recò negli Stati Uniti e,
dopo un’accoglienza tiepida e quasi indifferente da parte delle
Autorità di quel paese, la figura dello statista italiano si va
sempre più affermando per le idee che esprime, per la fermezza
con cui le esprime e per la forte personalità che evidenzia in ogni
circostanza. Inizia il discorso al convegno dicendo che a Londra
era stato accolto come nemico, a Parigi come belligerante, a
Washington ed a Chicago, invece, era stato trattato come amico.
Alla fine, quando De Gasperi ebbe l’onore di sfilare per la via
principale di New York, il popolo americano accolse con calore e
simpatia.
La nostra Bandiera fu scortata da un drappello di quaranta
guardie a cavallo in uniforme.
Si ebbe così una sorta di solenne riconciliazione tra le due
Nazioni, ma soprattutto tra i due popoli.
De Gasperi acquistò prestigio internazionale e, facendosi
interprete dei bisogni degli italiani, chiese ed ottenne aiuti,
soprattutto in danaro, poi puntualmente restituiti.
Ritornato in Patria De Gasperi, dovette constatare che la
situazione sociale si era notevolmente “incattivita”.
Vi furono diversi scioperi, scontri con le forze dell’ordine, durante
i quali si contarono non solo feriti, ma anche dei morti.
Inoltre la situazione politica aveva visto la scissione del Partito
Socialista.
Non mi dilungo su questo argomento.
Dico soltanto che De Gasperi si dimise e, dopo travagliati contatti
con tutti i partiti, decise di dar vita ad un governo monocolore
democristiano, quindi senza comunisti e socialisti. Di questo
governo, che ebbe la fiducia dell’Assemblea Costituente nel
giugno del 47, facevano parte, oltre agli uomini politici
democristiani, due liberali , tra cui Einaudi e quattro indipendenti
e tra questi vi era Merzagora.
Risolto il problema governo, l’Italia comincia a crescere, sia pure
in mezzo a tante difficoltà.
Una grossa mano la dà anche il PIANO MARSHALL.
Piano Marshall
Gli Stati Uniti d’America si rendono conto che la loro potenza
economica, che era notevole, si era moltiplicata nei confronti
dell’Europa, impoverita dalla lunga e disastrosa guerra.
Inoltre, desiderano arginare l’espansionismo dell’Unione
Sovietica, che, non solo sta cercando di imporre la propria volontà
a quei paesi già destinati alla sua influenza dagli accordi di Yalta,
come l’Ungheria, la Polonia, la Jugoslavia, la Romania, la
Cecoslovacchia, ecc., ma sta tentando di portare al potere, sia
pure in modo democratico, il partito comunista in Italia ed anche
in Francia.
Nel mese di giugno del 47, ricordo che siamo nel periodo in cui De
Gasperi vara un governo monocolore, cioè senza comunisti e
socialisti, il Gen. Marshall annuncia che gli Stati uniti d’America
hanno messo a disposizione dell’Europa, e quindi anche dei paesi
dell’est, 22 miliardi di dollari in quattro anni, naturalmente a
certe condizioni. Era, allora, una grande cifra. Ciò anche allo
scopo di dare organicità agli aiuti che finora avevano elargito a
pioggia ad alcune nazione come l’Italia e nello stesso
tempo cercare di rompere l’egemonia sovietica nell’est europeo.
Inghilterra e Francia aderirono subito e organizzarono un
convegno a Parigi allo scopo di definire l’atteggiamento dei paesi
comunisti.
Durante la conferenza il delegato dell’Unione Sovietica attaccò
piuttosto duramente gli Stati Uniti affermando che tutti i paesi
che avrebbero accettato, sicuramente avrebbero dovuto dare una
contropartita e, quindi, avrebbero perso parte della loro
indipendenza.
Questa linea d’azione fu chiara anche per i paesi satelliti che si
adeguarono, rinunciando a malincuore a questi aiuti.
Tuttavia anche l’Italia non era del tutto convinta.
La svolta si ebbe quando i paesi occidentali capirono quali erano
veramente le intenzioni dell’Unione Sovietica, nei paesi occupati
dall’armata rossa.
I dirigenti comunisti si impadronivano di tutte le leve del potere,
cancellando ogni opposizione interna. In poche parole tutte le
nazioni dell’Est europeo furono assoggettati ai voleri di Mosca.
Questa nuova “mappa” europea che si stava definendo in modo
da determinare due blocchi, comunisti da una parte e democrazie
dall’altra, unitamente al fatto che la situazione economica e
sociale dell’Italia era quanto mai critica, spinsero il governo
italiano ad accettare gli aiuti.
L’Italia accetta, quindi, il Piano Marshall e comincia a disporre di
nuove risorse che le consentono di accelerare la ricostruzione,
specialmente per quanto riguarda le opere pubbliche.
Preciso che molti di queste elargizioni erano a fondo perduto.
Esistevano però alcune clausole che prevedevano, tra
l’altro, l’acquisto di materie prime, di macchinari e di tecnologie
dagli Stati Uniti.
Gli aiuti durarono fino al 1951 ed in totale assommarono a circa
1,5 miliardi di dollari.
Avvenimenti salienti dal 1948
Mi limito proprio ad enunciarli, altrimenti occorrerebbe un giorno
intero.
Insediatosi il governo De Gasperi ed eletto il Presidente della
Repubblica nella persona di Einaudi, sembrava che si fossero
poste le basi per la soluzione dei numerosissimi problemi che
affliggevano la nostra Nazione a partire dalle condizioni piuttosto
precarie della maggior parte della nostra popolazione.
Ma così non fu.
Il 14 luglio un giovane siciliano attentò alla vita di Togliatti
sparandogli quattro colpi, di cui tre andarono a segno, ma non in
modo mortale.
Tutte le sinistre scesero in piazza, a volte anche in modo violento.
Si sfiorò la guerra civile. Alla fine la moderazione ebbe il
sopravvento, anche per volere dello stesso Togliatti, che non era
affatto convinto della riuscita di una insurrezione, ancorché
proveniente dal basso.
Nell’aprile del 49 l’Italia entra a far parte del Patto Atlantico cui
aderiscono la maggior parte delle democrazie occidentali e che
prevede, tra l’altro, l’impegno della difesa comune nel caso uno
stato membro venisse attaccato.
Nell’aprile del 51 nasce a Parigi la Ceca, Comunità Europea del
carbone e dell’acciaio. Mercato comune del carbone e dell’acciaio.
Le nazioni aderenti sono, oltre all’Italia, la Francia, la Germania
Occidentale, il Belgio, il Lussemburgo ed i Pesi Bassi. Il trattato
entra in vigore nel luglio del 52.
Nell’ottobre del 1954 Trieste ritorna all’Italia, dopo una serie di
manifestazioni in tutto il paese.
La guerra si allontana sempre più, l’Italia cresce non solo
economicamente ed industrialmente, ma anche dal punto di vista
politico e nel dicembre del 1955 viene ammessa alle Nazioni
Unite, l’organizzazione comunemente indicata con la sigla ONU e
che comprende la maggior parte degli stati della terra.
Contemporaneamente grandi contatti vengono presi tra le
maggiori nazioni europee per un accordo commerciale. Nascono
così a Roma nel marzo del 1957 la Comunità Europea
dell’Energia Atomica (EURATOM) e la Comunità Economica
Europea, comunemente chiamata con la sigla CEE. Le nazioni
firmatarie furono le stesse del trattato Ceca. Il trattato CEE si
prefigge lo scopo di conseguire, nei successivi 12 anni, come
infatti avvenne, la libera circolazione, nei paesi firmatari, delle
persone, delle merci, dei servizi e dei capitali. Questa CEE cresce
sempre più ed oggi comprende ben 25 Nazioni ed altre si
apprestano a farne parte.
Nel luglio del 58, ad opera di Fanfani, nasce il primo governo di
centro sinistra, che vede i socialisti a fianco dei democristiani, per
la prima volta dopo il governo monocolore di De Gasperi del 1947.
Ma questa nuova esperienza politica non dura nemmeno un
anno. Ritorna alla ribalta della politica italiana, però, con
maggiore convinzione, nel 1960.
Arriviamo al 1961. Si celebra il primo centenario dell’Unità
d’Italia. In tutta Italia si festeggia l’avvenimento con conferenze,
mostre, concerti ecc..
Nel novembre del 1962 viene nazionalizzata l’industria elettrica,
ritenuta di vitale importanza per i bisogni dei cittadini e per le
esigenze dell’ industria.
Scompaiono alcune grandi figure della storia: nel novembre del
63 viene assassinato il Presidente degli Stati Uniti d’America
Kennedy, nell’agosto del 64 muore a Yalta, Palmiro Togliatti,
indiscusso capo del partito comunista italiano per parecchi
decenni e nel gennaio del 65 se ne va anche Churchill, grande
protagonista della politica inglese e mondiale, soprattutto durante
la seconda guerra mondiale.
Nel 1966 avviene la grave alluvione di Firenze, che colpisce tutta
la città nei suoi affetti più cari, le opere d’arte. Ci son voluti
diversi anni per cancellare le tracce di questa tremenda alluvione.
Il 1968 è un anno pieno di avvenimenti molto rilevanti.
Nel mese di gennaio inizia un nuovo corso politico in
Cecoslovacchia comunemente chiamato “la primavera di Praga”,
poi soffocato, nel mese di agosto, dai carri dei paesi del Patto di
Varsavia, che è un patto stipulato dai paesi comunisti, simile al
Patto Atlantico di cui abbiamo già parlato.
Nel mese di maggio divampa a Parigi una protesta giovanile, che
dopo qualche mese si propaga in tutta l’Europa.
Nel 1969 l’Italia e l’Austria firmano un accordo per l’autonomia
dell’Alto Adige.
Nel dicembre del 1970 è approvata la legge sul divorzio.
Nel febbraio del 72 il presidente della Repubblica Leone, per la
prima volta nella storia repubblicana, scioglie le Camere e nel
successivo mese di marzo si fanno vive le brigate rosse,
movimento eversivo, con il rapimento di un dirigente di una
grande industria.
Il 1973 è caratterizzato da una svolta politica ed economica di
grande importanza. La svolta politica fu attuata dal Segretario del
partito comunista, Enrico Berlinguer, che propose quello che poi
prese il nome di “compromesso storico”, cioè la collaborazione di
diversi partiti per dare all’Italia governi stabili e duraturi. Si
concretizzò nel 1978, quando il partito comunista dette il proprio
appoggio esterno al monocolore di Andreotti.
La svolta economica si ebbe nel mese di dicembre quando i paesi
produttori di petrolio quadruplicarono il prezzo del greggio.
Si comprende quali furono le conseguenze negative in tutte le
economie delle nazioni importatrici di questo prezioso liquido. In
Italia si arrivò al razionamento dei carburanti.
Arriviamo così al 1976, quando nel mese di maggio il Friuli
viene colpito da uno spaventoso terremoto, che causa circa mille
morti e numerosissimi feriti.
Nel gennaio del 77 viene approvata la legge sull’aborto e nel 78,
quando il fenomeno delle brigate rosse è praticamente al culmine,
viene rapito e, dopo più di un mese, ucciso Aldo Moro, eminente
uomo politico italiano appartenente alla Democrazia Cristiana.
Nel giugno del 79 si hanno le prime elezioni europee, mentre a
settembre viene varato dal governo un piano per far fronte alla
crisi energetica.
Il 1980 è tristemente noto per la strage alla stazione di Bologna
avvenuta il due agosto, quando una bomba esplose nella sala
d’attesa facendo 85 vittime e numerosi feriti e per il terremoto in
Irpinia, a causa del quale persero la vita circa 3000 persone e
numerosi città e comuni rimasero danneggiati, alcuni anche
completamente distrutti.
Nell’81, mese di maggio, viene ferito il Santo Padre in un attentato
a Piazza San Pietro.
Nel mese di agosto dell’83 abbiamo, per la prima volta nella
nostra storia Repubblicana, come primo ministro un socialista e
precisamente l’Onorevole Craxi.
Salto, poiché non vi sono fatti di grande importanza, al mese di
novembre del 1988, quando cade il muro di BERLINO.
La guerra fredda è finita e la storia del mondo si avvia verso un
nuovo corso, che, purtroppo, non rispetta le aspettative in quanto
le guerre continuano in tutti i continenti.
Nel mese di febbraio del 92 viene firmato, dai 12 paesi della CEE
di allora, il trattato di Maastricht, tappa importante nel processo
di unificazione europea.
Questi i cardini del trattato:
- nascita della Unione Europea che riunisce tutti i vari trattati in
vigore fino a quel momento;
- sviluppo di una politica comune per quanto riguarda la politica
estera e la sicurezza;
- cooperazione tra tutti i paesi firmatari nei settori della giustizia
e degli affari interni
e non ultimo
- l’introduzione della Cittadinanza Europea e della Moneta
unica, l’Euro. La moneta unica, come tutti sapete, è già in atto
sin dal gennaio del 1992.
E mi fermo al mese di agosto del 1993 quando viene approvata
una nuova legge elettorale che prevede un sistema
prevalentemente maggioritario con una quota proporzionale.
Inizia così una nuova era per l’Italia che porta ad una maggiore
stabilizzazione dei vari governi fino ad arrivare al penultimo che
ha visto lo stesso Presidente del Consiglio per i cinque anni
dell’intera legislatura.
Certo questa elencazione di avvenimenti può essere stata noiosa,
credo, però, serva a puntualizzare i momenti più importanti della
nostra storia repubblicana. Storia repubblicana che ha visto
momenti di prosperità e periodi di difficoltà politica ed economica.
Di una cosa tutti, però, dobbiamo essere orgogliosi: qualsiasi
governo abbiamo scelto per governarci ha saputo mantenere
sempre viva la fiaccola della pace.
Mai l’Italia ha saputo costruire in tutta la sua storia un periodo
così lungo di pace.
E questo lo dobbiamo anche a quei personaggi che ebbero in
mano le sorti dell’Italia subito dopo la guerra, i quali, in momenti
difficili, pieni di incognite e di difficoltà di tutti i generi, seppero
fare delle scelte giuste ed oculate che hanno dato all’Italia quei
due valori che io ritengo importantissimi per qualsiasi popolo:
libertà e democrazia.
A noi, ai giovani il testimone di quegli uomini, affinché il loro
intelligente lavoro non venga vanificato o, peggio
ancora, annullato.
BRACCIANO, dicembre 2006
Pres. Sez. A.N.Art.I. di BRACCIANO
( Gen. Antonino MOZZICATO )